A. Sandrinelli,
|
|
|
- Lidia Bonetti
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1
2 L atmosfera terreste limita cio che possiamo osservare: La trasparenza dell atmosfera alla luce dipende dalle lunghezze d'onda. Solo la luce all interno di alcune finestre di lunghezza d onda puo attraversare l'atmosfera e raggiungere la terra cosi da essere visibile agli astronomi. Queste includono le bande da 3000 A a 7000 A (viola e rosso) e le onde radio.
3
4
5 Onde lunghe Bassa energia Onde corte Alta energia Le lunghezze d onda in nanometri: - Un metro e uguale a 1,000,000,000 di nanometri. - Un nanometro corrisponde a circa 10 atomi in fila (10A).
6 Telescopi per luce visibile Osservazioni dalla Terra Telescopi per infrarossi Telescopi solari Telescopi per onde radio submillimetriche Telescopi per onde radio mm cm - m Telescopi per luce visibile e ultravioletti Osservazioni dallo Spazio Telescopi per infrarossi Telescopi per raggi-x Telescopi per raggi γ
7
8 Il telescopio è il più importante strumento in dotazione all'astronomia. Nel suo senso più generale, raccoglie e focalizza la radiazione elettromagnetica emanata dall'oggetto che si vuole osservare; nel suo senso più comune, quando la suddetta radiazione ha una frequenza tale da rientrare nel campo del visibile, il telescopio funziona semplicemente in modo ottico ed è quel tubo con lenti ben che tutti hanno ben presente. Con il termine "telescopio", infatti, ci si riferisce generalmente ad un telescopio ottico, ma esso non è che un caso particolare di telescopio: se ne costruiscono infatti per osservare tutto lo spettro elettromagnetico, non solo la sua porzione visibile dall'occhio umano.
9 Il telescopio è composto da una montatura e da due parti ottiche: l'obiettivo e l'oculare. La montatura serve a sorreggere in modo robusto e stabile lo strumento. Il compito dell'obiettivo è quello di formare un'immagine il piu possibile dettagliata, luminosa e fedele. Il compito dell'oculare e di rendere tale immagine leggibile al meglio per l'occhio o per la fotocamera ingrandendola opportunamente.
10
11 Per montatura di un telescopio s'intende la struttura meccanica che si occupa di sostenere la componente strumentale ottica e la relativa strumentazione osservativa. Dal momento che la Terra ruota in senso antiorario da Ovest verso Est, la montatura (per annullare il moto apparente degli astri da Est verso Ovest) deve ruotare in senso orario allo stesso tasso di velocità della Terra: soddisfacendo questa condizione l'oggetto osservato rimarrà sempre al centro del campo d'osservazione: cosiddetto moto di azimuth.
12 Le montature si dividono in due grandi categorie: altazimutali ed equatoriali. La montatura altazimutale, avendo l'asse principale (azimuth) perpendicolare al suolo, origina il fenomeno della cosiddetta rotazione di campo, secondo il quale l'immagine risultante ruota ad una velocità dipendente dalla declinazione del corpo celeste osservato. Il telescopio, per mantenere l'oggetto osservato al centro del campo, si deve muovere continuamente nei due assi orizzontale e verticale che nel gergo si chiamano azimuth e declinazione. Le montature equatoriali si dividono in più categorie. Esse presentano tutte in comune due caratteristiche: una fisica ed una strumentale. 1. La caratteristica fisica comune a tutte le montature equatoriali consiste nel fatto che l'asse principale intorno a cui ruota tutta la massa strumentale presenta, rispetto al suolo, un'inclinazione variabile in funzione della latitudine del posto in cui lo strumento si trova: tale asse mira quindi il Polo Nord celeste. 2. L'altra caratteristica consiste nell' invariabilità della declinazione strumentale: una volta puntato l'oggetto da osservare, entra in funzione il solo moto siderale e non c'è rotazione di campo.
13
14 L'occhio umano ha risorse limitate come strumento di osservazione all'oculare di un telescopio. Le osservazioni fotografiche hanno permesso si studiare dettagli della struttura della nostra Galassia e anche di galassie lontane. Il maggiore inconveniente e pero il comportamento non lineare: ad una illuminazione doppia non corrisponde infatti un annerimento doppio. Ciò compromette la possibilità di eseguire misure di luminosità con precisione. Queste misure vengono invece fatte usando i cosiddetti fotometri (per singoli oggetti). E importante studiare non solo le immagini del cielo, ma anche lo spettro della luce proveniente da un corpo celeste. Lo spettro è semplicemente la distribuzione della radiazione (luce visibile, o altre lunghezze d'onda) alle varie energie, o lunghezze d'onda. Lo spettro di un oggetto celeste, è in generale composto da una parte la cui intensità varia lentamente al variare della lunghezza d'onda ( spettro continuo), su cui sono sovrapposte le cosiddette righe spettrali, in assorbimento o in emissione se esse sono rispettivamente più scure o più brillanti dello spettro continuo sottostante. La forma dello spettro continuo è determinata dalla temperatura superficiale dell'oggetto celeste osservato. Ciascuna riga è prodotta da un ben determinato elemento chimico (o da molecole), e la loro osservazione (e misura quantitativa) fornisce quindi informazioni sulle condizioni fisiche e sulla composizione chimica della superficie dell'oggetto osservato.
15 Spettri ottici di stelle di vario tipo spettrale. Si notino le righe di assorbimento (scure) sovrapposte sullo spettro continuo, soprattutto nelle stelle meno massicce e più fredde, come le stelle di tipo K e M (in basso). Sopra la figura sono indicate le posizioni delle righe più intense dell'idrogeno (H-beta, H-gamma e H-delta) e del calcio (Ca II K).
16 Esempi di configurazioni degli oculari
17
18 Gli obiettivi dei telescopi ottici si dividono principalmente in tre tipi: Rifrattori, usano come obiettivo un insieme di lenti per focalizzare l'immagine. Riflettori, raccolgono la luce per mezzo di un grande specchio di forma parabolica e la concentra nel fuoco della parabola, dove può essere direttamente osservata, fotografata e analizzata oppure nuovamente riflessa. Poiché gli specchi funzionano sfruttando il fenomeno della riflessione, mentre le lenti funzionano per rifrazione, i telescopi con obiettivo a specchio si dicono riflettori, quelli con obiettivo a lenti rifrattori. Misti (catadioptric), usano come obiettivo una combinazione di lenti e specchi.
19 L'aberrazione ottica è una distorsione nella forma o nel colore di una immagine prodotta da un sistema ottico qualsiasi, composto da più lenti. È causata da imperfezioni o compromessi costruttivi e può essere ridotta o a volte eliminata utilizzando materiali migliori, lavorando in modo particolare le ottiche o accoppiando componenti diversi. In generale la correzione comporta un aumento dei costi di produzione. Elemento influenzante lo sviluppo dell'aberrazione è lo spessore del mezzo ottico attraversato dalla luce, dalla scomposizione di quest'ultima legata al fenomeno della rifrazione ed alla suddivisione nelle diverse lunghezze d'onda dei colori percepiti nel visibile. Le princiali tipologie di aberrazione ottica, che influenzano la qualita dell osservazione sono: 1. L'aberrazione sferica 2. Il coma
20 L'aberrazione sferica è un difetto che in un sistema ottico con lenti sferiche porta alla formazione di una immagine distorta. È provocato dal fatto che la sfera non è la superficie ideale per realizzare una lente, ma è comunemente usata per semplicità costruttiva. I raggi distanti dall'asse vengono focalizzati ad una distanza differente dalla lente rispetto a quelli più centrali. Per evitare il fenomeno si utilizzano particolari lenti non sferiche, chiamate asferiche, più complesse da realizzare e molto costose.
21 Il coma è una aberrazione ottica che deriva il suo nome dal caratteristico aspetto a cometa delle immagini create dai sistemi ottici che presentano tale difetto. Il coma si ha quando l'oggetto ripreso è spostato lateralmente rispetto all'asse del sistema di un angolo θ. I raggi che passano per il centro di una lente con distanza focale f, sono focalizzati alla distanza f tan θ. I raggi che passano in periferia sono focalizzati invece in un punto diverso sull'asse, più lontano nel caso del coma positivo e più vicino nel coma negativo. In generale, un fascio di raggi passanti per la lente ad una certa distanza dal centro, è focalizzato in una forma ad anello sul piano focale. La sovrapposizione di questi diversi anelli origina una forma a V, simile alla coda di una cometa.
22 I Telescopi Rifrattori sono cio che e comunemente identificato con la parola "telescopio : un lungo e sottile tubo dove la luce passa tramite un sistema di lenti in una linea retta dall'obiettivo obiettivo posto anteriormente direttamente ad un oculare posto all'estremità opposta del tubo. più grande che esista è quello di 102 cm di diametro e 19,6 m di focale installato nel 1897 all'osservatorio di Yerkes, Chicago.
23 Un telescopio riflettore raccoglie la luce per mezzo di un grande specchio di forma parabolica e la concentra nel fuoco della parabola, dove può essere osservata direttamente dagli astronomi, fotografata e analizzata con i più sofisticati strumenti. Per configurazione ottica s'intende il particolare tipo di percorso che la radiazione luminosa compie in funzione delle superfici riflettenti (sferiche o piane che siano) e rifrangenti che incontra nel suo percorso. Configurazioni: 1. Fuoco diretto 2. Newtioniano 3. Cassegrain
24 Costruire lenti di dimensioni maggiori ai 100 cm presenta gravi difficoltà tecniche: perciò oggi i grandi telescopi usano solo obiettivi a specchio concavo sferico o parabolico. Sono questi i yelescopi riflettori. Le Loro configurazioni più comuni sono la newtoniana e la cassegrain.
25 I telescopi riflettore di Newton, anche conosciuti come catoptrics, hanno solitamente uno specchio primario concavo e parabolico per raccogliere e focalizzare la luce verso uno specchio secondario, piano, posto in posizione diagonale. Questo devia l immagine riflessa verso un apertura posta sul lato del cilindro dove e posto l oculare.
26 Telescopio Anno Lente Addizionale Specchio primario Specchio secondario Riflettore Gregoriano Concavo Parabolico Concavo Ellittico Cassegrain Concavo Parabolico Convesso Iperbolico Ritchey-Chrétien Concavo Iperbolico Concavo Iperbolico Dall-Kirkham Concavo Iperbolico Convesso Sferico Misto Schmidt-Cassegrain Lente di Schmidt Concavo Sferico Convesso Sferico Maksutov-Cassegrain Menisco Concavo Sferico Convesso Sferico Sigler-Maksutov Menisco Concavo Sferico Convesso Sferico Telescopi riflettori con configurazione Cassegrain, riflettori e misti.
27 Il telescopio Cassegrain (1672) è costituito da due specchi: il primario concavo e parabolico ed il secondario convesso iperbolico. Lo specchio primario è forato e l'osservazione della sorgente luminosa avviene dietro a questo. Il percorso luminoso segue in questo caso un doppio tragitto all'interno del tubo ottico, il che consente di avere focali lunghe in uno strumento abbastanza compatto.
28 Telescopio Ritchey-Chrétien (1910): sia lo specchio primario che quello secondario sono concavi iperbolici. Risulta molto compatto, esente da aberrazioni sferiche e di coma, in grado di offtire una largo campo visivo. E la configurazione piu comune per I grandi telescopi ottici. Esempi: Keck Observatory (10m, 2x), Paranal Observatory (8.2m, 4x), Gemini Observatory (8m, 2x), Gran Telescopio Canarias (10.4m), Subaru-Manua Kea (8.2m) telescope at Mauna Kea Observatory, Hubble Space Telescope (2.4m), Herschel Space Observatory (3.5m).
29 Il telescopio Dall-Kirkham (1928) è. è una variante del Cassegrain classico, anche in questo caso troviamo una differenza nella curvatura degli specchi, iperbolico il primario e sferico il secondario; con tale configurazione si abbattono le aberrazioni sferiche già all'origine senza l'introduzione di elementi correttori.
30 Il telescopio Schmidt-Cassegrain è composto da uno specchio primario concavo sferico, da uno specchio secondario convesso sferico e da una sottile lente dotata di potere convergente al centro e divergente ai bordi (superficie di Schmidt) che ha lo scopo di correggere le aberrazioni ottiche residue del sistema. L'immagine si forma nella parte posteriore del tubo, dietro un foro praticato al centro dello specchio primario.
31 Per evitare i problemi posti dalla lavorazione della superficie di Schmidt, negli anni '40 si ipotizzo la superficie asferica poteva essere sostituita da un menisco concavo (cioè una lente con le curvature nello stesso senso), concentrico allo specchio e di potenza debolmente negativa. Il menisco, praticamente acromatico, è calcolato per neutralizzare l'aberrazione sferica dello specchio (Maksutov). L applicazione di questa soluzione con la configurazione Cassegrain, e nota come Telescopio Maksutov-Cassegrain.
32 Evoluzione del Maksutov-Cassegrain: Robert D. Sigler progetto negli anni '70 un Maksutov con uno specchio secondario quasi a metà strada tra il principale e il correttore incrementando in misura notevole il campo di buona definizione.
33
34 Il Very Large Telescope Project (VLT) è un sistema di quattro telescopi ottici separati. Ognuno dei quattro strumenti principali è un telescopio riflettore con uno specchio primario di 8,2 metri. Il progetto VLT fa parte dell'european Southern Observatory (ESO) Il VLT si trova all'osservatorio del Paranal sul Cerro Paranal, una montagna alta metri nel deserto di Atacama, nel Cile settentrionale. Come per la maggior parte degli Osservatori mondiali, il posto è stato scelto per la sua secchezza (sul Paranal non è mai piovuto a memoria d'uomo), l'abbondanza di notti serene, la quota elevata e lontananza da fonti di inquinamento luminoso.
35 Il Large Synoptic Survey Telescope (LSST). Caratterizzato da tre specchi. Lo specchio primario ha un diametro di 8.4 m, il secondario di 3.4 m ed il terziario di 5.0 m. La luce entrante si riflette sullo specchio primario, e riflessa sullo specchio secondario raggiunge il terzo specchi prime di raggiungere l oculare.
36 L Extremely Large Telescope (ELT) e un telescopio caratterizzato da uno specchio primario diametro 42 m, composto da 906 segmenti esagonali, ciascuno della dimensione di 1.45 m. Lo specchio secondario ha un diametro di 6 m.
37 L Overwhelmingly Large Telescope (OWL) è un progetto dell'european Southern Observatory che prevede la costruzione di un telescopio con singola apertura di 100 metri di diametro.
38 Il Large Binocular Telescope (LBT) è un telescopio a doppia pupilla a montatura altazimutale in configurazione gregoriana, ottimizzato per interferometria e osservazione a grande campo. È collocato sul monte Graham, nel sud-est dell'arizona, a più di 3000 metri di altezza, nel complesso delle montagne Pinaleño.
39
40 Ottica adattiva (Specchi multipli)
41 Il sistema di ottica adattiva permette di migliorare sensibilmente le prestazioni poiche' in linea di principio permette di avere immagini prive di distorsione atmosferica (fonte Keck).
42 Immagine di Saturno. E' evidente il guadagno in termini di risoluzione utilizzando l'ottica Adattiva (fonte Keck).
43 Una visione ravvicinata dei 261 attuatori che fanno parte del sistema di ottica attiva del telescopio Subaru. Ottica attiva (Specchi sottili)
44 I Liquid Mirrors (LM) sono specchi realizzati utilizzando dei liquidi riflettenti. Sono costituiti dat tre componenti principali: 1. Un disco contenente un metallo liquido riflettente, ad esempio del mercurio o della lega di gallio. 2. Un cuscino ad aria che supporta il Liquid Mirror. 3. Un sistema di guida e controllo. Il disco viene fatto ruotare finche il liquido non si dispone nella tipica forma a parabola. Il vantaggio e di costo (1% rispetto ad uno specchio tradizionale). Il limite e che puo essere posizionato solol'asse principale (azimuth) perpendicolare al suolo.
45 Il Large-Aperture Mirror Array (LAMA) e un progetto che utilizzara technologie avanzate (liquid-mirror, ottica adattiva ed interferometria) per potere realizzare specchi primari di grandi dimensioni per ottenere altissime risoluzioni ad un costo contenuto.
46
47 Il McMath-Pierce Solar Telescope (3-mirror heliostat design) e il piu grande telescopio solare esistente. E formato da soli specchi. Lo specchio primario misura 2 m in diametro. La luce solare viene riflessa verso uno specchio secondario della misura di 1.6 m, posto ad una distanza di 15 m. Questa viene poi riflessa verso l ultimo specchio che riflette l immagine nella camera di osservazione.
48 Lo Swedish Solar Telescope (SST) e un vacuum telescope. Il vuoto serve ad evitare che il surriscaldamento dell aria all interno falsi le immagini.
49 Advanced Technology Solar Telescope (ATST) L obiettivo è costruire grandi telescopi solari, che raccolgono grandi quantità di luce e calore per ottenere un forte potere di risoluzione e insieme potere usare didelicatissimi strumenti scientifici, a temperatura controllata: il problema principale è la dissipazione dell'enorme calore raccolto.
50
51 Il radiotelescopio è un telescopio specializzato nel rilevare onde radio emesse dalle varie radiosorgenti sparse per l'universo, generalmente grazie ad una grande antenna parabolica, o più antenne collegate. Il radiotelescopio più conosciuto, che è anche quello più grande, si trova ad Arecibo, in Porto Rico, ricavato in una depressione naturale larga circa 350 metri. Il più grande radiotelescopio composto da una singola antenna orientabile e si trova a Green Bank, in Virginia (GBT), ed ha un diametro di 100 metri.
52 Il radiotelescopio submillimetrico (Submillimeter Telescope) esplora la regione delle radiazioni elettromagnetiche compresa tra gli IR e le onde corte (Lunghezze d onda tra i 300 microns ed il 1 millimetro; frequenze tra 300 Gigahertz e 1 Terahertz). Questa regione non e mai stata studiata in modo esaustivo principalmente a causa della iterferenza dell atmosfera e dalla mancanza di strumentazione adeguata. Le aree geografiche che permettono una migliore osservazione sono quelle con atmosfera rarefatta (alta quota) e quelle antartiche.
53 I radiotelescopi paraboloidi cilindri (cicylindrical paraboloid telescope) sono stati progettati per estendere la superfici di riflessione delle onde radio. Ruotando attorno all asse principale possono inseguire gli oggetti celesti fono a 10 ore ed possono operare con bande di frequenza incluse tra I 10MHz e i 500 MHz. Sono ormai superati dagli array.
54 L'interferometria è utilizzata per eseguire misurazioni di lunghezze d'onda, di distanze e di spostamenti dello stesso ordine di grandezza; si misurano anche velocità di propagazione della luce in vari mezzi e indici di rifrazione. L'interferometria è particolarmente utilizzata in radioastronomia. Si basa sul principio di interferenza delle onde elettromagnetiche e permette di ottenere elevati poteri risolutivi combinando coerentemente le informazioni che provengono da più osservatori astronomici distanti fra loro. Il potere risolutivo risultante è proporzionale alla distanza tra gli osservatori stessi. L'interferometria, quindi, permette di superare i limiti imposti dalle difficoltà tecniche di realizzazione di radiotelescopi a grande apertura. Nei radiointerferometri il raggio del disco di diffrazione entro cui è possibile osservare è fornito dalla legge: λ corrisponde alla lunghezza d'onda a cui si osserva, D al diametro dell'antenna. É evidente che per ottenere una migliore risoluzione occorre osservare con strumenti di grandi dimensioni. In particolare nella banda radio occorrono parabole molto grandi, perché le onde radio hanno lunghezza d'onda variabile da qualche millimetro a parecchi chilometri.
55 Il "Very Large Array" (VLA), situato nel New Mexico, è costituito da 27 radiotelescopi, ciascuno delle dimensioni di una "casa" (i paraboloidi hanno un'apertura di 25 metri), che possono scorrere lungo dei binari.
56 Very Long Baseline Interferometry (VLBI), Merlin. Utilizzano radiotelescopi posti su tutta la terra (ed anche nello spazio) per effettuare osservazioni interferometriche con risoluzioni angolari pari o inferiori al millesimo di secondo d'arco. Tali osservazioni hanno permesso di studiare le regioni più interne dei nuclei attivi che sono all'origine dell'energia necessaria per l'emissione nella banda radio delle galassie.
57 Square Kilometre Array (SKA) è un progetto di ricerca internazionale che ha come fine la realizzazione di un radio telescopio con una superficie efficace di raccolta del segnale di un chilometro quadrato, cioè circa l estensione di 200 campi da calcio. La sensibilità di questo strumento sarà 100 volte più grande di quella degli strumenti attuali e coprirà una banda di frequenza compresa tra 100MHz e 25GHz.
58 Grafico della evoluzione dei radiotelescopi in funzione della sesibilita relativa.
59
60 Mauna Kea, Hawaii, metri slm, e probabilmente il piu famoso sito per l osservazione astronomica dalla terra, nelle gamme del visibile, IR e radio (submillimeter, mm, cm, m).
61
62 Dimensione degli specchi riflettori di tutti i telescopi, sia ottici che IR presenti a Mauna Kea.
63
64 Osservazioni dallo spazio Negli anni '50, sulla base dell'esperienza acquisita durante la seconda guerra mondiale sul lancio di missili, si ebbe la possibilità di lanciare dei razzi che uscissero per alcuni minuti fuori dall'atmosfera terrestre. Alcuni scienziati approfittarono di questa opportunità per lanciare piccoli strumenti, allo scopo di osservare il cielo a quelle lunghezze d'onda (per esempio lontano ultravioletto e raggi X) che vengono assorbite dall'atmosfera. Tramite razzi furono appunto ottenute le prime immagini nei raggi X del Sole. Successivamente, in seguito all'avvento dell'era spaziale, alla fine degli anni '60 non solo furono lanciate sonde verso corpi del Sistema Solare, ma fu anche possibile mettere in orbita attorno alla Terra satelliti artificiali con a bordo strumenti per osservazioni astronomiche.
65 L Hubble Space Telescope (HST) e destinato allo studio delle emissioni elettromegnetiche incluse nell intervallo tra 1000 A e A (UV e IR).
66 Dettaglio delle lunghezze d onda osservabili con l Hubble Space Telescope
67 Il Telescopio Spaziale Spitzer, in missione dal 25 agosto 2003, è un osservatorio spaziale che osserva nell'infrarosso. Il telescopio ha uno specchio primario di 85 cm di diametro, raffreddato alla temperatura di 5,5 Kelvin, temperatura necessaria per abbattere l'emissione termica dello specchio che andrebbe a sovrapporsi alla radiazione che si vuole osservare.
68 Il Telescopio Spaziale James Webb, considerato il sucessore di Hubble,sara un telescopio spaziale infrarosso la cui missione primaria sara quella di esaminare il residuo a infrarossi del big bang per poter determinare le condizioni iniziali di formazione dell'universo. Il telescopio, destinato ad essere messo in orbita nel 2011, avra uno specchio primario di 4.0 m di diametro. Saranno installati quattro strumenti: MIRI (Mid-Infrared Instrument), NIRCam (Near-Infrared Camera), NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph) e l FGS (Fine Guidance Sensor).
69 I telescopi ottici non sono adatti a produrre immagini in raggi X: infatti questi ultimi sono molto penetranti, ed attraversano un normale specchio posto sul loro cammino, invece di venirne riflessi. I raggi X necessitano di specchi ad incidenza radente. Perciò, invece di utilizzare la regione della parabola vicina al vertice come nei telescopi ottici o nei ricevitori radio, si usano le pareti, che formano con il fascio incidente un angolo piccolo quanto è necessario.
70 Naturalmente, non basta fare convergere i raggi X nel fuoco di un telescopio, ma bisogna anche mettere sul piano focale uno strumento (rivelatore) capace di registrare la radiazione ricevuta dallo spazio, producendo immagini che gli astronomi possano analizzare. I contatori proporzionali sono basati sulla proprietà dei raggi X di causare la ionizzazione del mezzo che attraversano. In figura Il contatore proporzionale PSPC, a bordo di ROSAT. I CCD, già presentati riguardo alle osservazioni ottiche, sono stati applicati solo di recente per osservazioni nei raggi X.
71 Il satellite per osservazioni in raggi X ROSAT. In alto a destra si nota l'apertura (a forma di ragnatela) del telescopio per raggi X. Sono anche visibili pannelli solari, che forniscono energia elettrica, e l'antenna per la trasmissione a terra dei dati di osservazione.
72 Il satellite per osservazioni in raggi X CHANDRA e caratterizzato dal visibile telescopio.
73 L'importanza dello studio dei raggi gamma come fonte d'informazione dall'universo dipende dal loro difficile assorbimento nello spazio, e dal fatto che essi non sono deviati da campi magnetici. Il loro studio richiede tuttavia l'uso di telescopi orbitanti dato che l'atmosfera terrestre assorbe ad oltre 25km di altitudine la loro radiazione. Il Compton Gamma-Ray Observatory fu lanciato il 7 aprile E' rientrato nell atmosfera il 4 Giugno 2000 dopo essere stato risollevato in orbita nel Era destinato allo studio delle emissioni elettromegnetiche dai corpi celesti nell'intervallo di energie tra i 30 KeV e i 30 GeV (raggi gamma).
74 LAT (Large Area Telescope) Il lancio del Gamma-ray Large Area Space Telescope (GLAST), ovvero Telescopio spaziale ai raggi gamma ad ampia superficie, è previsto per il settembre del Servirà allo studio delle emissioni elettromegnetiche dai corpi celesti nell'intervallo di energie tra i 20 MeV e i 300 GeV (raggi gamma). Uno strumento secondario, il Gamma-ray bursts monitor, verrà utilizzato per rilevare energie inferiori, fino a 10 kev, e fenomeni più brevi come i Gamma ray bursts.
75 Il telescopio europeo Integral, in missione dal 17 ottobre 2002, è il primo telescopio spaziale in grado di osservare il cielo contemporaneamente nei raggi gamma, nei raggi X e nella luce visibile.
6 CORSO DI ASTRONOMIA
 6 CORSO DI ASTRONOMIA Il Telescopio, dall antichità ai giorni nostri 5 marzo 2016 spiegazioni di Giuseppe Conzo Parrocchia SS. Filippo e Giacomo Oratorio Salvo D Acquisto SOMMARIO Nascita di strumenti
6 CORSO DI ASTRONOMIA Il Telescopio, dall antichità ai giorni nostri 5 marzo 2016 spiegazioni di Giuseppe Conzo Parrocchia SS. Filippo e Giacomo Oratorio Salvo D Acquisto SOMMARIO Nascita di strumenti
Telescopi ed aberrazioni ottiche
 Centro Osservazione e Divulgazione Astronomica Siracusa Emanuele Schembri Telescopi ed aberrazioni ottiche Siracusa,, 30 aprile 2010 Definizione Le aberrazioni ottiche sono difetti apparenti del comportamento
Centro Osservazione e Divulgazione Astronomica Siracusa Emanuele Schembri Telescopi ed aberrazioni ottiche Siracusa,, 30 aprile 2010 Definizione Le aberrazioni ottiche sono difetti apparenti del comportamento
Osservare l Universo. Lezioni d'autore di Claudio Censori
 Osservare l Universo Lezioni d'autore di Claudio Censori INTRODUZIONE VIDEO TELESCOPI (I) I telescopi si dividono in 1. rifrattori, o diottrici (detti cannocchiali), se l obiettivo è fatto con lenti: 2.
Osservare l Universo Lezioni d'autore di Claudio Censori INTRODUZIONE VIDEO TELESCOPI (I) I telescopi si dividono in 1. rifrattori, o diottrici (detti cannocchiali), se l obiettivo è fatto con lenti: 2.
Lezione 2. Basi di ottica, telescopi, antenne
 Lezione 2 Basi di ottica, telescopi, antenne La formazione dell'immagine La radiazione che viene intercettata da un telescopio: una serie di onde piane provenienti dalle diverse regioni del cielo Il piano
Lezione 2 Basi di ottica, telescopi, antenne La formazione dell'immagine La radiazione che viene intercettata da un telescopio: una serie di onde piane provenienti dalle diverse regioni del cielo Il piano
LENTI SOTTILI. Le lenti sottili sono gli strumenti ottici più importanti tra quelli più semplici.
 LENTI SOTTILI Chiamiamo lente un qualsiasi corpo trasparente limitato da due superfici curve o da una superficie piana ed una curva, in grado di trasmettere un fascio di luce focalizzandolo in modo da
LENTI SOTTILI Chiamiamo lente un qualsiasi corpo trasparente limitato da due superfici curve o da una superficie piana ed una curva, in grado di trasmettere un fascio di luce focalizzandolo in modo da
Fisica II - CdL Chimica. Formazione immagini Superfici rifrangenti Lenti sottili Strumenti ottici
 Formazione immagini Superfici rifrangenti Lenti sottili Strumenti ottici Ottica geometrica In ottica geometrica si analizza la formazione di immagini assumendo che la luce si propaghi in modo rettilineo
Formazione immagini Superfici rifrangenti Lenti sottili Strumenti ottici Ottica geometrica In ottica geometrica si analizza la formazione di immagini assumendo che la luce si propaghi in modo rettilineo
09/10/15. 1 I raggi luminosi. 1 I raggi luminosi. L ottica geometrica
 1 I raggi luminosi 1 I raggi luminosi Per secoli si sono contrapposti due modelli della luce il modello corpuscolare (Newton) la luce è un flusso di particelle microscopiche il modello ondulatorio (Christiaan
1 I raggi luminosi 1 I raggi luminosi Per secoli si sono contrapposti due modelli della luce il modello corpuscolare (Newton) la luce è un flusso di particelle microscopiche il modello ondulatorio (Christiaan
Lezione 22 - Ottica geometrica
 Lezione 22 - Ottica geometrica E possibile, in certe condizioni particolari, prescindere dal carattere ondulatorio della radiazione luminosa e descrivere la propagazione della luce usando linee rette e
Lezione 22 - Ottica geometrica E possibile, in certe condizioni particolari, prescindere dal carattere ondulatorio della radiazione luminosa e descrivere la propagazione della luce usando linee rette e
Fisica II - CdL Chimica. Formazione immagini Superfici rifrangenti Lenti sottili Strumenti ottici
 Formazione immagini Superfici rifrangenti Lenti sottili Strumenti ottici Ottica geometrica In ottica geometrica si analizza la formazione di immagini assumendo che la luce si propaghi in modo rettilineo
Formazione immagini Superfici rifrangenti Lenti sottili Strumenti ottici Ottica geometrica In ottica geometrica si analizza la formazione di immagini assumendo che la luce si propaghi in modo rettilineo
Spettroscopia ottica di sorgenti celesti ignote
 Spettroscopia ottica di sorgenti celesti ignote Filippo Dalla, Angelo La Rocca, Luca Palmieri ABSTRACT La spettroscopia è la scienza che si occupa dello studio e della misura di uno spettro, i dati che
Spettroscopia ottica di sorgenti celesti ignote Filippo Dalla, Angelo La Rocca, Luca Palmieri ABSTRACT La spettroscopia è la scienza che si occupa dello studio e della misura di uno spettro, i dati che
I prolungamenti di due raggi riflessi si incrociano in un punto che diventa l'immagine dell'oggetto.
 Riflessione e specchi Immagini reali e immagini virtuali Abbiamo applicato le leggi della riflessione per studiare le immagini che si vengono a creare in presenza di uno specchio piano. L'immagine che
Riflessione e specchi Immagini reali e immagini virtuali Abbiamo applicato le leggi della riflessione per studiare le immagini che si vengono a creare in presenza di uno specchio piano. L'immagine che
LA LUCE. Perché vediamo gli oggetti Che cos è la luce La propagazione della luce La riflessione La rifrazione
 LA LUCE Perché vediamo gli oggetti Che cos è la luce La propagazione della luce La riflessione La rifrazione Perché vediamo gli oggetti? Perché vediamo gli oggetti? Noi vediamo gli oggetti perché da essi
LA LUCE Perché vediamo gli oggetti Che cos è la luce La propagazione della luce La riflessione La rifrazione Perché vediamo gli oggetti? Perché vediamo gli oggetti? Noi vediamo gli oggetti perché da essi
Lo Spettro Elettromagnetico
 Spettroscopia 1 Lo Spettro Elettromagnetico Lo spettro elettromagnetico è costituito da un insieme continuo di radiazioni (campi elettrici e magnetici che variano nel tempo, autogenerandosi) che va dai
Spettroscopia 1 Lo Spettro Elettromagnetico Lo spettro elettromagnetico è costituito da un insieme continuo di radiazioni (campi elettrici e magnetici che variano nel tempo, autogenerandosi) che va dai
E noto che la luce, o radiazione elettromagnetica, si propaga sottoforma di onde. Un onda è caratterizzata da due parametri legati fra loro: la
 1 E noto che la luce, o radiazione elettromagnetica, si propaga sottoforma di onde. Un onda è caratterizzata da due parametri legati fra loro: la lunghezza d onda ( ), definita come la distanza fra due
1 E noto che la luce, o radiazione elettromagnetica, si propaga sottoforma di onde. Un onda è caratterizzata da due parametri legati fra loro: la lunghezza d onda ( ), definita come la distanza fra due
Corso di Laurea in Astronomia. Laurea Triennale DISPENSE DI ESPERIMENTAZIONI DI FISICA 2
 Corso di Laurea in Astronomia Laurea Triennale DISPENSE DI ESPERIMENTAZIONI DI FISICA A.A. 01-013 Indice 1 Introduzione 5 1.1 Indice di rifrazione.............................. 5 1. Riflessione e rifrazione............................
Corso di Laurea in Astronomia Laurea Triennale DISPENSE DI ESPERIMENTAZIONI DI FISICA A.A. 01-013 Indice 1 Introduzione 5 1.1 Indice di rifrazione.............................. 5 1. Riflessione e rifrazione............................
Formazione dell'immagine
 Ottica geometrica Percepiamo la luce perché ci arriva direttamente dalla sorgente oppure riflessa dagli oggetti L'emissione della luce è complessa da capire, mentre la propagazione è, di solito, più semplice
Ottica geometrica Percepiamo la luce perché ci arriva direttamente dalla sorgente oppure riflessa dagli oggetti L'emissione della luce è complessa da capire, mentre la propagazione è, di solito, più semplice
3. (Da Veterinaria 2006) Perché esiste il fenomeno della dispersione della luce bianca quando questa attraversa un prisma di vetro?
 QUESITI 1 FENOMENI ONDULATORI 1. (Da Medicina 2008) Perché un raggio di luce proveniente dal Sole e fatto passare attraverso un prisma ne emerge mostrando tutti i colori dell'arcobaleno? a) Perché riceve
QUESITI 1 FENOMENI ONDULATORI 1. (Da Medicina 2008) Perché un raggio di luce proveniente dal Sole e fatto passare attraverso un prisma ne emerge mostrando tutti i colori dell'arcobaleno? a) Perché riceve
4. Gli oggetti non stellari
 1. Oltre le stelle 2. Le nebulose In cielo sono presenti anche corpi luminosi diffusi. Il nome nebulose si riferisce all'aspetto sfuocato di questi oggetti e non ad ipotesi sulla loro natura. 3. Charles
1. Oltre le stelle 2. Le nebulose In cielo sono presenti anche corpi luminosi diffusi. Il nome nebulose si riferisce all'aspetto sfuocato di questi oggetti e non ad ipotesi sulla loro natura. 3. Charles
SPECCHI. Dalla posizione dell'immagine non emergono raggi luminosi; essa si trova sull'immaginario prolungamento dei raggi di luce riflessa.
 SPECCHI SPECCHI PIANI Per specchio si intende un dispositivo la cui superficie è in grado di riflettere immagini di oggetti posti davanti a essa. Uno specchio è piano se la superficie riflettente è piana.
SPECCHI SPECCHI PIANI Per specchio si intende un dispositivo la cui superficie è in grado di riflettere immagini di oggetti posti davanti a essa. Uno specchio è piano se la superficie riflettente è piana.
Lezioni di illuminotecnica. Fenomeni ottici fondamentali
 7 Lezioni di illuminotecnica Fenomeni ottici fondamentali Interazione luce-materiali Consideriamo una lastra di materiale immersa in aria. Quando la radiazione lin viaggio nell aria incontra l interfaccia
7 Lezioni di illuminotecnica Fenomeni ottici fondamentali Interazione luce-materiali Consideriamo una lastra di materiale immersa in aria. Quando la radiazione lin viaggio nell aria incontra l interfaccia
I molti volti dell'universo
 I molti volti dell'universo L astronomia infrarossa Paolo Saracco INAF - Osservatorio Astronomico di Brera / DVWURQRPLDLQIUDURVVD 2OWUHLOLPLWL /DVFRSHUWD GHOOD UDGLD]LRQH,5 3URSULHWDC ILVLFKH GHOO,5 /
I molti volti dell'universo L astronomia infrarossa Paolo Saracco INAF - Osservatorio Astronomico di Brera / DVWURQRPLDLQIUDURVVD 2OWUHLOLPLWL /DVFRSHUWD GHOOD UDGLD]LRQH,5 3URSULHWDC ILVLFKH GHOO,5 /
Laboratorio PLS di astrofisica_ Modulo 1 Attività teoriche e sperimentali preliminari svolte presso le singole scuole
 Laboratorio PLS di astrofisica_ Modulo 1 Attività teoriche e sperimentali preliminari svolte presso le singole scuole Classe/i LICEO SCIENTIFICO CANNIZZARO IVA, IVL, IVC, IVD 11 ARTIACO LUIGIA ( Enrico
Laboratorio PLS di astrofisica_ Modulo 1 Attività teoriche e sperimentali preliminari svolte presso le singole scuole Classe/i LICEO SCIENTIFICO CANNIZZARO IVA, IVL, IVC, IVD 11 ARTIACO LUIGIA ( Enrico
Telerilevamento: una panoramica sui sistemi
 Telerilevamento: una panoramica sui sistemi Il telerilevamento: cos è? Il telerilevamento è la scienza (o l arte) di ottenere informazioni riguardanti un oggetto, un area o un fenomeno utilizzando dati
Telerilevamento: una panoramica sui sistemi Il telerilevamento: cos è? Il telerilevamento è la scienza (o l arte) di ottenere informazioni riguardanti un oggetto, un area o un fenomeno utilizzando dati
Profili di trasmissione dei filtri interferenziali del telescopio PSPT
 I.N.A.F Osservatorio Astronomico di Roma Profili di trasmissione dei filtri interferenziali del telescopio PSPT Mauro Centrone Fabrizio Giorgi Nota tecnica - 2003 1 Introduzione I filtri interferenziali
I.N.A.F Osservatorio Astronomico di Roma Profili di trasmissione dei filtri interferenziali del telescopio PSPT Mauro Centrone Fabrizio Giorgi Nota tecnica - 2003 1 Introduzione I filtri interferenziali
Le onde elettromagnetiche
 Campi elettrici variabili... Proprietà delle onde elettromagnetiche L intuizione di Maxwell (1831-1879) Faraday ed Henry misero in evidenza che un campo magnetico variabile genera un campo elettrico indotto.
Campi elettrici variabili... Proprietà delle onde elettromagnetiche L intuizione di Maxwell (1831-1879) Faraday ed Henry misero in evidenza che un campo magnetico variabile genera un campo elettrico indotto.
ONDE ELETTROMAGNETICHE
 Fisica generale II, a.a. 01/014 OND LTTROMAGNTICH 10.1. Si consideri un onda elettromagnetica piana sinusoidale che si propaga nel vuoto nella direzione positiva dell asse x. La lunghezza d onda è = 50.0
Fisica generale II, a.a. 01/014 OND LTTROMAGNTICH 10.1. Si consideri un onda elettromagnetica piana sinusoidale che si propaga nel vuoto nella direzione positiva dell asse x. La lunghezza d onda è = 50.0
Università degli Studi di Milano. Dipartimento di Fisica Corso di laurea triennale in FISICA. Anno accademico 2013/14. Figure utili da libri di testo
 Università degli Studi di Milano Dipartimento di Fisica Corso di laurea triennale in FISICA Anno accademico 2013/14 Figure utili da libri di testo Onde & Oscillazioni Corso A Studenti con il cognome che
Università degli Studi di Milano Dipartimento di Fisica Corso di laurea triennale in FISICA Anno accademico 2013/14 Figure utili da libri di testo Onde & Oscillazioni Corso A Studenti con il cognome che
CARATTERISTICHE DELLE STELLE
 CARATTERISTICHE DELLE STELLE Lezioni d'autore di Claudio Censori VIDEO Introduzione I parametri stellari più importanti sono: la le la la luminosità, dimensioni, temperatura e massa. Una stella è inoltre
CARATTERISTICHE DELLE STELLE Lezioni d'autore di Claudio Censori VIDEO Introduzione I parametri stellari più importanti sono: la le la la luminosità, dimensioni, temperatura e massa. Una stella è inoltre
Ottica Geometrica. Si dividono solitamente in
 aberrazioni Ottica Geometrica Le aberrazioni ottiche sono delle deformazioni o imprecisioni nella formazione delle immagini, dovute alla geometria delle lenti ed al comportamento della luce. Si dividono
aberrazioni Ottica Geometrica Le aberrazioni ottiche sono delle deformazioni o imprecisioni nella formazione delle immagini, dovute alla geometria delle lenti ed al comportamento della luce. Si dividono
Spettroscopia. Spettroscopia
 Spettroscopia Spettroscopia IR Spettroscopia NMR Spettrometria di massa 1 Spettroscopia E un insieme di tecniche che permettono di ottenere informazioni sulla struttura di una molecola attraverso l interazione
Spettroscopia Spettroscopia IR Spettroscopia NMR Spettrometria di massa 1 Spettroscopia E un insieme di tecniche che permettono di ottenere informazioni sulla struttura di una molecola attraverso l interazione
INTERFERENZA - DIFFRAZIONE
 INTERFERENZA - F. Due onde luminose in aria, di lunghezza d onda = 600 nm, sono inizialmente in fase. Si muovono poi attraverso degli strati di plastica trasparente di lunghezza L = 4 m, ma indice di rifrazione
INTERFERENZA - F. Due onde luminose in aria, di lunghezza d onda = 600 nm, sono inizialmente in fase. Si muovono poi attraverso degli strati di plastica trasparente di lunghezza L = 4 m, ma indice di rifrazione
Riassunto lezione 14
 Riassunto lezione 14 Onde meccaniche perturbazioni che si propagano in un mezzo Trasversali Longitudinali Interferenza (principio di sovrapposizione) Onde elettromagnetiche (si propagano anche nel vuoto)
Riassunto lezione 14 Onde meccaniche perturbazioni che si propagano in un mezzo Trasversali Longitudinali Interferenza (principio di sovrapposizione) Onde elettromagnetiche (si propagano anche nel vuoto)
I esonero di Ottica Geometria a.a compito A
 I esonero di Ottica Geometria a.a. 2016-17 compito A Un onda elettromagnetica piana con frequenza 5x10 12 Hz entra con incidenza normale in un mezzo spesso 10 Km. Sapendo che la luce impiega un tempo t=50
I esonero di Ottica Geometria a.a. 2016-17 compito A Un onda elettromagnetica piana con frequenza 5x10 12 Hz entra con incidenza normale in un mezzo spesso 10 Km. Sapendo che la luce impiega un tempo t=50
Microscopia (specchi, lenti, ecc.) Principio generale per cui si creano le immagini nel nostro occhio:
 Microscopia (specchi, lenti, ecc.) Principio generale per cui si creano le immagini nel nostro occhio: Specchi piani O e un oggetto (= sorgente di luce), nel caso piu semplice e puntiforme Immagine virtuale
Microscopia (specchi, lenti, ecc.) Principio generale per cui si creano le immagini nel nostro occhio: Specchi piani O e un oggetto (= sorgente di luce), nel caso piu semplice e puntiforme Immagine virtuale
Bande elettromagnetiche, brillanza superficiale, intensità specifica
 Corso di introduzione all'astrofisica secondo modulo Programma svolto A.A. 2010-2011 Astronomia ad occhio nudo Il funzionamento dell'occhio umano Il meccanismo della visione Sensibilità spettrale 1. Potere
Corso di introduzione all'astrofisica secondo modulo Programma svolto A.A. 2010-2011 Astronomia ad occhio nudo Il funzionamento dell'occhio umano Il meccanismo della visione Sensibilità spettrale 1. Potere
Lezione 3. Ottiche adattive
 Lezione 3 Ottiche adattive Definizione delle bande elettromagnetiche Visibile Definizione di bande nel visibile e nell'infrarosso Infrarosso Definizione di bande nel visibile e nell'infrarosso Microonde
Lezione 3 Ottiche adattive Definizione delle bande elettromagnetiche Visibile Definizione di bande nel visibile e nell'infrarosso Infrarosso Definizione di bande nel visibile e nell'infrarosso Microonde
LARGE BINOCULAR TELESCOPE
 LARGE BINOCULAR TELESCOPE LBT: LARGE BINOCULAR TELESCOPE LBT, con i due specchi da 8.4 metri di diametro su un unica montatura meccanica, è il più grande telescopio esistente. La sua configurazione binoculare
LARGE BINOCULAR TELESCOPE LBT: LARGE BINOCULAR TELESCOPE LBT, con i due specchi da 8.4 metri di diametro su un unica montatura meccanica, è il più grande telescopio esistente. La sua configurazione binoculare
Laboratorio di Ottica, Spettroscopia, Astrofisica
 Università degli Studi di Palermo Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea in Fisica Progetto Lauree Scientifiche Laboratorio di Ottica, Spettroscopia, Astrofisica Antonio Maggio
Università degli Studi di Palermo Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea in Fisica Progetto Lauree Scientifiche Laboratorio di Ottica, Spettroscopia, Astrofisica Antonio Maggio
I Esonero di Elementi di Ottica del 13/06/2011
 I Esonero di Elementi di Ottica del 13/06/2011 1) L onda elettromagnetica piana sinusoidale di frequenza f= 100 khz emessa da un sottomarino in superficie, si propaga orizzontalmente sia nell aria che
I Esonero di Elementi di Ottica del 13/06/2011 1) L onda elettromagnetica piana sinusoidale di frequenza f= 100 khz emessa da un sottomarino in superficie, si propaga orizzontalmente sia nell aria che
Ottica fisiologica, ovvero perché funzionano i Google Glass (parte 2)
 Ottica fisiologica, ovvero perché funzionano i Google Glass (parte 2) Corso di Principi e Modelli della Percezione Prof. Giuseppe Boccignone Dipartimento di Informatica Università di Milano boccignone@di.unimi.it
Ottica fisiologica, ovvero perché funzionano i Google Glass (parte 2) Corso di Principi e Modelli della Percezione Prof. Giuseppe Boccignone Dipartimento di Informatica Università di Milano boccignone@di.unimi.it
Telescopi. Il telescopio come concentratore della radiazione ricevuta per rivelare oggetti deboli Lenti e specchi Telescopi per raggi X e gamma
 Telescopi Il telescopio come concentratore della radiazione ricevuta per rivelare oggetti deboli Lenti e specchi Telescopi per raggi X e gamma LBT: 2 Telescopi con D=8,4 m (Monte Graham Arizona Lenti convergenti
Telescopi Il telescopio come concentratore della radiazione ricevuta per rivelare oggetti deboli Lenti e specchi Telescopi per raggi X e gamma LBT: 2 Telescopi con D=8,4 m (Monte Graham Arizona Lenti convergenti
La Luce ed i Telescopi. Lezione 4
 La Luce ed i Telescopi Lezione 4 Sommario La luce come radiazione elettromagnetica. Lo spettro elettromagnetico. Luminosità e flusso; la legge dell inverso del quadrato della distanza. I fotoni. La pressione
La Luce ed i Telescopi Lezione 4 Sommario La luce come radiazione elettromagnetica. Lo spettro elettromagnetico. Luminosità e flusso; la legge dell inverso del quadrato della distanza. I fotoni. La pressione
3B SCIENTIFIC PHYSICS
 3B SCIENTIFIC PHYSICS Set dimostrativo di ottiche per laser U17300 e set supplementare Istruzioni per l uso 1/05 ALF Sommario Pagina N. esp. Esperimento Kit da utilizzare 1 Introduzione 2 Fornitura 3 E1
3B SCIENTIFIC PHYSICS Set dimostrativo di ottiche per laser U17300 e set supplementare Istruzioni per l uso 1/05 ALF Sommario Pagina N. esp. Esperimento Kit da utilizzare 1 Introduzione 2 Fornitura 3 E1
Ottica fisica - Diffrazione
 Ottica fisica - Diffrazione 1. Diffrazione di Fraunhofer 2. Risoluzione di una lente 3. Reticoli di diffrazione IX - 0 Diffrazione Interferenza di un onda con se stessa, in presenza di aperture od ostacoli
Ottica fisica - Diffrazione 1. Diffrazione di Fraunhofer 2. Risoluzione di una lente 3. Reticoli di diffrazione IX - 0 Diffrazione Interferenza di un onda con se stessa, in presenza di aperture od ostacoli
OTTICA GEOMETRICA. Ovvero la retta perpendicolare alla superficie riflettente. Figura 1. Figura 2
 OTTICA GEOMETRICA L ottica geometrica si occupa di tutta quella branca della fisica che ha a che fare con lenti, specchi, vetri e cose simili. Viene chiamata geometrica in quanto non interessa la natura
OTTICA GEOMETRICA L ottica geometrica si occupa di tutta quella branca della fisica che ha a che fare con lenti, specchi, vetri e cose simili. Viene chiamata geometrica in quanto non interessa la natura
Università degli Studi di Milano. Dipartimento di Fisica Corso di laurea triennale in FISICA. Anno accademico 2013/14. Figure utili da libri di testo
 Università degli Studi di Milano Dipartimento di Fisica Corso di laurea triennale in FISICA Anno accademico 2013/14 Figure utili da libri di testo Onde & Oscillazioni Corso A Studenti con il cognome che
Università degli Studi di Milano Dipartimento di Fisica Corso di laurea triennale in FISICA Anno accademico 2013/14 Figure utili da libri di testo Onde & Oscillazioni Corso A Studenti con il cognome che
Bocchi Carlotta matr Borelli Serena matr Lezione del 5/05/2016 ora 8:30-10:30. Grandezze fotometriche ILLUMINOTECNICA
 Bocchi Carlotta matr. 262933 Borelli Serena matr. 263448 Lezione del 5/05/2016 ora 8:30-10:30 NOZIONI DI ILLUMINOTECNICA ILLUMINOTECNICA Che cos'è la luce e le cara7eris9che delle onde ele7romagne9che
Bocchi Carlotta matr. 262933 Borelli Serena matr. 263448 Lezione del 5/05/2016 ora 8:30-10:30 NOZIONI DI ILLUMINOTECNICA ILLUMINOTECNICA Che cos'è la luce e le cara7eris9che delle onde ele7romagne9che
Ottica geometrica. Spettro elettromagnetico
 Nome file d:\scuola\corsi\corso fisica\ottica\riflessione e rifrazione.doc Creato il 09/05/003 0.3 Dimensione file: 48640 byte Andrea Zucchini Elaborato il 8/05/003 alle ore.3, salvato il 8/05/03 0.3 stampato
Nome file d:\scuola\corsi\corso fisica\ottica\riflessione e rifrazione.doc Creato il 09/05/003 0.3 Dimensione file: 48640 byte Andrea Zucchini Elaborato il 8/05/003 alle ore.3, salvato il 8/05/03 0.3 stampato
Ottica fisica. Marcello Borromeo corso di Fisica per Farmacia - Anno Accademico
 Ottica fisica La natura ondulatoria della luce è stata evidenziata da Young ai primi dell 800 usando l interferenza e confutando l idea corpuscolare di Newton Le onde elettromagnetiche sono state previste
Ottica fisica La natura ondulatoria della luce è stata evidenziata da Young ai primi dell 800 usando l interferenza e confutando l idea corpuscolare di Newton Le onde elettromagnetiche sono state previste
Ottica Geometrica. (λà 0 trascuriamo i fenomeni di diffrazione )
 Ottica Geometrica Ottica Geometrica Metodo approssimato che permette di studiare il comportamento della luce quando incontra discontinuità nello spazio in cui si propaga, nei casi in cui la lunghezza d
Ottica Geometrica Ottica Geometrica Metodo approssimato che permette di studiare il comportamento della luce quando incontra discontinuità nello spazio in cui si propaga, nei casi in cui la lunghezza d
Quando lungo il percorso della luce vi sono fenditure ed ostacoli con dimensioni dello stesso ordine di grandezza della lunghezza d'onda incidente
 OTTICA FISICA Quando lungo il percorso della luce vi sono fenditure ed ostacoli con dimensioni dello stesso ordine di grandezza della lunghezza d'onda incidente gli effetti sperimentali non sono spiegabili
OTTICA FISICA Quando lungo il percorso della luce vi sono fenditure ed ostacoli con dimensioni dello stesso ordine di grandezza della lunghezza d'onda incidente gli effetti sperimentali non sono spiegabili
RIFLESSIONE TOTALE, DIOTTRO
 RIFLESSIONE TOTALE, DIOTTRO 11.1. In un parallelepipedo di quarzo (n q = 1.553) è scavato un cilindro di raggio R = 10 cm ripieno di acetone (n a = 1.358). Un fascio uniforme di luce di sezione LxL = 20x20
RIFLESSIONE TOTALE, DIOTTRO 11.1. In un parallelepipedo di quarzo (n q = 1.553) è scavato un cilindro di raggio R = 10 cm ripieno di acetone (n a = 1.358). Un fascio uniforme di luce di sezione LxL = 20x20
La Luce ed i Telescopi. Lezione 4
 La Luce ed i Telescopi Lezione 4 Sommario La luce come radiazione elettromagnetica. Lo spettro elettromagnetico. Luminosità e flusso; la legge dell inverso del quadrato della distanza. I fotoni. La pressione
La Luce ed i Telescopi Lezione 4 Sommario La luce come radiazione elettromagnetica. Lo spettro elettromagnetico. Luminosità e flusso; la legge dell inverso del quadrato della distanza. I fotoni. La pressione
Astronomia Lezione 17/10/2011
 Astronomia Lezione 17/10/2011 Docente: Alessandro Melchiorri e.mail:alessandro.melchiorri@roma1.infn.it Libri di testo: - An introduction to modern astrophysics B. W. Carroll, D. A. Ostlie, Addison Wesley
Astronomia Lezione 17/10/2011 Docente: Alessandro Melchiorri e.mail:alessandro.melchiorri@roma1.infn.it Libri di testo: - An introduction to modern astrophysics B. W. Carroll, D. A. Ostlie, Addison Wesley
Ottica geometrica. Propagazione per raggi luminosi (pennello di luce molto sottile)
 Ottica geometrica Propagazione per raggi luminosi (pennello di luce molto sottile) All interno di un mezzo omogeneo la propagazione e rettilinea: i raggi luminosi sono pertanto rappresentati da tratti
Ottica geometrica Propagazione per raggi luminosi (pennello di luce molto sottile) All interno di un mezzo omogeneo la propagazione e rettilinea: i raggi luminosi sono pertanto rappresentati da tratti
VISIONE_01 OTTICA GEOMETRICA. FGE aa
 VISIONE_01 OTTICA GEOMETRICA FGE aa.2015-16 OBIETTIVI Principi di refrazione delle lenti, indice di refrazione Lenti biconcave e lenti biconvesse, fuoco principale e distanza focale Potere refrattivo di
VISIONE_01 OTTICA GEOMETRICA FGE aa.2015-16 OBIETTIVI Principi di refrazione delle lenti, indice di refrazione Lenti biconcave e lenti biconvesse, fuoco principale e distanza focale Potere refrattivo di
a.a. 2005/2006 Laurea Specialistica in Fisica Corso di Fisica Medica 1 Ottica 28/2/2006
 a.a. 2005/2006 Laurea Specialistica in Fisica Corso di Fisica Medica 1 Ottica 28/2/2006 Leggi dell ottica 1. Il raggio incidente, il raggio riflesso e il raggio rifratto giacciono sullo stesso piano 2.
a.a. 2005/2006 Laurea Specialistica in Fisica Corso di Fisica Medica 1 Ottica 28/2/2006 Leggi dell ottica 1. Il raggio incidente, il raggio riflesso e il raggio rifratto giacciono sullo stesso piano 2.
M.PAOLILLO (E IL GRUPPO DI ASTROFISICA) ACQUISIZIONE ED ANALISI DI IMMAGINI ASTRONOMICHE CON IL TELESCOPIO DE RITIS
 M.PAOLILLO (E IL GRUPPO DI ASTROFISICA) ACQUISIZIONE ED ANALISI DI IMMAGINI ASTRONOMICHE CON IL TELESCOPIO DE RITIS PRINCIPI DI OTTICA: RIFRATTORE RITCHEY- CHRÉTIEN Il Planewave CDK 20 della Baader Planetarium
M.PAOLILLO (E IL GRUPPO DI ASTROFISICA) ACQUISIZIONE ED ANALISI DI IMMAGINI ASTRONOMICHE CON IL TELESCOPIO DE RITIS PRINCIPI DI OTTICA: RIFRATTORE RITCHEY- CHRÉTIEN Il Planewave CDK 20 della Baader Planetarium
LE LENTI E L OCCHIO UMANO Prof. Erasmo Modica erasmo@galois.it
 LE LENTI E L OCCHIO UMANO Prof. Erasmo Modica erasmo@galois.it LE LENTI E LE LORO PROPRIETÀ Una lente è uno strumento costituito da un mezzo trasparente delimitato da due superfici curve, oppure da una
LE LENTI E L OCCHIO UMANO Prof. Erasmo Modica erasmo@galois.it LE LENTI E LE LORO PROPRIETÀ Una lente è uno strumento costituito da un mezzo trasparente delimitato da due superfici curve, oppure da una
Lezione 2. Basi di ottica, telescopi, antenne
 Lezione 2 Basi di ottica, telescopi, antenne I telescopi in astronomia I telescopi sono sistemi che hanno lo scopo di raccogliere la radiazione celeste e convogliarla su un ricevitore opportuno. Si dividono
Lezione 2 Basi di ottica, telescopi, antenne I telescopi in astronomia I telescopi sono sistemi che hanno lo scopo di raccogliere la radiazione celeste e convogliarla su un ricevitore opportuno. Si dividono
Gruppo A (indicativamente dopo le prime 2-3 settimane di lezione
 Gruppo A (indicativamente dopo le prime 2-3 settimane di lezione 1) Un prisma retto di vetro con indice di rifrazione n=1.55. ha come base un triangolo retto isoscele, la cui ipotenusa misura 8 cm. Un
Gruppo A (indicativamente dopo le prime 2-3 settimane di lezione 1) Un prisma retto di vetro con indice di rifrazione n=1.55. ha come base un triangolo retto isoscele, la cui ipotenusa misura 8 cm. Un
3.6 - Strumenti ottici
 3.6 - Strumenti ottici Lente d'ingrandimento - E' il più semplice degli strumenti ottici. E' costituito da una lente convergente di fuoco f posta ad una istanza d
3.6 - Strumenti ottici Lente d'ingrandimento - E' il più semplice degli strumenti ottici. E' costituito da una lente convergente di fuoco f posta ad una istanza d
MISURA DI LUNGHEZZE D ONDA CON UNO SPETTROSCOPIO A RETICOLO DI DIFFRAZIONE
 MISURA DI LUNGHEZZE D ONDA CON UNO SPETTROSCOPIO A RETICOLO DI DIFFRAZIONE Il reticolo di diffrazione può essere utilizzato per determinare la lunghezza d onda di una radiazione monocromatica. Detto d
MISURA DI LUNGHEZZE D ONDA CON UNO SPETTROSCOPIO A RETICOLO DI DIFFRAZIONE Il reticolo di diffrazione può essere utilizzato per determinare la lunghezza d onda di una radiazione monocromatica. Detto d
L elemento fondamentale è l obiettivo, ovvero la lente o lo specchio che forniscono l immagine dell oggetto.
 Il telescopio, è lo strumento ottico impiegato in astronomia, per osservare e studiare gli oggetti celesti. È generalmente separato in due componenti principali: una parte ottica (costituita dal tubo delle
Il telescopio, è lo strumento ottico impiegato in astronomia, per osservare e studiare gli oggetti celesti. È generalmente separato in due componenti principali: una parte ottica (costituita dal tubo delle
Facoltà di Ingegneria Università di Parma. Antenne a Riflettore. A. Cucinotta 1
 Facoltà di Ingegneria Università di Parma Antenne a Riflettore A. Cucinotta 1 Antenne a Riflettore Le a. a bocca radiante sono a. che irradiano (o captano) potenza nello (dallo) spazio attraverso un apertura
Facoltà di Ingegneria Università di Parma Antenne a Riflettore A. Cucinotta 1 Antenne a Riflettore Le a. a bocca radiante sono a. che irradiano (o captano) potenza nello (dallo) spazio attraverso un apertura
M.PAOLILLO (E IL GRUPPO DI ASTROFISICA) MISURE ASTRONOMICHE CON IL TELESCOPIO DE RITIS
 M.PAOLILLO (E IL GRUPPO DI ASTROFISICA) MISURE ASTRONOMICHE CON IL TELESCOPIO DE RITIS PRINCIPI DI OTTICA: RIFRATTORE RITCHEY- CHRÉTIEN Il Planewave CDK 20 della Baader Planetarium è un telescopio rifrattore
M.PAOLILLO (E IL GRUPPO DI ASTROFISICA) MISURE ASTRONOMICHE CON IL TELESCOPIO DE RITIS PRINCIPI DI OTTICA: RIFRATTORE RITCHEY- CHRÉTIEN Il Planewave CDK 20 della Baader Planetarium è un telescopio rifrattore
Storia dell astronomia moderna, da Galileo al cielo virtuale. GIULIA IAFRATE Corso di Astronomia 2011 Associazione Astronomica Cortina
 Storia dell astronomia moderna, da Galileo al cielo virtuale GIULIA IAFRATE Corso di Astronomia 2011 Associazione Astronomica Cortina Tycho Brahe (1546-1601) * Più precise osservazioni a occhio nudo (1
Storia dell astronomia moderna, da Galileo al cielo virtuale GIULIA IAFRATE Corso di Astronomia 2011 Associazione Astronomica Cortina Tycho Brahe (1546-1601) * Più precise osservazioni a occhio nudo (1
Esercizi di Fisica LB - Ottica
 Esercizi di Fisica LB - Ottica Esercitazioni di Fisica LB per ingegneri - A.A. 2003-2004 Esercizio Un sistema ottico centrato è costituito (da sinistra a destra) da una lente sottile biconcava (l indice
Esercizi di Fisica LB - Ottica Esercitazioni di Fisica LB per ingegneri - A.A. 2003-2004 Esercizio Un sistema ottico centrato è costituito (da sinistra a destra) da una lente sottile biconcava (l indice
Telescopi. Telescopi
 o Schmidt (*) C SA + LC PF R SS Specchio Sferico (SS) concavo con raggio di curvatura R Stop di Apertura (SA), con Lastra Correttrice (LC) rifrattiva, posto sul centro di curvatura dello SS Piano Focale
o Schmidt (*) C SA + LC PF R SS Specchio Sferico (SS) concavo con raggio di curvatura R Stop di Apertura (SA), con Lastra Correttrice (LC) rifrattiva, posto sul centro di curvatura dello SS Piano Focale
OTTICA E LABORATORIO
 PROGRAMMA DI OTTICA E LABORATORIO Anno Scolastico 2014-2015 Classe IV P indirizzo OTTICO Prof. Giuseppe CORSINO Programma di OTTICA E LABORATORIO Anno Scolastico 2013-2014 Classe IV P indirizzo OTTICO
PROGRAMMA DI OTTICA E LABORATORIO Anno Scolastico 2014-2015 Classe IV P indirizzo OTTICO Prof. Giuseppe CORSINO Programma di OTTICA E LABORATORIO Anno Scolastico 2013-2014 Classe IV P indirizzo OTTICO
Gli esercizi di Astronomia a cura di ESA/ESO
 Gli esercizi di Astronomia a cura di ESA/ESO L astronomia è considerata generalmente una scienza visuale ed accessibile, che si rende ideale per scopi didattici. Nel corso degli ultimi anni, il telescopio
Gli esercizi di Astronomia a cura di ESA/ESO L astronomia è considerata generalmente una scienza visuale ed accessibile, che si rende ideale per scopi didattici. Nel corso degli ultimi anni, il telescopio
OTTICA ONDE INTERFERENZA DIFFRAZIONE RIFRAZIONE LENTI E OCCHIO
 OTTICA ONDE INTERFERENZA DIFFRAZIONE RIFRAZIONE LENTI E OCCHIO 1 INTERFERENZA Massimi di luminosità Onda incidente L onda prodotta alla fenditura S0, che funge da sorgente, genera due onde alle fenditure
OTTICA ONDE INTERFERENZA DIFFRAZIONE RIFRAZIONE LENTI E OCCHIO 1 INTERFERENZA Massimi di luminosità Onda incidente L onda prodotta alla fenditura S0, che funge da sorgente, genera due onde alle fenditure
IL MOTO di ROTAZIONE. CONSEGUENZE del MOTO di ROTAZIONE
 IL MOTO di ROTAZIONE moto di rotazione: il moto di rotazione è il movimento che la Terra compie attorno al proprio asse, da ovest verso est, in senso antiorario per un osservatore posto al polo nord celeste;
IL MOTO di ROTAZIONE moto di rotazione: il moto di rotazione è il movimento che la Terra compie attorno al proprio asse, da ovest verso est, in senso antiorario per un osservatore posto al polo nord celeste;
Universo invisibile: a caccia di Raggi X
 Universo invisibile: a caccia di Raggi X Anna Wolter INAF Osservatorio Astronomico di Brera Ringrazio Fabio Pizzolato per alcune immagini Astronomia X e l ITALIA Bruno Rossi con Marjorie Townsend e UHURU
Universo invisibile: a caccia di Raggi X Anna Wolter INAF Osservatorio Astronomico di Brera Ringrazio Fabio Pizzolato per alcune immagini Astronomia X e l ITALIA Bruno Rossi con Marjorie Townsend e UHURU
Introduzione alla Cosmologia Fisica Lezione 11
 Introduzione alla Cosmologia Fisica Lezione 11 La radioastronomia Giorgio G.C. Palumbo Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Astronomia Lo spettro elettromagnetico Osservare il cielo solo nella
Introduzione alla Cosmologia Fisica Lezione 11 La radioastronomia Giorgio G.C. Palumbo Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Astronomia Lo spettro elettromagnetico Osservare il cielo solo nella
SOLE, struttura e fenomeni
 SOLE, struttura e fenomeni Lezioni d'autore di Claudio Censori VIDEO Introduzione (I) Il Sole è la stella più vicina a noi, della quale possiamo pertanto ricavare in dettaglio informazioni dirette. Si
SOLE, struttura e fenomeni Lezioni d'autore di Claudio Censori VIDEO Introduzione (I) Il Sole è la stella più vicina a noi, della quale possiamo pertanto ricavare in dettaglio informazioni dirette. Si
13 ottobre Prof. Manlio Bellesi
 XV OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA MODENA 2015 13 ottobre 2014 Prof. Manlio Bellesi Fin dalle origini gli esseri umani hanno osservato il cielo. Cosmologie, miti, religioni, aspirazioni e sogni hanno
XV OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA MODENA 2015 13 ottobre 2014 Prof. Manlio Bellesi Fin dalle origini gli esseri umani hanno osservato il cielo. Cosmologie, miti, religioni, aspirazioni e sogni hanno
Laboratorio di Ottica, Spettroscopia, Astrofisica
 Università degli Studi di Palermo Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea in Fisica Progetto Lauree Scientifiche Laboratorio di Ottica, Spettroscopia, Astrofisica Antonio Maggio
Università degli Studi di Palermo Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea in Fisica Progetto Lauree Scientifiche Laboratorio di Ottica, Spettroscopia, Astrofisica Antonio Maggio
I rivelatori. Osservare il microcosmo. EEE- Cosmic Box proff.: M.Cottino, P.Porta
 I rivelatori Osservare il microcosmo Cose prima mai viste L occhio umano non riesce a distinguere oggetti con dimensioni inferiori a 0,1 mm (10-4 m). I primi microscopi vennero prodotti in Olanda alla
I rivelatori Osservare il microcosmo Cose prima mai viste L occhio umano non riesce a distinguere oggetti con dimensioni inferiori a 0,1 mm (10-4 m). I primi microscopi vennero prodotti in Olanda alla
1. La luce delle stelle
 1. La luce delle stelle 2. La scala delle magnitudini La luminosità delle stelle appare diversa a occhio nudo. Ipparco di Nicea creò, intorno al 120 a.c., una scala di luminosità che assegnava il valore
1. La luce delle stelle 2. La scala delle magnitudini La luminosità delle stelle appare diversa a occhio nudo. Ipparco di Nicea creò, intorno al 120 a.c., una scala di luminosità che assegnava il valore
Astronomia Osservazione del cielo
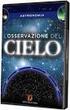 Corso facoltativo Astronomia Osservazione del cielo Christian Ferrari & Gianni Boffa Liceo di Locarno Parte O: Osservazione del cielo Osservazione semplici (occhio nudo, binocolo) Sviluppo degli strumenti
Corso facoltativo Astronomia Osservazione del cielo Christian Ferrari & Gianni Boffa Liceo di Locarno Parte O: Osservazione del cielo Osservazione semplici (occhio nudo, binocolo) Sviluppo degli strumenti
DEFINIZIONE DI RADIANZA La radiazione è caratterizzata tramite la Radianza Spettrale, I (λ, θ, φ, T), definita come la densità di potenza per unità di
 SISTEMI PASSIVI Ogni corpo a temperatura T diversa da 0 K irradia spontaneamente potenza elettromagnetica distribuita su tutto lo spettro Attraverso un elemento da della superficie del corpo, fluisce p
SISTEMI PASSIVI Ogni corpo a temperatura T diversa da 0 K irradia spontaneamente potenza elettromagnetica distribuita su tutto lo spettro Attraverso un elemento da della superficie del corpo, fluisce p
LE LENTI GRAVITAZIONALI. Luca Ciotti
 LE LENTI GRAVITAZIONALI Luca Ciotti 1. Introduzione storica Albert Einstein nella sua Teoria della Relatività Generale del 1915 fece una delle deduzioni che più avrebbero acceso l'immaginazione del grande
LE LENTI GRAVITAZIONALI Luca Ciotti 1. Introduzione storica Albert Einstein nella sua Teoria della Relatività Generale del 1915 fece una delle deduzioni che più avrebbero acceso l'immaginazione del grande
Lezione 6 Macchine digitali Lente di ingrandimento I telescopi Microscopi Aberrazioni delle lenti Laser e principi di funzionamento
 Dr. Andrea Malizia 1 Lezione 6 Macchine digitali Lente di ingrandimento I telescopi Microscopi Aberrazioni delle lenti Laser e principi di funzionamento Macchine digitali ed a pellicola 2 Macchine digitali
Dr. Andrea Malizia 1 Lezione 6 Macchine digitali Lente di ingrandimento I telescopi Microscopi Aberrazioni delle lenti Laser e principi di funzionamento Macchine digitali ed a pellicola 2 Macchine digitali
LA RIFRAZIONE E LA RIFLESSIONE DELLA LUCE. IV^C 2016/2017 Lepore Gianluca Ianniciello Antonio
 LA RIFRAZIONE E LA RIFLESSIONE DELLA LUCE IV^C 2016/2017 Lepore Gianluca Ianniciello Antonio INTRODUZIONE La riflessione e la rifrazione della luce si possono spiegare utilmente supponendo che la luce
LA RIFRAZIONE E LA RIFLESSIONE DELLA LUCE IV^C 2016/2017 Lepore Gianluca Ianniciello Antonio INTRODUZIONE La riflessione e la rifrazione della luce si possono spiegare utilmente supponendo che la luce
Illuminotecnica - Grandezze Fotometriche
 Massimo Garai - Università di Bologna Illuminotecnica - Grandezze Fotometriche Massimo Garai DIN - Università di Bologna http://acustica.ing.unibo.it Massimo Garai - Università di Bologna 1 Radiazione
Massimo Garai - Università di Bologna Illuminotecnica - Grandezze Fotometriche Massimo Garai DIN - Università di Bologna http://acustica.ing.unibo.it Massimo Garai - Università di Bologna 1 Radiazione
Capitolo 15. L interferenza e la natura ondulatoria della luce. Copyright 2009 Zanichelli editore
 Capitolo 15 L interferenza e la natura ondulatoria della luce 15.2 Il principio di sovrapposizione e l interferenza della luce Quando due onde luminose passano per uno stesso punto, i loro effetti si sommano
Capitolo 15 L interferenza e la natura ondulatoria della luce 15.2 Il principio di sovrapposizione e l interferenza della luce Quando due onde luminose passano per uno stesso punto, i loro effetti si sommano
Fisica II - CdL Chimica. Interferenza Coerenza Diffrazione Polarizzazione
 Interferenza Coerenza Diffrazione Polarizzazione Fenomeni interferenziali Interferenza: combinazione di onde identiche provenienti da diverse sorgenti che si sovrappongono in un punto dello spazio costruttiva
Interferenza Coerenza Diffrazione Polarizzazione Fenomeni interferenziali Interferenza: combinazione di onde identiche provenienti da diverse sorgenti che si sovrappongono in un punto dello spazio costruttiva
L energia assorbita dall atomo durante l urto iniziale è la stessa del fotone che sarebbe emesso nel passaggio inverso, e quindi vale: m
 QUESITI 1 Quesito Nell esperimento di Rutherford, una sottile lamina d oro fu bombardata con particelle alfa (positive) emesse da una sorgente radioattiva. Secondo il modello atomico di Thompson le particelle
QUESITI 1 Quesito Nell esperimento di Rutherford, una sottile lamina d oro fu bombardata con particelle alfa (positive) emesse da una sorgente radioattiva. Secondo il modello atomico di Thompson le particelle
Corso di Laurea in Informatica. Dipartimento di Scienze Fisiche -- Università di Napoli Federico II. Colori. Sistemi Informativi Multimediali
 Colori 1 La Percezione dei Colori Immanuel Kant (Königsberg,, 1724-1804) 1804) tratta il fenomeno (Phainomenon)) percepito secondo quello che appare e non nella sua reale essenza 2 Rappresentazione dei
Colori 1 La Percezione dei Colori Immanuel Kant (Königsberg,, 1724-1804) 1804) tratta il fenomeno (Phainomenon)) percepito secondo quello che appare e non nella sua reale essenza 2 Rappresentazione dei
I concetti fondamentali
 I concetti fondamentali La luce 1 Un raggio luminoso è un di luce molto, che rappresentiamo con una I raggi luminosi si propagano in 2 Leggi della riflessione. Prima legge: il raggio incidente, il raggio
I concetti fondamentali La luce 1 Un raggio luminoso è un di luce molto, che rappresentiamo con una I raggi luminosi si propagano in 2 Leggi della riflessione. Prima legge: il raggio incidente, il raggio
S P E T T R O S C O P I A. Dispense di Chimica Fisica per Biotecnologie Dr.ssa Rosa Terracciano
 S P E T T R O S C O P I A SPETTROSCOPIA I PARTE Cenni generali di spettroscopia: La radiazione elettromagnetica e i parametri che la caratterizzano Le regioni dello spettro elettromagnetico Interazioni
S P E T T R O S C O P I A SPETTROSCOPIA I PARTE Cenni generali di spettroscopia: La radiazione elettromagnetica e i parametri che la caratterizzano Le regioni dello spettro elettromagnetico Interazioni
5 Lenti e Specchi. Formazione immagini Specchi Superfici rifrangenti Lenti sottili Lenti spessi Punti cardinali
 Laboratorio di didattica della Fisica (III modulo): Metodologie di insegnamento del Laboratorio di Ottica Formazione immagini Specchi Superfici rifrangenti Lenti sottili Lenti spessi Punti cardinali 5
Laboratorio di didattica della Fisica (III modulo): Metodologie di insegnamento del Laboratorio di Ottica Formazione immagini Specchi Superfici rifrangenti Lenti sottili Lenti spessi Punti cardinali 5
Esercizi selezionati per l esame scritto del corso di Fotonica. Laser
 Esercizi selezionati per l esame scritto del corso di Fotonica Laser Si consideri un laser Nd-YAG con cavità ad anello (vedi figura). Il cristallo Nd-YAG ha lunghezza L = 2.5 cm e R A = R C = 100%. Supponendo
Esercizi selezionati per l esame scritto del corso di Fotonica Laser Si consideri un laser Nd-YAG con cavità ad anello (vedi figura). Il cristallo Nd-YAG ha lunghezza L = 2.5 cm e R A = R C = 100%. Supponendo
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali Corso di Laurea Specialistica in Fisica
 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali Corso di Laurea Specialistica in Fisica CURRICULUM ASTROFISICA E FISICA DELLO SPAZIO Anno Accademico 2011-2012 PROGRAMMA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali Corso di Laurea Specialistica in Fisica CURRICULUM ASTROFISICA E FISICA DELLO SPAZIO Anno Accademico 2011-2012 PROGRAMMA
Laboratorio di Ottica, Spettroscopia, Astrofisica
 Progetto Lauree Scientifiche Laboratorio di Ottica, Spettroscopia, Astrofisica Antonio Maggio INAF Osservatorio Astronomico di Palermo con la collaborazione di Salvo Massaro Perché un laboratorio di ottica
Progetto Lauree Scientifiche Laboratorio di Ottica, Spettroscopia, Astrofisica Antonio Maggio INAF Osservatorio Astronomico di Palermo con la collaborazione di Salvo Massaro Perché un laboratorio di ottica
L'Astrofisica va a scuola 16 Novembre 2004
 L'Astrofisica va a scuola 16 Novembre 2004 Concetti guida nella progettazione dei telescopi terrestri e telescopi passivi, attivi, adattavi Docente F. Cortecchia L Astrofisica va a scuola - Napoli - OAC
L'Astrofisica va a scuola 16 Novembre 2004 Concetti guida nella progettazione dei telescopi terrestri e telescopi passivi, attivi, adattavi Docente F. Cortecchia L Astrofisica va a scuola - Napoli - OAC
La luce Pagina 1 di 12. I raggi di luce
 La luce Pagina di I raggi di luce L ottica è quella parte della fisica che studia la propagazione della luce e la sua interazione con i corpi materiali. L esperienza comune ci consente di affermare che
La luce Pagina di I raggi di luce L ottica è quella parte della fisica che studia la propagazione della luce e la sua interazione con i corpi materiali. L esperienza comune ci consente di affermare che
L UNIVERSO L UNIVERSO È IMMENSO. CONTIENE TUTTE LE STELLE E TUTTI I PIANETI CHE ESISTONO (MOLTI SONO COSÌ LONTANI CHE NOI NON LI CONOSCIAMO).
 L UNIVERSO L UNIVERSO È IMMENSO. CONTIENE TUTTE LE STELLE E TUTTI I PIANETI CHE ESISTONO (MOLTI SONO COSÌ LONTANI CHE NOI NON LI CONOSCIAMO). LA SCIENZA CHE STUDIA I CORPI CELESTI (CIOE' LE STELLE E I
L UNIVERSO L UNIVERSO È IMMENSO. CONTIENE TUTTE LE STELLE E TUTTI I PIANETI CHE ESISTONO (MOLTI SONO COSÌ LONTANI CHE NOI NON LI CONOSCIAMO). LA SCIENZA CHE STUDIA I CORPI CELESTI (CIOE' LE STELLE E I
1 p. 1 q 1 R. altrimenti se il mezzo circostante ha un indice di rifrazione n 0. , al posto di n si deve usare
 2 Lenti Le lenti sono costituite da un mezzo rifrangente, di indice di rifrazione n, omogeneo, delimitato da superfici sferiche nel caso in cui il mezzo circostante é l aria: l equazione delle lenti é
2 Lenti Le lenti sono costituite da un mezzo rifrangente, di indice di rifrazione n, omogeneo, delimitato da superfici sferiche nel caso in cui il mezzo circostante é l aria: l equazione delle lenti é
