Università degli Studi di Roma la Sapienza Facoltà di Psicologia
|
|
|
- Silvano Salvatore
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Università degli Studi di Roma la Sapienza Facoltà di Psicologia Dottorato di Ricerca in Neuroscienze Cognitive XVII ciclo Coordinatore prof. Luigi Pizzamiglio La Morfologia Derivazionale: Aspetti Neuroanatomici, Cognitivi e Comportamentali Candidato Fabrizio Piras
2 INDICE INDICE CAPITOLO 1 LA MORFOLOGIA: ASPETTI LINGUISTICI E COGNITIVI 1. La morfologia p.6 2. La derivazione p Studi comportamentali e cognitivi sui processi di elaborazione morfologica p Evidenza sperimentale su soggetti normali p Evidenza sperimentale su soggetti cerebrolesi p.15 CAPITOLO 2 - ESPERIMENTO 1 CORRELATI NEUROANATOMICI DELLA MORFOLOGIA DERIVAZIONALE 1. Introduzione p Metodi e materiali p Soggetti p Stimoli p Compiti cognitivi p Sessioni p Procedure fmri p Elaborazione delle immagini ed analisi p Risultati p Risultati comportamentali p Risultati fmri p Discussione p Conclusioni p. 53 CAPITOLO 3 ESPERIMENTO 2 MORFOLOGIA DERIVAZIONALE E SELEZIONE DELLA RISPOSTA 1. Introduzione p Soggetti p Prove di morfologia derivazionale p Test neuropsicologici p Ragionamento logico-deduttivo p Funzioni esecutive p Attenzione p Selezione della risposta p Metodo p Risultati p Discussione p. 72
3 INDICE CAPITOLO 4 ESPERIMENTO 3 MORFOLOGIA DERIVAZIONALE E MECCANISMI ATTENTIVI 1. Introduzione p Metodo p Soggetti p Stimoli p Compiti p Risultati p Discussione p. 84 CAPITOLO 5 DISCUSSIONE GENERALE p. 87 BIBLIOGRAFIA p. 95 APPENDICE A p. 105 APPENDICE B p. 106 APPENDICE C p. 110 APPENDICE D p. 111
4 Ringraziamenti A Michela, alla mia famiglia Ringraziamenti Gli esperimenti presentati in questo lavoro sono stati realizzati presso l Unità di Diagnosi e Terapia Neuropsicologica ed il Laboratorio di Neuroimmagini Funzionali della Fondazione I.R.C.C.S. S. Lucia, Roma. Desidero quindi ringraziare il prof. Luigi Pizzamiglio che mi ha permesso di accedere a queste strutture, il prof. Gaspare Galati, la dott.ssa Giorgia Committeri e la dott.ssa Cristina Burani per il prezioso aiuto fornito durante la realizzazione del primo Esperimento, la dott.ssa Paola Marangolo, insegnante senza eguali, per la supervisione lungo il corso di dottorato, la dott.ssa Marianna Nasti, compagna di stanza e prossima dottoranda, per aver contribuito alla realizzazione ed alla raccolta dati degli Esperimenti 2 e 3, a tutti i soggetti sperimentali per la pazienza dimostrata. Un ringraziamento va anche a chi ha reso speciali questi tre anni di dottorato: a Nina Dronkers e tutto il Center for Aphasia and Related Disorders del VA Northern California Health Care System di Martinez per la calorosa accoglienza, a Grazia e Taryn, compagne di dottorato e di pranzi, agli amici Cioci, Marco, Laura, Carlao, Giffredi, Meie, Elena, Cristina, Sol ecc., a Milla e Unze, alla dott.ssa Chiara Scalesse, a N.S., a Domenico Crapa e consorte. Parte dei dati discussi in questo lavoro sono stati presentati in forma preliminare ai seguenti convegni: The Science of 4
5 Ringraziamenti Aphasia (2002, Acquaforte di Maratea), The Twenty-first European Workshop on Cognitive Neuropsychology, (2003, Bressanone), 9 th International Conference on Functional Mapping of the Human Brain, (2003, New York), Third International Workshop on Morphological Processing, (2003, Aix-en-Provence), First Congress of the European Neuropsychology Societies, (2004 Modena). 5
6 Capitolo1 La morfologia: aspetti linguistici e cognitivi CAPITOLO 1 LA MORFOLOGIA: ASPETTI LINGUISTICI E COGNITIVI 1. La morfologia La morfologia è il settore della linguistica che studia i principi che controllano la formazione interna delle parole. Esistono parole che non sono scomponibili in unità dotate di un significato autonomo (con, tu, no etc.) e parole in cui è invece possibile una scomposizione morfologica: nell aggettivo raro, ad esempio, rarveicola il significato di non comune, non frequente, difficile a trovarsi e o esprime il significato di maschile, singolare ; in correva, corr- esprime il concetto di andare, procedere velocemente ev- esprime il tempo imperfetto e a la terza persona singolare. Le unità minime dotate di significato vengono chiamate morfemi e l unione di questi morfemi forma parole morfologicamente complesse. In italiano esistono parole monomorfemiche (composte cioè da un solo morfema) come io (trascrivibile morfologicamente [# io #]), parole bimorfemiche (composte da due morfemi) come tazza ([# tazz + a #]) e parole plurimorfemiche (composte da tre o più morfemi) come invincibile ([# in + vinc + ibil + e #]). A secondo delle loro caratteristiche combinatorie, i morfemi si distinguono in morfemi liberi, che da soli sono in grado di veicolare un insieme di informazioni lessicali e grammaticali tali da poter formare una parola indipendente (come oggi) e morfemi legati che, per esprimere significati completi, non possono essere isolati ma devono unirsi ad una 6
7 Capitolo1 La morfologia: aspetti linguistici e cognitivi forma libera (la parola barista, ad esempio, è formata dal morfema libero bar- e da quello legato ista). Come schematicamente rappresentato nella Figura 1, fanno parte dei morfemi legati le basi legate i morfemi che veicolano unicamente il significato della parola, come mamm- nella parola mamma-, le forme contratte come c è- e gli affissi, cioè morfemi che vengono inseriti prima (detti prefissi, come ri- nel verbo rifare) o dopo l unità costitutiva della parola (detti suffissi, come -aggio nel sostantivo atterraggio), cambiandone il significato. Morfemi Liberi Morfemi Legati Basi Legate Forme Contratte Affissi Prefissi Suffissi Figura 1. I morfemi in base alle loro caratteristiche combinatorie A seconda che l informazione veicolata sia di natura lessicale o grammaticale, i morfemi di distinguono ulteriormente in morfemi lessicali e morfemi grammaticali. I primi costituiscono una classe aperta e produttiva, che può essere arricchita di nuove unità costituenti, mentre i secondi rappresentano una classe chiusa e prestabilita. I morfemi grammaticali a loro volta vengono distinti in morfemi flessivi e morfemi derivazionali (Figura 2). I morfemi flessivi sono morfemi grammaticali che svolgono una funzione prevalentemente sintattica ed esprimono, nel caso di 7
8 Capitolo1 La morfologia: aspetti linguistici e cognitivi aggettivi e sostantivi, i valori di genere e numero e, nel caso dei verbi, informazioni circa il tempo, il modo, la persona e il numero. Nella lingua italiana questo tipo di morfemi è posto alla fine della parola (bambin-o buon-o, maschile singolare). I morfemi derivazionali invece svolgono una funzione semantico-lessicale ed hanno un ruolo fondamentale nella formazione di parole morfologicamente complesse. Tale funzione si esplica facendo derivare un tipo di entrata lessicale da un altro: nel caso del verbo amare, per esempio, è possibile aggiungere all unità lessicale am- uno o più morfemi derivazionali per creare parole dal significato diverso alla parola base (am+abil+e per formare l aggettivo amabile e am+abil+mente per creare l avverbio amabilmente). Morfemi Lessicali Morfemi Grammaticali Morfemi Flessivi Morfemi Derivazionali Figura 2. I morfemi in base alla natura dell informazione veicolata Il fatto che l arricchimento lessicale di una lingua sia, in linea di principio, legato più all organizzazione morfologica delle parole che non alla creazione vera e propria di nuovi lessemi, può essere ascrivibile ad un principio di economia lessicale. Se, infatti, ogni qualvolta si rendesse necessario esprimere un nuovo concetto venisse creato un nuovo vocabolo, il lessico di una lingua 8
9 Capitolo1 La morfologia: aspetti linguistici e cognitivi diverrebbe enorme. Attraverso l organizzazione morfologica, invece, è sufficiente apprendere un numero relativamente misurato di radici ed affissi per poter creare un numero potenzialmente infinito di lessemi. 2. La derivazione Come già accennato in precedenza, una parola derivata è formata da una base cui viene aggiunto un affisso che può essere un suffisso (1) o un prefisso (2) Cont+abile contabile ri+fare rifare post+ale postale dis+abile disabile avvert+imento avvertimento pre+dire predire Il processo derivazionale può essere espresso attraverso regole di derivazione che constano di una parte formale (l aggiunta del prefisso o del suffisso) e una parte semantica (il cambiamento di significato avvenuto tramite l aggiunta del suddetto affisso). Nel caso del verbo rifare, ad esempio, la parte formale consta nell aggiunta alla base fare del prefisso ri- mentre la parte semantica si esplica nel passaggio al significato fare di nuovo. Le più importanti regole di derivazione sono le regole di suffissazione e le regole di prefissazione. Le regole di suffissazione hanno, di norma, la funzione di cambiare la categoria lessicale della base alla quale si applicano: gentile + ezza gentilezza atterrare + aggio atterraggio (aggettivo) (sostantivo) (verbo) (sostantivo) 9
10 Capitolo1 La morfologia: aspetti linguistici e cognitivi Tuttavia, esistono casi in cui, applicando un suffisso derivazionale ad una parola, la classe grammaticale della parola così formata, rimane la stessa. benzina + aio benzinaio bastone + ata bastonata (sostantivo) (sostantivo) (sostantivo) (sostantivo) Le regole di prefissazione non possono cambiare la categoria lessicale delle basi a cui si applicano ma sono in grado di cambiare la loro proprietà, come rendere transitivo un verbo intransitivo: ridere di Antonio deridere Antonio Le regole di derivazione si applicano una alla volta ed è possibile che la stessa regola possa venire applicata anche due volte. Quando il rapporto morfologico tra due parole è chiaramente riconoscibile, la parola morfologicamente complessa viene definita trasparente rispetto alla sua base. Tale trasparenza è tanto maggiore quanto più riconoscibili sono i costituenti che formano la parola complessa; ad esempio, il rapporto tra la parola derivata unzione e la sua base ungere è meno trasparente rispetto a quello esistente tra la parola derivata organizzazione e la sua base organizzare. 3.Studi comportamentali e cognitivi sui processi di elaborazione morfologica Negli ultimi due decenni sono stati condotti numerosi studi aventi lo scopo di indagare i processi cognitivi sottostanti l elaborazione dell informazione morfologica. Tali studi, oltre che diversificarsi per le metodologie applicate, possono essere in linea 10
11 Capitolo1 La morfologia: aspetti linguistici e cognitivi di principio distinti in base alla popolazione con cui sono stati condotti: da un lato sono stati raccolti diversi dati che indicano come la struttura morfologica delle parole venga utilizzata nei processi di riconoscimento, comprensione e produzione delle parole stesse da parte di soggetti adulti normali. Dall altro, è stata analizzata approfonditamente la prestazione di soggetti (casi singoli e studi di gruppo) cerebrolesi con disturbi di linguaggio acquisiti. 3.1 Evidenza sperimentale su soggetti normali Il tema fondamentale su cui si è focalizzata la ricerca psicolinguistica, è stato quello di stabilire come l organizzazione morfologica delle parole sia rappresentata a livello mentale. Il problema principale in questo tipo di ricerche è stato quello di distinguere l elaborazione degli aspetti morfologici delle parole da quella di altri aspetti linguistici: due parole che condividono la struttura morfologica, infatti, sono in genere simili dal punto di vista fonologico e ortografico e condividono alcuni tratti semantici. Nell interpretare i dati ottenuti sperimentalmente diventa quindi fondamentale capire se i fenomeni osservati siano ascrivibili a effetti puramente morfologici o se non siano piuttosto riferibili ad effetti di somiglianza di forma e di significato. Il paradigma sperimentale maggiormente utilizzato per indagare la rappresentazione mentale dell organizzazione morfologica delle parole è definito morphological repetition priming: in compiti di decisione lessicale (compiti cioè in cui il soggetto deve decidere il più rapidamente possibile se una determinata stringa di lettere che gli viene presentata visivamente è o non è una parola reale), 11
12 Capitolo1 La morfologia: aspetti linguistici e cognitivi una determinata parola (definita parola target) è preceduta, ad una distanza variabile, da un altra parola (definita prime) con cui condivide caratteristiche morfologiche. La parola target viene in genere riconosciuta più velocemente rispetto a quando è preceduta da una parola morfologicamente non collegata (ad esempio, la parola tagliare viene riconosciuta più velocemente quando è preceduta dalla parola taglia rispetto a quando è preceduta dalla parola penna). Tale facilitazione viene attribuita al fatto che, nel lessico mentale, le unità lessicali sono collegate da relazioni di natura morfologica (Fowler e coll, 1985; Feldman e Moskovljevic,1987; Drews e Zwitserlood,1995). Molti lavori condotti con tale metodologia hanno dimostrato come la facilitazione osservata sia prettamente di natura morfologica e non ascrivibile alla similarità ortografica e/o fonologica tra prime e target : ad esempio, Drews e Zwitserlood (1995, Esperimento 2) hanno trovato che soggetti di lingua tedesca rispondevano più velocemente a parole target come kers se queste erano precedute da primes correlati morfologicamente (kersen) piuttosto che da primes simili dal punto di vista ortografico (kerst). Risultati simili sono stati ottenuti da Feldman e Moskovljevic (1987) che hanno riportato una maggiore facilitazione in lingua serba quando le coppie prime-target erano composte da parole con una relazione morfologica (stancic-stan) rispetto a quando la relazione era di natura ortografica (stanicastan). Inoltre Fowler e coll (1985) hanno mostrato come la presentazione di un prime morfologicamente relato ad un target, faciliti il riconoscimento di quest ultimo sia quando le due parole 12
13 Capitolo1 La morfologia: aspetti linguistici e cognitivi hanno una pronuncia simile (healer-heal) sia quando sono pronunciate differentemente (health-heal). Tali risultati suggeriscono che gli effetti di facilitazione osservati sono riconducibili alla relazione morfologica tra prime e target piuttosto che alla loro somiglianza ortografico-fonologica, suggerendo quindi che la struttura morfologica delle parole è rappresentata a livello mentale in maniera distinta da informazioni riguardanti la forma. Come brevemente accennato in precedenza, parole che hanno in comune la struttura morfologica, condividono anche tratti di significato, quindi occorre stabilire se gli effetti di facilitazione morfologica osservati non siano interpretabili come effetti semantici. In linea generale, gli effetti facilitatori ottenuti grazie ad una relazione semantica tra gli stimoli differiscono da quelli ottenuti grazie ad una relazione morfologica per due aspetti fondamentali: la distanza tra prime e target (in termini di intervallo temporale o di numero di stimoli intervenienti) e la sensibilità dei suddetti effetti alla composizione della lista sperimentale. Per quanto riguarda la distanza tra gli items, la facilitazione morfologica sembra essere più robusta rispetto a quella semantica dal momento che risulta osservabile ad intervalli molto più lunghi di quelli che caratterizzano gli effetti dovuti ad una semplice associazione di significato. In un recente lavoro, ad esempio, Feldman (2000) ha trovato facilitazione di natura semantica e morfologica in un compito di decisione lessicale immediata (32 millisecondi di distanza tra prime e target) ma soltanto una facilitazione morfologica in un altro compito di 13
14 Capitolo1 La morfologia: aspetti linguistici e cognitivi decisione lessicale differita (300 millisecondi). In modo simile, Bentin e Feldman (1990) hanno proposto lo stesso tipo di compito variando però, oltre che il numero di items intervenienti tra prime e target (0 o 15), la natura della relazione tra gli items, essendo di natura prettamente semantica, morfologica o una combinazione tra le due. I risultati indicavano, per la relazione semantica, un forte effetto di facilitazione in assenza di stimoli intervenienti tra prime e target. Tale effetto, tuttavia, scompariva totalmente quando prime e target erano separati da 15 stimoli intervenienti. Nella condizione morfologica, invece, l effetto osservato in assenza di stimoli intervenienti era meno forte rispetto alla condizione semantica ma era presente anche quando prime e target erano separati da 15 stimoli. Il pattern di facilitazione per la condizione morfologico-semantica, infine, era, in assenza di stimoli intervenienti, simile a quello della condizione semantica e paragonabile a quello della condizione morfologica quando tra prime e target erano inseriti 15 stimoli. Un effetto positivo (sia con 0 che con 15 stimoli intervenienti) è stato anche trovato dagli autori quando prime e target erano composti da non parole che condividevano la stessa radice priva di significato ma avevano diversi affissi derivazionali reali (pirtaggio-pirtabile). Un altra variabile in grado di discriminare la facilitazione dovuta alla somiglianza morfologica tra gli items da quella dovuta alla somiglianza semantica è la composizione della lista sperimentale. É stato infatti dimostrato come, in compiti di priming semantico (cfr. Neely, 1991 per una review), gli effetti di facilitazione siano influenzabili dalla proporzione dei casi in cui, nella lista, coppie di 14
15 Capitolo1 La morfologia: aspetti linguistici e cognitivi parole sono legate tra di loro da un rapporto di significato (ad esempio tavolo sedia). In altre parole, la facilitazione semantica è sensibile alla densità di relazioni semantiche esistenti nella lista che viene utilizzata sperimentalmente: un alto numero di tali relazioni permette ai soggetti di sviluppare strategie anticipatorie grazie alle quali sono osservabili effetti facilitatori. Al contrario, gli effetti determinati da relazioni di natura morfologica tra prime e target si riscontrano anche in condizioni in cui la densità di tale relazione è assai bassa (anche con il 6% degli stimoli, come ha osservato Napps (1989)) e senza un sostanziale decremento dell entità dell effetto. Riassumendo, dai dati ottenuti in studi su soggetti normali, appare possibile affermare che l informazione morfologica è rappresentata a livello del lessico mentale in modo autonomo ed è governata da principi di organizzazione ed attivazione non riconducibili a quelli che governano la rappresentazione delle informazioni di natura ortografica e semantica. 3.2 Evidenza sperimentale su soggetti cerebrolesi Oltre ai dati provenienti dalle prestazioni di soggetti normali, ve ne sono altri che hanno avuto lo scopo di studiare il modo in cui l informazione morfologica è rappresentata a livello mentale partendo dall analisi degli errori di pazienti cerebrolesi in prove di produzione e comprensione di parole morfologicamente complesse. La logica che ha guidato questo tipo di lavori si basa sul concetto che, se nei processi normali di produzione e comprensione linguistica avviene un analisi dell informazione 15
16 Capitolo1 La morfologia: aspetti linguistici e cognitivi morfologica, si può supporre che esista un meccanismo mentale preposto a tale tipo di analisi. Un danno cerebrale può quindi compromettere la funzionalità di questo meccanismo e riflettersi nella prestazione del paziente. I dati provenienti dagli studi con pazienti cerebrolesi, svolti per spiegare il modo in cui le parole morfologicamente complesse sono rappresentate ed elaborate a livello mentale, hanno contribuito allo sviluppo di tre teorie: secondo la classe di teorie unitarie (Semenza, 1999), tutte le parole morfologicamente complesse sono singolarmente immagazzinate nel lessico mentale in forma intera, indipendentemente dalla loro somiglianza fonologica o semantica. Secondo un opposta visione invece, le singole unità che compongono le parole a livello morfologico sono rappresentate ed immagazzinate separatamente, in forma decomposta : Patterson (1980) ha descritto la prestazione in prove di lettura e decisione lessicale di due pazienti affetti da dislessia profonda che, oltre ad errori di natura semantica, tipici di questo tipo di patologia, commettevano errori derivazionali: i pazienti, infatti, commettevano più errori con parole suffissate (hardest) rispetto a parole semplici (hard) e la maggior parte degli errori (sostituzioni ed omissioni) riguardava proprio gli affissi. Questo dato era evidente anche nelle prove di decisione lessicale in cui i pazienti commettevano meno errori con parole e non parole non suffissate, risultati, questi, che hanno permesso agli autori di stabilire l esistenza di una rappresentazione distinta per radici ed affissi. 16
17 Capitolo1 La morfologia: aspetti linguistici e cognitivi Il paziente F.S. descritto da Miceli e Caramazza (1988), presentava una difficoltà selettiva ad elaborare morfemi flessivi in presenza di una conservata capacità ad elaborare quelli lessicali (le radici delle parole). Il paziente infatti commetteva errori di natura morfologica in prove di eloquio spontaneo e di ripetizione ed il 97% di tali errori erano di natura flessiva. Tali errori non erano ascrivibili ad un disturbo fonologico dal momento che nella maggior parte delle sostituzioni prevaleva la forma di citazione (il maschile singolare per gli aggettivi e l infinito o il participio passato per i verbi). Badecker, Hillis e Caramazza (1990) hanno studiato un paziente disgrafico, D.H., la cui prestazione in compiti di scrittura sotto dettato e di spelling orale era influenzata dalla lunghezza degli stimoli (il paziente commetteva più errori con gli stimoli lunghi rispetto a quelli corti). Gli autori hanno sfruttato questa caratteristica per verificare se la composizione morfologica delle parole avesse un influenza sulla prestazione del paziente. Partendo dall idea che le parole sono rappresentate in forma decomposta, gli autori hanno preparato una lista di stimoli composta da parole bimorfemiche e monomorfemiche di uguale lunghezza (ad esempio rough e tried). Secondo gli autori il paziente avrebbe dovuto commettere meno errori con le parole del primo tipo che sarebbero state elaborate in due unità distinte, ognuna delle quali sarebbe quindi risultata più corta rispetto a quelle del secondo tipo. Gli autori hanno infatti osservato che il paziente commetteva un minor numero di errori con gli stimoli bimorfemici rispetto a quelli monomorfemici. 17
18 Capitolo1 La morfologia: aspetti linguistici e cognitivi Tuttavia, recentemente, sta prendendo corpo una terza classe di teorie (dette a doppia via ) che rappresenta una mediazione tra le due appena descritte. Tali teorie hanno proposto l esistenza di due distinti processi di elaborazione dell informazione morfologica sia per quanto riguarda la distinzione tra morfologia flessiva regolare ed irregolare che per la distinzione tra morfologia flessiva e derivazionale. Sono stati infatti ipotizzati l immagazzinamento e l elaborazione in forma unitaria dei paradigmi flessivi irregolari ed in forma decomposta di quelli regolari. Tale distinzione nasce dalla descrizione di pazienti affetti da diverse patologie che presentavano deficit selettivi nell elaborazione di uno dei due paradigmi: pazienti affetti da morbo di Parkinson o da lesioni cerebrali frontali sinistre (Marslen-Wilsone Tyler 1997; Ulman e coll, 1997), mostrano generalmente difficoltà con le forme flesse regolari (walked), mentre pazienti con morbo di Alzheimer o con lesioni temporo-parietali, presentano deficit selettivi con le forme irregolari (bought). Tale doppia dissociazione è riscontrabile in diversi paradigmi sperimentali, quali compiti di produzione del participio passato, di lettura, di decisione lessicale e di priming morfologico. L elaborazione delle forme regolari ed irregolari è stata quindi considerata dipendente da due distinti sistemi di memoria: la memoria procedurale e quella dichiarativa. La memoria procedurale è un sistema di processi largamente impliciti, coinvolti nell apprendimento di nuove abilità motorie e cognitive e nel controllo di quelle già apprese. Il sistema è implicato nell apprendimento e nell applicazione di regole 18
19 Capitolo1 La morfologia: aspetti linguistici e cognitivi grammaticali e sintattiche quali quelle che regolano la combinazione tra radici ed affissi nella morfologia flessiva regolare (walk-ed) la cui elaborazione è stata quindi considerata dipendente da un processo ruled-based (Pinker, 1991; Ullman, 2001). La memoria dichiarativa, invece, è un sistema implicato in processi espliciti di immagazzinamento e rievocazione di informazioni episodiche (eventi) o semantiche (parole, simboli, conoscenze enciclopediche etc.). La memoria dichiarativa è stata associata alle forme morfologiche irregolari: dal momento che le trasformazioni irregolari sono per loro stessa natura arbitrarie, le forme irregolari (sing-sang) non possono essere composte tramite l applicazione di regole precedentemente apprese, ma devono essere immagazzinate direttamente nel lessico per poter essere rievocate. Miozzo (2003) ha descritto il caso di una paziente, AW, che presentava un danno consistente a livello lessicale ed un sistema semantico relativamente integro. In compiti di produzione orale, la paziente mostrava notevoli difficoltà di reperimento lessicale, mentre era in grado di accedere con successo alle informazioni semantiche delle parole che non riusciva a produrre. Alla paziente sono stati presentati verbi e sostantivi e le è stato chiesto di produrre il corrispondente participio passato o il corrispondente plurale. Dai risultati è emerso che la paziente non aveva nessuna difficoltà nella produzione di forme regolari (walk-walked, handhands) mentre commetteva numerosi errori con quelle irregolari (find-found, child-children). Questo dato è stato interpretato 19
20 Capitolo1 La morfologia: aspetti linguistici e cognitivi dall autore come prova del fatto che le forme irregolari sono immagazzinate nel lessico in forma unitaria e quindi possono essere elaborate con difficoltà nel caso di una grave compromissione a livello lessicale. Quelle regolari, al contrario, vengono elaborate attraverso un meccanismo rule-based. Per quanto riguarda la distinzione tra morfologia flessiva e derivazionale, è stato ipotizzato che le parole derivate e quelle flesse regolarmente, sono rispettivamente rappresentate nel lessico mentale in modo unitario ed in modo decomposto. Tyler e Cobb (1987) hanno presentato il caso di un paziente, D.E., il cui eloquio spontaneo era particolarmente povero di morfemi grammaticali e che manifestava un consistente disturbo nella comprensione degli aspetti sintattici della frase. Nel tentativo di capire se il disturbo fosse dovuto ad una specifica difficoltà ad elaborare i morfemi flessivi, il paziente è stato sottoposto ad un compito in cui doveva individuare una parola all interno di un contesto frasale. Le parole target erano precedute da parole test morfologicamente complesse, formate da un affisso derivazionale o flessivo che poteva essere appropriato rispetto al contesto, non appropriato o in combinazione non legale (se la parola target era cook, le possibilità potevano rispettivamente essere: the most wasteful cook il cuoco più sprecone-, the most wastage cook il cuoco più spreco-, the most wastely cook il cuoco più sprechevolmente-). I risultati mostravano come i tempi di reazione di D.E. fossero significativamente più brevi nella condizione in cui la parola derivata era appropriata, mentre nel caso di parole flesse questo vantaggio non era visibile. Gli autori hanno quindi 20
21 Capitolo1 La morfologia: aspetti linguistici e cognitivi ipotizzato che il paziente avesse un deficit selettivo nell analisi delle proprietà sintattiche dei morfemi flessivi mentre mostrava un inalterata capacità nell elaborazione delle proprietà semantiche di quelli derivazionali. Più recentemente il concetto di doppia via ha subito un evoluzione grazie alla quale si è arrivati a supporre che non tutte le parole derivate sono ugualmente soggette a decomposizione morfologica: alcune proprietà semantico-lessicali, infatti, determinano la probabilità che le parole vengano elaborate in forma unitaria o decomposta. Una di queste proprietà è la trasparenza semantica: ad esempio Marslen-Wilson e coll (1994) hanno osservato, in compiti di decisione lessicale, una facilitazione quando gli stimoli erano preceduti da primes semanticamente trasparenti rispetto al target (create-creation) ma non quando tale relazione era opaca (departdepartment). Questo dato ha portato gli autori a supporre che, in Inglese, solamente le parole derivate che sono trasparenti rispetto alla base vengono elaborate nel lessico in forma decomposta. Un altro fattore che può discriminare un elaborazione decomposta di parole morfologicamente complesse rispetto ad un elaborazione in forma unitaria è la frequenza d uso: sembra infatti (Burani e Thornton, 2003; Schreuder e Baayen, 1997) che parole a bassa frequenza d uso ma composte da una radice ed un affisso ad alta frequenza vengono elaborate in forma decomposta mentre parole composte da radice ed affisso a bassa frequenza vengono elaborate in forma unitaria. 21
22 Capitolo1 La morfologia: aspetti linguistici e cognitivi Tutti gli studi che hanno descritto deficit di natura morfologica, riportavano casi di pazienti afasici o che comunque presentavano lesioni cerebrali localizzate nell emisfero sinistro. Inoltre, la natura puramente linguistica dell elaborazione morfologica, ha portato a considerare tale emisfero come centrale in studi che si sono occupati di questo argomento. Tuttavia recentemente, Marangolo e coll. (2003) hanno, per la prima volta in letteratura, descritto il caso di due soggetti, M.S. e I.M., che, in presenza di una lesione cerebrale a carico dell emisfero destro ed in assenza di deficit di natura linguistica, presentavano un disturbo selettivo nella produzione di morfemi derivazionali ma non flessivi. Gli autori hanno proposto ai pazienti una prova di produzione di 288 parole morfologicamente relate in cui, presentato un verbo nella forma infinita (atterrare) i soggetti dovevano produrre il sostantivo derivato (atterraggio) e, dato un sostantivo derivato (liberazione), i soggetti dovevano produrre il corrispettivo verbo in forma infinita (liberare). I pazienti non commettevano errori nella produzione del verbo dal nome, mentre producevano rispettivamente il 59 e l 87% di errori nella condizione opposta. Tutti gli errori consistevano nella sostituzione del morfema derivazionale con un morfema verbale flessivo, solitamente il participio passato (dato il verbo liberare, i pazienti rispondevano liberato invece di liberazione). Per dimostrare che il deficit si manifestava esclusivamente nella produzione di un sostantivo derivato da un verbo, ai pazienti è stato richiesto di svolgere il medesimo compito con 84 aggettivi (gentile) e gli 84 corrispondenti sostantivi derivati (gentilezza). In 22
23 Capitolo1 La morfologia: aspetti linguistici e cognitivi queste due prove, il numero degli errori commessi dai due pazienti era inconsistente. Il disturbo selettivo per la produzione dei sostantivi derivati da verbi non era riconducibile ad una perdita di conoscenza riguardante i sostantivi derivati, dal momento che in una prova di decisione lessicale i pazienti commettevano un numero di risposte errate nella norma. La prestazione dei pazienti non era neppure interpretabile come un mero effetto di variabili semantico-lessicali, perché le differenze osservate tra le classi di stimoli in termini di frequenza d uso, lunghezza ed immaginabilità, seguivano un pattern inverso rispetto alla direzione della dissociazione. Nel tentativo di fornire una spiegazione a questo disturbo specifico ed alla presenza in entrambi i pazienti di lesioni temporoparietali a carico dell emisfero cerebrale destro, gli autori hanno proposto due possibili interpretazioni: una interpretazione linguistica del disturbo ed un interpretazione basata sull ipotesi di un coinvolgimento di meccanismi di selezione della risposta. Per quanto riguarda l ipotesi linguistica, gli autori hanno fatto riferimento alle diverse modalità di accesso lessicale che caratterizzano i due emisferi: diversi studi sul priming (Chiarello e Beaman, 1998; Coney e Evans, 2000; Chiarello, 1998) hanno suggerito che, durante la fase di riconoscimento di una parola, sebbene l attivazione del suo significato dominante sia competenza dell emisfero sinistro, l emisfero destro è in grado di attivare un ampio spettro di significati di più bassa frequenza d uso e relati alla parola in modo più periferico. Inoltre l emisfero destro sembra essere maggiormente coinvolto nell elaborazione di 23
24 Capitolo1 La morfologia: aspetti linguistici e cognitivi sostantivi caratterizzati da un alta immaginabilità (Chiarello e coll., 2002; Nittono e coll., 2002). La derivazione di un sostantivo da un verbo coinvolge la selezione di significati più periferici rispetto alle numerose alternative verbali possibili (come il participio passato) che hanno una frequenza più alta e sono semanticamente più vicine alla forma infinita. Al contrario, la generazione di un verbo dal corrispondente sostantivo derivato, coinvolge l attivazione dell unica unità lessicale possibile, ovvero la forma infinita del verbo. Anche nella condizione di derivazione di un sostantivo da un aggettivo (e viceversa), viene richiesta la selezione della risposta corretta tra un limitato set di alternative, tutte fortemente legate in termini di significato rispetto alla base (figura 3). Osservare Osservo Osserviamo Osservereste... Osservato Osservazione Osservatore Osservabile Gentile Gentili Gentilezza Gentilmente Figura3. Modello schematico di rappresentazione lessicale di verbi e aggettivi La presenza di un danno a carico dell emisfero destro nei pazienti descritti potrebbe quindi aver compromesso proprio la capacità di attivare unità lessicali che sono meno legate a livello semantico alla forma infinita del verbo, come il sostantivo derivato. 24
25 Capitolo1 La morfologia: aspetti linguistici e cognitivi Tuttavia, il disturbo osservato nei due pazienti, potrebbe non essere strettamente di natura linguistica, ma interpretato come un deficit a carico dei meccanismi di selezione della risposta. Molti studi recenti (Desmond, e coll., Gabrieli e Glover, 1998, Decary e Richer, 1995) hanno dimostrato come alcune strutture frontali cortico-sottocorticali di entrambi gli emisferi siano coinvolte in compiti di selezione della risposta. È stato inoltre dimostrato (Fletcher e coll, 1999, Kalaska e Crammond, 1995) come molte delle attività a carico delle aree frontali siano in realtà mediate da un circuito cerebrale che coinvolge le aree posteriori di entrambi gli emisferi. I meccanismi di selezione della risposta coinvolti nella produzione del sostantivo derivato dal verbo, potrebbero quindi richiedere l interazione tra aree anteriori e posteriori dei due emisferi. Gli autori hanno suggerito che solamente una lesione delle aree temporo-parietali destre darebbe luogo ad un deficit linguistico così selettivo, dal momento che lesioni a carico delle medesime aree dell emisfero sinistro produrrebbero un insieme di deficit linguistici e non linguistici che maschererebbero questo tipo di disturbo. L ipotesi sembrerebbe confermata dal dato che entrambi i pazienti fornivano prove patologiche in test come il Wisconsin Card Sorting Test ed il Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (B.A.D.S.), test che richiedono capacità di ragionamento, previsione e selezione della risposta. Riassumendo, è stato spiegato come molte delle parole utilizzate nella lingua Italiana sono scomponibili, dal punto di vista 25
26 Capitolo1 La morfologia: aspetti linguistici e cognitivi linguistico, in parti dotate di significato autonomo, i morfemi. La rappresentazione nel lessico mentale dell informazione morfologica possiede una propria autonomia ed è organizzata da principi che non possono essere ricondotti a quelli che governano la rappresentazione dell informazione fonologica, ortografica e semantica. Diversi tipi di relazioni morfologiche possono essere rappresentati ed elaborati in modo diverso. Una delle distinzioni fondamentali è quella tra la morfologia flessiva (che svolge un ruolo prevalentemente sintattico) e derivazionale (che ha invece una funzione semantico-lessicale). Mentre gran parte degli studi di neuroimaging ed in ambito afasiologico sembrano attribuire un ruolo dominante dell emisfero sinistro nell elaborazione della morfologia flessiva, quella derivazionale sembra, almeno in parte, richiedere anche il coinvolgimento dell emisfero destro. Tuttavia, rimangono diversi aspetti da chiarire: il reale ruolo dell emisfero destro nell elaborazione della morfologia derivazionale, la natura di questo coinvolgimento ed i meccanismi che entrano in gioco nell esecuzione di compiti di morfologia derivazionale. L obiettivo principale del presente lavoro sarà quello di indagare il ruolo dell emisfero destro nell elaborazione della morfologia derivazionale. A tale scopo verrà svolto un esperimento di risonanza magnetica funzionale con soggetti normali, in cui verranno paragonati compiti di morfologia derivazionale, morfologia flessiva e ripetizione utilizzando parole appartenenti a diverse classi grammaticali. Sarà inoltre selezionato un gruppo di pazienti con lesioni cerebrali unilaterali destre ai quali verranno 26
27 Capitolo1 La morfologia: aspetti linguistici e cognitivi proposte diverse prove di morfologia flessiva e derivazionale allo scopo di individuare altri casi che presentano il disturbo descritto da Marangolo e coll. (2003). I pazienti verranno infine sottoposti a numerosi test neuropsicologici per capire se il deficit di morfologia derivazionale è presente in associazione con disturbi di altra natura. 27
28 Capitolo 2 Esperimento 1 Correlati neuroanatomici della morfologia derivazionale CAPITOLO 2 ESPERIMENTO 1 CORRELATI NEUROANATOMICI DELLA MORFOLOGIA DERIVAZIONALE 1. Introduzione Recentemente molti studi si sono occupati di stabilire i correlati neuroanatomici di specifiche funzioni linguistiche. Per quanto riguarda le caratteristiche morfosintattiche delle parole, molti lavori si sono occupati prinicipalmente della morfologia flessiva. Ulmann e collaboratori (Ullman et al., 1997; Ullman, 2001) hanno proposto il modello dichiarativo/procedurale secondo il quale le forme flesse regolari (ad esempio walked) vengono elaborate attraverso la loro scomposizione nei singoli morfemi costituenti, tramite un circuito che attiva le regioni frontali, mentre quelle irregolari (ad esempio bought) vengono immagazzinate e richiamate in forma intera attraverso un circuito tempo-parietale. Studi svolti con pazienti cerebrolesi sembrano confermare il ruolo delle regioni frontali di sinistra ed in particolare del giro frontale inferiore (LIFG) nell elaborazione della morfologia flessiva (Novoa e Ardila, 1987; Miceli e coll.1989; Tyler, e coll., 2002, De Mornay-Davies e coll, 2002; Shapiro e Caramazza, 2003). Studi di neuroimaging, svolti con soggetti normali adulti, confermano questo dato (Laine e coll., 1999; Moro e coll, 2001; Shapiro e coll, 2001; Miceli e coll., 2002; Tyler e coll2004). Come accennato nel Capitolo 1, gli affissi flessivi svolgono una funzione sostanzialmente sintattica, mentre quelli derivazionali 28
29 Capitolo 2 Esperimento 1 Correlati neuroanatomici della morfologia derivazionale svolgono una funzione semantico-lessicale. In italiano, i suffissi flessivi dei sostantivi e degli aggettivi veicolano informazioni riguardo genere e numero, mentre i suffissi dei verbi specificano il tempo, il modo, la persona, il genere ed il numero. La morfologia derivazionale, invece, ha la funzione di creare, data una parola, distinte unità lessicali che possono differire dalla base per classe grammaticale ma alla quale sono comunque relate dal punto di vista semantico (ad esempio gentil-e aggettivo gentil-ezza sostantivo). Inoltre, i due meccanismi morfologici differiscono per il tipo di processo che porta all attivazione del corretto suffisso: per quanto riguarda l italiano, una parola viene regolarmente flessa secondo il paradigma flessivo proprio di quella parola e questo avviene grazie all attivazione dell unica variante flessiva propria della parola che si intende produrre. Al contrario, la produzione del corretto affisso derivazionale non dipende da una paradigma preesistente ma implica una selezione tra un alto numero di competitori plausibili. Ad esempio, i due sostantivi osservazione e osservatore sono corrette derivazioni del verbo osservare, mentre le parole osservamento ed osservista, sebbene rappresentino possibili alternative, non sono parole derivate esistenti (Figura 3). E quindi possibile ipotizzare che l elaborazione della morfologia flessiva e di quella derivazionale possano richiedere l attivazione di processi cognitivi diversi e quindi di aree cerebrali distinte. 29
30 Capitolo 2 Esperimento 1 Correlati neuroanatomici della morfologia derivazionale Fino ad ora, i lavori di neuroimaging presenti in letteratura che si sono occupati di capire quali fossero le aree cerebrali coinvolte nell elaborazione della morfologia derivazionale sono pochi. Osservare Osservo Osserviamo Osservereste... Osservato Osservazione Osservatore Osservabile Gentile Gentili Gentilezza Gentilmente Figura3. Modello schematico di rappresentazione lessicale di verbi e aggettivi Davis e coll (2004), hanno svolto uno studio fmri in cui hanno chiesto ai soggetti di leggere singole parole e di premere un tasto se la parola appena presentata era relata in termini di significato a quella immediatamente precedente. Gli stimoli erano divisi in quattro gruppi di parole che differivano per la loro complessità morfologica (parole semplici, parole monomorfemiche, parole derivate e parole flesse) e per la classe grammaticale (verbi, sostantivi e aggettivi). I risultati non hanno mostrato differenze di attivazione per le parole semplici e quelle complesse. Tuttavia, dal momento che tutte le parole complesse avevano una relazione semantica trasparente con la loro base, è possibile che l assenza di differenze nell attivazione sia stata dovuta alla natura del compito proposto: nel giudicare la presenza di una relazione 30
31 Capitolo 2 Esperimento 1 Correlati neuroanatomici della morfologia derivazionale semantica tra le parole presentate, infatti, i soggetti potrebbero aver preso in considerazione solamente le radici delle parole, ignorando la natura della loro complessità morfologica. In un recente lavoro di fmri, Vannest, e coll. (2003) hanno comparato la lettura di parole derivate con quella di parole flesse monomorfemiche, dimostrando un attivazione dell area di Broca e dei gangli della base non soltanto per le parole regolarmente flesse, ma anche per quelle parole derivate per cui è possibile ipotizzare un elaborazione di tipo decomposto, e cioè parole che contengono affiissi produttivi (-ness, -less, -able) e che sono trasparenti rispetto alla base da cui derivano sia dal punto di vista fonologico che da quello semantico (darkness, dark). Al contrario, le parole derivate che non vengono elaborate in modo decomposto e che non sono completamente trasparenti rispetto alla base (serenity) non mostravano un incremento di attività in quelle aree. Gli autori hanno concluso che l elaborazione morfologica delle parole del primo tipo si basi su un processo rulebased, mentre per le parole del secondo tipo è necessaria un elaborazione di tipo unitario. Questa interpretazione sembra essere congruente con gli studi sperimentali già citati nel Capitolo 1 che hanno dimostrato come, almeno nella fase di riconoscimento, non tutte le parole derivate vengono morfologicamente decomposte. Diverse caratteristiche di queste parole (la trasparenza fonologica e semantica rispetto alla base, la relazione tra frequenza della parola intera rispetto ai suoi costituenti) influenzano la probabilità che esse vengano elaborate in forma decomposta o unitaria (Burani e Caramazza, 1987; 31
32 Capitolo 2 Esperimento 1 Correlati neuroanatomici della morfologia derivazionale Marslen-Wilson e coll., 1994; Wurm, 1997; Bertram e coll., 2000; Burani e Thornton, 2003). Allo scopo di capire quali fossero le aree cerebrali coinvolte nell elaborazione della morfologia derivazionale, sono stati utilizzati tre compiti per ognuno dei quali sono stati utilizzati verbi, aggettivi e sostantivi: un compito di derivazione (compito sperimentale); un compito di morfologia flessiva scelto al fine di controllare l elaborazione morfologica coinvolta nel processo di derivazione; un compito di ripetizione scelto per controllare i processi di elaborazione uditiva, fonologica, e quelli semanticolessicali automaticamente generati dalla presentazione degli stimoli; Le parole derivate utilizzate fanno parte di quel tipo di parole che vengono prodotte utilizzando una strategia decomposizionale, essendo trasparenti rispetto alla base ed essendo caratterizzate da suffissi produttivi e frequenti. Considerando che le parole flesse scelte erano tutte trasparenti e regolari, lo scopo del lavoro è stato quello di stabilire se le aree attivate dai due processi morfologici fossero simili. È ipotizzabile che, oltre ad un coinvolgimento delle aree frontali di sinistra, responsabili anche dell elaborazione morfologica di parole regolarmente flesse, la produzione di parole derivate possa coinvolgere aree aggiuntive che tradizionalmente sono implicate nell elaborazione semantico-lessicale (cfr ad esempio Cappa e coll., 1998) e nei processi di selezione della risposta (cfr. il già citato lavoro di Marangolo e coll:, 2003). 32
33 Capitolo 2 Esperimento 1 Correlati neuroanatomici della morfologia derivazionale 2. Metodi e materiali 2.1. Soggetti Per questo studio sono stati selezionati dieci soggetti destrimani (Edinburgh Handedness Inventory, Oldfield, 1971) con età compresa tra i 21 ed i 29 anni, i quali hanno fornito il consenso informato per la partecipazione all esperimento Stimoli Gli stimoli sperimentali (riportati nell appendice A) consistevano in 90 parole suddivise nelle tre classi grammaticali di appartenenza: 30 verbi nella forma infinita, 30 aggettivi in forma singolare e 30 sostantivi derivati da verbi (tali verbi erano diversi rispetto a quelli utilizzati sperimentalmente). La frequenza media degli stimoli appartenenti alle tre classi grammaticali era la stessa (Istituto di Linguistica Computazionale, CNR di Pisa, 1988). I sostantivi derivati erano semanticamente trasparenti rispetto alla loro base (divertire-divertimento). Tutti gli stimoli sono stati letti da uno speaker professionista, registrati digitalmente, normalizzati per il volume e salvati in singoli files in formato audio Compiti cognitivi L esperimento è stato diviso in tre sessioni durante le quali i soggetti dovevano ascoltare le parole appartenenti alle tre classi grammaticali. Per ogni sessione si alternavano tre compiti diversi, durante i quali ai soggetti è stato chiesto di produrre una parola in risposta ad ogni stimolo udito. Nella sessione dei verbi, i soggetti 33
34 Capitolo 2 Esperimento 1 Correlati neuroanatomici della morfologia derivazionale dovevano produrre il sostantivo derivato corrispondente (compito di derivazione sostantivo-verbo, ad esempio osservareosservazione), oppure il participio passato corrispondente (compito flessivo verbo-verbo, ad esempio osservare-osservato) o infine ripetere il verbo udito (compito di ripetizione verbo-verbo, ad esempio osservare-osservare) (Tabella 1). Nella sessione degli aggettivi, i soggetti dovevano produrre il sostantivo derivato corrispondente (compito di derivazione aggettivo-sostantivo, ad esempio gentile-gentilezza), oppure il plurale dell aggettivo ascoltato (compito di flessione aggettivo-aggettivo, ad esempio gentile-gentili), oppure ripetere l aggettivo (compito di ripetizione aggettivo-aggettivo, ad esempio gentile-gentile). Nella sessione dei sostantivi derivati, infine, ai soggetti veniva chiesto di produrre il verbo da cui derivavano (compito di generazione sostantivoverbo, ad esempio fallimento-fallire), oppure produrre il plurale di tali sostantivi (compito flessivo sostantivo-sostantivo, ad esempio fallimento-fallimenti), oppure ripetere il sostantivo (compito di ripetizione sostantivo-sostantivo, fallimento-fallimento) (Tabella 1). E importante notare che la produzione del verbo dal sostantivo derivato non può essere considerata un vero e proprio compito di derivazione perché non prevede l aggiunta di un morfema derivazionale alla radice dello stimolo presentato, ma un ritorno alla forma base (la forma infinita del verbo). Sia i sostantivi derivati dai verbi che quelli derivati dagli aggettivi erano trasparenti in termini di significato rispetto alla loro base. In questo modo è stato assicurato che la relazione semantica tra 34
35 Capitolo 2 Esperimento 1 Correlati neuroanatomici della morfologia derivazionale stimolo e risposta fosse bilanciata tra i compiti flessivi e derivazionali. Tabella1. Sommario delle condizioni sperimentali Derivazione e Generazione Flessione Ripetizione Verbi Derivazione del sostantivo dal verbo: osservare --> osserv-azione Produzione del participio passato: osserv-are --> osserv-ato Ripetizione del verbo Aggettivi Derivazione del sostantivo dall aggettivo: gentil-e --> gentil-ezza Produzione dell aggettivo plurale: gentil-e --> gentil-i Ripetizione dell aggettivo Sostantivi Generazione del verbo dal sostantivo: fall-imento --> fall-ire Produzione del sostantivo plurale: falliment- o --> falliment--i Ripetizione del sostantivo 2.4 Sessioni Le sessioni avevano una durata di 6 minuti e rispettavano un ordine fisso: sostantivi derivati, aggettivi e verbi. In ogni sessione i tre compiti si alternavano in blocchi della durata di 15.5 secondi ciascuno secondo una sequenza randomizzata. Ogni blocco era preceduto da una fase di istruzione della durata di 3 secondi, durante la quale veniva presentata una scritta posta al centro dello schermo che indicava il tipo di compito da svolgere. Tale fase era poi seguita dalla presentazione uditiva di uno stimolo ogni 2.5 secondi. Sono stati presentati 6 blocchi di cinque stimoli 35
Parole di contenuto elementi appartenenti alle classi grammaticali maggiori
 DISTURBI DEL LIVELLO SINTATTICO- GRAMMATICALE Parole di contenuto elementi appartenenti alle classi grammaticali maggiori Parole funzione o funtori elementi grammaticali: - morfemi grammaticali liberi
DISTURBI DEL LIVELLO SINTATTICO- GRAMMATICALE Parole di contenuto elementi appartenenti alle classi grammaticali maggiori Parole funzione o funtori elementi grammaticali: - morfemi grammaticali liberi
Istituzioni di linguistica a.a Federica Da Milano
 Istituzioni di linguistica a.a.2014-2015 Federica Da Milano federica.damilano@unimib.it I processi di lettura, scrittura e calcolo nell età adulta La lettura: la capacità di leggere stringhe di lettere
Istituzioni di linguistica a.a.2014-2015 Federica Da Milano federica.damilano@unimib.it I processi di lettura, scrittura e calcolo nell età adulta La lettura: la capacità di leggere stringhe di lettere
Effetto della morfologia sull accuratezza in scrittura: uno studio in bambini normolettori e con dislessia
 Effetto della morfologia sull accuratezza in scrittura: uno studio in bambini normolettori e con dislessia Paola Angelelli*, +Chiara Valeria Marinelli e **Cristina Burani *Università del Salento; +Università
Effetto della morfologia sull accuratezza in scrittura: uno studio in bambini normolettori e con dislessia Paola Angelelli*, +Chiara Valeria Marinelli e **Cristina Burani *Università del Salento; +Università
I SISTEMI DI LETTURA E LE DISLESSIE
 I SISTEMI DI LETTURA E LE DISLESSIE L alessia senza agrafia -Disturbo di lettura senza altri disturbi concomitanti -I pazienti scrivono senza essere capaci di leggere quello che hanno scritto Interpretazione
I SISTEMI DI LETTURA E LE DISLESSIE L alessia senza agrafia -Disturbo di lettura senza altri disturbi concomitanti -I pazienti scrivono senza essere capaci di leggere quello che hanno scritto Interpretazione
Consistenza ortografico-semantica:
 Consistenza ortografico-semantica: EFFETTI DI TRASPARENZA SEMANTICA IN PAROLE MORFOLOGICAMENTE SEMPLICI? Marco Marelli, Simona Amenta, Davide Crepaldi Masked-priming in morfologia TARGET Condizione trasparente
Consistenza ortografico-semantica: EFFETTI DI TRASPARENZA SEMANTICA IN PAROLE MORFOLOGICAMENTE SEMPLICI? Marco Marelli, Simona Amenta, Davide Crepaldi Masked-priming in morfologia TARGET Condizione trasparente
Prerequisiti linguistici e scrittura
 Prerequisiti linguistici e scrittura Paola Viterbori Polo Bozzo Università di Genova Scrittura come attività complessa Codifica (Alfabetizzazione o Literacy) Attività linguistica di trasformazione del
Prerequisiti linguistici e scrittura Paola Viterbori Polo Bozzo Università di Genova Scrittura come attività complessa Codifica (Alfabetizzazione o Literacy) Attività linguistica di trasformazione del
Un Software per il potenziamento delle abilità di lettura e scrittura
 OTTOVOLANTE Un Software per il potenziamento delle abilità di lettura e scrittura *G. STELLA *G. CAIAZZO - *G. ZANZURINO * Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia San Marino 19/09/2008 Progetto
OTTOVOLANTE Un Software per il potenziamento delle abilità di lettura e scrittura *G. STELLA *G. CAIAZZO - *G. ZANZURINO * Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia San Marino 19/09/2008 Progetto
Cognitivismo e neuroscienze cognitive. Alberto Oliverio Università di Roma, Sapienza
 Cognitivismo e neuroscienze cognitive Alberto Oliverio Università di Roma, Sapienza L importanza dell azione. Il controllo motorio è in qualche modo il contrario di quanto si verifica nella percezione.
Cognitivismo e neuroscienze cognitive Alberto Oliverio Università di Roma, Sapienza L importanza dell azione. Il controllo motorio è in qualche modo il contrario di quanto si verifica nella percezione.
Il cervello: due emisferi, ciascuno suddiviso in quattro lobi: frontale, parietale, temporale e occipitale.
 LINGUAGGIO E CERVELLO Il cervello: due emisferi, ciascuno suddiviso in quattro lobi: frontale, parietale, temporale e occipitale. Unità cellulare fondamentale è il neurone. 12mld di neuroni, connessi in
LINGUAGGIO E CERVELLO Il cervello: due emisferi, ciascuno suddiviso in quattro lobi: frontale, parietale, temporale e occipitale. Unità cellulare fondamentale è il neurone. 12mld di neuroni, connessi in
ISTITUTO COMPRENSIVO LABORATORIO DI SCUOLA MEDIA E SUPERIORE N. SCARANO DI TRIVENTO DI ALFABETIZZAZIONE ALLA LINGUA LATINA CLASSI IIª A, IIª B, IIª C
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MEDIA E SUPERIORE N. SCARANO DI TRIVENTO LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE ALLA LINGUA LATINA CLASSI IIª A, IIª B, IIª C DOCENTE: Prof.ssa Maria Concetta Savino ANNO SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MEDIA E SUPERIORE N. SCARANO DI TRIVENTO LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE ALLA LINGUA LATINA CLASSI IIª A, IIª B, IIª C DOCENTE: Prof.ssa Maria Concetta Savino ANNO SCOLASTICO
Due cervelli per una mente
 28 Febbraio 2007 Corso di Laurea in Informatica Multimediale Facoltà di Scienze MMFFNN Università di Verona Due cervelli per una mente Chiara Della Libera DSNV Università di Verona Sezione di Fisiologia
28 Febbraio 2007 Corso di Laurea in Informatica Multimediale Facoltà di Scienze MMFFNN Università di Verona Due cervelli per una mente Chiara Della Libera DSNV Università di Verona Sezione di Fisiologia
TEORIE E TECNICHE DEI TEST. Modulo 1: I fondamenti e i test cognitivi
 Corso di Laurea Triennale Processi di Sviluppo Psicologico e Gestione delle Risorse Umane TEORIE E TECNICHE DEI TEST Modulo 1: I fondamenti e i test cognitivi Dott.ssa Silvana Bertoglio Lezione del 6/11/2003
Corso di Laurea Triennale Processi di Sviluppo Psicologico e Gestione delle Risorse Umane TEORIE E TECNICHE DEI TEST Modulo 1: I fondamenti e i test cognitivi Dott.ssa Silvana Bertoglio Lezione del 6/11/2003
Atkinson e Shiffrin cercarono di unificare le nuove conoscenze sulla memoria in un unico modello multimodale.
 LA MEMORIA Atkinson e Shiffrin cercarono di unificare le nuove conoscenze sulla memoria in un unico modello multimodale. Secondo questo modello l informazione sensoriale viene conservata per un breve periodo
LA MEMORIA Atkinson e Shiffrin cercarono di unificare le nuove conoscenze sulla memoria in un unico modello multimodale. Secondo questo modello l informazione sensoriale viene conservata per un breve periodo
COME FUNZIONA IL NOSTRO CERVELLO IL LINGUAGGIO
 Referente Dott.ssa Renza Rosiglioni Corso Re Umberto I, n.5 Ivrea (To) renzarosiglioni@libero.it Cellulare 347 9662237 a cura di RENZA ROSIGLIONI & LARA MASOERO COME FUNZIONA IL NOSTRO CERVELLO IL LINGUAGGIO
Referente Dott.ssa Renza Rosiglioni Corso Re Umberto I, n.5 Ivrea (To) renzarosiglioni@libero.it Cellulare 347 9662237 a cura di RENZA ROSIGLIONI & LARA MASOERO COME FUNZIONA IL NOSTRO CERVELLO IL LINGUAGGIO
Istituto Comprensivo di Pralboino Curricolo Verticale
 ITALIANO CLASSE 2 a PRIMARIA ASCOLTO E PARLATO -L allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando
ITALIANO CLASSE 2 a PRIMARIA ASCOLTO E PARLATO -L allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando
QUADRO DI RIFERIMENTO DI ITALIANO PROVE INVALSI 2009
 QUADRO DI RIFERIMENTO DI ITALIANO PROVE INVALSI 2009 RIFERIMENTI NORMATIVI INDICAZIONI NAZIONALI 2003 (OSA) L. n 53/2003 e D. Lgs 59/2004 INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICULO 2007 QUADRO DI RIFERIMENTO
QUADRO DI RIFERIMENTO DI ITALIANO PROVE INVALSI 2009 RIFERIMENTI NORMATIVI INDICAZIONI NAZIONALI 2003 (OSA) L. n 53/2003 e D. Lgs 59/2004 INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICULO 2007 QUADRO DI RIFERIMENTO
Descrizione delle operazioni di calcolo. Espressioni costanti semplici
 Descrizione delle operazioni di calcolo Come abbiamo detto l interprete è in grado di generare nuovi valori a partire da valori precedentemente acquisiti o generati. Il linguaggio di programmazione permette
Descrizione delle operazioni di calcolo Come abbiamo detto l interprete è in grado di generare nuovi valori a partire da valori precedentemente acquisiti o generati. Il linguaggio di programmazione permette
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO
 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO CLASSE PRIMA OBIETTIVI 1. PRODUZIONE E COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE: ASCOLTARE, COMPRENDERE, PARLARE 1.1 Ascoltare e comprendere semplici messaggi 1.2 Ascoltare
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO CLASSE PRIMA OBIETTIVI 1. PRODUZIONE E COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE: ASCOLTARE, COMPRENDERE, PARLARE 1.1 Ascoltare e comprendere semplici messaggi 1.2 Ascoltare
Modelli e Metodi per la Simulazione (MMS)
 Modelli e Metodi per la Simulazione (MMS) adacher@dia.uniroma3.it Programma La simulazione ad eventi discreti, è una metodologia fondamentale per la valutazione delle prestazioni di sistemi complessi (di
Modelli e Metodi per la Simulazione (MMS) adacher@dia.uniroma3.it Programma La simulazione ad eventi discreti, è una metodologia fondamentale per la valutazione delle prestazioni di sistemi complessi (di
IL B-ABACO ANALISI COGNITIVA DI UNO STRUMENTO FRA L ABACO E IL SUAN PAN CINESE. Barbara Bianchin* & Anna Baccaglini- Frank**
 IL B-ABACO ANALISI COGNITIVA DI UNO STRUMENTO FRA L ABACO E IL SUAN PAN CINESE Barbara Bianchin* & Anna Baccaglini- Frank** *Istituto Comprensivo Di Preganziol, Treviso; **Dipartimento di Educazione e
IL B-ABACO ANALISI COGNITIVA DI UNO STRUMENTO FRA L ABACO E IL SUAN PAN CINESE Barbara Bianchin* & Anna Baccaglini- Frank** *Istituto Comprensivo Di Preganziol, Treviso; **Dipartimento di Educazione e
Marco Piccinno Introduzione generale ai Disturbi specifici dell apprendimento e alla Dislessia
 Marco Piccinno Introduzione generale ai Disturbi specifici dell apprendimento e alla Dislessia Il Disturbi specifici dell apprendimento (DSA) rappresentano dei deficit che insistono a carico delle funzioni
Marco Piccinno Introduzione generale ai Disturbi specifici dell apprendimento e alla Dislessia Il Disturbi specifici dell apprendimento (DSA) rappresentano dei deficit che insistono a carico delle funzioni
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO
 ASCOLTARE E PARLARE Istituto Comprensivo Rignano Incisa PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO Classe V 1 Quadrimestre Obiettivi Attività Cogliere l argomento principale dei discorsi altrui; Prendere la parola
ASCOLTARE E PARLARE Istituto Comprensivo Rignano Incisa PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO Classe V 1 Quadrimestre Obiettivi Attività Cogliere l argomento principale dei discorsi altrui; Prendere la parola
Disturbi Specifici di Scrittura
 Disturbi Specifici di Scrittura e disturbi specifici della funzione motoria Il processo di scrittura Condivide con la lettura il nucleo essenziale del processo, Richiede un abilità grafica aggiuntiva Richiede
Disturbi Specifici di Scrittura e disturbi specifici della funzione motoria Il processo di scrittura Condivide con la lettura il nucleo essenziale del processo, Richiede un abilità grafica aggiuntiva Richiede
Il quadro di riferimento delle prove di italiano del Servizio Nazionale di Valutazione
 Mimma Siniscalco Il quadro di riferimento delle prove di italiano del Servizio Nazionale di Valutazione Palermo, 25 ottobre 2011 Senso Per chi costruisce la prova: permette di pianificare e guidare il
Mimma Siniscalco Il quadro di riferimento delle prove di italiano del Servizio Nazionale di Valutazione Palermo, 25 ottobre 2011 Senso Per chi costruisce la prova: permette di pianificare e guidare il
PROVE DI CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE LIVELLO A2 LIVELLO B1
 test informatizzato (durata 45 min) PROVE DI CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE 2 c-test 1 cloze test (esercizio di grammatica) 2 esercizi di lettura comprensione 1 esercizio di ascolto comprensione LIVELLO
test informatizzato (durata 45 min) PROVE DI CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE 2 c-test 1 cloze test (esercizio di grammatica) 2 esercizi di lettura comprensione 1 esercizio di ascolto comprensione LIVELLO
Dott.ssa Silvia Re Psicologa Psicoterapeuta SC NPI Cuneo-Mondovì
 Dott.ssa Silvia Re Psicologa Psicoterapeuta SC NPI Cuneo-Mondovì Molte persone hanno memoria buona per certe cose ma meno buona per altre. Un bambino piccolo ha una memoria visiva migliore di quella
Dott.ssa Silvia Re Psicologa Psicoterapeuta SC NPI Cuneo-Mondovì Molte persone hanno memoria buona per certe cose ma meno buona per altre. Un bambino piccolo ha una memoria visiva migliore di quella
Alla base della conoscenza di sé e degli altri la teoria della mente. a cura di laura Aleni Sestito
 Alla base della conoscenza di sé e degli altri la teoria della mente a cura di laura Aleni Sestito LA CONOSCENZA DI SE E DEGLI ALTRI Premack e Woodruff, 1978 TEORIA DELLA MENTE T O M, Theory of Mind ovvero
Alla base della conoscenza di sé e degli altri la teoria della mente a cura di laura Aleni Sestito LA CONOSCENZA DI SE E DEGLI ALTRI Premack e Woodruff, 1978 TEORIA DELLA MENTE T O M, Theory of Mind ovvero
Linguistica generale a.a Federica Da Milano.
 Linguistica generale a.a.2014-2015 Federica Da Milano federica.damilano@unimib.it Le afasie Sintomi che insorgono spesso in concomitanza con quelli afasici: Aprassia gestuale: incapacità o difficoltà di
Linguistica generale a.a.2014-2015 Federica Da Milano federica.damilano@unimib.it Le afasie Sintomi che insorgono spesso in concomitanza con quelli afasici: Aprassia gestuale: incapacità o difficoltà di
Riassumere significa ridurre la lunghezza di un testo mantenendone il senso globale.
 Riassumere Riassumere significa ridurre la lunghezza di un testo mantenendone il senso globale. Non esistono regole fisse per il riassunto, che può variare a seconda del tipo di testo da riassumere, dello
Riassumere Riassumere significa ridurre la lunghezza di un testo mantenendone il senso globale. Non esistono regole fisse per il riassunto, che può variare a seconda del tipo di testo da riassumere, dello
Le competenze metafonologiche: attività, giochi metalinguistici e fonologici per favorire il loro sviluppo. Relatrice: Maria Angela Berton
 Le competenze metafonologiche: attività, giochi metalinguistici e fonologici per favorire il loro sviluppo Relatrice: Maria Angela Berton IL LINGUAGGIO VERBALE E UNO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE COME SI
Le competenze metafonologiche: attività, giochi metalinguistici e fonologici per favorire il loro sviluppo Relatrice: Maria Angela Berton IL LINGUAGGIO VERBALE E UNO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE COME SI
PROVE DI CERTIFICAZIONE LINGUA TEDESCA LIVELLO A2
 PROVE DI CERTIFICAZIONE LINGUA TEDESCA TEST INFORMATIZZATO (durata 55 min) 5 cloze: 1 cloze lessico 1cloze preposizioni 1 cloze pronomi 1 cloze sostantivi 1 cloze verbi 1 c-test (grammatica) 2 esercizi
PROVE DI CERTIFICAZIONE LINGUA TEDESCA TEST INFORMATIZZATO (durata 55 min) 5 cloze: 1 cloze lessico 1cloze preposizioni 1 cloze pronomi 1 cloze sostantivi 1 cloze verbi 1 c-test (grammatica) 2 esercizi
dr.ssa Paola Cavalcaselle psicologa
 Screening delle capacità di lettoscrittura per la rilevazione precoce di alunni a rischio di difficoltà di apprendimento nelle prime due classi della scuola primaria dr.ssa Paola Cavalcaselle psicologa
Screening delle capacità di lettoscrittura per la rilevazione precoce di alunni a rischio di difficoltà di apprendimento nelle prime due classi della scuola primaria dr.ssa Paola Cavalcaselle psicologa
U. A. 1 ITALIANO settembre-ottobre-novembre
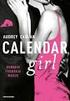 U. A. 1 ITALIANO settembre-ottobre-novembre ABILITÀ a. Ascoltare attivamente e comprendere vari tipi di testo. b. Intervenire appropriatamente ed esprimere attraverso il parlato pensieri e stati d animo.
U. A. 1 ITALIANO settembre-ottobre-novembre ABILITÀ a. Ascoltare attivamente e comprendere vari tipi di testo. b. Intervenire appropriatamente ed esprimere attraverso il parlato pensieri e stati d animo.
Funzioni distribuite: Funzioni localizzate: Emisfero non Emisfero dominante:
 FUNZIONI COGNITIVE Funzioni distribuite: Orientamento Attenzione Memoria Funzioni frontali Funzioni localizzate: Emisfero non Emisfero dominante: linguaggio dominante: Capacità visuo-costruttive Capacità
FUNZIONI COGNITIVE Funzioni distribuite: Orientamento Attenzione Memoria Funzioni frontali Funzioni localizzate: Emisfero non Emisfero dominante: linguaggio dominante: Capacità visuo-costruttive Capacità
Parlare ai bambini che imparano a parlare
 Parlare ai bambini che imparano a parlare Il ruolo dell ambiente linguistico nell acquisizione del linguaggio In che modo le caratteristiche di una data lingua influenzano il processo di acquisizione del
Parlare ai bambini che imparano a parlare Il ruolo dell ambiente linguistico nell acquisizione del linguaggio In che modo le caratteristiche di una data lingua influenzano il processo di acquisizione del
PROTOCOLLO DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE E MONITORAGGIO DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
 PROTOCOLLO DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE E MONITORAGGIO DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA DI SCREENING Istituto Comprensivo Statale Rita Levi-Montalcini SUISIO PREMESSA La legge 8 ottobre, n
PROTOCOLLO DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE E MONITORAGGIO DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA DI SCREENING Istituto Comprensivo Statale Rita Levi-Montalcini SUISIO PREMESSA La legge 8 ottobre, n
DISTURBI DELLA CONOSCENZA CORPOREA
 DISTURBI DELLA CONOSCENZA CORPOREA Dr.ssa Alessandra Girardi Dr.ssa Nicoletta Beschin Dipartimento di Neuroscienze Universita` di Edimburgo, Scozia Servizio di Neuropsicologia A.O. S.Antonio Abate, Gallarate
DISTURBI DELLA CONOSCENZA CORPOREA Dr.ssa Alessandra Girardi Dr.ssa Nicoletta Beschin Dipartimento di Neuroscienze Universita` di Edimburgo, Scozia Servizio di Neuropsicologia A.O. S.Antonio Abate, Gallarate
AppuntiBicoccaAppuntiBicoccaAppu ntibicoccaappuntibicoccaappuntibic occaappuntibicoccaappuntibicoccaa ppuntibicoccaappuntibicoccaappunt
 AppuntiBicoccaAppuntiBicoccaAppu ntibicoccaappuntibicoccaappuntibic occaappuntibicoccaappuntibicoccaa ppuntibicoccaappuntibicoccaappunt Struttura delle parole ibicoccaappuntibicoccaappuntibicoc Riassunto
AppuntiBicoccaAppuntiBicoccaAppu ntibicoccaappuntibicoccaappuntibic occaappuntibicoccaappuntibicoccaa ppuntibicoccaappuntibicoccaappunt Struttura delle parole ibicoccaappuntibicoccaappuntibicoc Riassunto
Appunti di psicologia
 Appunti di psicologia La memoria LA MEMORIA È un processo che si basa su tre meccanismi: l immagazzinamento,la ritenzione e il consolidamento delle conoscenze acquisite con l apprendimento Tali meccanismi
Appunti di psicologia La memoria LA MEMORIA È un processo che si basa su tre meccanismi: l immagazzinamento,la ritenzione e il consolidamento delle conoscenze acquisite con l apprendimento Tali meccanismi
Criteri per la definizione della parola grammaticale
 Criteri per la definizione della parola grammaticale Una parola grammaticale (morfo-sintattica, non fonologica) è definita in base alla co-occorrenza dei seguenti criteri: a) COESIONE: si definisce parola
Criteri per la definizione della parola grammaticale Una parola grammaticale (morfo-sintattica, non fonologica) è definita in base alla co-occorrenza dei seguenti criteri: a) COESIONE: si definisce parola
POTENZIAMENTO GRAMMATICA E LESSICO. Dott.ssa Renata Salvadorini IRCCS Stella Maris Calambrone - Pisa Con la partecipazione di:
 POTENZIAMENTO GRAMMATICA E LESSICO Dott.ssa Renata Salvadorini IRCCS Stella Maris Calambrone - Pisa Con la partecipazione di: LESSICO Il lessico o vocabolario è il complesso delle parole che appartengono
POTENZIAMENTO GRAMMATICA E LESSICO Dott.ssa Renata Salvadorini IRCCS Stella Maris Calambrone - Pisa Con la partecipazione di: LESSICO Il lessico o vocabolario è il complesso delle parole che appartengono
Intelligenza. Germano Rossi ISSR 2011/12
 Intelligenza Germano Rossi ISSR 2011/12 Intelligenza Il concetto di intelligenza è stato ed è uno dei più controversi della storia della In realtà è anche difficile definire l intelligenza perché dipende
Intelligenza Germano Rossi ISSR 2011/12 Intelligenza Il concetto di intelligenza è stato ed è uno dei più controversi della storia della In realtà è anche difficile definire l intelligenza perché dipende
Studio del caso di una alunna con ritardo cognitivo lieve. Scuola Secondaria di II grado
 Studio del caso di una alunna con ritardo cognitivo lieve Scuola Secondaria di II grado Laboratorio neo-immessi in ruolo 2015/2016 Daniele Leporatti Marini Caterina Anna Lisa giuntini Drogo Teresa Rosa
Studio del caso di una alunna con ritardo cognitivo lieve Scuola Secondaria di II grado Laboratorio neo-immessi in ruolo 2015/2016 Daniele Leporatti Marini Caterina Anna Lisa giuntini Drogo Teresa Rosa
informatica di base per le discipline umanistiche
 informatica di base per le discipline umanistiche vito pirrelli Istituto di Linguistica Computazionale CNR Pisa Dipartimento di linguistica Università di Pavia sesta lezione: la dinamica del testo vito
informatica di base per le discipline umanistiche vito pirrelli Istituto di Linguistica Computazionale CNR Pisa Dipartimento di linguistica Università di Pavia sesta lezione: la dinamica del testo vito
Il disordine fonologico: valutazione e trattamento - I e II livello
 Il disordine fonologico: valutazione e trattamento - I e II livello Roma 14 e 15 ottobre 2 e 3 dicembre 2017 Sede Hotel Il Cantico Via del Cottolengo 50 Docente: Vaquer Maria Luisa Patrizia Obiettivi:
Il disordine fonologico: valutazione e trattamento - I e II livello Roma 14 e 15 ottobre 2 e 3 dicembre 2017 Sede Hotel Il Cantico Via del Cottolengo 50 Docente: Vaquer Maria Luisa Patrizia Obiettivi:
SPM. TEST di ABILITA di SOLUZIONE dei PROBLEMI MATEMATICI
 SPM TEST di ABILITA di SOLUZIONE dei PROBLEMI MATEMATICI CAPACITA di RISOLVERE I PROBLEMI È una delle principali competenze del sistema cognitivo KATONA e WURTHEIMER (Gestaltisti) Una mente strategica
SPM TEST di ABILITA di SOLUZIONE dei PROBLEMI MATEMATICI CAPACITA di RISOLVERE I PROBLEMI È una delle principali competenze del sistema cognitivo KATONA e WURTHEIMER (Gestaltisti) Una mente strategica
DOCENTE : TIZIANA COMINOTTO ANNO SCOLASTICO 2012/ 2013
 ISIS VINCENZO MANZINI PIANO DI LAVORO ANNUALE CLASSE : 1 A LL DISCIPLINA : LATINO DOCENTE : TIZIANA COMINOTTO ANNO SCOLASTICO 2012/ 2013 Situazione della classe. La classe 1^ALL è formata da 22 allievi,
ISIS VINCENZO MANZINI PIANO DI LAVORO ANNUALE CLASSE : 1 A LL DISCIPLINA : LATINO DOCENTE : TIZIANA COMINOTTO ANNO SCOLASTICO 2012/ 2013 Situazione della classe. La classe 1^ALL è formata da 22 allievi,
Lo sviluppo linguistico nei primi anni di vita
 Università di Genova Polo M.T. Bozzo Lo sviluppo linguistico nei primi anni di vita Paola Viterbori Il ritardo di linguaggio il ritardo di linguaggio è un rallentamento nell acquisizione delle normali
Università di Genova Polo M.T. Bozzo Lo sviluppo linguistico nei primi anni di vita Paola Viterbori Il ritardo di linguaggio il ritardo di linguaggio è un rallentamento nell acquisizione delle normali
CURRICOLO DISCIPLINARE DI FRANCESE
 A.S. 2014/2015 MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto Comprensivo Palena-Torricella Peligna Scuola dell Infanzia, Primaria e Secondaria di 1 grado Palena (CH) SCUOLA SECONDARIA
A.S. 2014/2015 MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto Comprensivo Palena-Torricella Peligna Scuola dell Infanzia, Primaria e Secondaria di 1 grado Palena (CH) SCUOLA SECONDARIA
L attenzione dei bambini dipende dalla lingua usata dall adulto Hanna Marno
 L attenzione dei bambini dipende dalla lingua usata dall adulto In questo studio eravamo curiosi di capire se i bambini sono selettivi nel prestare attenzione a parlanti di lingue diverse nel proprio ambiente.
L attenzione dei bambini dipende dalla lingua usata dall adulto In questo studio eravamo curiosi di capire se i bambini sono selettivi nel prestare attenzione a parlanti di lingue diverse nel proprio ambiente.
PROGETTAZIONE DISCIPLINARE
 PROGETTAZIONE DISCIPLINARE ITALIANO classe 3^ PER ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE I Q. II Q. CONTENUTI /ATTIVITA 1a) Ascolto e comprensione di ciò che l insegnante e i compagni comunicano
PROGETTAZIONE DISCIPLINARE ITALIANO classe 3^ PER ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE I Q. II Q. CONTENUTI /ATTIVITA 1a) Ascolto e comprensione di ciò che l insegnante e i compagni comunicano
Fondamenti cognitivi dell attività cerebrale
 Fondamenti cognitivi dell attività cerebrale Come le neuroscienze studiano i meccanismi cognitivi Veronica Mazza Centro Interdipartimentale Mente e Cervello (CIMeC) Università di Trento Cosa sono le neuroscienze
Fondamenti cognitivi dell attività cerebrale Come le neuroscienze studiano i meccanismi cognitivi Veronica Mazza Centro Interdipartimentale Mente e Cervello (CIMeC) Università di Trento Cosa sono le neuroscienze
LA MEMORIA. è la funzione che ci permette di codificare, conservare nel tempo e recuperare le informazioni tratte dalla nostra esperienza quotidiana
 Non abbiamo una memoria, ma molte memorie (Baddeley, 1984) LA MEMORIA è la funzione che ci permette di codificare, conservare nel tempo e recuperare le informazioni tratte dalla nostra esperienza quotidiana
Non abbiamo una memoria, ma molte memorie (Baddeley, 1984) LA MEMORIA è la funzione che ci permette di codificare, conservare nel tempo e recuperare le informazioni tratte dalla nostra esperienza quotidiana
Grandezze fisiche e loro misura
 Grandezze fisiche e loro misura Cos è la fisica? e di che cosa si occupa? - Scienza sperimentale che studia i fenomeni naturali suscettibili di sperimentazione e caratterizzati da entità o grandezze misurabili.
Grandezze fisiche e loro misura Cos è la fisica? e di che cosa si occupa? - Scienza sperimentale che studia i fenomeni naturali suscettibili di sperimentazione e caratterizzati da entità o grandezze misurabili.
Scuola statale italiana di Madrid Anno scolastico 2016/17 LINGUA ITALIANA Classe 2C Insegnante: Cristina Contri. ABILITÀ Obiettivi di apprendimento
 Scuola statale italiana di Madrid Anno scolastico 2016/17 LINGUA ITALIANA Classe 2C Insegnante: Cristina Contri NUCLEI FONDANTI ASCOLTO E PARLATO COMPETENZE Ascoltare e comprendere messaggi in contesti
Scuola statale italiana di Madrid Anno scolastico 2016/17 LINGUA ITALIANA Classe 2C Insegnante: Cristina Contri NUCLEI FONDANTI ASCOLTO E PARLATO COMPETENZE Ascoltare e comprendere messaggi in contesti
informatica di base per le discipline umanistiche
 informatica di base per le discipline umanistiche vito pirrelli Istituto di Linguistica Computazionale CNR Pisa Dipartimento di linguistica Università di Pavia ottava lezione: la dinamica del testo vito
informatica di base per le discipline umanistiche vito pirrelli Istituto di Linguistica Computazionale CNR Pisa Dipartimento di linguistica Università di Pavia ottava lezione: la dinamica del testo vito
COME FUNZIONA IL NOSTRO CERVELLO la memoria
 Referente Dott.ssa Renza Rosiglioni Corso Re Umberto I, n.5 Ivrea (To) Cellulare 347 9662237 COME FUNZIONA IL NOSTRO CERVELLO la memoria a cura di RENZA ROSIGLIONI & LARA MASOERO Ivrea 15 Gennaio 2014
Referente Dott.ssa Renza Rosiglioni Corso Re Umberto I, n.5 Ivrea (To) Cellulare 347 9662237 COME FUNZIONA IL NOSTRO CERVELLO la memoria a cura di RENZA ROSIGLIONI & LARA MASOERO Ivrea 15 Gennaio 2014
LIVELLO A2 LIVELLO B1
 PROVE DI CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE Test informatizzato (durata 45 min): LIVELLO A2 2 cloze test (esercizi gap-fill di grammatica e lessico) livello A2 al fine di individuare i termini o la tipologia
PROVE DI CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE Test informatizzato (durata 45 min): LIVELLO A2 2 cloze test (esercizi gap-fill di grammatica e lessico) livello A2 al fine di individuare i termini o la tipologia
Seconda Lingua Comunitaria (Francese Spagnolo) Classe seconda secondaria
 CURRICOLO DISCIPLINARE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE Seconda Lingua Comunitaria (Francese Spagnolo) Classe seconda secondaria Traguardi per lo sviluppo delle competenze Conoscenze Obiettivi di apprendimento
CURRICOLO DISCIPLINARE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE Seconda Lingua Comunitaria (Francese Spagnolo) Classe seconda secondaria Traguardi per lo sviluppo delle competenze Conoscenze Obiettivi di apprendimento
LINGUA ITALIANA L.E.1 ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE. L.E.2 LEGGERE E COMPRENDERE TESTI DI VARIO TIPO.
 LINGUA ITALIANA L.E.1 ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE. 1a. Prestare attenzione e dimostrare di aver capito i discorsi dei coetanei e degli adulti. 1b. Saper ascoltare ciò che viene letto
LINGUA ITALIANA L.E.1 ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE. 1a. Prestare attenzione e dimostrare di aver capito i discorsi dei coetanei e degli adulti. 1b. Saper ascoltare ciò che viene letto
IL RUOLO DELLA TECNOLOGIA NEL PROGETTO DI ARCHITETTURA. Progettazione dei Sistemi Costruttivi
 IL RUOLO DELLA TECNOLOGIA NEL PROGETTO DI ARCHITETTURA Progettazione dei Sistemi Costruttivi 1 Cosa è la tecnologia? La Tecnologia è la disciplina del fare secondo una regola, etimologicamente rappresenta
IL RUOLO DELLA TECNOLOGIA NEL PROGETTO DI ARCHITETTURA Progettazione dei Sistemi Costruttivi 1 Cosa è la tecnologia? La Tecnologia è la disciplina del fare secondo una regola, etimologicamente rappresenta
Istituto Comprensivo
 CURRICOLO DELLA SECONDA LINGUA COMUNITARIA CLASSE I - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RICEZIONE ORALE (ASCOLTO) Comprendere frasi semplici, brevi registrazioni trattanti argomenti con significati molto
CURRICOLO DELLA SECONDA LINGUA COMUNITARIA CLASSE I - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RICEZIONE ORALE (ASCOLTO) Comprendere frasi semplici, brevi registrazioni trattanti argomenti con significati molto
Mason, Psicologia dell'apprendimento e dell'istruzione, Il Mulino, Capitolo VI.
 Capitolo VI. APPRENDERE STRATEGIE E ABILITÀ: METACOGNIZONE, COMPRENSIONE E PRODUZIONE DEL TESTO 1 Evoluzione per: esperienze sviluppo delle abilità meta cognitive. 2 Cosa è la metacognizione? E la metacomprensione?
Capitolo VI. APPRENDERE STRATEGIE E ABILITÀ: METACOGNIZONE, COMPRENSIONE E PRODUZIONE DEL TESTO 1 Evoluzione per: esperienze sviluppo delle abilità meta cognitive. 2 Cosa è la metacognizione? E la metacomprensione?
LABORATORIO Corso di Pedagogia speciale Prof.ssa Zappaterra IV anno GRUPPO 1 23 settembre :00/19:00 Dr.ssa Lucia Donata Nepi
 Scuola di Studi Umanistici e della Formazione CdS in Scienze della Formazione Primaria! LABORATORIO Corso di Pedagogia speciale Prof.ssa Zappaterra IV anno GRUPPO 1 23 settembre 2015 16:00/19:00 Dr.ssa
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione CdS in Scienze della Formazione Primaria! LABORATORIO Corso di Pedagogia speciale Prof.ssa Zappaterra IV anno GRUPPO 1 23 settembre 2015 16:00/19:00 Dr.ssa
Classe Prima Scuola Secondaria di Primo Grado
 FRANCESE Classe Prima Scuola Secondaria di Primo Grado NUCLEI TEMATICI CONOSCENZE ABILITA Ascolto Suoni, ritmo ed intonazione della Ascoltare e capire lingua globalmente brevi (Ricezione orale) conversazioni
FRANCESE Classe Prima Scuola Secondaria di Primo Grado NUCLEI TEMATICI CONOSCENZE ABILITA Ascolto Suoni, ritmo ed intonazione della Ascoltare e capire lingua globalmente brevi (Ricezione orale) conversazioni
PROGRAMMA PREVENTIVO
 Settore Servizi Scolastici e Educativi PAGINA: 1 PROGRAMMA PREVENTIVO A.S. 2015/16 SCUOLA LICEO LINGUISTICO A. MANZONI DOCENTE: C. FRESCURA MATERIA: MATEMATICA Classe 5 Sezione B FINALITÀ DELLA DISCIPLINA
Settore Servizi Scolastici e Educativi PAGINA: 1 PROGRAMMA PREVENTIVO A.S. 2015/16 SCUOLA LICEO LINGUISTICO A. MANZONI DOCENTE: C. FRESCURA MATERIA: MATEMATICA Classe 5 Sezione B FINALITÀ DELLA DISCIPLINA
PROF. Silvia Tiribelli MATERIA: GEOGRAFIA CLASSE: II D
 PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DOCENTE ANNO SCOLASTICO 2013-14 PROF. Silvia Tiribelli MATERIA: GEOGRAFIA CLASSE: II D DATA DI PRESENTAZIONE: 30/11/2013 FINALITÀ E OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA La geografia
PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DOCENTE ANNO SCOLASTICO 2013-14 PROF. Silvia Tiribelli MATERIA: GEOGRAFIA CLASSE: II D DATA DI PRESENTAZIONE: 30/11/2013 FINALITÀ E OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA La geografia
Unità didattica n 1: Conoscenze e abilità implicate dagli obiettivi annuali
 Unità didattica n 1: Obiettivi annuali 1. Osservare, descrivere, confrontare, correlare elementi della realtà circostante : distinguere piante e parti di esse cogliendone somiglianze e differenze 2. Riconoscere
Unità didattica n 1: Obiettivi annuali 1. Osservare, descrivere, confrontare, correlare elementi della realtà circostante : distinguere piante e parti di esse cogliendone somiglianze e differenze 2. Riconoscere
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico Indirizzo: Grafica e comunicazione
 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca I.I.S. CATERINA CANIANA Via Polaresco 19 24129 Bergamo Tel: 035 250547 035 253492 Fax: 035 4328401 http://www.istitutocaniana.it email: canianaipssc@istitutocaniana.it
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca I.I.S. CATERINA CANIANA Via Polaresco 19 24129 Bergamo Tel: 035 250547 035 253492 Fax: 035 4328401 http://www.istitutocaniana.it email: canianaipssc@istitutocaniana.it
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA
 LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA Linee guida per l apprendimento delle lingue 1 Centro Linguistico di Ateneo via Verdi, 8 - I piano tel. +39 0461 283460 cla@unitn.it www.cla.unitn.it Pag.
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA Linee guida per l apprendimento delle lingue 1 Centro Linguistico di Ateneo via Verdi, 8 - I piano tel. +39 0461 283460 cla@unitn.it www.cla.unitn.it Pag.
OBIETTIVI MINIMI DI ITALIANO
 OBIETTIVI MINIMI DI ITALIANO TERZA NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI SPECIFICI COMPETENZE VERIFICHE ASCOLTARE Ascoltare e comprendere comandi, istruzioni, regole. Seguire una conversazione e comprendere ciò di
OBIETTIVI MINIMI DI ITALIANO TERZA NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI SPECIFICI COMPETENZE VERIFICHE ASCOLTARE Ascoltare e comprendere comandi, istruzioni, regole. Seguire una conversazione e comprendere ciò di
7 Disegni sperimentali ad un solo fattore. Giulio Vidotto Raffaele Cioffi
 7 Disegni sperimentali ad un solo fattore Giulio Vidotto Raffaele Cioffi Indice: 7.1 Veri esperimenti 7.2 Fattori livelli condizioni e trattamenti 7.3 Alcuni disegni sperimentali da evitare 7.4 Elementi
7 Disegni sperimentali ad un solo fattore Giulio Vidotto Raffaele Cioffi Indice: 7.1 Veri esperimenti 7.2 Fattori livelli condizioni e trattamenti 7.3 Alcuni disegni sperimentali da evitare 7.4 Elementi
OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME. Competenze specifiche Abilità Conoscenze ABILITÀ MORFO-SINTATTICHE
 OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME Fonetica sue strutture morfosintattiche di base. 3. Arricchire il proprio bagaglio lessicale, imparando a usarlo consapevolmente. 4. Comprendere lo stretto rapporto
OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME Fonetica sue strutture morfosintattiche di base. 3. Arricchire il proprio bagaglio lessicale, imparando a usarlo consapevolmente. 4. Comprendere lo stretto rapporto
La lingua dell autonomia e del successo
 La lingua dell autonomia e del successo Le ricerche sull educazione bilingue hanno dimostrato che L apprendimento della madrelingua in ambito scolastico sia come strumento veicolare sia come materia facoltativa
La lingua dell autonomia e del successo Le ricerche sull educazione bilingue hanno dimostrato che L apprendimento della madrelingua in ambito scolastico sia come strumento veicolare sia come materia facoltativa
ITALIANO classe quarta
 NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CONOSCENZE ASCOLTO E PARLATO - SA ESPRIMERE LA PROPRIA OPINIONE SU UN ARGOMENTO TRATTATO - SA PORRE DOMANDE PERTINENTI ALL ARGOMENTO E AL CONTESTO DURANTE O DOPO L ASCOLTO -
NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CONOSCENZE ASCOLTO E PARLATO - SA ESPRIMERE LA PROPRIA OPINIONE SU UN ARGOMENTO TRATTATO - SA PORRE DOMANDE PERTINENTI ALL ARGOMENTO E AL CONTESTO DURANTE O DOPO L ASCOLTO -
COMPETENZA CHIAVE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
 COMPETENZA ITALIANO COMPETENZA CHIAVE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA Definizione: è la capacità di esprimere e interpretare pensieri,sentimenti e fatti in forma sia in forma orale che scritta (comprensione
COMPETENZA ITALIANO COMPETENZA CHIAVE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA Definizione: è la capacità di esprimere e interpretare pensieri,sentimenti e fatti in forma sia in forma orale che scritta (comprensione
Corso di Laurea in Scienze Motorie A.A Docente: M. Stella Valle
 Corso di Laurea in Scienze Motorie A.A. 2007-2008 Docente: M. Stella Valle Approccio all elaborazione dell informazione input Cos e l input? E un informazione ambientale che un individuo riceve per elaborarla.
Corso di Laurea in Scienze Motorie A.A. 2007-2008 Docente: M. Stella Valle Approccio all elaborazione dell informazione input Cos e l input? E un informazione ambientale che un individuo riceve per elaborarla.
Funzioni fondamentali della frase (soggetto, oggetto diretto, ecc.) Ruoli tematici: agente, paziente, beneficiario, strumento, ecc.
 Both English and Dyirbal have different syntactic means of encoding the same semantic roles (p. 114) Funzioni fondamentali della frase (soggetto, oggetto diretto, ecc.) Ruoli tematici: agente, paziente,
Both English and Dyirbal have different syntactic means of encoding the same semantic roles (p. 114) Funzioni fondamentali della frase (soggetto, oggetto diretto, ecc.) Ruoli tematici: agente, paziente,
NEUROSHOPPING La psicologia del consumatore tra marketing e scelte di acquisto G I A N P I E R O L U G L I U N I V E R S I T A D I P A R M A
 NEUROSHOPPING La psicologia del consumatore tra marketing e scelte di acquisto G I A N P I E R O L U G L I U N I V E R S I T A D I P A R M A Nel futuro del marketing ci sono le neuroscienze La necessità
NEUROSHOPPING La psicologia del consumatore tra marketing e scelte di acquisto G I A N P I E R O L U G L I U N I V E R S I T A D I P A R M A Nel futuro del marketing ci sono le neuroscienze La necessità
DIREZIONE DIDATTICA DI RACCONIGI CURRICOLO DI LINGUA INGLESE
 DIREZIONE DIDATTICA DI RACCONIGI CURRICOLO DI LINGUA INGLESE PREMESSA Il Curricolo di lingua straniera attualmente in uso nel nostro circolo è stato elaborato tenendo presenti le indicazioni del Progetto
DIREZIONE DIDATTICA DI RACCONIGI CURRICOLO DI LINGUA INGLESE PREMESSA Il Curricolo di lingua straniera attualmente in uso nel nostro circolo è stato elaborato tenendo presenti le indicazioni del Progetto
CAPITOLO 1 L ENCEFALITE ERPETICA Encefalite da Herpes Simplex Virus (HSV)
 INTRODUZIONE La memoria semantica è il patrimonio di conoscenze generali sul mondo che ogni individuo possiede. A partire dalla metà degli anni settanta vi è stato un crescente interesse per lo studio
INTRODUZIONE La memoria semantica è il patrimonio di conoscenze generali sul mondo che ogni individuo possiede. A partire dalla metà degli anni settanta vi è stato un crescente interesse per lo studio
La lettura come processo di decodifica. Di Giacomo Dallari
 La lettura come processo di decodifica. Di Giacomo Dallari Leggere significa attivare dei meccanismi molto complessi che richiedono l intervento di una serie di abilità e di processi articolati e cooperativi.
La lettura come processo di decodifica. Di Giacomo Dallari Leggere significa attivare dei meccanismi molto complessi che richiedono l intervento di una serie di abilità e di processi articolati e cooperativi.
SCUOLA PRIMARIA ITALIANO (Classe 1ª)
 SCUOLA PRIMARIA ITALIANO (Classe 1ª) Leggere testi brevi e rispondere a semplici domande di comprensione. Ricostruire cronologicamente un semplice testo ascoltato. Eseguire semplici istruzioni, consegne
SCUOLA PRIMARIA ITALIANO (Classe 1ª) Leggere testi brevi e rispondere a semplici domande di comprensione. Ricostruire cronologicamente un semplice testo ascoltato. Eseguire semplici istruzioni, consegne
Grandezze fisiche e loro misura
 Grandezze fisiche e loro misura Cos è la fisica? e di che cosa si occupa? - Scienza sperimentale che studia i fenomeni naturali suscettibili di sperimentazione e caratterizzati da grandezze misurabili.
Grandezze fisiche e loro misura Cos è la fisica? e di che cosa si occupa? - Scienza sperimentale che studia i fenomeni naturali suscettibili di sperimentazione e caratterizzati da grandezze misurabili.
Il disordine fonologico: valutazione e trattamento. 1 livello. Docente Vaquer Maria Luisa Patrizia. Obiettivi:
 Il disordine fonologico: valutazione e trattamento. 1 livello. Firenze 7 e 8 maggio 2011 Grand Hotel Cavour Via del Proconsolo 3 Docente Vaquer Maria Luisa Patrizia Obiettivi: Nella pratica clinica relativa
Il disordine fonologico: valutazione e trattamento. 1 livello. Firenze 7 e 8 maggio 2011 Grand Hotel Cavour Via del Proconsolo 3 Docente Vaquer Maria Luisa Patrizia Obiettivi: Nella pratica clinica relativa
PROGETTAZIONE FORMATIVA ANNUALE PROGETTAZIONE ANNUALE DIDATTICA:
 PROGETTAZIONE FORMATIVA ANNUALE Docente PICCHI MARIA LETIZIA Plesso Scuola dell'infanzia Giuseppe Giusti Classe.. Sezione A e B (anni 5) Disciplina/Macroarea/Campo d esperienza I DISCORSI E LE PAROLE Tavola
PROGETTAZIONE FORMATIVA ANNUALE Docente PICCHI MARIA LETIZIA Plesso Scuola dell'infanzia Giuseppe Giusti Classe.. Sezione A e B (anni 5) Disciplina/Macroarea/Campo d esperienza I DISCORSI E LE PAROLE Tavola
Il processo di comprensione del testo scritto
 ALLEGATO 1 testo di partenza Il processo di comprensione del testo scritto Gli studi dedicati alla lettura, soprattutto in ambito psicolinguistico e neurolinguistico, pur collocandosi su livelli diversi,
ALLEGATO 1 testo di partenza Il processo di comprensione del testo scritto Gli studi dedicati alla lettura, soprattutto in ambito psicolinguistico e neurolinguistico, pur collocandosi su livelli diversi,
Obiettivo/i educativi formativi complessivi dell attività formativa
 NEUROPSICOLOGIA DEL DISTURBO DI APPRENDIMENTO DELLA SCRITTURA: LA VALUTAZIONE E LA RIABILITAZIONE Roma 26 e 27 maggio 23 e 24 giugno 2012 Sede Villa Eur Parco dei Pini P.le M. Champagnat, 2 Relatori Dott.ssa
NEUROPSICOLOGIA DEL DISTURBO DI APPRENDIMENTO DELLA SCRITTURA: LA VALUTAZIONE E LA RIABILITAZIONE Roma 26 e 27 maggio 23 e 24 giugno 2012 Sede Villa Eur Parco dei Pini P.le M. Champagnat, 2 Relatori Dott.ssa
Indice. Introduzione. Il razionale sotteso all evoluzione delle Scale WISC Introduzione 3 Bambini e realtà clinica 5. L evoluzione degli strumenti 15
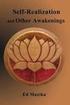 Indice Introduzione XIII Parte prima Il razionale sotteso all evoluzione delle Scale WISC Introduzione 3 Bambini e realtà clinica 5 Quali modelli psicopatologici per i bambini 5 Un modo diverso di considerare
Indice Introduzione XIII Parte prima Il razionale sotteso all evoluzione delle Scale WISC Introduzione 3 Bambini e realtà clinica 5 Quali modelli psicopatologici per i bambini 5 Un modo diverso di considerare
Scuola Primaria. Scuola Secondaria di Primo Grado. L I N G U A T E D E S C A Scuola dell Infanzia. Primo anno Secondo anno Terzo anno
 Primo anno Secondo anno Terzo anno Primo anno Secondo anno Terzo anno Quarto anno Quinto anno L I N G U A T E D E S C A Scuola dell Infanzia Scuola Primaria a. Obiettivi formativi della disciplina Scuola
Primo anno Secondo anno Terzo anno Primo anno Secondo anno Terzo anno Quarto anno Quinto anno L I N G U A T E D E S C A Scuola dell Infanzia Scuola Primaria a. Obiettivi formativi della disciplina Scuola
SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA LINGUA CLASSE SECONDA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO. Micro- obiettivi
 SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA LINGUA CLASSE SECONDA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Nuclei Macro- obiettivi al termine della classe terza Ascolto e parlato Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA LINGUA CLASSE SECONDA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Nuclei Macro- obiettivi al termine della classe terza Ascolto e parlato Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
LO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO NEI BAMBINI CON ABERRAZIONI DEL CROMOSOMA 14
 LO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO NEI BAMBINI CON ABERRAZIONI DEL CROMOSOMA 14 Laura D Odorico, Laura Zampini, Paola Zanchi Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Milano-Bicocca Associazione Internazionale
LO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO NEI BAMBINI CON ABERRAZIONI DEL CROMOSOMA 14 Laura D Odorico, Laura Zampini, Paola Zanchi Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Milano-Bicocca Associazione Internazionale
Hai una mente creativa? Copyright EdiTEST 2010
 Hai una mente creativa? Copyright EdiTEST 2010 Il termine creatività si riferisce a quei processi mentali che portano a soluzioni, idee, concetti, forme artistiche, teorie o prodotti che sono unici e originali.
Hai una mente creativa? Copyright EdiTEST 2010 Il termine creatività si riferisce a quei processi mentali che portano a soluzioni, idee, concetti, forme artistiche, teorie o prodotti che sono unici e originali.
La prova scritta di italiano nell esame conclusivo del primo ciclo
 La prova scritta di italiano nell esame conclusivo del primo ciclo La prova d esame come esito di una didattica efficace Un ambiente di apprendimento funzionale allo sviluppo delle competenze di scrittura
La prova scritta di italiano nell esame conclusivo del primo ciclo La prova d esame come esito di una didattica efficace Un ambiente di apprendimento funzionale allo sviluppo delle competenze di scrittura
Classi 4ª. Anno Scolastico 2013/2014. U.d.A. 0. Bentornati siamo in quarta. Durata: SETTEMBRE
 I.C. ALCMEONE Scuola Primaria Classi 4ª Anno Scolastico 2013/2014 U.d.A. 0 Bentornati siamo in quarta Durata: SETTEMBRE Docenti: SAPIA TERESA ADAMO ANTONELLA GODANO ANGELA CASTELLI PATRIZIA ASTERITI ADELE
I.C. ALCMEONE Scuola Primaria Classi 4ª Anno Scolastico 2013/2014 U.d.A. 0 Bentornati siamo in quarta Durata: SETTEMBRE Docenti: SAPIA TERESA ADAMO ANTONELLA GODANO ANGELA CASTELLI PATRIZIA ASTERITI ADELE
Psicoterapia cognitivo-comportamentale in età evolutiva. Dott.ssa Elena Luisetti
 Psicoterapia cognitivo-comportamentale in età evolutiva Dott.ssa Elena Luisetti PIU CHE UNA SCUOLA E UNA PROSPETTIVA EMERSE CON IL CONVERGERE DI PIU FILONI PRINCIPI BASE Kendell, 1993 A. L individuo reagisce
Psicoterapia cognitivo-comportamentale in età evolutiva Dott.ssa Elena Luisetti PIU CHE UNA SCUOLA E UNA PROSPETTIVA EMERSE CON IL CONVERGERE DI PIU FILONI PRINCIPI BASE Kendell, 1993 A. L individuo reagisce
A R R I V O I N I T A L I A
 CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI DI LIVELLO A1-A2 3 MariaTeresa Frattegiani Rosella Baldelli SOMMAR I O PREMESSA 07 INTRODUZIONE 08 L ALFABETO ITALIANO 08-09 LE SILLABE 10-11 I NUMERI 11
CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI DI LIVELLO A1-A2 3 MariaTeresa Frattegiani Rosella Baldelli SOMMAR I O PREMESSA 07 INTRODUZIONE 08 L ALFABETO ITALIANO 08-09 LE SILLABE 10-11 I NUMERI 11
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 CURRICOLO DI FRANCESE SPAGNOLO CLASSE PRIMA TRAGUARDI DI COMPETENZA Comprendere il significato globale di un breve e semplice messaggio orale e riconoscere in esso informazioni utili. NUCLEI TEMATICI ASCOLTO
CURRICOLO DI FRANCESE SPAGNOLO CLASSE PRIMA TRAGUARDI DI COMPETENZA Comprendere il significato globale di un breve e semplice messaggio orale e riconoscere in esso informazioni utili. NUCLEI TEMATICI ASCOLTO
Progettazione modulare Percorso di istruzione di 1 livello, 2 periodo didattico, asse linguaggi Modulo 1
 Modulo 1 MODULO N.1 Il testo narrativo Durata 5 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti. Padroneggiare gli strumenti espressivi. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi
Modulo 1 MODULO N.1 Il testo narrativo Durata 5 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti. Padroneggiare gli strumenti espressivi. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi
Che cos è la Psicologia sociale? Dott.ssa Daniela Cipollone
 Che cos è la Psicologia sociale? Dott.ssa Daniela Cipollone Difficoltà ad identificare una definizione sufficientemente articolata e sintetica: - complessità del campo di pertinenza della psicologia sociale;
Che cos è la Psicologia sociale? Dott.ssa Daniela Cipollone Difficoltà ad identificare una definizione sufficientemente articolata e sintetica: - complessità del campo di pertinenza della psicologia sociale;
