COST: un progetto europeo per lo studio della dislessia e la valutazione delle prime fasi di apprendimento della lettura
|
|
|
- Luigina Capasso
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 1 COST: un progetto europeo per lo studio della dislessia e la valutazione delle prime fasi di apprendimento della lettura Lucia Carriero, Claudio Vio, Patrizio E. Tressoldi Psicologia clinica dello sviluppo, 2, 2001, pp SOMMARIO 1. La Batteria di prove: 1.1 Gli scopi 1.2 Criteri di costruzione delle liste del Livello - base 1.3 Criteri di costruzione delle liste del livello ortografico 1.4 La validazione: soggetti e metodo 2. In che modo si possono può usare le liste? 2.1 Come procedere con le liste del Livello base 2.2 Quali informazioni si possono ricavare utilizzando le liste. 2.3 Come procedere con le liste del Livello - ortografico 3. Le liste 3.1 Norme APPENDICE BIBLIOGRAFIA
2 2 1. La Batteria di prove: 1.1 Gli scopi Le prove per l individuazione delle difficoltà in lettura ed in scrittura proposte in questo volume sondano le abilità dei bambini all inizio della loro carriera scolastica fino al momento in cui la prestazione dovrebbe essere ormai consolidata. Le prime fasi di apprendimento sono caratterizzate da elevata variabilità nelle prestazioni dei bambini, ma anche dalla presenza di alunni che riescono ad acquisire le abilità della fase alfabetica solo in terza elementare, creando la possibilità che questi soggetti valutati nelle prestazioni in lettura durante la seconda elementare presentino prestazioni negative per livelli attesi (falsi positivi). Ciononostante, avere a disposizione per le prime classi della scuola primaria (prima, seconda e terza elementare) uno strumento che consenta di indagare accanto ad una prestazione generale in lettura anche il possesso di specifiche competenze caratteristiche della fase alfabetica dovrebbe favorire l approfondimento del percorso compiuto dal bambino, ma anche potrebbe consentire di verificare più facilmente intoppi in una o più fasi di apprendimento del processo in esame, ed individuare quindi le competenze verso le quali è opportuno prevedere un intervento di recupero. Gli strumenti infatti attualmente a disposizione di insegnati, ricercatori e clinici per un approfondimento del problema prevedono che il bambino abbia almeno otto anni di età (questo anche in accordo con i criteri diagnostici riconosciuti per l individuazione del Disturbo). Lo strumento che qui proponiamo deriva dal coinvolgimento degli autori nel progetto europeo COST (Niessen, Frith, Reitsma, &Ohngren, 2000) che ha visto la partecipazione di ben 16 nazioni nello studio delle prime fasi di alfabetizzazione i cui risultati sono sintetizzati nell articolo Foundation of literacy acquisition in European orthographies di Seymour, Aro e Erskine (2003). Le prove sono suddivise in due parti: la prima denominata Livello di Base, fa riferimento alle abilità che dovrebbero rappresentare le fondamenta del processo di apprendimento; la seconda parte di prove vengono raccolte all interno del Livello ortografico, così da poter definire il livello di acquisizione delle competenze fonologiche e lessicali.
3 3 Le liste del livello Ortografico sono di complessità grafemica e sillabica maggiore rispetto a quelle del livello Base, e costituiscono il complemento di queste ultime. L obiettivo delle liste del livello Base è quello di identificare il possesso di alcune competenze preliminari indispensabili alla corretta codifica del testo scritto (attribuzione del suono corretto ai singoli grafemi) nonché di sondare l impiego, da parte del bambino, di procedure di conversione fonologica adeguate (non parole con struttura bisillabica). Nel livello Ortografico le competenze di lettura di tipo alfabetico vengono sondate in maniera più approfondita e mirata perché vengono poste in relazione ad alcune variabili psicolinguistiche importanti come: lo status lessicale (parola vs. non parola), la frequenza d uso, la lunghezza (parole e non parole multisillabiche), la regolarità (influenze del contesto di lettera precedente o successiva a un dato grafema sulla lettura), la quantità fonetica (presenza di doppie che allungano la pronuncia di un dato suono)e i grafemi complessi (due grafemi letti con un solo suono). 1.2 Criteri di costruzione delle liste del Livello - base Sono state costruite 10 liste di stimoli formate da forme parallele di singole lettere, da sillabe, da parole contenuto e parole funzione e da non parole allo scopo di sondare le abilità acquisite dal bambino in lettura e in scrittura sotto dettatura; ed una lista, la X, per consentire al bambino una migliore comprensione delle richiesta dell esaminatore. La lista A e la lista B prevedono che il bambino identifichi col loro corretto suono i vari grafemi. Ognuna di queste due liste riporta 20 lettere dell alfabeto che vanno prima lette e poi scritte sotto dettatura (in questo caso le liste vanno somministrate assieme). La lista X riporta due parole ( tu, cane ) e quattro non parole: è una specie di prova pratica di lettura e scrittura. Le liste C e D sono composte da 9 parole bisillabiche ciascuna: esse vogliono sondare l abilità del bambino a leggere parole contenuto (es. come cane), ad alto valore di immagine e per lo più ben conosciute dal bambino. Le liste E ed F indagano la capacità a leggere parole - funzione, ossia articoli e preposizioni. Le liste G ed H contengono pseudoparole: esse sono non parole monosillabiche e hanno struttura Vocale Consonante (di seguito V indica una vocale; C indica una consonante), CV e CVC. Le ultime due liste, la I e la L contengono nonparole con una struttura bisillabica del tipo VCV, VCVC e CVCV.
4 4 1.3 Criteri di costruzione delle liste del livello ortografico Le liste per la valutazione ortografica sono più complesse di quelle del Livello di Base ( Foundation Level ) e questo al fine di valutare quanto incida la maggiore complessità sulle competenze di lettura del bambino. Due sono i livelli di difficoltà, che vengono indagati separatamente: Complessità grafemica Complessità sillabica La complessità grafemica si riferisce a 4 aspetti: grafemi complessi e accenti, influenze contestuali sulla pronuncia, allungamento fonemico e competenze di base (baseline list). La complessità sillabica riguarda i gruppi consonantici iniziali delle parole. Grafemi complessi Questa sezione dell assessment ortografico riguarda i casi in cui: a) Due o più lettere corrispondono a un singolo fonema b) La pronuncia di una lettera risulta modificata da un accento. In Italiano è possibile individuare dei casi in cui a più grafemi corrisponde un singolo fonema: per consonanti: CQ, CH, GH per vocali: HA, HO. cq si pronuncia sempre /k/ davanti a /u/ e non risulta influenzato da contesti di lettere precedenti o seguenti. ch e gh si leggono sempre rispettivamente come /k/ e /g/ (come in /perché/ oppure /ghiro/) davanti a e ed i e non sono influenzate da contesti.
5 5 Tenendo presenti queste considerazioni si sono costruite due liste di nove parole ciascuna, ad alta (Acqua, Chiodo, Schiavo, ecc.) e bassa frequenza d uso (Chicchi, Schiera, Ghiro, ecc.). Le non parole della terza lista si sono ottenute per anagramma delle parole contenute nella prima e nella seconda lista (Dochio, Voschia, Reschia, ecc.). Influenze contestuali sulla pronuncia Questa sezione comprende i casi in cui un grafema è pronunciato in modo diverso a seconda del contesto di lettere che lo seguono o lo precedono. C si pronuncia /k/ se seguita da a, o, u ; si pronuncia tζ (/c/ dolce come in cena ) se seguita da e, i. G segue le stesse regole della c, leggendosi velare (dura) o dolce (/dζ/) a seconda del contesto di lettere da cui è seguita. Z (/dz/) può essere dolce (es. zio ) o sorda (es. cozze ), ma non è mai sorda a inizio di parola. GL è dura davanti ad a, e, o, u ; dolce, /λ/ davanti a i (eccetto a inizio di parola, es. glicine, glicemia, ecc.) S può essere dolce (es. rosa ) o aspra (es. sole ); non è mai dolce a inizio di parola. Sc seguito da i, e, si pronuncia /ζ/ (es. sci, cosce ). Seguito da a, o, u si pronuncia /sk/ (es. scatola ). Per questa sezione sono state costruite liste di nove parole ad alta e bassa frequenza che rispettassero queste regole; la lista di non parole è stata costruita, anche qui, per anagramma delle parole delle due liste precedenti.
6 6 Quantità fonemica In questa sezione si analizzano le convenzioni ortografiche usate nella nostra lingua per indicare variazioni nella quantità (allungamento/accorciamento del suono nella pronuncia) di vocali e consonanti. TT, ss, dd, e tutte le consonanti raddoppiate modificano il suono della parola che si legge, rendendolo più intenso e allungato. L accento modifica la lunghezza del suono con cui viene pronunciata una vocale (es. parole piane, tronche, sdrucciole, ecc.) ( Viòla oppure Vìola ). Nella nostra lingua non abbiamo dittonghi che vengano letti come un unico suono; le parole che contengono doppie vocali si leggono in modo regolare (es. coorte ). Le liste che sono state costruite facendo riferimento a queste regole contengono parole in cui la presenza di doppie consonanti produce un allungamento nel suono durante la pronuncia (es. piatto, penna, sciocco, ecc.). La lista di non parole mantiene queste caratteristiche negli anagrammi delle parole delle due liste precedenti(es. attopi, iccosco, ecc.). Competenze di base Le liste per la valutazione delle competenze di lettura di base sono state costruite con parole e non parole dalla struttura semplice e regolare. Lo scopo è quello di definire un Livello - base di performance nella lettura nel quale si evidenzino le semplici regole di conversione grafema-fonema e non intervengano le regole discusse nelle sezioni precedenti. Esempi di parole ad alta frequenza sono: Pane, Pera ; tra le parole a bassa frequenza: Tono, Cono ; tra le non parole: Nepa, Lose.
7 7 Strutture sillabiche (complesse perchè complesse, lascerei solo strutture sillabiche) Lo scopo di queste liste è quello di stabilire gli effetti dell aggiunta di consonanti alla sillaba iniziale o finale di una parola. A partire da due liste di parole che cominciavano/terminavano con una consonante(es. per, sole, ecc.)o con un cluster di consonanti (es. tra, freddo, ecc.), sono state costruite due liste di non-parole: la prima ( baseline ) con struttura molto semplice del tipo CVCV (es. lose, poto ) la seconda più complessa con delle non parole che cominciavano con un cluster di consonanti (es. frelo, brupo, ecc.). Numerosità sillabica Lo scopo di queste liste è quello di stabilire come viene affrontato il compito di leggere parole multisillabiche (3 o più sillabe) dal bambino. Le parole che compongono le liste sono state selezionate in base alla frequenza d uso. La prima lista (lista A) include parole multisillabiche semplici(es. tavolo, favola, ecc.). La seconda lista (lista B) include parole multisillabiche complesse, nelle quali sono presenti cluster di consonanti iniziali e doppie consonanti ( bruciare, gessetto, ecc.). La prima lista di non-parole è costruita anagrammando le parole della lista A ( lavoto, valofa, ecc.). La seconda è composta da anagrammi della lista B ( cubrirea, gossette, ecc.). Si è cercato di fare in modo che le liste di non parole ricalcassero le caratteristiche delle due liste di parole riguardo alla struttura sillabica. 1.4 La validazione: soggetti e metodo Le liste del Livello Base sono state sottoposte a un gruppo di 75 bambini frequentanti la prima elementare. La somministrazione ha avuto luogo individualmente e a ciascun soggetto è stato chiesto di leggere e scrivere sotto dettatura quanto riportato nelle liste. Le liste del Livello Base sono state presentate in modo bilanciato tra i soggetti, cioè sono state applicate alternativamente le prove di
8 8 lettura e quelle di scrittura. La tab. 1.1 mostra i valori di media e deviazione standard delle risposte corrette ottenute con ciascuna lista. Tabella. 1.1 Medie e deviazioni stanard. delle risposte corrette fornite dal campione sperimentale alle liste del Livello Base. LISTA Media risposte corrette Deviazione standard 1) A ) B ) C ) D ) E ) F ) G ) H ) I ) L Le liste del Livello Ortografico sono state sottoposte a un gruppo di 181 bambini frequentanti le classi seconda (N = 89) e terza (N = 92). Anche le prove del Livello Ortografico sono state somministrate individualmente. La tab. 1.2 riporta i valori di media e dev. standard degli errori compiuti e del tempo impiegato dai soggetti sperimentali a leggere ciascuna lista. Tabella 1.2 Valori di media e dev. standard degli errori compiuti e del tempo impiegato a leggere ciascuna delle liste del Livello Ortografico, distinte per classi. Classe Seconda Classe Terza Lista Media Dev. Stand. Lista Media Dev. Stand. 1 errori errori tempo tempo errori errori tempo tempo
9 9 3 errori errori tempo tempo errori errori tempo tempo errori errori tempo tempo errori errori tempo tempo errori errori tempo tempo errori errori tempo tempo errori errori tempo tempo errori errori tempo tempo errori errori tempo tempo errori errori tempo tempo errori errori tempo tempo errori errori tempo tempo errori errori tempo tempo errori errori tempo tempo errori errori tempo tempo errori errori tempo tempo
10 10 2. IN CHE MODO SI POSSONO USARE LE LISTE? Le liste del Livello-Base e quelle del Livello-Ortografico vanno somministrate individualmente. Tuttavia le prove di scrittura sotto dettatura per le liste del Livello - base possono essere sottoposte a tutta la classe. L esaminatore può utilizzare tutte le liste del Livello-Base o solo una parte, a seconda di quali sono gli scopi della sua indagine. Ad esempio, se vuole verificare il livello di prestazione del bambino delle competenze fonologiche può essere utile la prova di lettura di parole funzione (lista E o lista F) e la lettura delle liste I o L (non parole); se invece la prestazione del bambino sembra bloccata ancora alle fasi iniziali dell apprendimento della lettura è utile verificare la velocità nel riconoscimento dei singoli grafemi (lista A o B). Inoltre, la possibilità di disporre due liste di stimoli per ogni variabile criterio della prestazione ha lo scopo di consentire la valutazione della stessa competenza in momenti diversi, ma soprattutto dopo un intervento di recupero, senza incorrere nel rischio che la misurazione di una stessa lista ripetuta più volte possa determinare un errore di misura elevato (effetto apprendimento) rispetto alla reale competenza acquisita dal bambino. a. COME PROCEDERE CON LE LISTE DEL LIVELLO - BASE. Le liste del Livello Base possono essere sottoposte: a) ai bambini di prima elementare tra i mesi di marzo-maggio per effettuare uno screening delle abilità di lettura-scrittura acquisite nel corso dell anno scolastico. b) ai bambini di seconda e terza elementare quando l insegnante riscontra delle difficoltà specifiche di certi alunni nella lettura delle liste del Livello ortografico (cfr. par. 2.3) COME VANNO SOMMINISTRATE? Il bambino deve leggere e scrivere sotto dettatura le singole lettere, le sillabe, le parole e le nonparole contenute nelle liste. Per la lettura è opportuno annotare anche una serie di informazioni, es. il n di rifiuti (ossia il numero di elementi di una lista che il bambino non legge), il numero di sostituzioni di parole con non-parole, il numero di non-parole sostituite con parole (es. quando il bambino tenta la procedura di regolarizzare una non-parola per poterla far rientrare nel lessico di parole che conosce) e infine il numero di elementi letti come suoni isolati (senza fondere le lettere in sillabe/parole). L esaminatore prende nota del tempo impiegato da ciascun bambino nella lettura delle singole liste. Nel caso le prove di scrittura vengono somministrate a tutta la classe,
11 11 l esaminatore detterà nell ordine le liste del Livello-base, chiedendo agli allievi di scrivere sotto dettatura con il carattere grafico che più gli è congeniale (corsivo, stampatello, ecc.); poi, raccolti i fogli delle prove di scrittura, chiederà a ciascuno di leggere i grafemi delle liste A e B. Di seguito è riportato un modello per l annotazione delle informazioni utili nel corso delle prove di lettura:
12 12 1. Informazioni sul soggetto: Età (in mesi): Presenza di difficoltà di apprendimento: SI NO Anni di frequenza della scuola elementare: Livello scolastico del padre (in anni di scuola): Livello scolastico della madre (in anni di scuola): numero n n n elementi LIVELLO tempo risposte numero sostituzioni sostituzioni letti come BASE (sec.) corrette rifiuti con non- con parole suoni isolati (punteggio) parole Lista A Lista B Lista C Lista D Lista E Lista F Lista G Lista H Lista I Lista L QUALI ABILITA RICHIEDONO LE LISTE X, A e B? La lista X è una sorta di prova pratica di lettura e di scrittura, in cui sono presenti due parole ( tu e cane ) e quattro non-parole. Per questa lista non vengono riportati i valori normativi di correttezza/rapidità perché essa ha il solo scopo di introdurre il bambino al compito di leggere e scrivere sotto dettatura le liste successive. Le liste A e B riportano ciascuna 20 lettere dell alfabeto e sondano l abilità del bambino nell attribuire il corretto suono a ognuno dei grafemi presentati.. Per eseguire la prova al bambino può essere
13 13 richiesto di leggere il grafema secondo il suo suono (permettendogli di usare una strategia nonlessicale) e/o secondo il suo nome (es. a, bi, ci, di, ecc., usando in questo caso una strategia lessicale). QUALI OSSERVAZIONI SI POSSONO RICAVARE DALLE LISTE A e B? L esaminatore può confrontare il numero dei grafemi correttamente letti e scritti dall allievo con i punteggi riportati nelle tabelle A, B1 e B2 in appendice. Si possono, a questo punto, ricavare una serie di informazioni: a) se la scrittura sotto dettatura dei singoli grafemi per le due liste è corretta (Tab. A, colonna A+B); in particolare quanti e quali grafemi sono riportati correttamente (es. se il bambino scrive correttamente meno di 33 grafemi per le due liste il suo punteggio è significativamente sotto la norma; è possibile constatare anche il tipo di errore commesso, ad es. se con le formanti (p, b, q, d) che sono lettere che hanno lo stesso simbolo grafico orientato in modo diverso, e in questo caso potrebbe essere inficiata l abilità di selezionare l adeguato grafema corrispondente a un certo suono). b) se la lettura dei grafemi è corretta (tabella B1) o se il bambino ha difficoltà nella selezione dell esatto suono corrispondente a una certa lettera c) se la lettura dei grafemi è lenta e difficoltosa (tabella B2: es. se il bambino impiega più di 28 secondi per leggere la lista A, o più di 23 sec. per leggere la lista B). QUALI ABILITA RICHIEDONO LE LISTE C e D? Queste due liste sono composte di 9 parole bisillabiche ciascuna ad alto valore di immagine e ad alta frequenza d uso. Per alto valore di immagine si intende la possibilità che una parola riferita a oggetti o concetti concreti susciti delle immagini e sia, quindi, rappresentabile mentalmente. La frequenza d uso riguarda la possibilità che la parola in questione sia nota al soggetto per averla ripetutamente ascoltata o letta e che, quindi, sia parte del suo vocabolario. Queste due caratteristiche, frequenza d uso e valore d immagine dovrebbero consentire al bambino di accedere velocemente al suo lessico mentale e di recuperare altrettanto velocemente anche la valenza semantica delle parole che legge o ascolta. Si sono
14 14 scelte parole bisillabiche proprio perché è noto che la lunghezza di una parola ha un certo peso nel facilitare/ostacolare il recupero della sua corretta pronuncia o del suo significato, o infine dell immagine che essa suscita. Quindi, le liste C e D sondano l abilità del bambino a leggere parole contenuto che sono brevi, hanno un significato, gli sono note e si possono rendere con rappresentazioni mentali. QUALI OSSERVAZIONI SI POSSONO RICAVARE DALLE LISTE C e D? L esaminatore può confrontare i risultati dei suoi allievi con i punteggi riportati nelle tabelle A, B1 e B2 in appendice. Ad es. può notare: a) se il numero di parole correttamente riportate sotto dettatura è nella norma (Tab. A colonne C e D). Si può osservare anche il tipo di errore che risulta più frequentemente commesso. Se ad es. alcune parole vengono riportate parzialmente ( or per ora, oppure cma per cima ) o sono presenti delle inversioni (es. vua per uva ) ci potrebbero essere delle difficoltà nella compitazione (cioè nell isolare fonologicamente i singoli suoni che compongono la parola da scrivere) o nel selezionare la sequenza corretta dei grafemi. b) se il numero delle parole correttamente lette a voce alta è nella norma (tabella B1 colonne C e D). Per quanto riguarda uno dei possibili errori, nel caso le parole delle liste venissero sostituite con altre parole (es. oro per ora ), questo potrebbe essere un indice proprio del fatto che il bambino sta facendo un confronto tra la stringa che deve leggere e quelle che ha nel suo lessico; nel caso la sostituzione avvenisse con una pseudoparola (es. dema per dama ) non va sottovalutata la possibilità di difficoltà di ordine fonologico. Andrebbe altresì valutata la competenza lessicale del bambino per le parole che non vengono lette correttamente, ossia la conoscenza del loro significato. c) se la velocità di lettura è quella attesa per età e scolarizzazione (tab. B2 colonne C e D) o se è significativamente inferiore. QUALI ABILITA RICHIEDONO LE LISTE E ed F?
15 15 Queste due liste sono composte da parole-funzione cioè da articoli e preposizioni. Le parole-funzione sono quelle che forniscono il minor numero di informazioni sul contenuto di una frase, le particelle più informative essendo gli aggettivi e i verbi. Anche i movimenti oculari che vengono impiegati nel corso della lettura (le fissazioni) si soffermano molto poco su queste particelle grammaticali. Il riconoscimento delle preposizioni, allorchè vengano presentate isolatamente, come nel caso delle liste E ed F, chiama in causa i processi di conversione grafema-suono. Queste due liste sondano, allora, la capacità del bambino di attuare una corretta decodifica fonologica di parole-funzione monosillabiche. QUALI OSSERVAZIONI SI POSSONO RICAVARE DALLE LISTE E ed F? I punteggi di correttezza e di velocità nella lettura sono riportati nelle tabelle A, B1 e B2, colonne E ed F, in appendice. a) se nella scrittura sotto dettatura compaiono numerosi errori ci potrebbero essere delle difficoltà nei meccanismi di conversione grafemica (dal suono udito al carattere grafico corrispondente). b) se nella lettura delle parole-funzione vengono commessi numerosi errori, si possono confrontare questi risultati con quelli ottenuti con le parole delle liste C e D: una difficoltà di ordine fonologico dovrebbe manifestarsi nella lettura delle parole-funzione ma non nella lettura di parole ad alta frequenza d uso e concrete, che potrebbe essere buona. c) trattandosi di parole monosillabiche la velocità di lettura dovrebbe essere piuttosto alta. Un punteggio di 12 secondi o più impiegati nel leggere ciascuna delle due liste (circa più di 1 sec. per leggere ciascuna preposizione) è da considerarsi significativamente inferiore alla norma (tab. B2 colonne E ed F). QUALI ABILITA RICHIEDONO LE LISTE G e H? Le due liste sono costituite da pseudoparole monosillabiche, cioè da stringhe di lettere ricavate da parole reali, ma che condividono con esse solo qualche grafema (es. la pseudoparola fir è molto simile alla parola fiore condividendo con essa i 3 grafemi f, i, ed r ; mur è simile a muro, ecc.). Se il lettore si sofferma solo sui grafemi che pseudoparole e parole corrispondenti condividono, paragonando la stringa a un vocabolo che gli è già noto, finirà per leggere la pseudoparola come una parola realmente esistente nel vocabolario. Per una corretta lettura delle liste G ed H sarà necessario,
16 16 allora, attivare una procedura supplementare, quella di convertire ciascun grafema nel suono corrispondente fondendo poi insieme i suoni. Anche queste due liste indagano, quindi, la capacità del bambino di attivare una corretta decodifica fonologica delle sequenze di lettere che gli sono presentate. QUALI OSSERVAZIONI SI POSSONO RICAVARE DALLE LISTE G e H? Si possono fare dei confronti fra il numero di pseudoparole correttamente lette dai soggetti con i punteggi di correttezza e rapidità riportati nelle tabelle A, B1 e B2 in appendice. In particolare: a) se la scrittura sotto dettatura e la lettura ad alta voce vengono effettuate riportando numerosi errori, è possibile che ci siano delle difficoltà nella compitazione o nella conversione fonologica rispettivamente (tab. A e B1 colonne G e H). b) se la lettura delle pseudoparole delle due liste è molto lenta (tab. B2) potrebbero essere proprio i meccanismi di conversione fonologica a rendere difficoltoso tutto il processo di decodifica. QUALI ABILITA RICHIEDONO LE LISTE I e L? Queste due liste contengono non-parole bisillabiche che riportano sequenze coerenti di vocali e consonanti, nel senso che pur essendo non-parole non risultano impossibili da leggere (es. brfri è una stringa di lettere illegibile in italiano, in quanto non esiste nessuna parola con una struttura CCCCV; viceversa la stringa fude è coerente con le sequenze CVCV che si riscontrano in numerose parole, es. fede, fune, ecc.). Trattandosi di non-parole, il lettore non può fare affidamento, per il loro riconoscimento, su vocaboli che ha già visto o ascoltato in precedenza. Mentre la lettura o la scrittura di parole familiari (es. fune ) attiva una rappresentazione semantica che a sua volta attiva una rappresentazione ortografica (la sequenza di grafemi di fune ) nel lessico mentale, nel caso delle nonparole, non esistendo nulla di simile a quella sequenza di lettere nel vocabolario mentale, ha luogo una conversione sub-lessicale per cui la stringa fude viene prima segmentata in brevi sequenze di fonemi (es. fu ude. de ) che poi vengono fuse insieme. QUALI OSSERVAZIONI SI POSSONO RICAVARE DALLE LISTE I e L?
17 17 Se il bambino legge e scrive correttamente le non-parole presentate con queste due liste vuol dire che è in grado di effettuare una buona decodifica fonologica. Si possono confrontare i risultati ottenuti con queste due liste con quelli ottenuti con le liste C e D. Se un bambino legge perfettamente delle parole che gli sono note e concrete, ma ha difficoltà con le stringhe di lettere che non ha mai incontrato prima come sono le non-parole, ha delle difficoltà nell attuare i processi di conversione fonologica, cioè nella attribuzione delle sequenze corrette di suoni alle corrispondenti sequenze di lettere. 2.2 QUALI INFORMAZIONI SI POSSONO RICAVARE UTILIZZANDO LE LISTE. Lo strumento che qui proponiamo ha essenzialmente lo scopo di individuare specifiche difficoltà nel processo di apprendimento del bambino in modo veloce ed immediatamente fruibile in ambito educativo e/o abilitativo. La possibilità inoltre di poter servirsi di due liste parallele rispetto alla stessa competenza da valutare dovrebbe consentire una maggiore obiettività in caso di verifica di specifici percorsi di recupero. E bene ricordare che la diagnosi clinica di Disturbo Specifico di Apprendimento non va posta prima degli otto anni di età, anche se è certamente utile identificare queste problematiche fin dalla prima elementare, pur correndo il rischio di trovarsi alla presenza di numerosi falsi positivi (bambini cioè che presentano alcune caratteristiche del Disturbo Specifico di apprendimento senza tuttavia incorrere nelle condizioni della diagnosi). Infatti, i contesti in cui si manifesta la difficoltà cognitiva possono essere differenti, a tutti gli insegnanti è capitato almeno una volta di incontrare un bambino che commetteva numerosi errori nella lettura, ma abilissimo nel calcolo aritmetico; il livello delle capacità del bambino dipende dalla sua situazione familiare e scolastica e non solo dalle sue caratteristiche individuali; nei primi anni di scuola primaria è a volte difficile distinguere il disturbo in questione dalle normali e transitorie variazioni del rendimento scolastico. Per porre una diagnosi di disturbo nella lettura, ad esempio, è necessaria la presenza di una compromissione clinicamente significativa di questa abilità specifica; questa conclusione può essere tratta valutando la gravità del disturbo che deve attestarsi al di sotto di 2 deviazioni standard sotto la media (cioè simile alla disabilità che si ritrova in meno del 10% della popolazione normale); poi bisogna considerare le abilità di intelligenza generali, cioè un disturbo di lettura si manifesterà in assenza di deficit intellettivi significativi. Le liste che qui proponiamo devono essere, perciò, considerate solo per lo scopo a cui possono servire: quello di effettuare uno screening delle abilità di lettura e scrittura acquisite dal bambino nel corso dei suoi primi tre anni di scuola, lasciando al clinico la possibilità di porre una vera e propria diagnosi di disturbo dell apprendimento della lettura e della scrittura, ove questo si manifesti realmente.
18 COME PROCEDERE CON LE LISTE DEL LIVELLO ORTOGRAFICO. Le liste del Livello Ortografico sono state ideate facendo riferimento alle principali caratteristiche psicolinguistiche della parola scritta: esse vogliono sondare l abilità del bambino a leggere parole ad alto/basso valore di immagine e ad alta frequenza d uso, con gruppi consonantici iniziali, con doppie consonanti, con grafemi complessi che vanno letti come un unico suono, parole variamente accentate e di lunghezza differente e non-parole con struttura consonante-vocale coerente con stringhe di lettere leggibili nella nostra lingua. Esse sono più complesse di quelle del livello base, e la loro lettura può comportare errori di natura diversa. Il lettore può commettere, ad es., errori di natura fonologica ( chiado per chiodo ) o visiva ( chiave per chiodo ), o più raramente semantica ( sedia per tavolo ) o infine errori di natura derivazionale o morfologici ( gesso per gessetto ). E più frequente osservare errori fonologici con le non-parole, perché in questo caso bisogna scomporre la stringa grafemica che si ha di fronte nelle sue componenti strutturali (le singole lettere che la compongono); è facile commettere errori visivi con parole al massimo bisillabiche ad alta frequenza d uso e ad alto valore di immagine (es. mamma per mano ) e infine gli errori derivazionali incorrono più spesso nella lettura di parole multisillabiche (es. giardiniere per giardino ). Le liste del Livello Ortografico vanno somministrate individualmente a bambini frequentanti la seconda e la terza elementare, prendendo nota del tempo impiegato nella lettura di ciascuna lista e del numero di errori commessi. Si può partire dalla lista 10 relativa alle competenze di base, che sonda le abilità a leggere semplici parole bisillabiche ad alta frequenza d uso e ad alto valore di immagine, e poi proseguire in ordine presentando tutte le altre liste (seguendo ad esempio questo ordine - ma questo è solo un suggerimento lista 10, lista 11, lista 12, lista 1, lista 2, lista 3, ecc.). In Appendice sono riportati i punteggi di correttezza e rapidità per ogni lista e per le due classi di scolarità (tabb. C1 e C2, D1 e D2). QUALI INFORMAZIONI SI POSSONO RICAVARE DALLE LISTE DEL LIVELLO ORTOGRAFICO? Per ognuna delle variabili linguistiche di cui si è tenuto conto, ossia per la diversa complessità grafemica e per quella sillabica, si sono create liste con parole ad alta frequenza, lista con parole a
19 19 bassa frequenza e liste di non-parole ottenute per anagramma delle precedenti due. Con le parole ad alta frequenza si vuole sondare l abilità del bambino a leggere stringhe grafemiche che già conosce, per essere presenti nel suo lessico mentale; con quelle a bassa frequenza le stesse abilità vanno esercitate in assenza di facilitatori lessicali; le non-parole, infine, chiamano in causa le competenze di decodifica fonologica. Le liste 10, 11, 12 sono state ideate per sondare alcune competenze di base: a) la capacità di leggere parole molto familiari, bisillabiche (che dovrebbero facilitare l accesso al vocabolario mentale e il recupero della pronuncia corretta) e ad alto valore di immagine(lista 10; gli errori commessi nella lettura di questa lista potrebbero essere di natura visiva, es. case per cane ); b) la competenza nella lettura di parole meno familiari che vanno decomposte in unità più piccole (es. le sillabe che le costituiscono) prima che vengano fuse insieme per dare la pronuncia della parola intera (lista 11); c) la capacità di decodificare la stringa di lettere mai veduta prima, la non-parola, attribuendo a ciascun grafema il suo suono e poi fondendoli insieme (lista 12). Se un bambino in seconda o terza elementare dovesse commettere più di 1 errore nella lettura della lista 10 e più di 3 errori nella lettura della lista 12, o dovesse impiegare più tempo di quello indicato nella tabella C2, potrebbe essere necessario somministrargli le liste del Livello Base prima di procedere con quelle del Livello ortografico. Le liste 1, 2, 3 sondano l abilità a leggere parole e non-parole costituite da grafemi complessi, ossia da gruppi di lettere che vanno letti come un unico suono (es. ch che va letto k ; cch che va letto ancora k, ecc.); le liste 4, 5, e 6 indagano la capacità di leggere grafemi il cui suono cambia a seconda che siano preceduti/seguiti da un altra lettera (se un bambino leggesse la parola bici come biki, non avrebbe tenuto conto di un effetto contestuale per la lettera c, ossia del fatto che quando essa è seguita da e oppure da i va letta come c dolce, e il suo sarebbe satato un errore di natura fonologica). Le liste 7, 8 e 9 sondano le competenze di lettura di consonanti doppie, che richiedono che la parola che le contiene vada pronunciata allungando il suono relativo alle consonanti. La lista 13 propone non-parole con struttura consonante- vocale bisillabiche e richiede l abilità a convertire grafemi in suoni, ma è più facile da decodificare rispetto alla lista 14 in cui le non-parole hanno dei grafemi complessi a inizio di parola (es. strare ). Infine la lista 15 indaga la capacità del lettore di utilizzare le proprie competenze lessicali (si tratta di parole ad alta frequenza) nella lettura di stringhe multisillabiche; la lista 16 richiede la stessa competenza, solo che è necessario che il lettore decomponga in unità più piccole le parole lunghe, non potendo utilizzare facilitazioni lessicali (il fatto di aver veduto spesso in precedenza quella parola). Gli errori che potrebbero essere più facilmente compiuti con le parole multisillabiche riguardano sostituzioni, omissioni, o inserzioni di singole lettere; questo tipo di errore potrebbe essere dovuto alla difficoltà di elaborare stringhe polimorfemiche in unità discrete, ad es. la radice ( gess- nella parola gessetto ) e l affisso ( -etto ), ognuna delle quali dovrebbe risultare più corta e quindi più agevole da processare rispetto alla parola
20 20 intera. Poi se l errore compiuto avviene più spesso con la radice ( goss invece che gess, ad es.) potrebbe essere di natura fonologica; se ha luogo con la derivazione ( gesso invece che gessetto ) potrebbe essere un errore di natura morfologica (siccome gessetto e gesso condividono una struttura morfologica comune, e sono simili tra di loro anche fonologicamente e ortograficamente escluso che per la lunghezza-, nonché semanticamente, potrebbero avere anche una rappresentazione comune nel vocabolario mentale, per cui la presentazione della stringa gess può pre-attivare contemporaneamente nel lessico delle entrate due affissi contemporaneamente: -o e si ha la lettura di gesso, oppure -etto e si ha la lettura di gessetto ). Le liste 17 e 18 sono costituite da non parole ottenute per anagramma rispettivamente delle parole della lista 15 e della lista 16, e sondano le abilità di conversione fonologica.
21 21 3. LE LISTE Qui di seguito vengono presentate le liste del Livello base; seguono quelle del livello Ortografico. Livello Base Lista A a n v b c e f o g i r l m p u q s d z t
22 22 Livello Base Lista B b v a n o g i m r u f q t d z p l s i e
23 23 Livello Base Lista X as tu sepe cane afor olu Livello Base Lista C ape ago ora lago cima dama prato resto colpo
24 24 Livello Base Lista D ala oca uva pane mela toro libro ponte treno Livello Base Lista E lo sul un in al da nel le sui
25 25 Livello base Lista F il la su fra per con del di tra Livello Base Lista G ul or es pa ti de den pol fir
26 26 Livello Base Lista H af id ot so be fu lat mur pes Livello Base Lista I tibe sopa fude ulaf erid otes ari ela ope
27 27 Livello Base Lista L beti defu pabe idor aful ides ifa ubi aru
28 28 LIVELLO ORTOGRAFICO A) Grafemi Complessi Lista 1 Parole Alta Frequenza Lista 2 Parole Bassa Frequenza Lista 3 Non Parole Acqua Chiodo Schiavo Chiave Mosche Chiuso Specchio Chiesa Hanno Chicchi Schiera Ghiro Schede Secchi Picchio Oche Succhi Vasche Spocchie Dochio Voschia Chesmo Orghi Reschia Occhipi Scuchi Svache
29 B) Influenze contestuali sulla pronuncia 29 Lista 4 Parole Alta Frequenza Lista 5 Parole Bassa Frequenza Lista 6 Non Parole Bici Gioco Gonna Zaino Puzza Paglia Sordo Rosa Biscia Scena Scusa Cura Guscio Globo Cosce Voglia Giro Forza Cogio Nioza Apagli Susca Sciguo Sceco Orgi Nango Scibia
30 30 C) Quantità Fonemica Lista 7 Parole Alta Frequenza Lista 8 Parole Bassa Frequenza Lista 9 Non Parole Piatto Penna Braccio Babbo Mamma Latte Notte Raggio Puzza Sciocco Valle Tazza Oggi Soffio Viaggio Zappa Scosse Vecchie Attopi Scesso Iccosco Iggo Offiso Iccheve Oggira Vioggia Raccibo
31 D) Competenze di Base 31 Lista 10 Parole Alta Frequenza Lista 11 Parole Bassa Frequenza Lista 12 Non Parole Mondo Pane Sole Pera Sale Libro Lana Cane Dado Corvo Palo Tono Tela Vena Cono Baro Lume Resa Nepa Lose Pare Nala Doda Leta Rabo Sare Brilo
32 E) Strutture Sillabiche 32 Lista 13 Baseline List (CVCV ) Lista 14 Non Parole con Cluster cconsonantico iniziale Lose Poto Love Pole Refa Mala Galo Cabo Nalu Frelo Brupo Trolo Stapo Scare Broma Draca Prana Strare
33 33 F) Numerosità Sillabica Lista 15 Parole Multisillabiche semplici Lista 16 Parole Multisillabiche Complesse Pericolo Tavolo Sapere Favola Salamino Felice Natale Panino Peperone Preferito Stringere Bruciare Gessetto Tritolo Cremoso Stupido Frenata Spendere
34 34 Lista 17 Non Parole con Pool (A) Lista 18 Non Parole Con Pool (B) Rilocope Lavoto Parese Valofa Losimana Cilefe Telana Ninopa Porenepe Protirefe Gernestri Cubrirea Gossette Lototri Moscreo Stidupo Netafra Desperne
35 6.1 Norme 35 LIVELLO BASE: VALORI NORMATIVI LISTA 5% 15% 25% 50% LISTA 5% 15% 25% 50% A risposte sbagliate F letti come suoni isolati A tempo G risposte corrette 0 <7 7 9 A rifiuti G tempo A risposte corrette 0 < G rifiuti B risposte sbagliate G sostituiti come parole B tempo G sost. come nonparole B rifiuti G letti come suoni isolati B risposte corrette 0 < H risposte corrette 0 <5 5 8 C risposte corrette 0 <7 7 9 H tempo C tempo H rifiuti C rifiuti H sostituiti come parole C sostituiti come parole H sost. come nonparole C sost. come nonparole H letti come suoni isolati C letti come suoni isolati I risposte corrette 0 <6 6 8 D risposte corrette 0 <7 7 9 I tempo D tempo I rifiuti D rifiuti I sostituiti come parole D sostituiti come parole I sost. come nonparole D sost. come nonparole I letti come suoni isolati D letti come suoni isolati L risposte corrette 0 <5 5 8 E risposte corrette 0 <7 8 9 L tempo E tempo L rifiuti E rifiuti L sostituiti come parole E sostituiti come parole L sost. come nonparole E sost. come nonparole L letti come suoni isolati E letti come suoni isolati Scrittura A+B corrette F risposte corrette 0 <7 8 9 Scrittura C risposte corrette 0 <8 8 9 F tempo Scrittura D risposte corrette 0 <8 8 9 F rifiuti Scrittura E risposte corrette 0 <8 8 9 F sostituiti come parole Scrittura F risposte corrette 0 <8 8 9 F sostituiti come nonparole Scrittura G+H corrette 9 < Scrittura I+L corrette 9 <
36
37 37 LISTE DEL LIVELLO ORTOGRAFICO : Valori Normativi (Classe seconda) LISTA Percentili LISTA Percentili 5% 15% 25% 50% 75% 5% 15% 25% 50% 75% 1 errori > errori > tempo tempo errori > errori > tempo tempo errori errori tempo tempo errori > errori tempo tempo errori > errori tempo tempo errori errori > tempo tempo errori errori > tempo tempo errori errori > tempo tempo errori errori > tempo tempo
38 38 LISTE DEL LIVELLO ORTOGRAFICO: Valori Normativi (Classe terza) LISTA Percentili LISTA Percentili 5% 15% 25% 50% 75% 5% 15% 25% 50% 75% 1 errori > errori > tempo tempo 13 > errori > errori > tempo tempo errori > errori > tempo tempo errori > errori tempo tempo errori > errori > tempo tempo errori errori > tempo tempo errori > errori > tempo tempo errori errori tempo tempo errori > errori > tempo tempo
39 APPENDICE 39 Tabella A: Punteggi di SCRITTURA delle liste del LIVELLO BASE. LISTE A+B C D E F G+H I+L punteggio molto basso punteggio limite punteggio nella norma <33 <8 <8 <8 <8 <15 < Tabella B1: Punteggi di LETTURA delle liste del LIVELLO BASE (CORRETTEZZA) LISTA A B C D E F G H I L punteggio molto basso punteggio limite punteggio nella norma <15 <13 <7 <7 <8 <8 <7 <5 <6 < Tabella B2: Punteggi di LETTURA delle liste del LIVELLO BASE (RAPIDITA ) LISTA A B C D E F G H I L punteggio (secondi) molto basso punteggio (secondi) limite punteggio (secondi) nella norma >28 >23 >25 >22 >12 >12 >15 >17 >25 >
40 40 COME CONSULTARE LE TABELLE: Nell ultima riga (grigio scuro) e riportato il punteggio nella norma, ossia il numero di elementi (singole lettere, parole funzione, non parole) per ciascuna delle liste del livello base che un bambino di prima elementare riesce mediamente a scrivere o a leggere correttamente. Un punteggio-limite richiederebbe approfondimenti ulteriori (es. confrontare il numero di elementi correttamente scritti con quelli correttamente letti per ogni lista, oppure il numero di risposte corrette con la rapidita, ecc.). Infine, un punteggio che si situa nella prima riga e un punteggio molto basso, che necessita eventualmente di un intervento specifico (cfr. paragrafo 4.4). Esempi di possibili profili alle prove del Livello Base. Profilo A: bambino lento, ma accurato nella gran parte delle liste, in particolare in quelle A (oppure B), C (oppure D); il processo di lettura i di scrittura e avviato, ma si stanno ancora consolidando le procedure di riconoscimento dei grafemi e di lettura di parole con struttura regolare (CVCV). I bambino è in ritardo rispetto alle competenze attese per classe di scolarità, ha avviat le abilità iniziali di riconoscimento delle lettere, o poco più, ma non sembra in grado di acquisire le strategie dello stadio alfabetico, andrebbe aiutato con esercizi particolari (cfr sezioni proposte di intervento, con esercizi di ricerca visiva di triplette di lettere ed esercizi di fusione e segmentazione uditiva). Profilo B: come sopra per le liste A e C, solo che questo bambino è lento e accurato anche nelle liste E (oppure F), G (oppure H), I(oppure L). Il soggetto sta avviando l utilizzo di adeguate competenze alfabetiche (basate sulla procedura di conversione grafema-fonema, o viceversa per la scrittura), anche se non ancora in modo sufficientemente veloce (ovvero automatizzato); ciò gli impedirebbe di arrivare facilmente al significato delle parole e/o di leggere attraverso l accesso diretto al lessico. Attenzione perché questo bambino pur rimando corretto nella lettura, può rimanere lento. Gli esercizi utili sono quelli che favoriscono una lettura globale della parola o che favoriscono il recupero del significato. Profilo C: si tratta di un bambino che evidenzia lentezza e inaccuratezza nelle prime liste; il processo di apprendimento, nonostante i primi mesi di scuola, non è ancora avviato o appare come instabile (impara alcune parole semplici e ripetute che poi dimentica); è fondamentale procedere subito alla ricerca dei precursori linguistici e/o di percezione visiva che favoriscono l apprendimento in esame (cfr Vio e Tressoldi, 1998) Profilo D: il bambino è veloce nella lettura delle liste A, C e D, ma inaccurato; in questo caso l analisi visiva degli stimoli è ancora approssimata; è opportuno intervenire con esercizi di ricerca visiva. La prognosi può essere favorevole.
41 41 BIBLIOGRAFIA Niessen, M., Frith, U., Reitsma, P., &Ohngren, B. (2000). Learning disorders as a barrier to human development Evaluation report. Technical Committee COST Social Sciences. Seymour, P.H.K., Aro, M., & Erskine, J.M. (2003). Foundation literacy acquisition in European orthographies. British Journal of Psychology, 94,
42
43 43 Tabella C1: Punteggi di errore nella LETTURA delle liste del LIVELLO ORTOGRAFICO - CLASSE SECONDA - (CORRETTEZZA) LISTE molto basso >1 >2 >3 >1 >2 >5 >1 >3 >5 >1 >2 >3 >3 >4 >1 >2 >3 >6 limite nella norma Tabella C2: Punteggi (in secondi) nella LETTURA delle liste del LIVELLO ORTOGRAFICO - CLASSE SECONDA - (RAPIDITA ) LISTE molto basso >21 >26 >43 >20 >24 >42 >17 >28 >41 >14 >20 >26 >18 >29 >25 >35 >44 >57 limite nella norma
44 44 Tabella D1: Punteggi di errore nella LETTURA delle liste del LIVELLO ORTOGRAFICO - CLASSE TERZA - (CORRETTEZZA) LISTE molto basso >1 >2 >3 >1 >2 >4 >1 >1 >4 >1 >1 >2 >2 >3 >2 >2 >3 >5 limite nella norma Tabella D2: Punteggi (in secondi) nella LETTURA delle liste del LIVELLO ORTOGRAFICO - CLASSE TERZA - (RAPIDITA ) LISTE molto basso >13 >19 >31 >13 >17 >26 >11 >12 >26 >10 >15 >16 >17 >20 >16 >22 >29 >33 limite nella norma
COST A8 Project Cross-linguistic assessment of reading. Italian Group. Progetto cross-linguistico europeo di valutazione della lettura Gruppo Italiano
 11/2011 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE Via Venezia, 8-35131 Padova - Tel. (049) 8276501 / 02- FAX (049) 8276600 e-mail: tressold@psico.unipd.it ITALY COST A8 Project
11/2011 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE Via Venezia, 8-35131 Padova - Tel. (049) 8276501 / 02- FAX (049) 8276600 e-mail: tressold@psico.unipd.it ITALY COST A8 Project
Prove di identificazione precoce difficoltà di apprendimento della letto-scrittua ANNO SCOLASTICO 2015-2016
 MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N 5 DANTE ALIGHIERI - FERRARA Scuola dell Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di 1 grado Via Camposabbionario,
MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N 5 DANTE ALIGHIERI - FERRARA Scuola dell Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di 1 grado Via Camposabbionario,
I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
 Circolo Didattico di Orvieto L. Barzini I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO LETTURA SCRITTURA CALCOLO DISLESSIA 5% della popolazione scolastica DISORTOGRAFIA molti
Circolo Didattico di Orvieto L. Barzini I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO LETTURA SCRITTURA CALCOLO DISLESSIA 5% della popolazione scolastica DISORTOGRAFIA molti
CONSIGLI PER POTENZIARE L APPRENDIMENTO DELLA LINGUA
 CONSIGLI PER POTENZIARE L APPRENDIMENTO DELLA LINGUA Possiamo descrivere le strategie di apprendimento di una lingua straniera come traguardi che uno studente si pone per misurare i progressi nell apprendimento
CONSIGLI PER POTENZIARE L APPRENDIMENTO DELLA LINGUA Possiamo descrivere le strategie di apprendimento di una lingua straniera come traguardi che uno studente si pone per misurare i progressi nell apprendimento
«I DSA: Conosciamoli» Prof.ssa Simonetta Longo Referente DSA (I.T.C.G. «G. Marconi» Penne. Prof.ssa Simonetta Longo
 «I DSA: Conosciamoli» Referente DSA (I.T.C.G. «G. Marconi» Penne LA DISLESSIA La Dislessia è un Disturbo Specifico dell Apprendimento (DSA). Tale termine indica i soli disturbi delle abilità scolastiche:
«I DSA: Conosciamoli» Referente DSA (I.T.C.G. «G. Marconi» Penne LA DISLESSIA La Dislessia è un Disturbo Specifico dell Apprendimento (DSA). Tale termine indica i soli disturbi delle abilità scolastiche:
LA DISLESSIA. Lucia Papalia lugr.papalia@libero.it
 LA DISLESSIA Lucia Papalia lugr.papalia@libero.it DISLESSIA È un disturbo di automatizzazione delle procedure di transcodifica dei segni scritti in corrispondenti fonologici che emerge all inizio della
LA DISLESSIA Lucia Papalia lugr.papalia@libero.it DISLESSIA È un disturbo di automatizzazione delle procedure di transcodifica dei segni scritti in corrispondenti fonologici che emerge all inizio della
LE SUCCESSIONI 1. COS E UNA SUCCESSIONE
 LE SUCCESSIONI 1. COS E UNA SUCCESSIONE La sequenza costituisce un esempio di SUCCESSIONE. Ecco un altro esempio di successione: Una successione è dunque una sequenza infinita di numeri reali (ma potrebbe
LE SUCCESSIONI 1. COS E UNA SUCCESSIONE La sequenza costituisce un esempio di SUCCESSIONE. Ecco un altro esempio di successione: Una successione è dunque una sequenza infinita di numeri reali (ma potrebbe
Insegnare le abilità sociali con la carta a T. ins. Fabrizia Monfrino
 Insegnare le abilità sociali con la carta a T ins. Fabrizia Monfrino Scuola: I circolo di Giaveno (To) Classe: trasversale Anno scolastico: 2003/2004 Insegnare le abilità sociali con l uso della carta
Insegnare le abilità sociali con la carta a T ins. Fabrizia Monfrino Scuola: I circolo di Giaveno (To) Classe: trasversale Anno scolastico: 2003/2004 Insegnare le abilità sociali con l uso della carta
Dislessia e altri Disturbi dell Apprendimento. Proposte didattiche per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado
 ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA Sezione di Parma Dislessia e altri Disturbi dell Apprendimento. Proposte didattiche per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado San Secondo (PR) 23 novembre
ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA Sezione di Parma Dislessia e altri Disturbi dell Apprendimento. Proposte didattiche per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado San Secondo (PR) 23 novembre
I libri di testo. Carlo Tarsitani
 I libri di testo Carlo Tarsitani Premessa Per accedere ai contenuti del sapere scientifico, ai vari livelli di istruzione, si usa comunemente anche un libro di testo. A partire dalla scuola primaria, tutti
I libri di testo Carlo Tarsitani Premessa Per accedere ai contenuti del sapere scientifico, ai vari livelli di istruzione, si usa comunemente anche un libro di testo. A partire dalla scuola primaria, tutti
Guida alla somministrazione delle prove e alla valutazione dei punteggi
 Guida alla somministrazione delle prove e alla valutazione dei punteggi Il test di valutazione delle abilità di calcolo e di soluzione di problemi aritmetici (AC-MT nuova edizione) è composto da tre diverse
Guida alla somministrazione delle prove e alla valutazione dei punteggi Il test di valutazione delle abilità di calcolo e di soluzione di problemi aritmetici (AC-MT nuova edizione) è composto da tre diverse
Tecnologie per la riduzione degli handicap - Laurea in Pedagogia
 Provate a leggere Probabilmente risulterà difficile leggere queste poche righe. Qualcuno si appellerà agli errori di stampa. Effettivamente abbiamo sostituito qualche lettera, omesso qualcosa, aggiunto
Provate a leggere Probabilmente risulterà difficile leggere queste poche righe. Qualcuno si appellerà agli errori di stampa. Effettivamente abbiamo sostituito qualche lettera, omesso qualcosa, aggiunto
ESERCIZI PER IL POTENZIAMENTO DELLA LETTO-SCRITTURA GRUPPO A
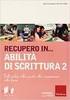 ESERCIZI PER IL POTENZIAMENTO DELLA LETTO-SCRITTURA GRUPPO A Progetto www.aprico.it Obiettivo Scuola Fondazione ASPHI Onlus - La riproduzione anche parziale è vietata senza autorizzazione scritta Data:
ESERCIZI PER IL POTENZIAMENTO DELLA LETTO-SCRITTURA GRUPPO A Progetto www.aprico.it Obiettivo Scuola Fondazione ASPHI Onlus - La riproduzione anche parziale è vietata senza autorizzazione scritta Data:
Antonella Martinucci, Rossana Nencini, 2013 IL PESO. classe quarta
 Antonella Martinucci, Rossana Nencini, 2013 IL PESO classe quarta I bambini utilizzano spontaneamente il concetto di pesante? Collochiamo su un banco alcuni oggetti: penne matite gomme fogli scottex quaderni
Antonella Martinucci, Rossana Nencini, 2013 IL PESO classe quarta I bambini utilizzano spontaneamente il concetto di pesante? Collochiamo su un banco alcuni oggetti: penne matite gomme fogli scottex quaderni
LETTURA DELLA DIAGNOSI E PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO. Germana Englaro, 9 settembre 2011
 LETTURA DELLA DIAGNOSI E PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO Germana Englaro, 9 settembre 2011 Edoardo, 8 anni, classe III Diagnosi: Disturbo Misto delle Capacità Scolastiche [F81.3] Disturbo Misto degli Apprendimenti
LETTURA DELLA DIAGNOSI E PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO Germana Englaro, 9 settembre 2011 Edoardo, 8 anni, classe III Diagnosi: Disturbo Misto delle Capacità Scolastiche [F81.3] Disturbo Misto degli Apprendimenti
CIRCOLO DIDATTICO DI SAN MARINO Anno Scolastico 2013/2014
 CIRCOLO DIDATTICO DI SAN MARINO Anno Scolastico 2013/2014 RICERCA-AZIONE Insegnare per competenze: Lo sviluppo dei processi cognitivi Scuola Elementare Fiorentino DESCRIZIONE DELL ESPERIENZA Docente: Rosa
CIRCOLO DIDATTICO DI SAN MARINO Anno Scolastico 2013/2014 RICERCA-AZIONE Insegnare per competenze: Lo sviluppo dei processi cognitivi Scuola Elementare Fiorentino DESCRIZIONE DELL ESPERIENZA Docente: Rosa
Ufficio Scolastico Regionale per l Abruzzo. Rapporto dal Questionari Studenti
 Rapporto dal Questionari Studenti SCUOLA xxxxxxxxx Anno Scolastico 2014/15 Le Aree Indagate Il questionario studenti ha lo scopo di indagare alcuni aspetti considerati rilevanti per assicurare il benessere
Rapporto dal Questionari Studenti SCUOLA xxxxxxxxx Anno Scolastico 2014/15 Le Aree Indagate Il questionario studenti ha lo scopo di indagare alcuni aspetti considerati rilevanti per assicurare il benessere
Istituto Comprensivo B.C. Ferrini Anno scolastico 2007-08. Le prove: cosa sono, come si svolgono, cosa accade dopo.
 Istituto Comprensivo B.C. Ferrini Anno scolastico 2007-08 2 Incontro informativo per i Genitori: Le prove: cosa sono, come si svolgono, cosa accade dopo. Progetto di monitoraggio delle capacità di lettoscrittura
Istituto Comprensivo B.C. Ferrini Anno scolastico 2007-08 2 Incontro informativo per i Genitori: Le prove: cosa sono, come si svolgono, cosa accade dopo. Progetto di monitoraggio delle capacità di lettoscrittura
Dislessia e mappe semantiche
 Dislessia e mappe semantiche Sperimentazione formale dell uso di Knowledge Master per l apprendimento dello studente dislessico Sarah Traversin Cos è la dislessia È un Disturbo Specifico dell Apprendimento
Dislessia e mappe semantiche Sperimentazione formale dell uso di Knowledge Master per l apprendimento dello studente dislessico Sarah Traversin Cos è la dislessia È un Disturbo Specifico dell Apprendimento
Diagnosi e trattamento dei DSA
 Franceschi, S., Lo Presti, G., Centro Studi Erickson (Trento), CentralMente Centro Neuropsicologia Clinica dello Sviluppo (Ascoli Piceno) Psicologo, Servizio di Neuropsicologia e Psicopatologia dell Apprendimento
Franceschi, S., Lo Presti, G., Centro Studi Erickson (Trento), CentralMente Centro Neuropsicologia Clinica dello Sviluppo (Ascoli Piceno) Psicologo, Servizio di Neuropsicologia e Psicopatologia dell Apprendimento
MATERIALI UTILI AI DOCENTI DI CLASSE PER RECUPERO E RINFORZO DEI BAMBINI INDIVIDUATI A RISCHIO NELLE RILEVAZIONI PRECOCI dei DSA
 ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 5 MATERIALI UTILI AI DOCENTI DI CLASSE PER RECUPERO E RINFORZO DEI BAMBINI INDIVIDUATI A RISCHIO NELLE RILEVAZIONI PRECOCI dei DSA Lavoro della commissione Area bisogni educativi
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 5 MATERIALI UTILI AI DOCENTI DI CLASSE PER RECUPERO E RINFORZO DEI BAMBINI INDIVIDUATI A RISCHIO NELLE RILEVAZIONI PRECOCI dei DSA Lavoro della commissione Area bisogni educativi
nell ambito della lettoscrittura
 Uno studente con dislessia è generalmente Una persona brillante Con difficoltà specifiche nell ambito della lettoscrittura LA LETTURA E un processo che ha come scopo la comprensione del significato di
Uno studente con dislessia è generalmente Una persona brillante Con difficoltà specifiche nell ambito della lettoscrittura LA LETTURA E un processo che ha come scopo la comprensione del significato di
Rapporto dal Questionari Insegnanti
 Rapporto dal Questionari Insegnanti SCUOLA CHIC81400N N. Docenti che hanno compilato il questionario: 60 Anno Scolastico 2014/15 Le Aree Indagate Il Questionario Insegnanti ha l obiettivo di rilevare la
Rapporto dal Questionari Insegnanti SCUOLA CHIC81400N N. Docenti che hanno compilato il questionario: 60 Anno Scolastico 2014/15 Le Aree Indagate Il Questionario Insegnanti ha l obiettivo di rilevare la
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 5
 ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 5 Indicazioni e MATERIALI UTILI AI DOCENTI DI CLASSE e alle famiglie PER RECUPERO E RINFORZO DEI BAMBINI INDIVIDUATI A RISCHIO NELLE RILEVAZIONI PRECOCI dei DSA Lavoro della
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 5 Indicazioni e MATERIALI UTILI AI DOCENTI DI CLASSE e alle famiglie PER RECUPERO E RINFORZO DEI BAMBINI INDIVIDUATI A RISCHIO NELLE RILEVAZIONI PRECOCI dei DSA Lavoro della
I Disturbi Specifici di Apprendimento. Brembati Federica Roberta Donini
 I Disturbi Specifici di Apprendimento Dott.ssa Brembati Federica Dott.ssa Roberta Donini Il disturbo specifico di apprendimento L uso del termine disturbo specifico dell apprendimento si riferisce a difficoltà
I Disturbi Specifici di Apprendimento Dott.ssa Brembati Federica Dott.ssa Roberta Donini Il disturbo specifico di apprendimento L uso del termine disturbo specifico dell apprendimento si riferisce a difficoltà
Principi generali. Vercelli 9-10 dicembre 2005. G. Bartolozzi - Firenze. Il Pediatra di famiglia e gli esami di laboratorio ASL Vercelli
 Il Pediatra di famiglia e gli esami di laboratorio ASL Vercelli Principi generali Carlo Federico Gauss Matematico tedesco 1777-1855 G. Bartolozzi - Firenze Vercelli 9-10 dicembre 2005 Oggi il nostro lavoro
Il Pediatra di famiglia e gli esami di laboratorio ASL Vercelli Principi generali Carlo Federico Gauss Matematico tedesco 1777-1855 G. Bartolozzi - Firenze Vercelli 9-10 dicembre 2005 Oggi il nostro lavoro
Giornate di supporto alla formazione dei referenti per la dislessia
 Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Associazione Italiana Dislessia Formazione MPI-AID Giornate di supporto alla formazione dei referenti per la dislessia
Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Associazione Italiana Dislessia Formazione MPI-AID Giornate di supporto alla formazione dei referenti per la dislessia
Metafonologia. Luciana Ventriglia. insegnante-pedagogista clinico Formatore A.I.D
 Metafonologia Luciana Ventriglia insegnante-pedagogista clinico Formatore A.I.D Definizione di competenza metafonologica È una particolare conoscenza metalinguistica che consiste nella capacità di percepire
Metafonologia Luciana Ventriglia insegnante-pedagogista clinico Formatore A.I.D Definizione di competenza metafonologica È una particolare conoscenza metalinguistica che consiste nella capacità di percepire
OSSERVAZIONI SISTEMATICHE DI RILEVAZIONE PRECOCE E ATTIVITA DI RECUPERO MIRATO (PRIMARIA)- Allegato A5
 OSSERVAZIONI SISTEMATICHE DI RILEVAZIONE PRECOCE E ATTIVITA DI MIRATO (PRIMARIA)- Allegato A5 Le Osservazioni Sistematiche di Rilevazione precoce di seguito previste, devono tener conto delle indicazioni
OSSERVAZIONI SISTEMATICHE DI RILEVAZIONE PRECOCE E ATTIVITA DI MIRATO (PRIMARIA)- Allegato A5 Le Osservazioni Sistematiche di Rilevazione precoce di seguito previste, devono tener conto delle indicazioni
Log. Marzia Lorenzini. S. Giorgio di Mantova 09 Dicembre 2013
 Log. Marzia Lorenzini S. Giorgio di Mantova 09 Dicembre 2013 Da Giocare con le parole 2 ED Erickson Capacità di percepire e riconoscere per via uditiva i fonemi che compongono le parole del linguaggio
Log. Marzia Lorenzini S. Giorgio di Mantova 09 Dicembre 2013 Da Giocare con le parole 2 ED Erickson Capacità di percepire e riconoscere per via uditiva i fonemi che compongono le parole del linguaggio
26/05/2015. Uno studente su 5 incontra difficoltà scolastiche, tali da richiedere l aiuto di un esperto. 25 maggio 2015. pamela@studioliberamente.
 Progetto di screening per Disturbi Specifici dell Apprendimento Tutti imparano a leggere e scrivere L apprendimento della lettura e della scrittura è un processo dato spesso per scontato In realtà richiede
Progetto di screening per Disturbi Specifici dell Apprendimento Tutti imparano a leggere e scrivere L apprendimento della lettura e della scrittura è un processo dato spesso per scontato In realtà richiede
DATI NORMATIVI PER LA SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE PAC-SI A BAMBINI DI INIZIO SCUOLA PRIMARIA 1
 DATI NORMATIVI PER LA SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE PAC-SI A BAMBINI DI INIZIO SCUOLA PRIMARIA 1 Marta Desimoni**, Daniela Pelagaggi**, Simona Fanini**, Loredana Romano**,Teresa Gloria Scalisi* * Dipartimento
DATI NORMATIVI PER LA SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE PAC-SI A BAMBINI DI INIZIO SCUOLA PRIMARIA 1 Marta Desimoni**, Daniela Pelagaggi**, Simona Fanini**, Loredana Romano**,Teresa Gloria Scalisi* * Dipartimento
Dislessia nell adulto e costruzione di protocolli di valutazione
 Dislessia nell adulto e costruzione di protocolli di valutazione A. M. Re Università degli studi di Padova Servizio per i Disturbi dell Apprendimento Evoluzione della velocità di lettura in normo-lettori
Dislessia nell adulto e costruzione di protocolli di valutazione A. M. Re Università degli studi di Padova Servizio per i Disturbi dell Apprendimento Evoluzione della velocità di lettura in normo-lettori
Istruzioni per leggere bene. Istruzioni per leggere bene
 Istruzioni per leggere bene A cura di Silvana Loiero 1 La lettura orientativa La prima: farsi un idea generale La seconda: identificare le parti La terza: scorrere indici e sintesi La quarta: leggere rapidamente
Istruzioni per leggere bene A cura di Silvana Loiero 1 La lettura orientativa La prima: farsi un idea generale La seconda: identificare le parti La terza: scorrere indici e sintesi La quarta: leggere rapidamente
Uso di base delle funzioni in Microsoft Excel
 Uso di base delle funzioni in Microsoft Excel Le funzioni Una funzione è un operatore che applicato a uno o più argomenti (valori, siano essi numeri con virgola, numeri interi, stringhe di caratteri) restituisce
Uso di base delle funzioni in Microsoft Excel Le funzioni Una funzione è un operatore che applicato a uno o più argomenti (valori, siano essi numeri con virgola, numeri interi, stringhe di caratteri) restituisce
SINTETICO COLLETTIVO E INDIVIDUALE
 MANUALE DI USO Documento: Manuale R01 SINTETICO COLLETTIVO E INDIVIDUALE Ultima revisione 25 Novembre 2015 ManR01 Sintetico collettivo e individuale 25 novembre 2015 Pag. 1 SINTETICO COLLETTIVO E INDIVIDUALE
MANUALE DI USO Documento: Manuale R01 SINTETICO COLLETTIVO E INDIVIDUALE Ultima revisione 25 Novembre 2015 ManR01 Sintetico collettivo e individuale 25 novembre 2015 Pag. 1 SINTETICO COLLETTIVO E INDIVIDUALE
LINEE GUIDA PER UN CORRETTO INSERIMENTO DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
 LINEE GUIDA PER UN CORRETTO INSERIMENTO DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO Tratte da: Progetto A scuola di dislessia Teramo 28 Ottobre 2010 I.T.C. Pascal Seminario di studio Prospettive
LINEE GUIDA PER UN CORRETTO INSERIMENTO DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO Tratte da: Progetto A scuola di dislessia Teramo 28 Ottobre 2010 I.T.C. Pascal Seminario di studio Prospettive
da 2 a 5 giocatori, dai 10 anni in su, durata 30 minuti
 da 2 a 5 giocatori, dai 10 anni in su, durata 30 minuti OBIETTIVO Il vincitore è colui che, dopo due round di gioco, delle sue 11 ordinazioni, ne ha consegnate il maggior numero. CONTENUTO DELLA SCATOLA
da 2 a 5 giocatori, dai 10 anni in su, durata 30 minuti OBIETTIVO Il vincitore è colui che, dopo due round di gioco, delle sue 11 ordinazioni, ne ha consegnate il maggior numero. CONTENUTO DELLA SCATOLA
Probabilità condizionata: p(a/b) che avvenga A, una volta accaduto B. Evento prodotto: Evento in cui si verifica sia A che B ; p(a&b) = p(a) x p(b/a)
 Probabilità condizionata: p(a/b) che avvenga A, una volta accaduto B Eventi indipendenti: un evento non influenza l altro Eventi disgiunti: il verificarsi di un evento esclude l altro Evento prodotto:
Probabilità condizionata: p(a/b) che avvenga A, una volta accaduto B Eventi indipendenti: un evento non influenza l altro Eventi disgiunti: il verificarsi di un evento esclude l altro Evento prodotto:
DIMENSIONI CRITERI INDICATORI
 Allegato 4 - Manerbio META EDUCATIVA: autonomia in ambito scolastico (classe 4/5 scuola primaria) DIMENSIONI CRITERI INDICATORI GESTIONALE OPERATIVA Uso degli strumenti Conoscere gli strumenti necessari
Allegato 4 - Manerbio META EDUCATIVA: autonomia in ambito scolastico (classe 4/5 scuola primaria) DIMENSIONI CRITERI INDICATORI GESTIONALE OPERATIVA Uso degli strumenti Conoscere gli strumenti necessari
NOTE DI APPROFONDIMENTO SU ALCUNI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
 SCHEDA TECNICA NOTE DI APPROFONDIMENTO SU ALCUNI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 1 - PREMESSA Con questo allegato si intendono offrire spunti operativi per una migliore pratica didattica nei confronti
SCHEDA TECNICA NOTE DI APPROFONDIMENTO SU ALCUNI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 1 - PREMESSA Con questo allegato si intendono offrire spunti operativi per una migliore pratica didattica nei confronti
L intelligenza numerica
 L intelligenza numerica Consiste nel pensare il mondo in termini di quantità. Ha una forte base biologica, sia gli animali che i bambini molto piccoli sanno distinguere poco e molto. È potentissima e può
L intelligenza numerica Consiste nel pensare il mondo in termini di quantità. Ha una forte base biologica, sia gli animali che i bambini molto piccoli sanno distinguere poco e molto. È potentissima e può
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBERINO MUGELLO
 IL PESO percorso didattico scuola primaria Sperimentazione didattica ISTITUTO COMPRENSIVO BARBERINO MUGELLO I bambini utilizzano spontaneamente il concetto di pesante? Collochiamo su un banco alcuni oggetti:
IL PESO percorso didattico scuola primaria Sperimentazione didattica ISTITUTO COMPRENSIVO BARBERINO MUGELLO I bambini utilizzano spontaneamente il concetto di pesante? Collochiamo su un banco alcuni oggetti:
Prof.ssa Patrizia Arrigo Istituto Finocchiaro Aprile di Palermo
 Esempio di progetto Screening per la rilevazione dei DSA in una scuola secondaria di secondo grado Istituto Finocchiaro Aprile di Palermo Sequenza dell intervento. Prima fase All inizio del primo quadrimestre
Esempio di progetto Screening per la rilevazione dei DSA in una scuola secondaria di secondo grado Istituto Finocchiaro Aprile di Palermo Sequenza dell intervento. Prima fase All inizio del primo quadrimestre
ISTITUTO COMPRENSIVO FAUGLIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO FAUGLIA CAMBIAMENTI NEL TEMPO (1 rilevazione - 2 rilevazione) DELLE PROVE DI APPRENDIMENTO: RISULTATI Nella prova di correttezza in lettura ai bambini veniva chiesto di leggere a voce
ISTITUTO COMPRENSIVO FAUGLIA CAMBIAMENTI NEL TEMPO (1 rilevazione - 2 rilevazione) DELLE PROVE DI APPRENDIMENTO: RISULTATI Nella prova di correttezza in lettura ai bambini veniva chiesto di leggere a voce
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEGROTTO TERME SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINA: MATEMATICA - CLASSE PRIMA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 PRIMA DELLA DISCIPLINA: MATEMATICA - CLASSE PRIMA L alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
PRIMA DELLA DISCIPLINA: MATEMATICA - CLASSE PRIMA L alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
Pensiero logico, lettura, Autori: Sestili, Moalli, Vianello
 Pensiero logico, lettura, scrittura e abilità di calcolo in ragazzi con sindrome di Down di 2 2 e 3 3 media Autori: Sestili, Moalli, Vianello Toffolon Sara Introduzione La ricerca si propone di rilevare
Pensiero logico, lettura, scrittura e abilità di calcolo in ragazzi con sindrome di Down di 2 2 e 3 3 media Autori: Sestili, Moalli, Vianello Toffolon Sara Introduzione La ricerca si propone di rilevare
I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
 I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO Si parla di disturbo specifico di apprendimento quando un soggetto in età evolutiva presenta difficoltà isolate e circoscritte
I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO Si parla di disturbo specifico di apprendimento quando un soggetto in età evolutiva presenta difficoltà isolate e circoscritte
Sviluppo del linguaggio. Le fasi dello sviluppo del linguaggio
 Sviluppo del linguaggio Le fasi dello sviluppo del linguaggio 1 2 Sviluppo del linguaggio: fase pre-linguistica I bambini sviluppano la capacità di parlare secondo una sequenza ordinata di fasi: passando
Sviluppo del linguaggio Le fasi dello sviluppo del linguaggio 1 2 Sviluppo del linguaggio: fase pre-linguistica I bambini sviluppano la capacità di parlare secondo una sequenza ordinata di fasi: passando
Guida Compilazione Piani di Studio on-line
 Guida Compilazione Piani di Studio on-line SIA (Sistemi Informativi d Ateneo) Visualizzazione e presentazione piani di studio ordinamento 509 e 270 Università della Calabria (Unità organizzativa complessa-
Guida Compilazione Piani di Studio on-line SIA (Sistemi Informativi d Ateneo) Visualizzazione e presentazione piani di studio ordinamento 509 e 270 Università della Calabria (Unità organizzativa complessa-
APPUNTI SU PROBLEMI CON CALCOLO PERCENTUALE
 APPUNTI SU PROBLEMI CON CALCOLO PERCENTUALE 1. Proporzionalità diretta e proporzionalità inversa Analizziamo le seguenti formule Peso Lordo = Peso Netto + Tara Ricavo = Utile + Costo Rata = Importo + Interesse
APPUNTI SU PROBLEMI CON CALCOLO PERCENTUALE 1. Proporzionalità diretta e proporzionalità inversa Analizziamo le seguenti formule Peso Lordo = Peso Netto + Tara Ricavo = Utile + Costo Rata = Importo + Interesse
Bisogni Educativi Speciali
 Bisogni Educativi Speciali BES, tre grandi sotto-categorie: disabilità; disturbi evolutivi specifici e svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. CHE FARE? Di Lucia ZANELLATO Disturbi Evolutivi
Bisogni Educativi Speciali BES, tre grandi sotto-categorie: disabilità; disturbi evolutivi specifici e svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. CHE FARE? Di Lucia ZANELLATO Disturbi Evolutivi
Difficoltà e disturbi specifici di apprendimento: dalla valutazione al potenziamento delle abilità
 Difficoltà e disturbi specifici di apprendimento: dalla valutazione al potenziamento delle abilità 13 gennaio 2012 Barbara Carta Barbara Carta Fattori predittivi dei DSA Gli è stato diagnosticato questo
Difficoltà e disturbi specifici di apprendimento: dalla valutazione al potenziamento delle abilità 13 gennaio 2012 Barbara Carta Barbara Carta Fattori predittivi dei DSA Gli è stato diagnosticato questo
POLO OPERATIVO DISLESSIA ASP
 Associazione Italiana Dislessia & Azienda Sanitaria Potenza & Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Ambito provinciale di Potenza PREMESSA Progetto di individuazione precoce delle difficoltà di
Associazione Italiana Dislessia & Azienda Sanitaria Potenza & Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Ambito provinciale di Potenza PREMESSA Progetto di individuazione precoce delle difficoltà di
DISTURBI SPECIFICI DELL APPRENDIMENTO RUOLO DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA
 DISTURBI SPECIFICI DELL APPRENDIMENTO RUOLO DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA DSA COSA SONO? costituiscono un termine di carattere generale che si riferisce ad un gruppo eterogeneo di disordini che si manifestano
DISTURBI SPECIFICI DELL APPRENDIMENTO RUOLO DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA DSA COSA SONO? costituiscono un termine di carattere generale che si riferisce ad un gruppo eterogeneo di disordini che si manifestano
IMPARARE A LEGGERE E SCRIVERE IN ITALIANO L2
 Arcangela Mastromarco IMPARARE A LEGGERE E SCRIVERE IN ITALIANO L2 Centro COME 2002 Centro COME, Farsi Prossimo Onlus www.centrocome.it 1 Presentazione IMPARARE A LEGGERE E SCRIVERE IN ITALIANO L2 La declinazione
Arcangela Mastromarco IMPARARE A LEGGERE E SCRIVERE IN ITALIANO L2 Centro COME 2002 Centro COME, Farsi Prossimo Onlus www.centrocome.it 1 Presentazione IMPARARE A LEGGERE E SCRIVERE IN ITALIANO L2 La declinazione
LE STRATEGIE DI COPING
 Il concetto di coping, che può essere tradotto con fronteggiamento, gestione attiva, risposta efficace, capacità di risolvere i problemi, indica l insieme di strategie mentali e comportamentali che sono
Il concetto di coping, che può essere tradotto con fronteggiamento, gestione attiva, risposta efficace, capacità di risolvere i problemi, indica l insieme di strategie mentali e comportamentali che sono
PROGRAMMAZIONE ANNUALE per la classe prima. Matematica
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SORISOLE Scuole Primarie PROGRAMMAZIONE ANNUALE per la classe prima Matematica Anno Scolastico 2015/ 2016 COMPETENZE : A -NUMERO Comprende il significato dei numeri, i modi per
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SORISOLE Scuole Primarie PROGRAMMAZIONE ANNUALE per la classe prima Matematica Anno Scolastico 2015/ 2016 COMPETENZE : A -NUMERO Comprende il significato dei numeri, i modi per
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI LINGUA ITALIANA - SCUOLA PRIMARIA IST. COMP. DON MILANI CERNUSCO S/N -
 PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI LINGUA ITALIANA - SCUOLA PRIMARIA IST. COMP. DON MILANI CERNUSCO S/N - LINGUA ITALIANA: PROGRAMMAZIONE CLASSE PRIMA 1 ASCOLTARE, COMPRENDERE, 1.1 Prendere la parola negli scambi
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI LINGUA ITALIANA - SCUOLA PRIMARIA IST. COMP. DON MILANI CERNUSCO S/N - LINGUA ITALIANA: PROGRAMMAZIONE CLASSE PRIMA 1 ASCOLTARE, COMPRENDERE, 1.1 Prendere la parola negli scambi
Energia potenziale elettrica e potenziale. In queste pagine R indicherà una regione in cui è presente un campo elettrostatico.
 Energia potenziale elettrica e potenziale 0. Premessa In queste pagine R indicherà una regione in cui è presente un campo elettrostatico. 1. La forza elettrostatica è conservativa Una o più cariche ferme
Energia potenziale elettrica e potenziale 0. Premessa In queste pagine R indicherà una regione in cui è presente un campo elettrostatico. 1. La forza elettrostatica è conservativa Una o più cariche ferme
I disturbi di comprensione del testo scritto
 I disturbi di comprensione del testo scritto Le difficoltà nella comprensione del testo sono pervasive e difficili da identificare. L insegnante avverte una sensazione di disagio nell interazione con il
I disturbi di comprensione del testo scritto Le difficoltà nella comprensione del testo sono pervasive e difficili da identificare. L insegnante avverte una sensazione di disagio nell interazione con il
s.c. di NPI Savigliano-Fossano-Saluzzo Log.Allamandri Valeria (mail: valeria.allamandri@aslcn1.it)
 s.c. di NPI Savigliano-Fossano-Saluzzo Log.Allamandri Valeria (mail: valeria.allamandri@aslcn1.it) Criteri Un trattamento riabilitativo dipenda da: Condizioni cliniche Età Motivazione Disponibilità e tempi
s.c. di NPI Savigliano-Fossano-Saluzzo Log.Allamandri Valeria (mail: valeria.allamandri@aslcn1.it) Criteri Un trattamento riabilitativo dipenda da: Condizioni cliniche Età Motivazione Disponibilità e tempi
COME SI IMPARA A LEGGERE E A SCRIVERE?
 COME SI IMPARA A LEGGERE E A SCRIVERE? a cura della Counselor Psicopedagogica dott.ssa P. Paolini Ogni bambino ha una sua SCRITTURA SPONTANEA TEORIA LINGUISTICA: idee e regole che ha ricavato osservando
COME SI IMPARA A LEGGERE E A SCRIVERE? a cura della Counselor Psicopedagogica dott.ssa P. Paolini Ogni bambino ha una sua SCRITTURA SPONTANEA TEORIA LINGUISTICA: idee e regole che ha ricavato osservando
DSA Come costruire un Piano Didattico Personalizzato efficace. Grazia Mazzocchi
 DSA Come costruire un Piano Didattico Personalizzato efficace Grazia Mazzocchi Faenza 25 Febbraio 2015 Centro Territoriale di Supporto per le disabilità Http://cts.w.istruzioneer.it/ DSA e normativa di
DSA Come costruire un Piano Didattico Personalizzato efficace Grazia Mazzocchi Faenza 25 Febbraio 2015 Centro Territoriale di Supporto per le disabilità Http://cts.w.istruzioneer.it/ DSA e normativa di
Da dove nasce l idea dei video
 Da dove nasce l idea dei video Per anni abbiamo incontrato i potenziali clienti presso le loro sedi, come la tradizione commerciale vuole. L incontro nasce con una telefonata che il consulente fa a chi
Da dove nasce l idea dei video Per anni abbiamo incontrato i potenziali clienti presso le loro sedi, come la tradizione commerciale vuole. L incontro nasce con una telefonata che il consulente fa a chi
Che cos è l intelligenza e come funzionano i test del Q.I.
 Che cos è l intelligenza e come funzionano i test del Q.I. Non esiste, al giorno d oggi, un parere unanime della comunità scientifica sulla definizione di intelligenza. In generale, potremmo dire che è
Che cos è l intelligenza e come funzionano i test del Q.I. Non esiste, al giorno d oggi, un parere unanime della comunità scientifica sulla definizione di intelligenza. In generale, potremmo dire che è
AIIDA Associazione Italiana per l Infanzia nelle Difficoltà di Apprendimento
 Associazione Italiana per l Infanzia nelle Difficoltà di Apprendimento INDIVIDUARE PER PREVENIRE E INTERVENIRE PROGETTO PER LA PREVENZIONE E VALUTAZIONE PRECOCE NELLA SCUOLA DELL INFANZIA DELLE DIFFICOLTA
Associazione Italiana per l Infanzia nelle Difficoltà di Apprendimento INDIVIDUARE PER PREVENIRE E INTERVENIRE PROGETTO PER LA PREVENZIONE E VALUTAZIONE PRECOCE NELLA SCUOLA DELL INFANZIA DELLE DIFFICOLTA
UNIVERSITA DELLA CALABRIA A.A
 UNIVERSITA DELLA CALABRIA A.A. 2012/2013 CORSO AGGIUNTIVO PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE PER GLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP NELLA SCUOLA DELL INFANZIA (MATERNA) E NELLA SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) Educazione
UNIVERSITA DELLA CALABRIA A.A. 2012/2013 CORSO AGGIUNTIVO PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE PER GLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP NELLA SCUOLA DELL INFANZIA (MATERNA) E NELLA SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) Educazione
QUALI SONO GLI INDICATORI CHE POSSONO FARTI VENIRE IL DUBBIO CHE UN BAMBINO ABBIA UN DSA?
 QUALI SONO GLI INDICATORI CHE POSSONO FARTI VENIRE IL DUBBIO CHE UN BAMBINO ABBIA UN DSA? WWW.DIDATTICAPERSUASIVA.COM Sicuramente un inattesa difficoltà nella acquisizione della lettura e della scrittura
QUALI SONO GLI INDICATORI CHE POSSONO FARTI VENIRE IL DUBBIO CHE UN BAMBINO ABBIA UN DSA? WWW.DIDATTICAPERSUASIVA.COM Sicuramente un inattesa difficoltà nella acquisizione della lettura e della scrittura
«Documentazione dell'apprendimento»
 Pagina: 1 di 9 Indice «Documentazione dell'apprendimento» Apprendista:... NPA / Località:... Azienda:... NPA / Località:... Parte 1 Scheda informativa Introduzione alla documentazione dell'apprendimento
Pagina: 1 di 9 Indice «Documentazione dell'apprendimento» Apprendista:... NPA / Località:... Azienda:... NPA / Località:... Parte 1 Scheda informativa Introduzione alla documentazione dell'apprendimento
2.0 Gli archivi. 2.1 Inserire gli archivi. 2.2 Archivio Clienti, Fornitori, Materiali, Noleggi ed Altri Costi. Impresa Edile Guida all uso
 2.0 Gli archivi All interno della sezione archivi sono inserite le anagrafiche. In pratica si stratta di tutti quei dati che ricorreranno costantemente all interno dei documenti. 2.1 Inserire gli archivi
2.0 Gli archivi All interno della sezione archivi sono inserite le anagrafiche. In pratica si stratta di tutti quei dati che ricorreranno costantemente all interno dei documenti. 2.1 Inserire gli archivi
SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO DI ITALIANO SECONDO BIENNIO
 SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO DI ITALIANO SECONDO BIENNIO CLASSI TERZA E QUARTA Competenza 1. Interagire e comunicare oralmente in contesti di diversa natura. Al termine del II biennio ( 3^ e 4^ Scuola Primaria)
SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO DI ITALIANO SECONDO BIENNIO CLASSI TERZA E QUARTA Competenza 1. Interagire e comunicare oralmente in contesti di diversa natura. Al termine del II biennio ( 3^ e 4^ Scuola Primaria)
f(x) = 1 x. Il dominio di questa funzione è il sottoinsieme proprio di R dato da
 Data una funzione reale f di variabile reale x, definita su un sottoinsieme proprio D f di R (con questo voglio dire che il dominio di f è un sottoinsieme di R che non coincide con tutto R), ci si chiede
Data una funzione reale f di variabile reale x, definita su un sottoinsieme proprio D f di R (con questo voglio dire che il dominio di f è un sottoinsieme di R che non coincide con tutto R), ci si chiede
CURRICOLO di ITALIANO classe terza
 CURRICOLO di ITALIANO classe terza 1 TERZA NUCLEO DISCIPLINARE: A COLTO E PARLATO OBIETTIVO GENERALE: A - ascoltare, comprendere e comunicare oralmente CONTENUTI ATTIVITA Ascolto e comprensione di testi
CURRICOLO di ITALIANO classe terza 1 TERZA NUCLEO DISCIPLINARE: A COLTO E PARLATO OBIETTIVO GENERALE: A - ascoltare, comprendere e comunicare oralmente CONTENUTI ATTIVITA Ascolto e comprensione di testi
LA COMBUSTIONE. Proposta didattica per la classe terza. Istituto Comprensivo di Barberino di Mugello Galliano. Anno scolastico 2011-2012
 LA COMBUSTIONE Proposta didattica per la classe terza Istituto Comprensivo di Barberino di Mugello Galliano Anno scolastico 2011-2012 IL FUOCO IO SO CHE Iniziamo il percorso con una conversazione: parliamo
LA COMBUSTIONE Proposta didattica per la classe terza Istituto Comprensivo di Barberino di Mugello Galliano Anno scolastico 2011-2012 IL FUOCO IO SO CHE Iniziamo il percorso con una conversazione: parliamo
Discussione di casi clinici
 Discussione di casi clinici Marcella Ferrari marcella.ferrari@unipv.it Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Pavia Laboratorio di Psicologia dell Apprendimento Master in Esperto in Disturbi dell
Discussione di casi clinici Marcella Ferrari marcella.ferrari@unipv.it Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Pavia Laboratorio di Psicologia dell Apprendimento Master in Esperto in Disturbi dell
Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2012 2013 per gli allievi con bisogni educativi speciali
 Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2012 2013 per gli allievi con bisogni educativi speciali 1 A.S. 2012 13 Bisogni educativi speciali. Documento pubblicato il 23.4.2013 1. Premessa A titolo di
Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2012 2013 per gli allievi con bisogni educativi speciali 1 A.S. 2012 13 Bisogni educativi speciali. Documento pubblicato il 23.4.2013 1. Premessa A titolo di
Elementi di Psicometria con Laboratorio di SPSS 1
 Elementi di Psicometria con Laboratorio di SPSS 1 12-Il t-test per campioni appaiati vers. 1.2 (7 novembre 2014) Germano Rossi 1 germano.rossi@unimib.it 1 Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca
Elementi di Psicometria con Laboratorio di SPSS 1 12-Il t-test per campioni appaiati vers. 1.2 (7 novembre 2014) Germano Rossi 1 germano.rossi@unimib.it 1 Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca
Ferreiro e Teberosky. Ferreiro e Teberosky. Lo sviluppo delle idee sulla scrittura
 Ferreiro e Teberosky Ferreiro e Teberosky Lo sviluppo delle idee sulla scrittura Studiose di orientamento piagetiano Studio sullo sviluppo delle conoscenze Piaget rappresentazione dei fenomeni fisici nel
Ferreiro e Teberosky Ferreiro e Teberosky Lo sviluppo delle idee sulla scrittura Studiose di orientamento piagetiano Studio sullo sviluppo delle conoscenze Piaget rappresentazione dei fenomeni fisici nel
CURRICOLO DISCIPLINARE DI ITALIANO ASCOLTO E PARLATO. Traguardi per lo sviluppo delle competenze. Obiettivi di apprendimento( conoscenze e
 CURRICOLO DISCIPLINARE DI ITALIANO ASCOLTO E PARLATO Traguardi per lo sviluppo delle competenze 1.Partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti, formulando messaggi chiari e pertinenti Obiettivi
CURRICOLO DISCIPLINARE DI ITALIANO ASCOLTO E PARLATO Traguardi per lo sviluppo delle competenze 1.Partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti, formulando messaggi chiari e pertinenti Obiettivi
Dalla Diagnosi Funzionale al PEI. Valutazione delle abilità attraverso l osservazione del comportamento e i test
 Dalla Diagnosi Funzionale al PEI Valutazione delle abilità attraverso l osservazione del comportamento e i test Effetti del non Valutare Sopravvalutare Problemi di comportamento (isolamento) Sottovalutare
Dalla Diagnosi Funzionale al PEI Valutazione delle abilità attraverso l osservazione del comportamento e i test Effetti del non Valutare Sopravvalutare Problemi di comportamento (isolamento) Sottovalutare
Come valutare le caratteristiche aerobiche di ogni singolo atleta sul campo
 Come valutare le caratteristiche aerobiche di ogni singolo atleta sul campo Prima di organizzare un programma di allenamento al fine di elevare il livello di prestazione, è necessario valutare le capacità
Come valutare le caratteristiche aerobiche di ogni singolo atleta sul campo Prima di organizzare un programma di allenamento al fine di elevare il livello di prestazione, è necessario valutare le capacità
COME PARLARE DI DISLESSIA IN CLASSE.
 COME PARLARE DI DISLESSIA IN CLASSE. UNA METAFORA PER SPIEGARE I DSA La psicologa americana ANIA SIWEK ha sviluppato in anni di pratica professionale un modo semplice ed efficace di spiegare i DSA ai bambini,
COME PARLARE DI DISLESSIA IN CLASSE. UNA METAFORA PER SPIEGARE I DSA La psicologa americana ANIA SIWEK ha sviluppato in anni di pratica professionale un modo semplice ed efficace di spiegare i DSA ai bambini,
REVISIONE-CORREZIONE. La Revisione è un momento molto importante nel processo della produzione scritta.
 REVISIONE-CORREZIONE La Revisione è un momento molto importante nel processo della produzione scritta. Il termine viene dato ai ragazzi verso la quarta, ma in realtà dovrebbe essere considerata parte integrante
REVISIONE-CORREZIONE La Revisione è un momento molto importante nel processo della produzione scritta. Il termine viene dato ai ragazzi verso la quarta, ma in realtà dovrebbe essere considerata parte integrante
Project Cycle Management
 Project Cycle Management Tre momenti centrali della fase di analisi: analisi dei problemi, analisi degli obiettivi e identificazione degli ambiti di intervento Il presente materiale didattico costituisce
Project Cycle Management Tre momenti centrali della fase di analisi: analisi dei problemi, analisi degli obiettivi e identificazione degli ambiti di intervento Il presente materiale didattico costituisce
Memory Fitness TECNICHE DI MEMORIA
 Memory Fitness TECNICHE DI MEMORIA IL CERVELLO E LE SUE RAPPRESENTAZIONI Il cervello e le sue rappresentazioni (1/6) Il cervello e le sue rappresentazioni (2/6) Approfondiamo ora come possiamo ulteriormente
Memory Fitness TECNICHE DI MEMORIA IL CERVELLO E LE SUE RAPPRESENTAZIONI Il cervello e le sue rappresentazioni (1/6) Il cervello e le sue rappresentazioni (2/6) Approfondiamo ora come possiamo ulteriormente
PIL : produzione e reddito
 PIL : produzione e reddito La misura della produzione aggregata nella contabilità nazionale è il prodotto interno lordo o PIL. Dal lato della produzione : oppure 1) Il PIL è il valore dei beni e dei servizi
PIL : produzione e reddito La misura della produzione aggregata nella contabilità nazionale è il prodotto interno lordo o PIL. Dal lato della produzione : oppure 1) Il PIL è il valore dei beni e dei servizi
A SCUOLA DI PAROLE. ATTIVITA PER I BIMBI DI 5 ANNI lavori di gruppo per docenti della Scuola dell Infanzia
 A SCUOLA DI PAROLE ATTIVITA PER I BIMBI DI 5 ANNI lavori di gruppo per docenti della Scuola dell Infanzia Lunedì 17 novembre 2014 Venerdì 30 gennaio 2015 Lunedì 11 maggio 2015 Chiara Portoraro - logopedista
A SCUOLA DI PAROLE ATTIVITA PER I BIMBI DI 5 ANNI lavori di gruppo per docenti della Scuola dell Infanzia Lunedì 17 novembre 2014 Venerdì 30 gennaio 2015 Lunedì 11 maggio 2015 Chiara Portoraro - logopedista
Metodi di alfabetizzazione
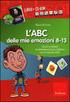 Metodi di alfabetizzazione a cura di Ambra Gasparetto Risorse dei non alfabetizzati Gli immigrati stranieri sono spesso più veloci nell apprendimento degli analfabeti italiani (che se al giorno d oggi
Metodi di alfabetizzazione a cura di Ambra Gasparetto Risorse dei non alfabetizzati Gli immigrati stranieri sono spesso più veloci nell apprendimento degli analfabeti italiani (che se al giorno d oggi
Indagine e rilevazione sulle abilità di lettura
 Indagine e rilevazione sulle abilità di lettura Prova individuale di correttezza e rapidità nella lettura La prova di lettura ad alta voce si è dimostrata estremamente utile per riconoscere il livello
Indagine e rilevazione sulle abilità di lettura Prova individuale di correttezza e rapidità nella lettura La prova di lettura ad alta voce si è dimostrata estremamente utile per riconoscere il livello
G iochi con le carte 1
 Giochi con le carte 1 PREPARAZIONE E DESCRIZIONE DELLE CARTE L insegnante prepara su fogli A3 e distribuisce agli allievi le fotocopie dei tre diversi tipi di carte. Invita poi ciascun allievo a piegare
Giochi con le carte 1 PREPARAZIONE E DESCRIZIONE DELLE CARTE L insegnante prepara su fogli A3 e distribuisce agli allievi le fotocopie dei tre diversi tipi di carte. Invita poi ciascun allievo a piegare
Il contributo della Psicologia dell apprendimento scolastico all Evidence Based Education. Lucia Bigozzi Università di Firenze
 Il contributo della Psicologia dell apprendimento scolastico all Evidence Based Education Lucia Bigozzi Università di Firenze Lucia Bigozzi Università di Firenze Cosa devo fare con un alunno che ha un
Il contributo della Psicologia dell apprendimento scolastico all Evidence Based Education Lucia Bigozzi Università di Firenze Lucia Bigozzi Università di Firenze Cosa devo fare con un alunno che ha un
AVVIO ALLA LETTO - SCRITTURA. Come scegliere un approccio corretto per presentare la lettura e avviare alla scrittura
 AVVIO ALLA LETTO - SCRITTURA Come scegliere un approccio corretto per presentare la lettura e avviare alla scrittura TEMPI NEI PRIMI 10/15 GIORNI DI SCUOLA ASPETTO FONOLOGICO COMPRENSIONE DEI MESSAGGI
AVVIO ALLA LETTO - SCRITTURA Come scegliere un approccio corretto per presentare la lettura e avviare alla scrittura TEMPI NEI PRIMI 10/15 GIORNI DI SCUOLA ASPETTO FONOLOGICO COMPRENSIONE DEI MESSAGGI
I DISTURBI SPECIFICI DELL APPRENDIMENTO. Dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia. Dott.ssa Patrizia Nagliati
 I DISTURBI SPECIFICI DELL APPRENDIMENTO Dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia. Dott.ssa Patrizia Nagliati Psicologo perf. In Neuropsicologia COME SI SVILUPPA UN ABILITA Predisposizione innata
I DISTURBI SPECIFICI DELL APPRENDIMENTO Dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia. Dott.ssa Patrizia Nagliati Psicologo perf. In Neuropsicologia COME SI SVILUPPA UN ABILITA Predisposizione innata
Analisi sensitività. Strumenti per il supporto alle decisioni nel processo di Valutazione d azienda
 Analisi sensitività. Strumenti per il supporto alle decisioni nel processo di Valutazione d azienda Premessa Con l analisi di sensitività il perito valutatore elabora un range di valori invece di un dato
Analisi sensitività. Strumenti per il supporto alle decisioni nel processo di Valutazione d azienda Premessa Con l analisi di sensitività il perito valutatore elabora un range di valori invece di un dato
Ins.Fiorella Dellasera
 I bambini che si avvicinano alla lettoscrittura in una prima elementare, sono fra loro molto eterogenei e l apprendimento successivo sarà notevolmente influenzato da: Abilità di base Metodologia utilizzata
I bambini che si avvicinano alla lettoscrittura in una prima elementare, sono fra loro molto eterogenei e l apprendimento successivo sarà notevolmente influenzato da: Abilità di base Metodologia utilizzata
Cosa sono i Bisogni Educativi Speciali?
 Pagina 1 di 5 Cosa sono i Bisogni Educativi Speciali? I BES sono le necessità di tutti quelli alunni che presentano delle particolarità che impediscono il loro normale apprendimento e richiedono interventi
Pagina 1 di 5 Cosa sono i Bisogni Educativi Speciali? I BES sono le necessità di tutti quelli alunni che presentano delle particolarità che impediscono il loro normale apprendimento e richiedono interventi
CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA
 CLASSI seconde CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA LINGUA ITALIANA l alunno utilizza in maniera appropriata il codice linguistico per descrivere, narrare argomentare. si esprime in modo
CLASSI seconde CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA LINGUA ITALIANA l alunno utilizza in maniera appropriata il codice linguistico per descrivere, narrare argomentare. si esprime in modo
~ Copyright Ripetizionando - All rights reserved ~ http://ripetizionando.wordpress.com STUDIO DI FUNZIONE
 STUDIO DI FUNZIONE Passaggi fondamentali Per effettuare uno studio di funzione completo, che non lascia quindi margine a una quasi sicuramente errata inventiva, sono necessari i seguenti 7 passaggi: 1.
STUDIO DI FUNZIONE Passaggi fondamentali Per effettuare uno studio di funzione completo, che non lascia quindi margine a una quasi sicuramente errata inventiva, sono necessari i seguenti 7 passaggi: 1.
Accoglienza come costruzione e condivisione di regole comuni. BENVENUTI NELLA NOSTRA SCUOLA Convegno 10 settembre 2015 Mirella Cova UST - Mantova
 Accoglienza come costruzione e condivisione di regole comuni BENVENUTI NELLA NOSTRA SCUOLA Convegno 10 settembre 2015 Mirella Cova UST - Mantova Accoglienza Integrazione scolastica sociale Alfabetizzazione
Accoglienza come costruzione e condivisione di regole comuni BENVENUTI NELLA NOSTRA SCUOLA Convegno 10 settembre 2015 Mirella Cova UST - Mantova Accoglienza Integrazione scolastica sociale Alfabetizzazione
