IL GRADIENTE IMPLICITO NELLA VERIFICA A FATICA DI GIUNZIONI SALDATE SOLLECITATE A FATICA
|
|
|
- Camilla Scala
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 IL GRADIENTE IMPLICITO NELLA VERIFICA A FATICA DI GIUNZIONI SALDATE SOLLECITATE A FATICA R. Tovo, P. Livieri Università di Ferrara, Dipartimento di Ingegneria, via Saragat 1, 440 Ferrara roberto.tovo@unife.it; paolo.livieri@unife.it SOMMARIO L incremento delle potenzialità di strumenti per la progettazione assistita (come modellatori solidi e strumenti per FEA in grado di gestire modelli molto complessi) permette di ipotizzare lo sviluppo di strumenti numerici specifici per la previsione della resistenza a fatica delle giunzioni saldate. Tali strumenti potrebbero essere in grado di valutare l influenza di geometria e carichi senza la necessità di elaborazioni successive, e spesso, del progettista (come nelle tensioni di Hot Spot). Il presente lavoro propone una metodologia di calcolo adatta alla previsione della vita a fatica di giunzioni saldate complesse. Un indice di resistenza è ottenuto innanzitutto risolvendo il problema tensionale completamente in modo numerico (agli elementi finiti). La previsione della resistenza a fatica, è calcolata facendo uso di un modello analitico basato sul gradiente implicito che assume come tensione efficace la tensione equivalente non locale derivante dalla tensione principale. Dapprima verrà tarato il metodo su prove sperimentali eseguite su giunzioni saldate a croce, successivamente il metodo verrà utilizzato per la verifica a fatica di giunzioni saldate più complesse a sviluppo tridimensionale. ABSTRACT In this paper, a non-local equivalent stress is calculated by solving a second order differential equation of implicit type. The solution is obtained by assuming a linear elastic constitutive behaviour and the maximum principal stress as equivalent stress. Fatigue behaviour of steel welded joints is taken into account and a general fatigue scatter band is proposed. The non local stress is computed, namely the effective stress, by means of a completely numerical solution of local elastic stress field. In complex 3D welded details the critical point turns out from the analysis and it is not assumed a priori. Parole chiave: Fatica, giunti saldati, tensioni non-locali 1
2 1. INTRODUZIONE Il disegno e la modellazione tridimensionale assistiti negli ultimi anni sono diventati, in molte aziende del settore meccanico, uno standard di progettazione che offre il vantaggio di cogliere l'aspetto e il funzionamento nelle tre dimensioni nonché la possibilità di usare la formulazione matematica dei volumi considerati per ulteriori elaborazioni. Nel caso delle saldature, ed in particolare dei cordoni d angolo, nella rappresentazione tridimensionale diviene naturale la schematizzazione con figure prismatiche o di rivoluzione aventi spigoli vivi. Tale assunzione è di fatto vicina alla realtà in quanto i cordoni di saldatura ottenuti ad arco, sono caratterizzati da raggi di raccordo il cui valore medio è nell ordine di grandezza di qualche decimo di millimetro [1],[2],[3]. Se da una parte, l adozione di uno spigolo vivo può semplificare la modellazione del componente, dall altra, dal punto di vista dell analisi strutturale, si introduce nel campo tensionale una singolarità (ossia un punto con soluzione tendente all infinito) che impedisce l uso di modelli di verifica basati sulla imposizione di un limite tensionale. L idea di confrontare un limite ritenuto ammissibile per il materiale con il valore di picco del campo di tensione, non può essere adottato in quanto qualunque valore assunto per la tensione ammissibile viene inevitabilmente superato purché ci si avvicini sufficientemente allo spigolo. In queste situazioni la letteratura scientifica a volte consiglia di utilizzare le tensioni nominali o le tensioni di hot spot [4]. Purtroppo le prime (nominali) spesso non sono definite o calcolabili in modelli solidi geometricamente complessi. Le tensioni di hot spot hanno altri problemi: il primo è che necessitano di un post-processing manuale e spesso non chiaro nella procedura da seguire; inoltre le previsioni sono a volte imprecise (approssimative), non valutano l effetto scala o non sono in grado di predire il comportamento meccanico di punti di rottura diversi dal piede del cordone (come i cedimenti alla radice del cordone). Per una trattazione teorica degli aspetti matematici e geometrici, in presenza di un raggio di raccordo nullo dei cordoni di saldatura, è possibile affidarsi ad approcci locali basati sul calcolo dei Notch Stress Intensity Factors (NSIF) valutati in prossimità dei punti in cui innesca la cricca per fatica [6]-[11]. Nel caso in cui solo modo I sia singolare o di modo I predominante su modo II, l NSIF può essere usato direttamente per il calcolo della vita a fatica utilizzando specifiche bande di dispersione [7],[8] e [11], mentre in condizioni di modo misto di sollecitazione, o nell ottica di utilizzare un unica banda di dispersione valida per qualunque angolo di apertura del cordone di saldatura, si rende necessario l impiego di un parametro di validità più generale come, ad esempio, l energia media all interno di un settore circolare posto in prossimità del punto critico [], [9] e [11]. Per gli aspetti più applicativi sarebbe opportuno disporre di un approccio metodologico che sia congruente con l inquadramento agli NSIF per l analisi del comportamento a fatica, ma al contempo adatto all impiego per un computo interamente numerico del problema della resistenza a fatica indipendentemente dalla complessità del giunto senza assumere a priori il punto di innesco della cricca. Ossia l obiettivo è quello di proporre una metodologia, adatta al calcolo della resistenza a fatica delle giunzioni saldate e capace, indipendentemente della complessità del giunto, di riportare la verifica a fatica al calcolo di un valore efficace della tensione calcolabile con strumenti automatici integrati con solutori agli elementi finiti. La presente memoria presenta una possibile soluzione del problema metodologico attraverso l approccio denominato gradiente implicito [12][13][14]. 2
3 Per validare il metodo proposto, saranno considerati dati sperimentali presi dalla letteratura di giunzioni saldate analizzabili con schemi bidimensionali, altresì a dettagli strutturali complessi schematizzati con modelli tridimensionali. 2. MODELLO NON LOCALE Assegnato un corpo generico di volume V, in accordo con le referenze[15] e [16] è possibile definire una tensione equivalente non locale σ nel punto generico P del volume V come media integrale di una tensione equivalente locale σ eq pesata con una opportuna funzione α che tiene in considerazione la distanza s del generico punto Q dal punto P dei punti del volume V (s= PQ ): 1 σ( P) = α ( PQ ) σ eq (Q) dv in V (1) V (P) r V Nell equazione (1), il simbolo V r (P) denota il volume di riferimento calcolato come V = α r (P) ( PQ ) dv. V Senza entrare nel dettaglio dei modelli non locali, il problema del calcolo della tensione equivalente non locale σ può essere trasferito alla risoluzione di una equazione differenziale del secondo ordine [17]. Dopo aver assunto la σ come tensione efficace ai fini della resistenza a fatica (σ eff ), l integrale (1) equivale a risolvere la seguente equazione differenziale: 2 2 σ c σ = σ in V (2) eff eff 2 dove c è una dimensione intrinseca legata al materiale in esame, è l operatore di Laplace e σ eq è la tensione equivalente locale ritenuta responsabile del danno a fatica (per una trattazione più approfondita del problema si rimanda alle referenze [12]-[14]). eq 3. CALCOLO DELLA TENSIONE EFFICACE L obiettivo del presente lavoro è quello di risolvere l equazione differenziale (2) in presenza di singolarità tensionali indotte dai cordoni di saldatura pensati come intagli ideali a spigolo vivo. A tale scopo, è stata messa a punto una procedura di tipo numerico capace di risolvere il problema (2) della non-località della tensione in modo completamente automatico. Nel caso di sollecitazione a fatica con carichi in fase, le direzioni principali rimangono invariate nel tempo ed il calcolo a fatica può risolversi facendo riferimento ai soli valori minimi e massimi della tensione efficace. In particolare, per le saldature che non hanno subito un trattamento di distensione termica, è sufficiente far riferimento al solo range della tensione efficace ( σ eff ). Perciò, per le saldature, nella (2) andranno inserite le variazioni che subiscono le tensioni nel ciclo di fatica. 3
4 σ eff n = 0 n σ n 2α K i N σ n 2α R D eq. (2) σ eff Figura 1: Geometria di riferimento Soluzione numerica 2D Alcune tipologie di giunti saldati come i giunti a croce e i giunti a T, possono essere studiati come giunzioni a sviluppo bidimensionale ipotizzando nulli i gradienti di tensione nella terza dimensione. Noto il parametro c del materiale in esame e le condizione al bordo, è possibile risolvere l equazione ellittica (2) nell intero volume V in funzione della tensione equivalente σ eq scelta. Espressioni asintotiche della tensione σ eq equivalente possono essere valutate se si conoscono a priori i valori dei Notch Stress Intensity Factors (NSIF) nel punto in cui innesca la cricca per fatica [13]. Sfruttando un sistema di riferimento polare, la soluzione numerica può essere ottenuta su un settore circolare di raggio R D di dimensioni maggiori al parametro c del materiale (c<<r D ). La figura 1 mostra il dominio di integrazione e le condizioni al bordo applicate. Come condizioni al bordo, in [13] sono state prese in esame solo le condizioni di Neumann che esprimono l ortogonalità del gradiente della soluzione cercata con la normale uscente al bordo del dominio di integrazione (dal punto di vista fisico ciò equivale ad imporre un flusso nullo della soluzione in direzione ortogonale al bordo). Ciò nonostante, se non sono noti gli NSIF della saldatura si può comunque ricorrere ad una soluzione completamente numerica del problema differenziale. La figura 2, riporta un esempio di calcolo della tensione σeff (adimensionalizzata rispetto alla tensione nominale nel piatto più spesso) ottenuta a partire da una analisi lineare elastica del problema tensionale che vede nei sei punti indicati in figura una singolarità del campo di tensione in accordo con la soluzione di Williams [18]. In figura 2, come tensione equivalente σ eq locale è stata assunta la tensione principale massima. Appare evidente che la singolarità del campo di tensione di partenza viene smussata, ottenendo un campo di tensione equivalente non locale di tipo continuo su tutto il giunto. La sola analisi della tensione efficace riportata come grafico tridimensionale al di sopra del dominio di integrazione, fornisce contemporaneamente la posizione di probabile innesco del difetto per fatica ed il valore del picco della tensione efficace. Va comunque sottolineato che a sostegno di quanto calcolato numericamente, accurate soluzioni analitiche di casi mono-dimensionali e bi-dimensionali sono riportate nelle referenze [12] e [13]. 4
5 σ eff σ n,2 H σ n,1 t /2 1 2α =135 s s 2α =135 t /2 2 σ n,2 [mm] σ n,1 σ n,2 [mm] Figura 2: Tipica soluzione in termini di tensione efficace di una giunzione piana a cordone portante. La tensione non locale è adimensionalizzata rispetto alla tensione nominale nel piatto di maggiore spessore Soluzione numerica 3D Nel caso di strutture saldate complesse per le quali non sia possibile ridursi ad uno schema di calcolo bidimensionale o nel caso in cui gli NSIF non siano noti, la procedura presentata al punto 3.1 non può essere applicata. Per superare il problema, è stata messa a punto una procedura di calcolo integrata, che partendo da un modello CAD 3D della saldatura è capace di risolvere il problema del calcolo della tensione efficace σ eff sull intero componente. Il problema della realizzazione di una mesh sufficientemente accurata sia per il calcolo tensionale che per la risoluzione del sistema differenziale (2), può essere gestito in modo completamente automatico con mesh di tipo adattativo. In questo modo non è richiesta a priori la conoscenza del punto di innesco della cricca da parte dell operatore ma è necessario fornire solamente la geometria, i vincoli ed i carichi esterni agenti. Le figure 3 e 4 mostrano esempi di modelli CAD e delle relative mesh 3D, ad elementi tetraedrici, adatte per la risoluzione dell equazione (2). Nelle figure vine anche illustrato il campo tensionale non locale σ eff. La lettura del picco di σ eff, accompagnato da una mappatura a scale di colori, consentirà al progettista di localizzare la zona critica della connessione saldata permettendo inoltre di calcolare il coefficiente di sicurezza o la vita a fatica del particolare saldato sulla base delle curva di progetto riportate nei successivi capitoli. Gli esempi riportati nel seguito mostreranno l efficienza del metodo e la sua capacità di prevedere la resistenza a fatica di strutture complesse tridimensionali. 5
6 a) b) c) Figura 3: Esempio di mesh e soluzione ottenuto in automatico partendo dal modello CAD di un giunto complesso: a) Modello CAD di un giunto a cordone portante sollecitato a trazione sul piatto principale. b) Mesh ad elementi tetraedrici utilizzata per analizzare il giunto; c) Mappatura a scale di colori della tensione efficace (massima tensione principale come tensione equivalente non locale; c=0.2 mm). 6
7 a) b) c) σ 1.5 σ eff σ eff, m ax d) σ eff, ma σ 1 σ eff, m ax z / D Figura 4: Esempio di mesh e soluzione ottenutao in automatico partendo dalla geometria del giunto. a) Modello CAD di un giunto a cordone portante sollecitato a flesso-torsione. b) Mesh ad elementi tetraedrici utilizzata per analizzare il giunto; c) Mappatura a scale di colori della tensione efficace (massima tensione principale come tensione equivalente non locale; c=0.2 mm); d) Andamento della tensione principale massima σ 1 e della tensione efficace σ eff lungo una generatrice esterna del cilindro. I valori sono normalizzati rispetto al valore massimo della tensione efficace σ eff, max e sono rappresentati in funzione della distanza z dal piede del cordone normalizzata rispetto al diametro esterno del tubo D. 7
8 4. VALUTAZIONE DEL PARAMETRO C PER LE SALDATURE Ipotizzato che il parametro c dipenda solamente dal materiale, è possibile calcolarne il suo valore numerico confrontando la resistenza a fatica, in termini di variazione della tensione efficace σ eff, di saldature con rotture alla radice (2α=0 ) con saldature aventi rotture al piede (2α=135 ). In accordo con la referenza [12], il valore di c per le saldature ad arco in acciaio è di circa 0.2 mm (c 2 =0.04 mm 2 ). D altra parte, analisi numeriche [12] ed soluzioni analitiche [13] hanno evidenziato che c è legato attraverso una costante di proporzionalità z alla distanza critica di El-Haddad et al. [21], definita dal limite di fatica del provino liscio σ o e dal valore di soglia dello Stress Intensity Factor K th : a 1 K 2 th 0 = (5) π σ0 Perciò, in un caso generale noto a 0 risulta immediato il calcolo di c in relazione alla tensione equivalente assunta. La relazione fra a 0 e c può essere così riassunta [12]: c = z a 0 (6) La tabella 1 propone il valore di z per le diverse tensioni equivalenti. Tabella 1: Valori del parametro z per differenti tensioni equivalenti [12] Tensione equivalente locale Tipo di sollecitazione z c = z a o massima principale von Mises Tresca massima principale von Mises Tresca Stato piano di tensione Stato piano di tensione Stato piano di tensione Stato piano di deformazione Stato piano di deformazione Stato piano di deformazione
9 5. BANDA DI DISPERSIONE PER LE SALDATURE E CURVA DI PROGETTO. Il metodo del gradiente implicito consente di rendere continuo un campo di tensione singolare anche nell ipotesi di materiale lineare elastico. Con tale formulazione è possibile, utilizzare il picco di tensione direttamente per il calcolo del coefficiente di sicurezza senza incorrere in errori formali. Utilizzando dati sperimentali di letteratura è possibile tracciare una banda di dispersione per le saldature nel campo della vita a termine fra 4 e 5 6 cicli. Con riferimento alle serie sperimentali precedentemente analizzati nelle referenze [7],[8] e [11], in figura 4 è stata tracciata la banda di dispersione in termini di variazione della tensione equivalente non locale massima σ eff, max calcolata in prossimità del punto di innesco della cricca. Gli spessori del piatto principale e degli irrigidimenti variavano da 3 a 0 mm. Il valore della pendenza della curva di Wöhler risulta pari a 3 ed il valore di riferimento a 2 6 cicli al 97.7% di probabilità di sopravvivenza è di 151 MPa. In figura 4 è possibile osservare che la curva di progetto proposta dall Eurocodice 3 [5] per i particolari tagliati all ossitaglio automatico presenta una classe di resistenza (140 MPa a 2 6 ) di poco inferiore al valore ottenuto per una probabilità di sopravvivenza del 97.7% (151 MPa). Perciò, in analogia con l Eurocodice 3 potremo dire che le giunzioni saldate, indipendentemente dalla loro forma, sollecitate principalmente a modo I, ricadono tutti all interno di una stessa classe, quantificabile in circa 150 MPa con pendenza fra 4 e 5 6 cicli pari a 3. Tabella 2: Valori dei parametri geometrici di figura 2 Caso s [mm] h [mm] t 1 [mm] t 2 [mm] ESEMPI APPLICATIVI Il problema differenziale (2), tranne nel caso di una cricca su una piastra di dimensione infinita [13], non è di semplice soluzione e comunque impone la conoscenza degli NSIF. Perciò ai fini progettuali risulta sicuramente molto efficiente una soluzione completamente numerica del problema differenziale. A tale scopo, è stata messa a punto una procedura di calcolo che richiede all operatore come dati di ingresso la geometria del giunto e la costante c del materiale ignorando completamente il problema della singolarità in prossimità degli intagli acuti ed affidando il problema della convergenza a soluzioni di tipo adattivo. 9
10 6.1 Giunzioni a T sollecitate a flessione In figura 5, sono riportati i valori sperimentali di rotture avvenute al piede del cordone di saldatura per una giunzione avente un angolo diverso da quello esaminato in figura 4. I risultati numerici contrassegnati dal simbolo sono relativi ad un giunto a T sollecitato a flessione con angolo di apertura del cordone di 118. Tali punti vanno a cadere all interno della banda di dispersione precedentemente calcolata. σ 3000 eff,max [MPa] 00 R c = 0.2 mm rotture al piede (2α = 135 ) H = 3-0 mm t = 3-0 mm Curva di progetto per particolari tagliati all'ossitaglio automatico (Eurocodice 3 ) L = 6-32 mm rotture alla radice t = 6-32 mm (2α = 0 ) cicli a rottura N 7 Figura 5: Banda di dispersione per giunzioni saldate ad arco in acciaio in termini di tensione efficace massima ottenuta con il metodo del gradiente implicito (R rapporto di ciclo) 6.2 Previsione della zona di innesco della cricca per giunzioni a croce a cordone portante sollecitare a trazione Un altro interessante esempio è quello relativo allo studio del punto di innesco della cricca per fatica in un giunto a croce a cordone portante sollecitato a trazione in cui gli spessori dei piatti principali siano diversi [22]. La figura 6 mostra la geometria del giunto in esame mentre le dimensioni geometriche delle 4 serie analizzate nella referenza [22] sono riportate in tabella 2. I punti critici di probabile innesco della cricca per fatica sono i punti evidenziati con un cerchio in figura 2. Nonostante le differenze geometriche fra le quattro serie di tabella 2, dal punto di vista sperimentale si sono sempre osservate rotture alla radice del cordone di saldatura dalla parte piatto più spesso. I risultati della relativa elaborazione numerica del campo di tensione sono riportati in figura 2 adimensionalizzati rispetto alla tensione nominale applicata al piatto di spessore maggiore. Il picco della tensione equivalente non locale risulta massimo in prossimità della radice del cordone di saldatura sul piatto di spessore maggiore esattamente nel punto in cui l evidenza sperimentale indica il punto di rottura.
11 σ 3000 eff,max [MPa] 00 c = 0.2 mm ref. [32] t t s 2α = cicli a rottura N 7 Figura 6: Previsione della resistenza a fatica calcolata per via completamente numerica di una saldatura a T avente angolo di apertura di 118 sollecitata a flessione (t= mm, s= 7.8 mm, R=0.1). 6.3 Previsione della vita a fatica in giunti complessi tridimensionali In generale nei componenti saldati, le cricche nucleano in corrispondenza dei piedi o delle radici dei cordoni cosicché il problema del valore dei carichi da applicare al componente è soprattutto legato all individuazione del punto di innesco della cricca per fatica. Per mostrare la versatilità del gradiente implicito allo studio della resistenza a fatica di strutture saldate complesse, saranno analizzati quattro differenti tipologie di giunti la cui geometria non può essere ridotta al 2D: a) giunti con irrigidimento longitudinale (spessore piatto principale 2 o 6 mm); b) giunti con irrigidimento circolare (spessore piatto principale 8 mm); c) giunti a cordone portante sollecitati a flessione ( spessore piatti 12 mm); d) giunti saldati composti da profilati tubolari a sezione rettangolare (spessore profili 7.9 mm). La figura 7, a titolo di esempio, mostra il valore della tensione effettiva ottenuta a partire dalla tensione massima principale. Le zone in cui si ha la massima sollecitazione effettiva σ eff, coincidono, di fatto, con quelle in cui si ha la frattura per fatica. L accordo fra risultati sperimentali e previsione della vita a fatica è soddisfacente per i giunti delle serie (a) e (b) come evidenziato in figura 8. Per le serie (c) e (d) la previsione della vita a fatica appare conservativa (vedere figura 9) e ciò potrebbe essere giustificato fondamentalmente per due motivi: 1) nella serie (c) e (d) è presente un carico di torsione nei cordoni di saldatura che comporta la presenza di un modo III singolare assente nelle giunzioni a croce sollecitate a trazione o a flessione; 2) il metodo del gradiente implicito così come è stato proposto in questa sede, è adatto per il calcolo della vita di innesco e di prima 11
12 propagazione del difetto per fatica. Nel caso di strutture complesse, tale approccio potrebbe risultare in vantaggio di sicurezza nel momento in cui si trascurata completamente la fase di propagazione del difetto. Tuttavia, per quanto riguarda il primo dei due aspetti, gli autori stanno cercando di introdurre nel modello di calcolo del gradiente implicito un approccio di tipo multiassiale alla fatica capace di prendere in considerazione il completo stato di tensione locale. a) σ eff b) σ eff σ eff σn R = 0 σ eff σ n σn σ n c) σeff d) σeff σ eff. Figure 7: Modelli e risultati ottenuti in termini di tensione effettiva per piastre irrigidite sollecitate a trazione (massima tensione principale come tensione equivalente non locale, c=0.2 mm). 12
13 σ 3000 c = 0.2 mm eff, max [MPa] 00 t = 2 mm [23] t = 6 mm [23] R = t = 8 mm [24] R = cicli a rottura N Figura 8: Previsione della vita a fatica di giunti irrigiditi utilizzando il metodo del gradiente implicito (t spessore piatto principale). σ 3000 c = 0.2 mm eff,max [MPa] 00 t=7.9 mm [26] R=-1 (as-welded) t=12 mm [25] R= 0 5 cicli a rottura N Figura 9: Previsione della vita a fatica di giunti con irrigidimento non simmetrico e di giunti ottenuti con profili tubolari (t spessore piatto principale). 13
14 5. CONCLUSIONI Una procedura di verifica a fatica basata sul metodo del gradiente implicito consente di affrontare il problema della singolarità del campo di tensione senza ricorrere a modifiche geometriche del componente in esame o all impiego di schematizzazioni non lineari del materiale. Disaccoppiando il problema della resistenza dall effetto gradiente Per durate a fatica superiori a 4 cicli, il materiale può essere schematizzato come lineare elastico. Per giunzioni saldate sollecitate prevalentemente a modo I, il valore del massimo della tensione equivalente non locale, ottenuto dall analisi numerica, può essere usato come dato di ingresso nella curva di riferimento del comportamento a fatica delle saldature. In questo caso, il metodo del gradiente implicito riporta il calcolo della vita a fatica delle saldature complesse al metodo delle tensioni ammissibili indipendentemente dalla forma del componente in esame. Per giunzioni sollecitate a modo mosto è necessario l impiego di una procedura più articolata la quale punto per punto del cordone di saldatura costruisce la curva di Woehler in funzione delle reali condizioni di sollecitazione del corpo. Il problema delle singolarità tensionali nella progettazione a fatica, in questo articolo, è stato risolto proponendo una filosofia di progettazione basata sui metodi a gradiente implicito capaci di rendere continui i campi di tensione singolari indotti dalla presenza di intagli a spigolo vivo. Tali metodi hanno il vantaggio di poter considerare il materiale come lineare elastico trasformando il problema del gradiente tensionale nella risoluzione di una equazione differenziale definita sull intero corpo in esame. La soluzione trovata, definita come tensione equivalente non locale assume il ruolo di tensione efficace per la valutazione della vita a fatica. Operando in questo modo è possibile studiare il comportamento a fatica delle giunzioni saldate utilizzando un unica banda di dispersione, definita in questa sede sulla base di numerose prove sperimentali tratte dalla letteratura. Il metodo proposto offre il vantaggio di prestarsi per una soluzione completamente numerica del calcolo della vita a fatica delle giunzioni saldate complesse. BIBLOGRAFIA [1] Lassen T (1990) The effect of the welding process on the fatigue crack growth. Welding Journal 69, Research Supplement, 75S-81S [2] Huther I., Primot L., Lieurade H.P., Janosch J.J., Colchen D., Debicz S., Weld quality snd the cyclic fatigue strength of steel welded joints, Welding in the World, 35, 2, pp , 1995 [3] Macdonald K.A, Haagensen P.J., Fatigue design of welded aluminum rectangular hollow section joints, Engineering Failure Analysis 6, , (1999). [4] Radaj, D., Sonsino, C.M., Fricke W. (2006). Fatigue assessment of welded joints by local approaches, Abington Publishing, Abington. [5] Eurocode 3: Design of steel structures; General rules [6] Verreman, Y., Nie, B. Early development of fatigue cracking at manual fillet welds, Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures 19, 1996, pp [7] Lazzarin, P., Tovo, R., A Notch Intensity Approach to the Stress Analysis of Welds, Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures 21, 1998, pp
15 [8] Lazzarin, P., Livieri, P., Notch Stress Intensity Factors and fatigue strength of aluminium and steel welded joints, International Journal of Fatigue 23, 2001, pp [9] Lazzarin, P., Lassen, T., Livieri, P., A Notch Stress Intensity approach applied to fatigue life predictions of welded joints with different local toe geometry, Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures 26, 2003, pp [] Lazzarin, P., Zambardi, R., A finite-volume-energy based approach to predict the static and fatigue behaviour of components with sharp V-shaped notches, International Journal of Fracture 112, 2001, pp [11] Livieri P., Lazzarin P., "Fatigue strength of steel and aluminium welded joints based on generalised stress intensity factors and local strain energy values", International Journal of Fracture, 133, 2005, pp [12] Tovo R., Livieri P., Benvenuti E. An implicit gradient type of static failure criterion for mixed-mode loading. International Journal of Fracture (2006) 141: [13] Tovo R., Livieri P. An implicit gradient application to fatigue of sharp notches and weldments. Engineering Fracture Mechanics 74 (2007) pp [14] Tovo R., Livieri P. An implicit gradient application to fatigue of complex structures. Engineering Fracture Mechanics Engineering Fracture Mechanics (2008), 75 (7), pp , [15] Kroener, E Elasticity Theorie with long-range cohesive forces. Int. J. Sol. Struct., 3, 731 [16] Eringen C.A., Edelen, D.G.B.. On nonlocal elasticity. Int.J.Engng.Science, 1972, [17] Peerlings R.H.J., de Borst R., Brekelmans W.A.M., J.H.P. de Vree,. Gradient enhanced damage for quasi-brittle material, Int. J. Num. Meth. Engn., 39, 1996, [18] Williams, M.L., Stress singularities resulting from various boundary conditions in angular corners of plates in extension, Journal of Applied Mechanics 19, 1952, pp [19] Lazzarin P., Tovo R., A unified approach to the evaluation of linear elastic stress fields in the neighbourhood of cracks and notches. International Journal of Fracture, 78, 1996, pp [20] Gross B., Mendelson A., Plane elastostatic analysis of V-notched plates, International Journal of Fracture Mechanics, 8, 1972, pp [21] El Haddad, M. H., Topper, T.H., Smith, K. N., Fatigue crack propagation of short cracks, ASME, Journal of engineering Material and Technology 1, 1979, pp [22] Kainuma S., Kim I.T., Fatigue strength evaluation of load-carrying cruciform filletwelded joints made with mild steel plates of different thickness,international Journal of Fatigue, 27, 2005, pp [23] Gurney TR., Fatigue of thin walled joints under complex loading. Abington Publishing, Abington, [24] L. Susmel, R. Tovo, Local and structural multiaxial stress states in welded joints under fatigue loading, International Journal of Fatigue 28 (2006) [25] Fricke W. Doerk O.: Simplified approach to fatigue strength assessment of filletwelded attachment ends, International Journal of Fatigue 28(2006) [26] H Kyuba, P. Dong: Equilibrum-equivalent structural stress approach to fatigue analysis of a rectangular hollow section joint, International Journal of Fatigue 27 (2005)
Il gradiente implicito nella verifica a fatica di giunzioni saldate sollecitate a fatica
 Il gradiente implicito nella verifica a fatica di giunzioni saldate sollecitate a fatica R. Tovo, P. Livieri Università di Ferrara, Dipartimento di Ingegneria, via Saragat 1, 440 Ferrara, roberto.tovo@unife.it
Il gradiente implicito nella verifica a fatica di giunzioni saldate sollecitate a fatica R. Tovo, P. Livieri Università di Ferrara, Dipartimento di Ingegneria, via Saragat 1, 440 Ferrara, roberto.tovo@unife.it
Densità di energia di deformazione locale e resistenza a fatica di giunti saldati di geometria complessa
 M. Zappalorto et al., Frattura ed Integrità Strutturale, 3 (008) -7; DOI: 0.3/IGF-ESIS.03.0 Densità di energia di deformazione locale e resistenza a fatica di giunti saldati di geometria complessa M. Zappalorto,
M. Zappalorto et al., Frattura ed Integrità Strutturale, 3 (008) -7; DOI: 0.3/IGF-ESIS.03.0 Densità di energia di deformazione locale e resistenza a fatica di giunti saldati di geometria complessa M. Zappalorto,
ATTIVITA TRIENNIO novembre 2009 - ottobre 2012
 ATTIVITA TRIENNIO novembre 2009 - ottobre 2012 Prof. Paolo LIVIERI Professore di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare ING-IND 14 Nel novembre 2006 Paolo Livieri, ha preso servizio presso
ATTIVITA TRIENNIO novembre 2009 - ottobre 2012 Prof. Paolo LIVIERI Professore di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare ING-IND 14 Nel novembre 2006 Paolo Livieri, ha preso servizio presso
ESERCITAZIONE SUL CRITERIO
 TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AEROSPAZIALI ESERCITAZIONE SUL CRITERIO DI JUVINALL Prof. Claudio Scarponi Ing. Carlo Andreotti Ing. Carlo Andreotti 1 IL CRITERIO DI JUVINALL La formulazione del criterio
TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AEROSPAZIALI ESERCITAZIONE SUL CRITERIO DI JUVINALL Prof. Claudio Scarponi Ing. Carlo Andreotti Ing. Carlo Andreotti 1 IL CRITERIO DI JUVINALL La formulazione del criterio
Comportamento meccanico dei materiali
 Comportamento meccanico dei materiali Fatica dei materiali Propagazione delle cricche Dati di fatica di base Dai provini ai componenti, fatica uniassiale Fatica con sollecitazioni ad ampiezza variabile
Comportamento meccanico dei materiali Fatica dei materiali Propagazione delle cricche Dati di fatica di base Dai provini ai componenti, fatica uniassiale Fatica con sollecitazioni ad ampiezza variabile
Agostinetti Piero (425902/IM)
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA FACOLTA DI INGEGNERIA Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica LABORATORIO DI ANALISI STRUTTURALE CON ANSYS 5.6: VERIFICHE STRUTTURALI PER IL BILANCERE DELLA PIATTAFORMA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA FACOLTA DI INGEGNERIA Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica LABORATORIO DI ANALISI STRUTTURALE CON ANSYS 5.6: VERIFICHE STRUTTURALI PER IL BILANCERE DELLA PIATTAFORMA
3) DIMENSIONAMENTO DI UNA SEZIONE INFLESSA
 3) DIMENSIONAMENTO DI UNA SEZIONE INFLESSA Quanto segue ci consente di dimensionare l altezza di una trave inflessa con un criterio di imporre che la tensione massima agente sulla sezione della trave sia
3) DIMENSIONAMENTO DI UNA SEZIONE INFLESSA Quanto segue ci consente di dimensionare l altezza di una trave inflessa con un criterio di imporre che la tensione massima agente sulla sezione della trave sia
PROGETTO DI ELEMENTI IN VETRO STRUTTURALE SECONDO LA NORMA pren (CEN/TC129/WG8).
 PROGETTO DI ELEMENTI IN VETRO STRUTTURALE SECONDO LA NORMA pren 13474-3 (CEN/TC129/WG8). Ing. Leonardo Lani 1 INTRODUZIONE La progettazione di elementi in vetro strutturale ha avuto negli ultimi quindici
PROGETTO DI ELEMENTI IN VETRO STRUTTURALE SECONDO LA NORMA pren 13474-3 (CEN/TC129/WG8). Ing. Leonardo Lani 1 INTRODUZIONE La progettazione di elementi in vetro strutturale ha avuto negli ultimi quindici
COMPORTAMENTO SPERIMENTALE DI TRAVI DI C.A. E RELATIVI METODI DI ANALISI
 LEZIONI N 32 E 33 COMPORTAMENTO SPERIMENTALE DI TRAVI DI C.A. E RELATIVI METODI DI ANALISI Prima di addentrarci nei dettagli della teoria tecnica delle costruzioni di cemento armato, è utile richiamare
LEZIONI N 32 E 33 COMPORTAMENTO SPERIMENTALE DI TRAVI DI C.A. E RELATIVI METODI DI ANALISI Prima di addentrarci nei dettagli della teoria tecnica delle costruzioni di cemento armato, è utile richiamare
RELAZIONE ESERCITAZIONI AUTODESK INVENTOR
 20 Ottobre 2015 RELAZIONE ESERCITAZIONI AUTODESK INVENTOR Corso di Costruzione di Macchine e Affidabilità C.d.L.M. in Ingegneria Meccanica Docente: Prof.ssa Cosmi Francesca Assistente: Dott.ssa Ravalico
20 Ottobre 2015 RELAZIONE ESERCITAZIONI AUTODESK INVENTOR Corso di Costruzione di Macchine e Affidabilità C.d.L.M. in Ingegneria Meccanica Docente: Prof.ssa Cosmi Francesca Assistente: Dott.ssa Ravalico
FATICA. FATICA: curva di Wohler
 FATICA Flessione rotante CURVA DI WOHLER 1 FATICA: curva di Wohler 2 1 FATICA: curva di Wohler 3 FATICA: curva di Wohler an f b f N f 1 1 m m f K N f f a 1 b 4 2 FATICA: curva di Wohler la curva viene
FATICA Flessione rotante CURVA DI WOHLER 1 FATICA: curva di Wohler 2 1 FATICA: curva di Wohler 3 FATICA: curva di Wohler an f b f N f 1 1 m m f K N f f a 1 b 4 2 FATICA: curva di Wohler la curva viene
Presentazione e obiettivi del corso
 Presentazione e obiettivi del corso Il corso si propone di fornire gli strumenti per il calcolo e la verifica di elementi strutturali soggetti a carichi statici o variabili nel tempo A questo scopo vengono
Presentazione e obiettivi del corso Il corso si propone di fornire gli strumenti per il calcolo e la verifica di elementi strutturali soggetti a carichi statici o variabili nel tempo A questo scopo vengono
Lezione Il calcestruzzo armato I
 Lezione Il calcestruzzo armato I Sommario Il calcestruzzo armato Il comportamento a compressione Il comportamento a trazione Il calcestruzzo armato Il cemento armato Il calcestruzzo armato Il calcestruzzo
Lezione Il calcestruzzo armato I Sommario Il calcestruzzo armato Il comportamento a compressione Il comportamento a trazione Il calcestruzzo armato Il cemento armato Il calcestruzzo armato Il calcestruzzo
Università degli studi di Trieste Laurea magistrale in ingegneria meccanica ESERCITAZIONI DEL CORSO DI COSTRUZIONE DI MACCHINE E AFFIDABILITÀ
 Università degli studi di Trieste Laurea magistrale in ingegneria meccanica ESERCITAZIONI DEL CORSO DI COSTRUZIONE DI MACCHINE E AFFIDABILITÀ DOCENTE: COSMI FRANCESCA STUDENTE: LUCA BATTAGLIA Indice: Metodo
Università degli studi di Trieste Laurea magistrale in ingegneria meccanica ESERCITAZIONI DEL CORSO DI COSTRUZIONE DI MACCHINE E AFFIDABILITÀ DOCENTE: COSMI FRANCESCA STUDENTE: LUCA BATTAGLIA Indice: Metodo
Dispense del Corso di SCIENZA DELLE COSTRUZIONI. Sollecitazioni semplici PARTE TERZA. Prof. Daniele Zaccaria
 Dispense del Corso di SCIENZA DELLE COSTRUZIONI Prof. Daniele Zaccaria Dipartimento di Ingegneria Civile Università di Trieste Piazzale Europa 1, Trieste PARTE TERZA Sollecitazioni semplici Corsi di Laurea
Dispense del Corso di SCIENZA DELLE COSTRUZIONI Prof. Daniele Zaccaria Dipartimento di Ingegneria Civile Università di Trieste Piazzale Europa 1, Trieste PARTE TERZA Sollecitazioni semplici Corsi di Laurea
GIUSTIFICAZIONE TEORICA DELLA FORMULA DI PETRY MEDIANTE L ANALISI DIMENSIONALE
 M. G. BUSATO GIUSTIFICAZIONE TEORICA DELLA FORMULA DI PETRY MEDIANTE L ANALISI DIMENSIONALE NOTA TECNICA MGBSTUDIO.NET SOMMARIO La formula di Petry è una formula semiempirica che consente di stimare,
M. G. BUSATO GIUSTIFICAZIONE TEORICA DELLA FORMULA DI PETRY MEDIANTE L ANALISI DIMENSIONALE NOTA TECNICA MGBSTUDIO.NET SOMMARIO La formula di Petry è una formula semiempirica che consente di stimare,
SOLUZIONE. Calcolo resistenze di progetto materiali: conglomerato: f ck = 200 dan / cm 2 (tab. 9.3_b); f ctk = 15daN / cm 2 f ctm = 22daN / cm 2
 (*)ESEMPIO 4. Sia data la trave di sezione rettangolare delle dimensioni di 20 cm x 40 cm, descritta all esempio 1 (vedere particolari in figura 16.22). Supponendo che la struttura sia stata confezionata
(*)ESEMPIO 4. Sia data la trave di sezione rettangolare delle dimensioni di 20 cm x 40 cm, descritta all esempio 1 (vedere particolari in figura 16.22). Supponendo che la struttura sia stata confezionata
La resistenza al fuoco delle strutture. La resistenza al fuoco delle strutture e il metodo prestazionale
 Mauro Caciolai 1 SVILUPPO NORMATIVO Documento interpretativo n. 2: 1994 (Sicurezza in caso di incendio) ENV 1991-2-2: 1995 (Azioni sulle strutture: Azioni in caso di incendio) CNR boll. n. 192: 1999 (Istruzioni
Mauro Caciolai 1 SVILUPPO NORMATIVO Documento interpretativo n. 2: 1994 (Sicurezza in caso di incendio) ENV 1991-2-2: 1995 (Azioni sulle strutture: Azioni in caso di incendio) CNR boll. n. 192: 1999 (Istruzioni
IL METODO DEGLI STATI LIMITE
 Corso sulle Norme Tecniche per le costruzioni in zona sismica (Ordinanza PCM 3274/2003, DGR Basilicata 2000/2003) POTENZA, 2004 IL METODO DEGLI STATI LIMITE Prof. Ing. Angelo MASI DiSGG, Università di
Corso sulle Norme Tecniche per le costruzioni in zona sismica (Ordinanza PCM 3274/2003, DGR Basilicata 2000/2003) POTENZA, 2004 IL METODO DEGLI STATI LIMITE Prof. Ing. Angelo MASI DiSGG, Università di
Il modello di trave adottato dal Saint-Venant si basa sulle seguenti ipotesi:
 IL PROBLEM DEL DE SINT-VENNT Il problema del De Saint-Venant è un particolare problema di equilibrio elastico di notevole interesse applicativo, potendosi considerare alla base della teoria tecnica delle
IL PROBLEM DEL DE SINT-VENNT Il problema del De Saint-Venant è un particolare problema di equilibrio elastico di notevole interesse applicativo, potendosi considerare alla base della teoria tecnica delle
Principi e Metodologie della Progettazione Meccanica
 Principi e Metodologie della Progettazione Meccanica ing. F. Campana a.a. 06-07 Lezione 13: Robust Design Robust Design significato ed esempi Le tecniche di ottimizzazione fin qui viste hanno un ampio
Principi e Metodologie della Progettazione Meccanica ing. F. Campana a.a. 06-07 Lezione 13: Robust Design Robust Design significato ed esempi Le tecniche di ottimizzazione fin qui viste hanno un ampio
ANALISI TERMICA DI UNA TRAVE TRALICCIATA PREM
 Luogo, Milano Data 03/11/2016 DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI E AMBIENTE COSTRUITO Indirizzo Piazza L. da Vinci 32 20113 Milano ANALISI TERMICA DI UNA TRAVE TRALICCIATA PREM
Luogo, Milano Data 03/11/2016 DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI E AMBIENTE COSTRUITO Indirizzo Piazza L. da Vinci 32 20113 Milano ANALISI TERMICA DI UNA TRAVE TRALICCIATA PREM
RELAZIONE DI CALCOLO
 RELAZIONE DI CALCOLO CONDOTTA IN ACCIAIO Premessa La costruzione della Strada Provinciale in oggetto prevede la realizzazione di una rotatoria sul tracciato esistente attraversato dal canale di bonifica
RELAZIONE DI CALCOLO CONDOTTA IN ACCIAIO Premessa La costruzione della Strada Provinciale in oggetto prevede la realizzazione di una rotatoria sul tracciato esistente attraversato dal canale di bonifica
Corso di Matematica per la Chimica
 Corso di Matematica per la Chimica Dott.ssa Maria Carmela De Bonis Dipartimento di Matematica, Informatica e Economia Università della Basilicata a.a. 2014-15 Introduzione La MATEMATICA è uno strumento
Corso di Matematica per la Chimica Dott.ssa Maria Carmela De Bonis Dipartimento di Matematica, Informatica e Economia Università della Basilicata a.a. 2014-15 Introduzione La MATEMATICA è uno strumento
Sollecitazioni semplici Il Taglio
 Sollecitazioni semplici Il Taglio Considerazioni introduttive La trattazione relativa al calcolo delle sollecitazioni flessionali, è stata asata sull ipotesi ce la struttura fosse soggetta unicamente a
Sollecitazioni semplici Il Taglio Considerazioni introduttive La trattazione relativa al calcolo delle sollecitazioni flessionali, è stata asata sull ipotesi ce la struttura fosse soggetta unicamente a
INFLUENZA DELLA GRAFITE CHUNKY SULLE
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA XXXII Congresso di Fonderia Brescia, 21-22 Novembre 2014 INFLUENZA DELLA GRAFITE CHUNKY SULLE PROPRIETÀ MECCANICHE E SUL COMPORTAMENTO A FATICA DI UNA GHISA SFEROIDALE
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA XXXII Congresso di Fonderia Brescia, 21-22 Novembre 2014 INFLUENZA DELLA GRAFITE CHUNKY SULLE PROPRIETÀ MECCANICHE E SUL COMPORTAMENTO A FATICA DI UNA GHISA SFEROIDALE
DIMENSIONAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PORTANTE DI UN ULTRALEGGERO SIMILE AL MACCHI 205
 Università degli Studi di Bologna FACOLTA DI INGEGNERIA Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica Disegno Tecnico Industriale DIMENSIONAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PORTANTE DI UN ULTRALEGGERO
Università degli Studi di Bologna FACOLTA DI INGEGNERIA Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica Disegno Tecnico Industriale DIMENSIONAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PORTANTE DI UN ULTRALEGGERO
STUDIO ED OTTIMIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PROTEZIONE PER ESCAVATORI
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA Tesi di laurea in Disegno Tecnico Industriale STUDIO ED OTTIMIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PROTEZIONE PER ESCAVATORI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA Tesi di laurea in Disegno Tecnico Industriale STUDIO ED OTTIMIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PROTEZIONE PER ESCAVATORI
Introduzione ai codici di calcolo agli Elementi Finiti
 Introduzione ai codici di calcolo agli Elementi Finiti Introduzione agli elementi finiti Gli elementi finiti nascono negli anni 50 per risolvere problemi nell ambito dell ingegneria delle strutture. Tale
Introduzione ai codici di calcolo agli Elementi Finiti Introduzione agli elementi finiti Gli elementi finiti nascono negli anni 50 per risolvere problemi nell ambito dell ingegneria delle strutture. Tale
Ing. Mauro Andreolli RICERCA E SPERIMENTAZIONE SU GIUNTI SEMIRIGIDI CON BARRE INCOLLATE PER GRANDI STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE
 RICERCA E SPERIMENTAZIONE SU GIUNTI SEMIRIGIDI CON BARRE INCOLLATE PER GRANDI STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE con il patrocinio di: Ing. Mauro Andreolli La progettazione di edifici di grandi dimensioni per
RICERCA E SPERIMENTAZIONE SU GIUNTI SEMIRIGIDI CON BARRE INCOLLATE PER GRANDI STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE con il patrocinio di: Ing. Mauro Andreolli La progettazione di edifici di grandi dimensioni per
Strutture di muratura: EC6 parte 1.2.
 Strutture di muratura: EC6 parte 1.2. Mauro Sassu Dipartimento di Ingegneria Strutturale Università di Pisa e-mail: m.sassu@unipi.it 23/09/2008 M.Sassu 1 L Eurocodice 6 (strutture di muratura): EN 1996
Strutture di muratura: EC6 parte 1.2. Mauro Sassu Dipartimento di Ingegneria Strutturale Università di Pisa e-mail: m.sassu@unipi.it 23/09/2008 M.Sassu 1 L Eurocodice 6 (strutture di muratura): EN 1996
Principi e Metodologie delle Costruzioni di Macchine
 Principi e Metodologie delle Costruzioni di Macchine Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica III anno A.A. 2010-2011 Docente: Domenico Gentile gentile@unicas.it 0776.2994336 Presentazione del corso PREREQUISITI
Principi e Metodologie delle Costruzioni di Macchine Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica III anno A.A. 2010-2011 Docente: Domenico Gentile gentile@unicas.it 0776.2994336 Presentazione del corso PREREQUISITI
ESERCITAZIONE 1 ESTENSIMETRIA
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI FACOLTA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DIPARTIMENTO DI MECCANICA, CHIMICA E MATERIALI CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA ESERCITAZIONE 1 ESTENSIMETRIA Relazione del
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI FACOLTA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DIPARTIMENTO DI MECCANICA, CHIMICA E MATERIALI CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA ESERCITAZIONE 1 ESTENSIMETRIA Relazione del
Le unioni. 5 L acciaio 5.3 Strutture in acciaio. Unioni con chiodi. Unioni con perni. Unioni con bulloni
 1 Le unioni Unioni con chiodi È il sistema di collegamento più antico, ma è in disuso in quanto sostituito dalle unioni bullonate o saldate, per cui si può ritrovare solo su vecchie strutture in acciaio.
1 Le unioni Unioni con chiodi È il sistema di collegamento più antico, ma è in disuso in quanto sostituito dalle unioni bullonate o saldate, per cui si può ritrovare solo su vecchie strutture in acciaio.
Gli effetti delle alte temperature sulla risposta sismica degli edifici in muratura
 Gli effetti delle alte temperature sulla risposta sismica degli edifici in muratura Antonio Formisano, Ricercatore Università di Napoli Federico II Francesco Fabbrocino, Ricercatore Università Telematica
Gli effetti delle alte temperature sulla risposta sismica degli edifici in muratura Antonio Formisano, Ricercatore Università di Napoli Federico II Francesco Fabbrocino, Ricercatore Università Telematica
CAE. Ingegnerizzazione assistita da calcolatore
 CAE Ingegnerizzazione assistita da calcolatore L ingegnerizzazione assistita da calcolatore (Computeraided engineering o CAE) si riferisce all uso di software su computer per simulare le prestazioni di
CAE Ingegnerizzazione assistita da calcolatore L ingegnerizzazione assistita da calcolatore (Computeraided engineering o CAE) si riferisce all uso di software su computer per simulare le prestazioni di
Argomento Resistenza al fuoco delle strutture
 Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale «Scienza e Tecnica della Prevenzione Incendi» A.A. 2013-2014 Argomento Resistenza al fuoco delle strutture Pietro Croce p.croce@ing.unipi.it Regolamento
Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale «Scienza e Tecnica della Prevenzione Incendi» A.A. 2013-2014 Argomento Resistenza al fuoco delle strutture Pietro Croce p.croce@ing.unipi.it Regolamento
MODULO 6: EFFETTO DI INTAGLIO
 MODULO 6: EFFETTO DI INTAGLIO Denis Benasciutti - Università degli Studi di Udine Costruzione di Macchine - 2009 M6/Slide 1 Intaglio: esempi Denis Benasciutti - Università degli Studi di Udine Costruzione
MODULO 6: EFFETTO DI INTAGLIO Denis Benasciutti - Università degli Studi di Udine Costruzione di Macchine - 2009 M6/Slide 1 Intaglio: esempi Denis Benasciutti - Università degli Studi di Udine Costruzione
5.4 Caratterizzazione in regime quasi statico e ad elevata velocità di deformazione di un acciaio per applicazione Oil and Gas
 5.4 Caratterizzazione in regime quasi statico e ad elevata velocità di deformazione di un acciaio per applicazione Oil and Gas Si riportano in questa sezione i risultati relativi ai test sperimentali effettuati
5.4 Caratterizzazione in regime quasi statico e ad elevata velocità di deformazione di un acciaio per applicazione Oil and Gas Si riportano in questa sezione i risultati relativi ai test sperimentali effettuati
STRUTTURE DI CALCESTRUZZO ARMATO: EC2-1-2 A.L. MATERAZZI
 CONVEGNO GLI EUROCODICI PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE ANTINCENDIO 18 settembre 2008 Istituto Superiore Antincendi, Roma STRUTTURE DI CALCESTRUZZO ARMATO: EC2-1-2 A.L. MATERAZZI Università di Perugia
CONVEGNO GLI EUROCODICI PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE ANTINCENDIO 18 settembre 2008 Istituto Superiore Antincendi, Roma STRUTTURE DI CALCESTRUZZO ARMATO: EC2-1-2 A.L. MATERAZZI Università di Perugia
Valutazione della curvatura media di un elemento strutturale in c.a.
 16.4 Stato limite di deformazione 16.4.1 Generalità Lo stato limite di deformazione può essere definito come la perdita di funzionalità della struttura a causa di una sua eccessiva deformazione. Segnali
16.4 Stato limite di deformazione 16.4.1 Generalità Lo stato limite di deformazione può essere definito come la perdita di funzionalità della struttura a causa di una sua eccessiva deformazione. Segnali
Alberto Rossi matr
 Alberto Rossi matr. 123456 Alberto Rossi matr. 123456 17 novembre 2010 pag. 1/16 Modello strutturale Il componente meccanico (forse una morsa...) ha dimensioni globali 100x100x25 quindi a rigore va considerato
Alberto Rossi matr. 123456 Alberto Rossi matr. 123456 17 novembre 2010 pag. 1/16 Modello strutturale Il componente meccanico (forse una morsa...) ha dimensioni globali 100x100x25 quindi a rigore va considerato
Ponti Isolati Criteri di progettazione ed analisi
 Ponti Isolati Criteri di progettazione ed analisi Università degli Studi di Pavia 1/38 Laboratorio di progettazione strutturale A 1 Sommario 1) Criteri base della progettazione 2) Componenti del sistema
Ponti Isolati Criteri di progettazione ed analisi Università degli Studi di Pavia 1/38 Laboratorio di progettazione strutturale A 1 Sommario 1) Criteri base della progettazione 2) Componenti del sistema
AICAP - ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCESTRUZZO ARMATO E PRECOMPRESSO
 AICAP - ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCESTRUZZO ARMATO E PRECOMPRESSO Guida all uso dell Eurocodice 2 nella progettazione strutturale Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Pisa Pisa, 26 Gennaio
AICAP - ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCESTRUZZO ARMATO E PRECOMPRESSO Guida all uso dell Eurocodice 2 nella progettazione strutturale Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Pisa Pisa, 26 Gennaio
Uno di questi casi è rappresentato dal cedimento in elementi di strutture soggetti a carichi di compressione che danno luogo ad instabilità elastica
 In alcuni casi una struttura soggetta a carichi statici può collassare con un meccanismo diverso da quello del superamento dei limiti di resistenza del materiale. Uno di questi casi è rappresentato dal
In alcuni casi una struttura soggetta a carichi statici può collassare con un meccanismo diverso da quello del superamento dei limiti di resistenza del materiale. Uno di questi casi è rappresentato dal
FATICA OLIGOCICLICA TEORIA E APPLICAZIONI. Fatica Oligociclica Costruzione di Macchine 3
 FATICA OLIGOCICLICA TEORIA E APPLICAZIONI 1 RICHIAMI La fatica è il complesso dei fenomeni per cui un elemento strutturale, soggetto a sollecitazioni cicliche, mostra una resistenza inferiore a quella
FATICA OLIGOCICLICA TEORIA E APPLICAZIONI 1 RICHIAMI La fatica è il complesso dei fenomeni per cui un elemento strutturale, soggetto a sollecitazioni cicliche, mostra una resistenza inferiore a quella
CORSO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI ESERCITAZIONE n 5 del 4/12/2015 PARTE 1: CALCOLO DELLE SOLLECITAZIONI SULLA TRAVE RETICOLARE
 CORSO DI TECICA DELLE COSTRUZIOI ESERCITAZIOE n 5 del 4//05 PARTE : CALCOLO DELLE SOLLECITAZIOI SULLA TRAVE RETICOLARE.) TRAVI RETICOLARI Il generico carico concentrato P è ottenuto moltiplicando il carico
CORSO DI TECICA DELLE COSTRUZIOI ESERCITAZIOE n 5 del 4//05 PARTE : CALCOLO DELLE SOLLECITAZIOI SULLA TRAVE RETICOLARE.) TRAVI RETICOLARI Il generico carico concentrato P è ottenuto moltiplicando il carico
Tensione equivalente o ideale Teorie di rottura
 Tensione equivalente o eale Teorie di rottura Sollecitazioni monodimensionali: le condizioni di ite o di rottura si determinano facilmente Se sollecitazioni sono plurimensionali (invarianti tutti non nulli),
Tensione equivalente o eale Teorie di rottura Sollecitazioni monodimensionali: le condizioni di ite o di rottura si determinano facilmente Se sollecitazioni sono plurimensionali (invarianti tutti non nulli),
LEZIONI N 5 E 6 LA NORMATIVA SULLE COSTRUZIONI
 LEZIONI N 5 E 6 LA NORMATIVA SULLE COSTRUZIONI Chiarito che occorre mantenere una distanza adeguata tra le condizioni di servizio e le condizioni ultime (di rottura), osserviamo che esistono tre possibilità
LEZIONI N 5 E 6 LA NORMATIVA SULLE COSTRUZIONI Chiarito che occorre mantenere una distanza adeguata tra le condizioni di servizio e le condizioni ultime (di rottura), osserviamo che esistono tre possibilità
Calcolo dei calastrelli e delle diagonali
 1 Calcolo dei calastrelli e delle diagonali La funzione dei calastrelli e delle diagonali è quella di conferire un elevata rigidità all asta composta, con una notevole limitazione della sua inflessione
1 Calcolo dei calastrelli e delle diagonali La funzione dei calastrelli e delle diagonali è quella di conferire un elevata rigidità all asta composta, con una notevole limitazione della sua inflessione
ANALISI DI DANNEGGIAMENTO STRUTTURALE PER GRUPPI DI SOLLEVAMENTO
 ANALISI DI DANNEGGIAMENTO STRUTTURALE PER GRUPPI DI SOLLEVAMENTO R.Tovo (1), F.Villani (1), G.Fabbri (2), P.Quagliarella (3),G.Balugani (3),G.Tartara (3) (1) Università degli Studi di Ferrara Facoltà di
ANALISI DI DANNEGGIAMENTO STRUTTURALE PER GRUPPI DI SOLLEVAMENTO R.Tovo (1), F.Villani (1), G.Fabbri (2), P.Quagliarella (3),G.Balugani (3),G.Tartara (3) (1) Università degli Studi di Ferrara Facoltà di
Ingegneria del vetro V.M. Sglavo UNITN Proprietà meccaniche. elasticità! resistenza! densità di legami chimici! forza del legame!
 Proprietà meccaniche elasticità! r 0 resistenza! densità di legami chimici! forza del legame! Durezza! P! profilo impronta scala Mohs diamante 10 zaffiro 9 topazio 8 quarzo ortoclasio apatite fluorite
Proprietà meccaniche elasticità! r 0 resistenza! densità di legami chimici! forza del legame! Durezza! P! profilo impronta scala Mohs diamante 10 zaffiro 9 topazio 8 quarzo ortoclasio apatite fluorite
Scienza delle costruzioni - Luigi Gambarotta, Luciano Nunziante, Antonio Tralli ESERCIZI PROPOSTI
 . Travi isostatiche ad asse rettilineo ESERCIZI PROPOSTI Con riferimento alle tre strutture isostatiche di figura, costituite da tre tratti, determinare: ) Reazioni vincolari; ) Diagrammi del momento flettente
. Travi isostatiche ad asse rettilineo ESERCIZI PROPOSTI Con riferimento alle tre strutture isostatiche di figura, costituite da tre tratti, determinare: ) Reazioni vincolari; ) Diagrammi del momento flettente
f yd = f yk ; s 0, 7 f yk calcestruzzo armato. Le caratteristiche degli acciai, conformi con le Norme Tecniche, vengono presentate più avanti.
 Acciaio per cemento armato ordinario. Le barre di armatura sono caratterizzate dal diametro della barra tonda equipesante, calcolato nell ipotesi che il peso specifico dell acciaio sia 7850 kg/m 3. Secondo
Acciaio per cemento armato ordinario. Le barre di armatura sono caratterizzate dal diametro della barra tonda equipesante, calcolato nell ipotesi che il peso specifico dell acciaio sia 7850 kg/m 3. Secondo
COSTRUZIONE DI MACCHINE
 Corso di laurea in Ingegneria Gestionale A.A. 2013-2014 COSTRUZIONE DI MACCHINE Marino Quaresimin i (Michele Zappalorto, Filippo Berto e Paolo Carraro) Marino Quaresimin Costruzione di Macchine - slide
Corso di laurea in Ingegneria Gestionale A.A. 2013-2014 COSTRUZIONE DI MACCHINE Marino Quaresimin i (Michele Zappalorto, Filippo Berto e Paolo Carraro) Marino Quaresimin Costruzione di Macchine - slide
SOLUZIONE ESERCIZIO 1.1
 SOLUZIONE ESERCIZIO 1.1 La temperatura di fusione ed il coefficiente di espansione termica di alcuni metalli sono riportati nella tabella e nel diagramma sottostante: Metallo Temperatura di fusione [ C]
SOLUZIONE ESERCIZIO 1.1 La temperatura di fusione ed il coefficiente di espansione termica di alcuni metalli sono riportati nella tabella e nel diagramma sottostante: Metallo Temperatura di fusione [ C]
Comportamento meccanico dei terreni
 Comportamento meccanico dei terreni Terreni non coesivi Metodi di analisi Non è possibile raccogliere campioni indisturbati di terreni non coesivi Si ricorre a prove in sito per la determinazione delle
Comportamento meccanico dei terreni Terreni non coesivi Metodi di analisi Non è possibile raccogliere campioni indisturbati di terreni non coesivi Si ricorre a prove in sito per la determinazione delle
Prestazioni degli adesivi strutturali per il rinforzo delle strutture lignee
 Prestazioni degli adesivi strutturali per il rinforzo delle strutture lignee Benedetto Pizzo CNR-IVALSA pizzo@ivalsa.cnr.it CNR-IVALSA Firenze Come si valutano le prestazioni di un adesivo strutturale
Prestazioni degli adesivi strutturali per il rinforzo delle strutture lignee Benedetto Pizzo CNR-IVALSA pizzo@ivalsa.cnr.it CNR-IVALSA Firenze Come si valutano le prestazioni di un adesivo strutturale
Università degli studi Roma Tre Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile
 Università degli studi Roma Tre Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile RELAZIONE DI FINE TIROCINIO PROVE DI CARATTERIZZAZIONE DEL CALCESTRUZZO UTILIZZATO PER I CAMPIONI IN
Università degli studi Roma Tre Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile RELAZIONE DI FINE TIROCINIO PROVE DI CARATTERIZZAZIONE DEL CALCESTRUZZO UTILIZZATO PER I CAMPIONI IN
(curriculum Meccanico & curriculum Meccatronico) Marino Quaresimin. Marino Quaresimin Costruzione di Macchine - slide 1
 Corso di laurea in Ingegneria Meccanica e Meccatronica (curriculum Meccanico & curriculum Meccatronico) COSTRUZIONE DI MACCHINE E LABORATORIO Marino Quaresimin Marino Quaresimin Costruzione di Macchine
Corso di laurea in Ingegneria Meccanica e Meccatronica (curriculum Meccanico & curriculum Meccatronico) COSTRUZIONE DI MACCHINE E LABORATORIO Marino Quaresimin Marino Quaresimin Costruzione di Macchine
Walter Salvatore, Dipartimento di Ingegneria Civile Università di Pisa
 PROGETTAZIONE PRESTAZIONALE ANTISIMICA: PROBLEMI SPECIFICI PER LE COSTRUZIONI IN ACCIAIO Walter Salvatore, e-mail walter@ing.unipi.it Dipartimento di Ingegneria Civile Università di Pisa Applicabilità
PROGETTAZIONE PRESTAZIONALE ANTISIMICA: PROBLEMI SPECIFICI PER LE COSTRUZIONI IN ACCIAIO Walter Salvatore, e-mail walter@ing.unipi.it Dipartimento di Ingegneria Civile Università di Pisa Applicabilità
Università degli Studi di Napoli Federico II
 Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Ingegneria Dipartimento di Analisi e Progettazione Strutturale TESI DI LAUREA ANALISI TEORICO SPERIMENTALE DI ELEMENTI MURARI RINFORZATI CON FRP:
Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Ingegneria Dipartimento di Analisi e Progettazione Strutturale TESI DI LAUREA ANALISI TEORICO SPERIMENTALE DI ELEMENTI MURARI RINFORZATI CON FRP:
Calcolo delle aste composte
 L acciaio. Strutture in acciaio 1 Calcolo delle aste composte Calcolo della snellezza equivalente La snellezza equivalente viene calcolata con le seguenti relazioni: aste calastrellate: λ eq λ y + λ 1
L acciaio. Strutture in acciaio 1 Calcolo delle aste composte Calcolo della snellezza equivalente La snellezza equivalente viene calcolata con le seguenti relazioni: aste calastrellate: λ eq λ y + λ 1
PRINCIPI E METODOLOGIE DELLE COSTRUZIONI DI MACCHINE A.A
 PRINCIPI E METODOLOGIE DELLE COSTRUZIONI DI MACCHINE A.A. 2015-2016 Docente: Domenico Gentile Tel. 07762994336 Mail: gentile@unicas.it Ulteriori informazioni sul sito del docente. 1 Altre informazioni
PRINCIPI E METODOLOGIE DELLE COSTRUZIONI DI MACCHINE A.A. 2015-2016 Docente: Domenico Gentile Tel. 07762994336 Mail: gentile@unicas.it Ulteriori informazioni sul sito del docente. 1 Altre informazioni
Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Ingegneria e Architettura. Fondamenti di Costruzioni Meccaniche Tensione e deformazione Carico assiale
 Esercizio N.1 Un asta di acciaio è lunga 2.2 m e non può allungarsi più di 1.2 mm quando le si applica un carico di 8.5 kn. Sapendo che E = 200 GPa, determinare: (a) il più piccolo diametro dell asta che
Esercizio N.1 Un asta di acciaio è lunga 2.2 m e non può allungarsi più di 1.2 mm quando le si applica un carico di 8.5 kn. Sapendo che E = 200 GPa, determinare: (a) il più piccolo diametro dell asta che
Esempi domande CMM pagina 1
 : omande di Statica - - -3-4 -5-6 -7-8 Nel diagramma σ - ε di un materiale duttile, secondo la simbologia UNI-ISO la tensione di scostamento dalla proporzionalità R P0 è: [A] il valore limite per cui la
: omande di Statica - - -3-4 -5-6 -7-8 Nel diagramma σ - ε di un materiale duttile, secondo la simbologia UNI-ISO la tensione di scostamento dalla proporzionalità R P0 è: [A] il valore limite per cui la
Mediatori didattici. 1) Insiemi ed elementi di un insieme Rappresentazione degli insiemi Sottoinsiemi Operazioni con gli insiemi
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERESARA GAZOLDO PIUBEGA SCUOLA SECONDARIA DI PIUBEGA Anno scolastico 2014-2015 PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA CLASSE III A Destinatari: alunni classe III Traguardo formativo generale:
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERESARA GAZOLDO PIUBEGA SCUOLA SECONDARIA DI PIUBEGA Anno scolastico 2014-2015 PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA CLASSE III A Destinatari: alunni classe III Traguardo formativo generale:
Il modello di cerniera plastica
 Il modello di cerniera plastica Quando il comportamento a rottura della sezione di una trave piana dipende dalla sola caratteristica di momento flettente, il dominio limite si riduce ad intervallo della
Il modello di cerniera plastica Quando il comportamento a rottura della sezione di una trave piana dipende dalla sola caratteristica di momento flettente, il dominio limite si riduce ad intervallo della
FATICA OLIGOCICLICA DI GIUNZIONI SALDATE DI ACCIAI A BASSA RESISTENZA IMPIEGATI NELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE
 FATICA OLIGOCICLICA DI GIUNZIONI SALDATE DI ACCIAI A BASSA RESISTENZA IMPIEGATI NELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE G. Chiofalo, V. Crupi, E. Guglielmino DCIIM, Facoltà di Ingegneria, Università di Messina,
FATICA OLIGOCICLICA DI GIUNZIONI SALDATE DI ACCIAI A BASSA RESISTENZA IMPIEGATI NELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE G. Chiofalo, V. Crupi, E. Guglielmino DCIIM, Facoltà di Ingegneria, Università di Messina,
Circonferenza. Matteo Tugnoli. February 26, 2012
 Circonferenza Matteo Tugnoli February 26, 2012 Versione preliminare, NON esente da errori, se il lettore riscontrasse delle imprecisioni può gentilmente segnalarle a matteo_tugnoli@yahoo.it 1 Luogo dei
Circonferenza Matteo Tugnoli February 26, 2012 Versione preliminare, NON esente da errori, se il lettore riscontrasse delle imprecisioni può gentilmente segnalarle a matteo_tugnoli@yahoo.it 1 Luogo dei
LA RIPARAZIONE DEGLI ACCIAI ALTORESISTENZIALI
 LA RIPARAZIONE DEGLI ACCIAI ALTORESISTENZIALI Aspetti tecnici Negli ultimi 10 anni la resistenza a trazione degli acciai strutturali è triplicata. Si parla di acciai altoresistenziali se il carico di snervamento
LA RIPARAZIONE DEGLI ACCIAI ALTORESISTENZIALI Aspetti tecnici Negli ultimi 10 anni la resistenza a trazione degli acciai strutturali è triplicata. Si parla di acciai altoresistenziali se il carico di snervamento
CEMENTO ARMATO CENNI SULLA TEORIA DEL CEMENTO ARMATO
 CEMENTO ARMATO CENNI SULLA TEORIA DEL CEMENTO ARMATO Normativa di riferimento Normativa di riferimento Le prescrizioni relative a! calcolo delle strutture dei componenti strutturali e alle caratteristiche
CEMENTO ARMATO CENNI SULLA TEORIA DEL CEMENTO ARMATO Normativa di riferimento Normativa di riferimento Le prescrizioni relative a! calcolo delle strutture dei componenti strutturali e alle caratteristiche
COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO PROF.RIZZO
 Parte da stralciare portandola a me tematica Parte da stralciare portandola a me tematica COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO PROF.RIZZO LEZIONE ARGOMENTI note 1. Introduzione Presentazione del corso 2. Cenni
Parte da stralciare portandola a me tematica Parte da stralciare portandola a me tematica COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO PROF.RIZZO LEZIONE ARGOMENTI note 1. Introduzione Presentazione del corso 2. Cenni
Principi e Metodologie della Progettazione Meccanica
 Principi e Metodologie della Progettazione Meccanica ing. F. Campana a.a. 06-07 Lezione 11: CAE e Ottimizzazione Strutturale Il ruolo dell ottimizzazione nell ambito della progettazione meccanica Durante
Principi e Metodologie della Progettazione Meccanica ing. F. Campana a.a. 06-07 Lezione 11: CAE e Ottimizzazione Strutturale Il ruolo dell ottimizzazione nell ambito della progettazione meccanica Durante
Stato di tensione residua di rullatura su elementi per prove di fatica da fretting con collegamento forzato albero mozzo
 Stato di tensione residua di rullatura su elementi per prove di fatica da fretting con collegamento forzato albero mozzo Autori: Prof. M. Beghini, Ing. B.D. Monelli, Ing. C. Santus Università di Pisa 1/24
Stato di tensione residua di rullatura su elementi per prove di fatica da fretting con collegamento forzato albero mozzo Autori: Prof. M. Beghini, Ing. B.D. Monelli, Ing. C. Santus Università di Pisa 1/24
ANALISI DI PANNELLI MURARI RINFORZATI CON FRP SOGGETTI A SOLLECITAZIONI DI TAGLIO
 Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Ingegneria Civile WORKSHOP 12-13 13 febbraio 27 Materiali ed Approcci Innovativi per il Progetto in Zona Sismica e la Mitigazione della Vulnerabilità delle
Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Ingegneria Civile WORKSHOP 12-13 13 febbraio 27 Materiali ed Approcci Innovativi per il Progetto in Zona Sismica e la Mitigazione della Vulnerabilità delle
3 Geometria delle masse e momento di 2 ordine 3.3 Ellisse centrale d inerzia e nocciolo centrale d inerzia
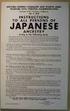 3 Geometria delle masse e momento di ordine ESERCIZI SVOLTI Considerata la sezione rappresentata in figura, calcolare i raggi d inerzia massimo e minimo, tracciare l ellisse d inerzia e il nocciolo centrale
3 Geometria delle masse e momento di ordine ESERCIZI SVOLTI Considerata la sezione rappresentata in figura, calcolare i raggi d inerzia massimo e minimo, tracciare l ellisse d inerzia e il nocciolo centrale
RELAZIONE COMPORTAMENTO MECCANICO DEI MATERIALI: MISURE ESTENSIMETRICHE
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA RELAZIONE COMPORTAMENTO MECCANICO DEI MATERIALI: MISURE ESTENSIMETRICHE Relazione a cura di: Mattia Lai 45295 Andrea Aresu 45198
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA RELAZIONE COMPORTAMENTO MECCANICO DEI MATERIALI: MISURE ESTENSIMETRICHE Relazione a cura di: Mattia Lai 45295 Andrea Aresu 45198
Le piastre Progettazione
 Corso di Progetto di Strutture POTENZA, a.a. 2012 2013 Le piastre Progettazione Dott. Marco VONA Scuola di Ingegneria, Università di Basilicata marco.vona@unibas.it http://www.unibas.it/utenti/vona/ CONTENUTI
Corso di Progetto di Strutture POTENZA, a.a. 2012 2013 Le piastre Progettazione Dott. Marco VONA Scuola di Ingegneria, Università di Basilicata marco.vona@unibas.it http://www.unibas.it/utenti/vona/ CONTENUTI
Prove sperimentali a rottura di travi rettangolari in cemento armato con staffatura tipo Spirex e staffatura tradizionale
 Università degli Studi di Firenze DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE LABORATORIO PROVE STRUTTURE E MATERIALI Via di Santa Marta, 3-50139 Firenze Prove sperimentali a rottura di travi rettangolari
Università degli Studi di Firenze DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE LABORATORIO PROVE STRUTTURE E MATERIALI Via di Santa Marta, 3-50139 Firenze Prove sperimentali a rottura di travi rettangolari
Calcolo strutturale dell albero a gomito di un motore motociclistico
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTA DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE Calcolo strutturale dell albero a gomito di un motore motociclistico Tesi di
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTA DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE Calcolo strutturale dell albero a gomito di un motore motociclistico Tesi di
Sistemi lineari. Lorenzo Pareschi. Dipartimento di Matematica & Facoltá di Architettura Universitá di Ferrara
 Sistemi lineari Lorenzo Pareschi Dipartimento di Matematica & Facoltá di Architettura Universitá di Ferrara http://utenti.unife.it/lorenzo.pareschi/ lorenzo.pareschi@unife.it Lorenzo Pareschi (Univ. Ferrara)
Sistemi lineari Lorenzo Pareschi Dipartimento di Matematica & Facoltá di Architettura Universitá di Ferrara http://utenti.unife.it/lorenzo.pareschi/ lorenzo.pareschi@unife.it Lorenzo Pareschi (Univ. Ferrara)
A A N LI A S LI I S I P U P S U H S - H OV
 ANALISI PUSH-OVER 1 Analisi push-over L analisi push-over rappresenta l ultima evoluzione dell analisi statica delle costruzioni in zona sismica L idea di fondo è quella di ricondurre l analisi dinamica
ANALISI PUSH-OVER 1 Analisi push-over L analisi push-over rappresenta l ultima evoluzione dell analisi statica delle costruzioni in zona sismica L idea di fondo è quella di ricondurre l analisi dinamica
ELETTRODOTTO AEREO A 150 KV VALUTAZIONE DEL RUMORE PRODOTTO DAL VENTO SUI CONDUTTORI COMUNE DI CORATO (BA)
 ELETTRODOTTO AEREO A 150 KV VALUTAZIONE DEL RUMORE PRODOTTO DAL VENTO SUI CONDUTTORI COMUNE DI CORATO (BA) 2 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI Ref. 1: Kiyoshi Shimojima, Aerodynamic Noise generated by Overhead
ELETTRODOTTO AEREO A 150 KV VALUTAZIONE DEL RUMORE PRODOTTO DAL VENTO SUI CONDUTTORI COMUNE DI CORATO (BA) 2 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI Ref. 1: Kiyoshi Shimojima, Aerodynamic Noise generated by Overhead
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA TENSOSTRUTTURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA NAPOLEONICA COMMITTENTE. Comune di Bagnolo di Po
 Pag. 1 di 11 totali LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA TENSOSTRUTTURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA NAPOLEONICA COMMITTENTE Comune di Bagnolo di Po UBICAZIONE TENSOSTRUTTURA PRESSO COMUNE DI BAGNOLO
Pag. 1 di 11 totali LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA TENSOSTRUTTURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA NAPOLEONICA COMMITTENTE Comune di Bagnolo di Po UBICAZIONE TENSOSTRUTTURA PRESSO COMUNE DI BAGNOLO
IL LEGNO COME MATERIALE STRUTTURALE E LE SUE PROPRIETA MECCANICHE
 Corso di formazione: SISTEMI COSTRUTTIVI DI COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE Ordine degli Ingegneri di Napoli 5 e 6 maggio 2014 IL LEGNO COME MATERIALE STRUTTURALE E LE SUE PROPRIETA MECCANICHE Parte 2: IL
Corso di formazione: SISTEMI COSTRUTTIVI DI COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE Ordine degli Ingegneri di Napoli 5 e 6 maggio 2014 IL LEGNO COME MATERIALE STRUTTURALE E LE SUE PROPRIETA MECCANICHE Parte 2: IL
Caratteristiche di materiali
 Caratteristiche di materiali Caratteristiche macroscopiche Lavorazione Microstruttura Formula chimica Legami chimici Struttura atomica Meccaniche Materiale Fisiche Elettriche Megnetiche Termiche Meccaniche
Caratteristiche di materiali Caratteristiche macroscopiche Lavorazione Microstruttura Formula chimica Legami chimici Struttura atomica Meccaniche Materiale Fisiche Elettriche Megnetiche Termiche Meccaniche
Corso di Riabilitazione Strutturale
 Corso di Riabilitazione Strutturale POTENZA, a.a. 2011 2012 VALUTAZIONE DIEDIFICI ESISTENTI IN C.A. I PARTE ANALISI E STRATEGIE DI INTERVENTO Dott. Marco VONA DiSGG, Università di Basilicata marco.vona@unibas.it
Corso di Riabilitazione Strutturale POTENZA, a.a. 2011 2012 VALUTAZIONE DIEDIFICI ESISTENTI IN C.A. I PARTE ANALISI E STRATEGIE DI INTERVENTO Dott. Marco VONA DiSGG, Università di Basilicata marco.vona@unibas.it
La prova di trazione e l effetto dell anisotropia. Giuseppe Pellegrini, Universita degli Studi di Bergamo
 La prova di trazione e l effetto dell anisotropia. Giuseppe Pellegrini, Universita degli Studi di Bergamo E pratica comune valutare le proprieta meccaniche di una lamiera utilizzando la prova di trazione.
La prova di trazione e l effetto dell anisotropia. Giuseppe Pellegrini, Universita degli Studi di Bergamo E pratica comune valutare le proprieta meccaniche di una lamiera utilizzando la prova di trazione.
Appunti su Indipendenza Lineare di Vettori
 Appunti su Indipendenza Lineare di Vettori Claudia Fassino a.a. Queste dispense, relative a una parte del corso di Matematica Computazionale (Laurea in Informatica), rappresentano solo un aiuto per lo
Appunti su Indipendenza Lineare di Vettori Claudia Fassino a.a. Queste dispense, relative a una parte del corso di Matematica Computazionale (Laurea in Informatica), rappresentano solo un aiuto per lo
VALIDAZIONE DI UN CODICE DI CALCOLO AGLI ELEMENTI FINITI
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Facoltà di Ingegneria CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO (CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA CIVILE E
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Facoltà di Ingegneria CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO (CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA CIVILE E
VERIFICA SECONDO UNI EN 13374
 Ferro-met SRL Via Medici 22/24/24a - 25080 Prevalle (BS) Tel. +39 030 6801973 Fax. +39 030 6801163 P.IVA - C.F. - C.C.I.A.A. BS: 01757240989 REA 349144 Cap. Soc. 300.000 Int. Vers. www.ferro-met.com info@ferro-met.com
Ferro-met SRL Via Medici 22/24/24a - 25080 Prevalle (BS) Tel. +39 030 6801973 Fax. +39 030 6801163 P.IVA - C.F. - C.C.I.A.A. BS: 01757240989 REA 349144 Cap. Soc. 300.000 Int. Vers. www.ferro-met.com info@ferro-met.com
Geometria delle Aree. Finora ci si è occupati di determinare le sollecitazioni che agiscono su sezioni di elementi monodimensionali
 eometria delle ree Finora ci si è occupati di determinare le sollecitazioni che agiscono su sezioni di elementi monodimensionali In realtà lo studio della Meccanica delle Strutture non si accontenta di
eometria delle ree Finora ci si è occupati di determinare le sollecitazioni che agiscono su sezioni di elementi monodimensionali In realtà lo studio della Meccanica delle Strutture non si accontenta di
Caratteristiche di materiali
 Caratteristiche di materiali Caratteristiche macroscopiche Lavorazione Microstruttura Formula chimica Legami chimici Struttura atomica Meccaniche Materiale Fisiche Elettriche Megnetiche Termiche Meccaniche
Caratteristiche di materiali Caratteristiche macroscopiche Lavorazione Microstruttura Formula chimica Legami chimici Struttura atomica Meccaniche Materiale Fisiche Elettriche Megnetiche Termiche Meccaniche
Premessa 1. Notazione e simbologia Notazione matriciale Notazione tensoriale Operazioni tensoriali in notazione matriciale 7
 Premessa 1 Notazione e simbologia 3 0.1 Notazione matriciale 3 0.2 Notazione tensoriale 4 0.3 Operazioni tensoriali in notazione matriciale 7 Capitolo 7 La teoria delle travi 9 7.1 Le teorie strutturali
Premessa 1 Notazione e simbologia 3 0.1 Notazione matriciale 3 0.2 Notazione tensoriale 4 0.3 Operazioni tensoriali in notazione matriciale 7 Capitolo 7 La teoria delle travi 9 7.1 Le teorie strutturali
LEZIONE N 46 LA TORSIONE ALLO S.L.U.
 LEZIONE N 46 LA ORSIONE ALLO S.L.U. Supponiamo di sottoporre a prova di carico una trave di cemento armato avente sezione rettangolare b x H soggetta a momento torcente uniforme. All interno di ogni sua
LEZIONE N 46 LA ORSIONE ALLO S.L.U. Supponiamo di sottoporre a prova di carico una trave di cemento armato avente sezione rettangolare b x H soggetta a momento torcente uniforme. All interno di ogni sua
ESERCITAZIONI. MATERIALI PER L EDILIZIA Prof. L. Coppola. Coffetti Denny
 MATERIALI PER L EDILIZIA Prof. L. Coppola ESERCITAZIONI Coffetti Denny PhD Candidate Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate Università degli Studi di Bergamo ESERCIZIO 1 IL COLLAUDO DI UNA BARRA
MATERIALI PER L EDILIZIA Prof. L. Coppola ESERCITAZIONI Coffetti Denny PhD Candidate Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate Università degli Studi di Bergamo ESERCIZIO 1 IL COLLAUDO DI UNA BARRA
COSTRUZIONE DI MACCHINE 1. Obiettivi formativi: PROGRAMMA TESTI DI RIFERIMENTO
 COSTRUZIONE DI MACCHINE 1 Obiettivi formativi: Il corso si propone di fornire la preparazione sui fondamenti dei criteri di calcolo, di progetto e di verifica di elementi e di organi delle macchine. PROGRAMMA
COSTRUZIONE DI MACCHINE 1 Obiettivi formativi: Il corso si propone di fornire la preparazione sui fondamenti dei criteri di calcolo, di progetto e di verifica di elementi e di organi delle macchine. PROGRAMMA
CURRICOLO DI MATEMATICA CLASSE PRIMA
 CURRICOLO DI MATEMATICA CLASSE PRIMA INDICATORI OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI NUMERI Eseguire le quattro operazioni con i numeri interi. Elevare a potenza numeri naturali e interi. Comprendere il significato
CURRICOLO DI MATEMATICA CLASSE PRIMA INDICATORI OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI NUMERI Eseguire le quattro operazioni con i numeri interi. Elevare a potenza numeri naturali e interi. Comprendere il significato
5. Effetto d intaglio
 5. Effetto d intaglio 5.1 Introduzione Intaglio: nelle costruzioni meccaniche, soluzione di continuità, feritoia di piccole dimensioni o anche brusca variazione di sezione di un pezzo meccanico La Piccola
5. Effetto d intaglio 5.1 Introduzione Intaglio: nelle costruzioni meccaniche, soluzione di continuità, feritoia di piccole dimensioni o anche brusca variazione di sezione di un pezzo meccanico La Piccola
