Acqua. La provincia di Trento è ricca di fiumi, laghi e acque sotterranee. Monitorarne la qualità significa garantirne la protezione.
|
|
|
- Alessia Santini
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 ACQUA AGGIORNAMENTO 2015 Acqua La provincia di Trento è ricca di fiumi, laghi e acque sotterranee. Monitorarne la qualità significa garantirne la protezione. 1
2 RAPPORTO SULLO STATO DELL AMBIENTE a cura di: Paolo Negri - Settore tecnico per la tutela dell ambiente APPA con la collaborazione di: Catia Monauni - Settore tecnico per la tutela dell ambiente APPA Sabrina Pozzi - Settore tecnico per la tutela dell ambiente APPA Jacopo Mantoan - Settore tecnico per la tutela dell ambiente APPA (redazione) impaginazione e grafica: Isabella Barozzi - APPA cartografia: Gaetano Patti e Mario Mazzurana - Settore tecnico per la tutela dell ambiente APPA 2
3 Contenuti Acqua (qualità dei corpi idrici) - aggiornamento Il nuovo Piano di tutela delle acque Il sistema delle acque superficiali e sotterranee Le acque superficiali Individuazione dei corpi idrici fluviali La rete di monitoraggio dei corpi idrici fluviali La classificazione dei corpi idrici fluviali La rete di monitoraggio dei corpi idrici lacustri La classificazione dei corpi idrici lacustri Il monitoraggio dei laghi nel Le acque sotterranee La rete di monitoraggio delle acque sotterranee Stato Chimico dei corpi idrici sotterranei... 23
4 RAPPORTO SULLO STATO DELL AMBIENTE
5 ACQUA AGGIORNAMENTO 2015 ACQUA - AGGIORNAMENTO 2013 Il capitolo affronta il tema della qualità delle acque superficiali (fluviali e lacustri) e sotterranee. Rispetto all ultimo Rapporto sullo Stato dell Ambiente, questo aggiornamento riporta la classificazione inserita nel Piano di tutela delle acque 2015, approvato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 233 di data 16 Febbraio 2015 e effettuata con i criteri della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE. 1. Il nuovo Piano di tutela delle acque Lo strumento di pianificazione dei corpi idrici provinciali della Provincia Autonoma di Trento è il Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato a febbraio 2015, che sostituisce il precedente risalente al Questo Piano si pone come tassello del vasto e organico sistema di governo e di gestione del territorio, assicurando la coerenza rispetto agli altri strumenti di pianificazione dell ambiente. La revisione del PTA ha recepito anche l adeguamento delle attività di monitoraggio ai cambiamenti della normativa in materia acque. Il PTA descrive la qualità dei corpi idrici e le misure necessarie da adottare per risanare i corpi idrici non buoni e mantenere lo stato di qualità di quelli buoni ed elevati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06. La nuova normativa vigente, la Direttiva comunitaria 2000/60/CE ed il relativo recepimento nazionale con il D.Lgs. n.152/06, hanno ridefinito l approccio in materia di tutela e gestione delle acque: innanzitutto la tutela delle acque viene estesa a tutti i corsi d acqua del reticolo idrografico aventi un bacino imbrifero maggiore di 10 kmq. Si passa dunque ad una metodologia a scala di corpo idrico, transitando quindi da una politica di tutela generale ad una politica di tutela e gestione del singolo corpo idrico (tratti fluviali, volumi distinti di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere e laghi). Per un completo quadro conoscitivo dei corpi idrici e del loro stato di qualità, APPA in questi anni ha condotto un capillare lavoro di analisi e ricerca sul campo e in laboratorio attraverso una fitta rete di monitoraggio aggiornata secondo le indicazioni del D.Lgs. 152/06. Il ricorso ad una solida attività di monitoraggio e a metodi per una valutazione complessiva dello stato dei corpi idrici sono elementi essenziali per una corretta gestione delle acque. Il monitoraggio secondo la normativa vigente prevede l utilizzo di indicatori sia chimico-fisici sia biologici. Tutta la documentazione del Piano di Tutela è consultabile sul sito 1 dell Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente. 5
6 T. CISMON RAPPORTO SULLO STATO DELL AMBIENTE 2. Il sistema delle acque superficiali e sotterranee Le acque superficiali II sistema idrografico trentino è condizionato fortemente dalla morfologia territoriale, caratterizzata da ampie valli glaciali, da sezioni ad U, contornate da versanti rocciosi e ripidi, come la Valle dell Adige e del Basso Sarca e da valli incise con alternanza di cenge 2 e lievi pendii moderati a seconda dell affioramento di rocce più o meno erodibili, come ad esempio la zona delle Dolomiti. Ne conseguono corsi d acqua con regime torrentizio nelle zone montane a maggiore acclività, caratterizzate da acque con forte ossigenazione e temperature piuttosto rigide (in genere inferiori ai 10 C) spesso originate da ghiacciai in quota e fiumi che scorrono nei fondovalle e assumono in qualche caso, in zone ancora poco antropizzate, andamenti a tratti meandriformi. Le pendenze elevate dei versanti in concomitanza alla limitata lunghezza delle aste fluviali, agevolano i fenomeni di trasporto e di abbattimento fisico delle sostanze immesse piuttosto che quelli di natura biologica, come l abbattimento della sostanza organica da parte di diversi tipi di organismi acquatici. E peculiare per la tipologia di corso d acqua quindi la fragilità di questi ecosistemi, che presentano fisiologicamente una bassa funzionalità ecosistemica. Tale capacità viene descritta e dettagliata mediante l applicazione dell Indice di Funzionalità Fluviale (IFF). E importante sottolineare come la portata idrica dei bacini principali sia fortemente influenzata da strutture quali invasi, sbarramenti e bacini artificiali per lo sfruttamento idroelettrico; a queste opere si aggiungono le derivazioni e i canali di gronda che riducono la portata dei corsi d acqua. La superficie totale dei bacini imbriferi principali e secondari equivale a Km 2 ; i primi si sviluppano per Km 2, i secondi per 186 Km 2 (Figura 1 e Tabella 1 e 2) con un estensione di 6.208,45 Km 2 all interno del territorio provinciale (98%). Figura 1: corsi d acqua e laghi principali della provincia di Trento L. di Fedaia L. di S.Giustina T. NOCE ISIO T. A V L. di Forte Buso L. di Stramentizzo T. NOCE T. AVISIO T. VANOI L. di Molveno L. della Serraia T. F ERS I NA L. dello Schener L. di Malga Bissina L. di Toblino L. di Levico FIUME BRENTA L. d'idro FIUME CHIESE L. di Ledro L. di Garda L. di Cavedine L. di Loppio FIUME ADIGE L. di Caldonazzo T. ASTICO Laghi e corsi d'acqua del Trentino Corsi d'acqua principali Laghi principali 1 Il link del PTA: 2 La cengia (o anche cornice) è una sporgenza pianeggiante di una parete rocciosa, che interrompe la verticalità della parete di una montagna, spesso sede di sentiero o punto di riposo durante un'ascensione. Durante la prima guerra mondiale, nelle cime delle Alpi, vennero molto utilizzate, o addirittura scavate, per poter muoversi al nascosto dal nemico. 6
7 ACQUA AGGIORNAMENTO 2015 Tabella 1: suddivisione dei bacini in territorio provinciale ed extra provinciale Bacini imbriferi principali Superficie scorrimento in provincia scorrimento fuori provincia km 2 km 2 % km 2 % NOCE 1.366, ,14 95,57 60,53 4,43 SARCA 1.267, ,62 98,96 13,16 1,04 ADIGE 949,65 935,78 98,54 13,86 1,46 AVISIO 939,58 920,16 97,93 19,42 2,07 BRENTA 618,35 612,55 99,06 5,8 0,94 CHIESE 409,94 408,63 99,68 1,31 0,32 VANOI 236,85 229,52 96,9 7,33 3,1 CISMON 208,6 201,33 96,51 7,27 3,49 FERSINA 170,35 170, Bacini imbriferi secondari ASTICO 84,05 81,62 97,12 2,42 2,88 CORDEVOLE 44,36 31,66 71,37 12,7 28,63 SENAIGA 43,75 29,55 67,54 14,2 32,46 ISARCO 7,59 7,57 99,83 0,01 0,17 ILLASI 6,43 5,14 80,02 1,28 19,98 Altri 13,82 Totale 6.353, ,44 97,71 159,29 2,51 Fonte: Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche PAT Tabella 2: superficie provinciale nei bacini di rilievo nazionale Bacino Superficie totale km 2 Superficie in provincia km 2 % ADIGE ,15 28 PO ,25 2,3 BRENTA-BACCHIGLIONE ,57 19,8 PIAVE ,66 0,8 Fonte: Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche PAT 7
8 RAPPORTO SULLO STATO DELL AMBIENTE Le morfologie montuose del Trentino ospitano circa 297 specchi lacustri, con una superficie complessiva di 35 Km2 nella quasi totalità dovuti all azione diretta o indiretta del modellamento glaciale. Lo stato trofico è variabile, legato sia a fattori naturali che all attività antropica. La distribuzione altimetrica si estende dai 65 m s.l.m. per il lago di Garda fino ai m s.l.m.; il maggior numero di laghi s incontra tra i 1500 e i m s.l.m. (257 unità) mentre i restanti sono tutti localizzati in un range altimetrico al di sotto dei 1200 m s.l.m.. I laghi di alta quota hanno la morfologia spiccatamente alpina del circo: di forma discretamente regolare, tendente alla circolarità, godono di una prevedibile lunga durata nel tempo data da una alimentazione di acque superficiali lievi, tranquille, prive di contenuti solidi che ne determinano la loro limpidezza. Dal punto di vista qualitativo i laghi più minacciati sono generalmente quelli in valle, dove maggiormente si concentrano gli agglomerati urbani. In questi laghi si evidenziano in qualche caso fenomeni di eutrofizzazione dovuti all eccessivo accumulo di nutrienti, presenti talvolta anche come retaggio del passato. Le acque sotterranee Gli acquiferi sotterranei rappresentano un ecosistema complesso e spesso fortemente interagente con gli ecosistemi superficiali. In relazione alle caratteristiche geologico-strutturali e morfologiche del territorio, le strutture degli acquiferi sotterranei si possono identificare in tre gruppi principali: strutture delle valli sovralluvionate alpine 3 ; strutture carbonatiche 4 ; strutture delle coltri eluviali e dei depositi quaternari sciolti di pendio nei massicci cristallini e metamorfici 5. Ad oggi sono stati censiti in provincia di Trento circa sorgenti e pozzi. Dal punto di vista qualitativo gli acquiferi maggiormente a rischio sono quelli di fondovalle, minacciati dall intensa attività umana che si svolge in superficie; ma dal punto di vista del rischio intrinseco, cioè legato alla vulnerabilità della matrice terreno, quelli che corrono maggiori rischi a causa della elevata permeabilità dei terreni sono situati in quota. Questi ultimi costituiscono inoltre le riserve strategiche della provincia. Il territorio, a causa della conformazione montana, concentra nelle valli la maggior parte delle attività, da quelle agricole a quelle industriali. E quindi nelle valli che il rischio d inquinamento dei corpi idrici è maggiore. Mentre l inquinamento di tipo industriale e agricolo è limitato ad alcuni ambiti, l impatto antropico dovuto al turismo, che ha acquistato sempre maggior rilievo negli ultimi anni, è un fenomeno piuttosto distribuito sul territorio e in genere sottostimato, causa di problemi nelle zone ambientalmente delicate. 3 Le valli sovralluvionate alpine sono costituite da un materasso di terreni quaternari diversi per composizione litologica e permeabilità; derivando sia da depositi fluviali molto grossolani e conducibili, sia da depositi di tipo lacustre a conducibilità ridotta o assente. Nelle valli principali (Adige, Sarca, Valsugana, Giudicarie inferiori) il materasso quaternario raggiunge potenze considerevoli (a Trento ad esempio supera i 600 metri). 4 Le strutture carbonatiche sono costituite da rocce sedimentarie in cui matrice e struttura sono composti da oltre il 50% di minerali carbonatici. Le strutture e tessiture delle rocce carbonatiche riflettono fattori biologici di bacino, la sorgente dei sedimenti carbonatici è quasi esclusivamente biologica. I massicci carbonatici, nonostante la locale frammentarietà delle strutture, costituiscono uno dei più importanti serbatoi idrici della provincia di cui fino ad ora si sfruttano solo le emergenze spontanee. 5 La coltre eluviale o eluvium è costituita dal prodotto di alterazione delle rocce in sito, che si sviluppa nella parte superficiale delle masse rocciose. Le strutture delle coltri eluviali e dei depositi quaternari sciolti di pendio nei massicci cristallini e metamorfici pur rappresentando realmente una parte preponderante del territorio provinciale non contengono acquiferi di significativa importanza. 8
9 ACQUA AGGIORNAMENTO Le acque superficiali Il controllo della qualità delle acque superficiali è avvenuto, fino al 2008, attraverso il monitoraggio e la classificazione secondo criteri e procedure definiti nel D.Lgs. 152/99. L entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, che ha recepito la Direttiva 2000/60/CE, ha proposto importanti modifiche relative alla metodologia di monitoraggio. L obiettivo del decreto è di stabilire un quadro generale coerente ed esauriente dello stato ecologico e chimico delle acque all interno di ciascun bacino idrografico, con lo scopo di raggiungere l obiettivo di qualità buono entro il 2015 per tutti i corpi idrici nazionali e mantenere lo stato elevato per i corpi idrici a cui è già attribuito. Lo stato ecologico buono significa che i valori degli elementi di qualità biologica [ ] si discostano solo lievemente da quelli di norma associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato (All.1, D.Lgs. 152/06). 3.1 Individuazione dei corpi idrici fluviali Per riuscire a classificare la qualità ecologica dei corsi d acqua, l Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente (APPA) nel ha individuato e tipizzato i corpi idrici per tutta la rete idrografica della provincia di Trento secondo la metodologia prevista dal D.M. 131/08. Un corso d acqua per essere tipizzato e suddiviso in corpi idrici deve avere un bacino scolante uguale o maggiore di 10 km2; il corpo idrico è un tratto omogeneo di corso d acqua, definito in base a caratteristiche geografiche, climatiche, morfologiche e di pressioni dovute all azione dell uomo, ed è l unità a cui fare riferimento per riportare e accertare la conformità con gli obiettivi ambientali di cui al D.Lgs. 152/06. In provincia di Trento sono stati quindi individuati in prima istanza 412 corpi idrici e sono stati inseriti nei Piani di gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali e dell Autorità di bacino del fiume Po. 9
10 RAPPORTO SULLO STATO DELL AMBIENTE 3.2 La rete di monitoraggio dei corpi idrici fluviali Con l emanazione del D.M. 260/2010, che definisce i criteri di classificazione dei corpi idrici, è iniziato il monitoraggio previsto dal D.Lgs. 152/06, dopo una prima fase sperimentale che era iniziata già nel biennio E stata definita la nuova rete di monitoraggio, articolata in quattro tipologie (rete operativa, di sorveglianza, rete nucleo e monitoraggio di indagine) ed è iniziata l attività di campo e di laboratorio. L APPA ha scelto le stazioni da inserire nella nuova rete di monitoraggio mantenendo la rete storica della provincia di Trento, che comprendeva 27 punti collocati sulle aste principali dei corsi d acqua in posizioni già individuate come significative per monitorare le pressioni presenti. Per assicurare la serie storica, il monitoraggio su questi punti viene mantenuto anche secondo le modalità tradizionali: oltre alle analisi richieste dal D.Lgs. 152/06, vengono quindi effettuate, quando possibile, anche le analisi chimiche, microbiologiche e biologiche previste dal D.Lgs. 152/99. A questi 27 punti sono stati aggiunti altri 10 già monitorati come acque a specifica destinazione per la vita dei pesci, secondo il D.Lgs. 130/ Nella scelta dei rimanenti punti si è tenuto conto dello stato dei corpi idrici, in base a dati pregressi di monitoraggio (erano disponibili i dati su una settantina di stazioni posizionate sui corsi d acqua secondari della provincia di Trento, che dagli anni 90 sono stati monitorati dall APPA con analisi chimico-fisiche, microbiologiche e biologiche) e, dove non erano disponibili dati, in base al giudizio esperto integrato dall analisi delle pressioni. Al fine di conseguire il miglior rapporto tra costi del monitoraggio e informazioni utili alla tutela delle acque, nella rete di sorveglianza (Tabella 3) sono stati inseriti i corpi idrici non a rischio di raggiungere gli obiettivi di qualità (quindi che hanno già giudizio buono o elevato), selezionandone un numero rappresentativo, al fine di fornire comunque una valutazione dello stato complessivo di tutte le acque superficiali di ciascun bacino compreso nei distretti idrografici. E stato rispettato il criterio di inserire nella rete almeno un corpo idrico per tipologia fluviale. Questi corpi idrici vengono monitorati almeno ogni sei anni.
11 ACQUA AGGIORNAMENTO 2015 Tabella 3: corpi idrici della provincia di Trento soggetti a monitoraggio di sorveglianza CODICE CORPO IDRICO nome STAZIONE A tn ROGGIA DI BONDONE O ROMAGNANO - TRENTO SD A tn TORRENTE ALA - foce SD A tn TORRENTE LENO DI VALLARSA (Loc.Spino) SD A0A tn TORRENTE ARIONE - CIMONE SD A0Z5A tn RIO DI VAL NEGRA - RIO CAGAREL SD A tn FIUME AVISIO - PENIA SD A tn FIUME AVISIO - SOVER SD A tn FIUME AVISIO - CAMPARTA SD A tn RIO DI BRUSAGO - BRUSAGO SD A tn TORR. TRAVIGNOLO - PREDAZZO SD A1Z tn RIO DELLE SEGHE SD A1Z tn RIO VAL MOENA - CAVALESE SD A1Z tn RIO SAN PELLEGRINO SD A tn TORRENTE FERSINA - CANEZZA SD A tn TORRENTE SILLA SD A tn TORRENTE NOCE VALLE DEL MONTE VP A tn TORRENTE NOCE - PELLIZZANO SD A tn TORRENTE NOCE - ponte per Portolo SD A tn TORRENTE NOCE - ponte della Fosina SD A tn TORRENTE VERMIGLIANA SD A tn TORRENTE PESCARA SD A tn TORRENTE RABBIES - RABBI VP A tn TORRENTE RABBIES - MALE' SD A3Z tn TORRENTE BARNES - LIVO SD B tn TORRENTE MOGGIO SD B tn TORRENTE GRIGNO - PIEVE TESINO SD B tn TORRENTE GRIGNO SD B0A tn RIO MANDOLA SD B0A2A1F001010tn FOSSA LA VENA - LEVICO TERME SD B0Z tn RIO VIGNOLA SD E tn FIUME SARCA DI CAMPIGLIO SD E tn FIUME SARCA DI VAL DI GENOVA VP E tn TORRENTE ARNO' SD E tn RIO BONDAI SD E1A tn TORRENTE DUINA - BLEGGIO SUPERIORE SD E1Z tn TORRENTE AMBIEZ VP E1Z tn RIO VAL D'ALGONE VP E tn FIUME CHIESE - PIEVE DI BONO SD E2Z tn TORRENTE PALVICO SD E2Z tn TORRENTE ADANA' SD
12 RAPPORTO SULLO STATO DELL AMBIENTE Il monitoraggio operativo è realizzato sui corpi idrici che sono stati evidenziati a rischio di non raggiungere l obiettivo di qualità buono (Tabella 4). Tale rischio può derivare da pressioni diffuse come l agricoltura, puntiformi quali scarichi civili o industriali, oppure ancora da modificazioni morfologiche quali briglie, argini, variazioni di livello dovute a uso idroelettrico. Il monitoraggio operativo è effettuato con cadenza triennale. Tabella 4: corpi idrici della provincia di Trento soggetti a monitoraggio operativo 12 CODICE CORPO IDRICO nome stazione A tn FIUME ADIGE - Sacco ROVERETO PR A tn FIUME ADIGE - ex Montecatini MORI PR A10000F007020tn FOSSA ADIGETTO - FOCE SD A00201F000030tn FOSSA MAESTRA NOMI SD A003A tn TORRENTE CAMERAS SD A0A1F1F001010IR FOSSA DI CALDARO - GRUMO SD A0A tn TORRENTE ARIONE - ALDENO SD A0A4A tn RIO MOLINI - VILLA LAGARINA SD A0Z tn RIO CAVALLO SD A tn FIUME AVISIO - ponte di SORAGA PR A tn FIUME AVISIO - LAVIS SG A1A tn RIO VAL DI GAMBIS SD A1A tn RIO VAL DI PREDAIA SD A tn TORRENTE NOCE BIANCO VP A tn TORRENTE NOCE - ponte di Cavizzana SG A tn TORRENTE NOCE - loc. Rupe SG A tn TORRENTE TRESENICA SD A tn TORRENTE SPOREGGIO SD A tn RIO DI S.ROMEDIO SD A tn RIO MOSCABIO SD A tn TORRENTE NOVELLA SD A tn ROGGIA DI FONDO SD A tn TORRENTE LAVAZE' - LIVO SD A3A3A tn RIO RIBOSC SD A3A tn TORRENTE LOVERNATICO SD B tn FIUME BRENTA - Ponte Cervia SG B tn FIUME BRENTA case Zaccon SD B tn FIUME BRENTA - Ponte del Cimitero SG B0Z tn TORRENTE CEGGIO SD B0Z tn TORRENTE CHIEPPENA SD E tn FIUME SARCA A COMANO TERME SD E tn FIUME SARCA-Monte presa E.N.E.L.Limaro' PR E1A tn TORRENTE DUINA - COMANO TERME SD E1B tn TORRENTE PONALE SD E1BA tn TORRENTE VARONE SD E1Z tn RIO SALONE SD E1Z tn RIO SALAGONI SD E1Z tn ROGGIA DI CALAVINO SD Fonte: Settore tecnico per la tutela dell ambiente
13 ACQUA AGGIORNAMENTO 2015 Nel monitoraggio della rete nucleo sono stati inseriti i corpi idrici in cui sono stati identificati i siti di riferimento (ovvero siti in cui l alterazione dovuta alle attività umane è talmente ridotta che si può considerare ininfluente) (Tabella 5). I risultati dell applicazione degli indici sugli elementi di qualità biologica in questi siti sono quelli a cui fare riferimento per la classificazione dello Stato Ecologico. Alla rete nucleo appartengono inoltre i corpi idrici sottoposti a pressioni particolarmente significative quali ad esempio lo scarico di un depuratore, un opera di presa importante, ecc.. Il monitoraggio della rete nucleo è effettuato con cadenza triennale. Tabella 5: corpi idrici della provincia di Trento soggetti a monitoraggio della rete nucleo CODICE CORPO IDRICO nome STAZIONE A IR FIUME ADIGE - Ponte Masetto SG A tn FIUME ADIGE - Ponte San Lorenzo SG A IR FIUME ADIGE - ponte di Borghetto SG A00000F003010IR CANALE MEDIO ADIGE O BIFFIS - AVIO SG A tn TORRENTE ALA - Loc. Acque Nere SD A tn TORRENTE LENO - ponte delle Zigherane PR A tn TORRENTE LENO DI TERRAGNOLO - Loc. GEROLI SD A tn FIUME AVISIO - ponte S.P.31 Del Manghen SG A tn FIUME AVISIO - ponte per Faver PR A tn TORRENTE TRAVIGNOLO - PANEVEGGIO VP A tn TORR. FERSINA - Ponte Regio PR A tn TORRENTE FERSINA - foce SG A tn TORRENTE MELEDRIO VP A3Z tn TORRENTE BARNES - BRESIMO SD B IR FIUME BRENTA - Ponte Filippini SG B tn TORRENTE VANOI - CANAL SAN BOVO loc. SERRAI SD B tn TORRENTE VANOI - CANAL SAN BOVO SG B tn TORRENTE CISMON - IMER SG D IR TORRENTE ASTICO - loc.busatti PR E tn FIUME SARCA - Ponte di Ragoli SG E tn FIUME SARCA A MONTE CENTRALE LINFANO SD E tn FIUME SARCA - LINFANO NAGO TORBOLE SG E1BA tn RIO SECCO SD E tn RIO VALLESINELLA VP E101A tn TORRENTE VAL D'AGOLA SD E tn FIUME SARCA DI NAMBRONE VP E tn FIUME CHIESE - RIO RIBOR SD E tn FIUME CHIESE - Ponte dei Tedeschi SG Il monitoraggio di indagine è stato effettuato di volta in volta su quei corpi idrici dove sono necessari controlli per situazioni di allarme (ad esempio per segnalazioni di sversamenti e/o contaminazioni puntiformi ed occasionali) o dove l incertezza del giudizio esperto attribuito nei piani di gestione risultava elevata. Questi monitoraggi vengono programmati di anno in anno. In definitiva la nuova rete di monitoraggio, attivata nel 2010, comprende 106 corpi idrici, di cui 40 nel monitoraggio di sorveglianza, 38 in quello operativo e 28 nella rete nucleo. 13
14 RAPPORTO SULLO STATO DELL AMBIENTE 3.3 La classificazione dei corpi idrici fluviali Lo stato di qualità dei corpi idrici fluviali secondo il D.Lgs. 152/06 si distingue in Stato Chimico e Stato Ecologico. Lo schema di classificazione è quello riportato in Figura 2. Figura 2: schema di classificazione dei corpi idrici fluviali STATO CHIMICO STATO ECOLOGICO ELEMENTI di QUALITÀ IDROMORFOLOGICA SOSTANZE PRIORITARIE EQR ALTRI INQUINANTI LIMeco (parametri chimicofisici a sostegno) ELEMENTI di QUALITÀ BIOLOGICA (macroinvertebrati, diatomee, fauna ittica) Per ognuna delle reti di monitoraggio è stato predisposto il programma specifico da condurre sui corpi idrici, scegliendo gli elementi di qualità biologica da monitorare, definendo il protocollo analitico chimico, attivando il monitoraggio idromorfologico e stabilendo le frequenze di campionamento. Tutti i 412 corpi idrici della Provincia di Trento sono stati classificati, in parte attraverso un monitoraggio che è partito nel 2010 e in parte attraverso il cosiddetto accorpamento. La stato di un corpo idrico può essere rappresenta da un tratto di corso d acqua monitorato che abbia le stesse caratteristiche di pressione, tipologia e obiettivi di qualità. Si evidenzia come la classificazione attualmente non comprenda l elemento di qualità biologica della fauna ittica (si è in attesa di una verifica dei criteri di classificazione con questo elemento di qualità biologica da parte del Ministero dell Ambiente). Lo Stato Ecologico sperimentale di tutti i corpi idrici è descritto in Tabella 6 e nel Grafico 1 (le percentuali sono riferite al numero di corpi idrici con i relativi giudizi di Stato Ecologico). Nella pagina successiva, la Figura 3 rappresenta la distribuzione dei giudizi di Stato Ecologico mediante un apposita cartografia. Tabella 6: distribuzione dei giudizi di Stato Ecologico preliminare sui corpi idrici fluviali monitorati dall Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente (APPA) ( ) stato ecologico cattivo scarso sufficiente buono elevato totale numero corpi idrici
15 ACQUA AGGIORNAMENTO 2015 Grafico 1: distribuzione dei giudizi di Stato Ecologico preliminare sui corpi idrici fluviali monitorati ( ) Figura 3: mappa dello Stato Ecologico preliminare dei corpi idrici 15
16 RAPPORTO SULLO STATO DELL AMBIENTE INDICATORE TEMATICA TIPOLOGIA DISPONIBILITÀ SITUAZIONE TREND DISPONIBILITÀ SPAZIALE 1. Qualità delle acque superficiali DISPONIBILITÀ TEMPORALE Acqua S D? P La rete di monitoraggio dei corpi idrici lacustri La rete di monitoraggio conforme alle richieste della Direttiva Europea e quindi al D.Lgs. 152/06 è stata ridefinita a partire dal 2010 cercando di mantenere il più possibile come punto fermo la vecchia rete di monitoraggio che ottemperava alle richieste del D.Lgs. 152/99. I quattro laghi naturali (Garda, Levico, Caldonazzo e Ledro) sono stati mantenuti nella nuova rete di monitoraggio mentre sono stati inseriti quattro laghi altamente modificati (Toblino, Cavedine, S. Giustina e Molveno). Degli otto laghi della rete di monitoraggio (Tabella 7), sei sono stati sottoposti a monitoraggio operativo (Caldonazzo, Levico, S. Giustina, Toblino, Cavedine e Ledro) e due sono stati inseriti nella rete nucleo (Garda e Molveno). Tabella 7: elenco dei corpi idrici lacustri inseriti nella rete di monitoraggio della Provincia di Trento NOME LAGO DI GARDA LAGO DI TOBLINO LAGO DI LEVICO LAGO DI S. GIUSTINA LAGO DI CALDONAZZO LAGO DI LEDRO LAGO DI CAVEDINE LAGO DI MOLVENO NATURA CORPO IDRICO naturale altamente modificato naturale altamente modificato naturale naturale altamente modificato altamente modificato 3.5 La classificazione dei corpi idrici lacustri Lo stato di qualità dei corpi idrici lacustri secondo il D.Lgs. 152/06 si distingue in Stato Chimico e Stato Ecologico. Lo schema di classificazione è quello riportato in figura 4. Figura 4: schema di classificazione dei corpi idrici lacustri STATO CHIMICO STATO ECOLOGICO ELEMENTI di QUALITÀ IDROMORFOLOGICA SOSTANZE PRIORITARIE EQR ALTRI INQUINANTI LTLeco (parametri chimicofisici a sostegno) ELEMENTI di QUALITÀ BIOLOGICA (fitoplancton, macrofite, fauna ittica) 16
17 ACQUA AGGIORNAMENTO 2015 Per ognuna delle reti di monitoraggio in cui sono stati inseriti i corpi idrici lacustri è stato predisposto il programma specifico da condurre, scegliendo gli EQB (Elementi di qualità biologica, es. fitoplancton) da monitorare, definendo il protocollo analitico chimico e secondo le frequenze stabilite dal Decreto 152/2006 (vd.allegato 1 alla parte Terza, tabella 3.6). L integrazione dei risultati relativi agli EQB e agli elementi chimici (sia quelli di base che quelli specifici) porta all assegnazione dello Stato Ecologico per ciascun corpo idrico inserito nella rete di monitoraggio, secondo le modalità precedentemente descritte. Nella tabella 8 sono riportati a scopo riassuntivo i risultati dello Stato Ecologico e Chimico relativo a tutti gli EQB utilizzati per la classificazione; lo Stato Ecologico finale è dato dal peggiore dei risultati dei singoli EQB. Per il Lago di Garda non è stata effettuata una classificazione triennale in quanto corpo idrico interregionale che deve essere classificato congiuntamente alla Regione Veneto e alla Regione Lombardia. Tabella 8: classificazione dei corpi idrici lacustri della provincia di Trento LAGO RQE ICF Stato Ecologico ICF LTLeco punteggio triennio Stato Ecologico LTLeco SQA inquinanti specifici Stato ecologico Elemento di qualità determinante CALDONAZZO 0.6 BUONO 9 SUFFICIENTE ELEVATO SUFFICIENTE LTLeco LEVICO 0.8 ELEVATO 13 BUONO ELEVATO BUONO LTLeco MOLVENO 0.8* BUONO 10** ELEVATO ELEVATO BUONO ICF LEDRO 0.6 BUONO 11 SUFFICIENTE ELEVATO SUFFICIENTE LTLeco GARDA *** *** *** *** S.GIUSTINA 0.5 SUFFICIENTE 10 SUFFICIENTE ELEVATO SUFFICIENTE ICF e LTLeco TOBLINO 0.7 BUONO 9* BUONO ELEVATO BUONO ICF e LTLeco CAVEDINE 0.5 SUFFICIENTE 8* BUONO ELEVATO SUFFICIENTE ICF Stato Ecologico sperimentale riferito al triennio di classificazione dei laghi inseriti nella rete di monitoraggio;non si tiene conto dell EQB macrofite. La rigatura segnala un corpo idrico altamente modificato (HMVB). * gli invasi non possono avere classe di qualità elevata a causa della loro non naturalità idromorfologica ** *** i livelli di trasparenza risultano ridotti per cause naturali (limo glaciale in sospensione), pertanto la classificazione viene effettuata seguendo le indicazioni della tabella 4.2.2/d del del D.Lgs 152/2006 seconda colonna la classificazione del Lago di Garda, in quanto corpo idrico interregionale, verrà effettuata congiuntamente ad ARPA Veneto dipartimento di Verona e ad ARPA Lombardia dipartimento di Brescia INDICATORE TEMATICA TIPOLOGIA DISPONIBILITÀ SITUAZIONE TREND DISPONIBILITÀ SPAZIALE DISPONIBILITÀ TEMPORALE 2. Qualità dei Laghi Acqua S D P * * Precedentemente i laghi erano stati monitorati con i criteri del D.Lgs. 152/99 17
18 RAPPORTO SULLO STATO DELL AMBIENTE 3.6 Il monitoraggio dei laghi nel 2013 A completamento delle informazioni relative alla qualità dei corpi idrici lacustri della Provincia di Trento si è ritenuto opportuno aggiungere anche i risultati ottenuti nel 2013, primo anno di monitoraggio utile per la classificazione del triennio Quella che viene riportata risulta quindi solo una classificazione parziale, che non ha un significato ufficiale presa da sola, ma che può essere utile per avere un idea del trend evolutivo dei laghi, almeno nel breve periodo Stato Ecologico parziale (riferito ai dati 2013) Qui di seguito, in tabella 9, sono riportati a scopo riassuntivo i risultati dello Stato Ecologico relativo a tutti gli EQB (Elementi di qualità biologica) utilizzati per la classificazione; lo Stato Ecologico finale è dato dal peggiore dei risultati dei singoli EQB. Lo Stato Ecologico parziale per i laghi inseriti nella rete di monitoraggio, relativo all anno 2013, è quella riportata nella tabella 9. Tabella 9: Stato Ecologico parziale riferito ai dati del 2013 dei laghi inseriti nella rete di monitoraggio. La rigatura segnala un corpo idrico altamente modificato (HMVB), ri-designati alla luce delle indicazioni del D. 27 novembre 2013, n LAGO RQE ICF Stato Ecologico ICF LTLeco Stato Ecologico LTLeco SQA inquinanti specifici Stato ecologico parziale 2013 Elemento di qualità determinante CALDONAZZO 0.6 BUONO 9 SUFFICIENTE ELEVATO SUFFICIENTE LTLeco LEVICO 0.8 ELEVATO 12 BUONO ELEVATO BUONO MOLVENO 0.8* BUONO 9** BUONO ELEVATO BUONO - LEDRO 0.5 SUFFICIENTE 11 SUFFICIENTE ELEVATO SUFFICIENTE ICF e LTLeco GARDA 0.6 BUONO 13 BUONO ELEVATO BUONO - S.GIUSTINA 0.5 SUFFICIENTE 10 SUFFICIENTE ELEVATO SUFFICIENTE ICF e LTLeco TOBLINO 0.9* BUONO 8** BUONO ELEVATO BUONO - CAVEDINE 0.7* BUONO 8** BUONO ELEVATO BUONO - * invasi non possono avere classe di qualità elevata a causa della loro non naturalità idromorfologica ** i livelli di trasparenza risultano ridotti per cause naturali (limo glaciale in sospensione), pertanto la classificazione viene effettuata seguendo le indicazioni della tabella 4.2.2/d del Decreto Ministeriale 260/2010 seconda colonna 18
19 ACQUA AGGIORNAMENTO Le acque sotterranee Questo paragrafo contiene i risultati ottenuti dal monitoraggio eseguito ai sensi del D.Lgs. 30/2009. Il monitoraggio, secondo tale normativa, ha avuto inizio in via sperimentale nel 2008 e nel 2010 ed è stato programmato definitivamente per la durata sessennale prevista dal citato Decreto nel periodo I dati presentati in questo lavoro si riferiscono pertanto al periodo Il monitoraggio è stato programmato con il Servizio geologico, che si è occupato di eseguire i campionamenti, mentre APPA (Settore Laboratorio) ha eseguito le analisi e infine, APPA (Settore tecnico per la tutela dell ambiente) ha eseguito la classificazione dei siti scelti. 4.1 La rete di monitoraggio delle acque sotterranee L individuazione dei corpi idrici sotterranei significativi è stata eseguita dal Dipartimento protezione civile e l attività si è conclusa con l identificazione di 10 corpi idrici, collocati nel bacino dell Adige, del Brenta e del Sarca (Figura 5). Figura 5: rappresentazione cartografica dei corpi idrici sotterranei della provincia di Trento e indicazione dei siti di monitoraggio utilizzati per la classificazione 19
20 RAPPORTO SULLO STATO DELL AMBIENTE L Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente, in sinergia con il Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento, ha provveduto alla scelta dei punti di monitoraggio avvalendosi anche dei dati regressi. La rete di monitoraggio per la determinazione dello stato qualitativo dei corpi idrici sotterranei identificati dalla Provincia di Trento è attualmente una rete di monitoraggio di sorveglianza, così come previsto dal D.Lgs. 30/09 (punto 4.2.1, allegato 4). Il programma di monitoraggio viene effettuato sia su corpi idrici a rischio che non a rischio, pertanto attualmente comprende siti a cui, dai dati pregressi, è attribuibile un giudizio puntuale di buono Stato Chimico e un sito a cui è attribuibile un giudizio puntuale di scarso Stato Chimico. L attività del monitoraggio di sorveglianza serve a fornire la base per programmare un eventuale monitoraggio operativo, qualora i risultati individuino corpi idrici a rischio. La rete di monitoraggio, per i 3 corpi idrici vallivi Adige, Sarca e Brenta ritenuti più vulnerabili, è stata progettata tenendo conto delle indicazioni derivanti dalla Carta della criticità idrica sotterranea approvata con Deliberazione della Giunta provinciale n del 10 ottobre La Carta della criticità idrica sotterranea individua le seguenti aree: AREE CRITICHE AREE DI ATTENZIONE per elevato sfruttamento della falda per alterazione qualitativa della falda per intenso sfruttamento della falda per potenziale alterazione della falda per riserva futura della falda Ogni tipologia di area è soggetta a specifiche disposizioni regolamentari che tendono a vietare nelle aree critiche la realizzazione di nuovi pozzi e a limitare anche il mantenimento di quelli esistenti mentre nelle aree di attenzione sono consentiti nuovi interventi a condizione che vengano eseguite approfondite analisi idrogeologiche redatte secondo specifiche linee guida. I siti di monitoraggio scelti per la definizione dello Stato Chimico dei corpi idrici vallivi più vulnerabili sono rappresentati singolarmente nella figura 6,7 e 8. Figura 6: rappresentazione cartografica del corpo idrico sotterraneo del bacino dell Adige (IT22-AVTN01), sovrapposta alla carta della criticità idrica sotterranea e riportante i punti di monitoraggio Legenda "h Monitoraggio 22AVTN01 codice Aree di attenzione per intenso sfruttamento della falda Aree critiche per elevato sfruttamento della falda Aree di attenzione per riserva futura della falda Aree critiche per alterazione qualitativa della falda Aree di attenzione per potenziale alterazione qualitativa della falda RIVA DEL GARDA 6 7 b 7 a 9 SGS "h MEZZOLOMBARDO SGS20170 "h TRENTO "h 3 PERGINE VALSUGANA SGS20100 BASELGA DI PINE' 1 MORI SGS a 1 4 b ROVERETO "h 1 1 LEVICO TERME "h SGS ALA ± BORGO 20
21 ACQUA AGGIORNAMENTO 2015 Figura 7: rappresentazione cartografica del corpo idrico sotterraneo del bacino del Brenta (IT22_AVTN04), sovrapposta alla carta della criticità idrica sotterranea e riportante i punti di monitoraggio ± "h SGS20380 BORGO BASELGA DI PINE' PERGINE VALSUGANA "h SGS20440 LEVICO TERME "h SGS Legenda "h Monitoraggio 22AVTN04 codice Aree di attenzione per intenso sfruttamento della falda Aree critiche per elevato sfruttamento della falda Aree di attenzione per riserva futura della falda Aree critiche per alterazione qualitativa della falda Aree di attenzione per potenziale alterazione qualitativa della falda 21
22 RAPPORTO SULLO STATO DELL AMBIENTE Figura 8: rappresentazione cartografica del corpo idrico sotterraneo del bacino del Sarca (IT22-AVTN02), sovrapposta alla carta della criticità idrica sotterranea e riportante i punti di monitoraggio Legenda "h Monitoraggio 22AVTN02 codice Aree di attenzione per intenso sfruttamento della falda Aree critiche per elevato sfruttamento della falda Aree di attenzione per riserva futura della falda Aree critiche per alterazione qualitativa della falda Aree di attenzione per potenziale alterazione qualitativa della falda PIETRAMURATA DRO "h SGS20500 RIVA DEL GARDA "h SGS20730 "h ARCO SGS20530 "h SGS20510 TORBOLE ± L elenco dei punti di monitoraggio è riportato nella seguente tabella: Tabella 10: rete di monitoraggio per lo Stato Chimico dei tre corpi idrici vallivi più vulnerabili (Adige, Brenta, Sarca) corpo idrico IT22-AVTN01 IT22-AVTN02 IT22-AVTN04 Valle dell Adige Valle del Sarca Valle del Brenta Descrizione codice denominazione punto di prelievo comune SGS20100 Pozzo Albere S.Michele a/a SGS20170 Pozzo Spini Trento SGS20230 Pozzo profondo Vegre Trento SGS20290 Pozzo Navicello 2 Rovereto SGS20710 Pozzo Campo sportivo Avio SGS20500 Sorgente Sass del Diaol Dro SGS20530 Pozzo troticoltura Arco SGS20510 Pozzo Prabi 1 Arco SGS20730 Piezometro Riva Arena Riva del Garda SGS20380 Pozzo ittica Resenzuola Grigno SGS20350 Risorgive Vena Levico Terme SGS20440 Pozzo Pompermaier Levico Terme 22
23 ACQUA AGGIORNAMENTO 2015 SGS20080 Sorgente Acquasanta Spormaggiore Dolomiti del Brenta SGS20030 Sorgente Centonia Dimaro SGS20460 Sorgente Rio Bianco Stenico Prealpi Val di Ledro SGS20630 Sorgente Sperone/Galleria Riva del Garda IT22-CATN01 Catena della Paganella SGS20700 Sorgente Trementina Zambana Gruppo Predaia Roen SGS20610 Sorgente Salin Alta Don Catena Bondone Stivo SGS20650 Sorgente Vigile Bassa Cimone SGS20490 Sorgente Rio Freddo Calavino Gruppo del Monte Baldo SGS20670 Sorgente Pian della Cenere Avio Gruppo Vigolana Marzola SGS20240 Sorgente Acquaviva Trento IT22-CATN02 Gruppo Pasubio Folgaria- Lessinia SGS20280 Sorgente Spino Trambileno SGS20620 Sorgente Acquasacra Ala Altipiano Lavarone SGS20600 Sorgente Pizzo Levico Terme IT22-CATN03 Monti del Tesino SGS20690 Sorgente Fontanazzi Castello Molina Dolomiti San Martino di Castrozza SGS20410 Sorgente Acque Nere Tonadico IT22-CATN04 Dolomiti Val di Fassa SGS20130 Sorgente Crepa Predazzo IT22-VUTN01 Gruppo Adamello Presena SGS20660 Sorgente Pra dell Era Pinzolo Metamorfitii Alta Val di Sole SGS20040 Sorgente Fontanon Rabbi IT22-VUTN02 Gruppo Lagorai Cima d Asta SGS20680 Sorgente Cristo Cadino Castello Molina IT22-AVTN03 Valle del Chiese SGS20540 Pozzo Storo/Gaggio Storo 4.2 Stato Chimico dei corpi idrici sotterranei Per la definizione dello Stato Chimico deve essere valutata la conformità degli standard di qualità e valori soglia individuati a livello comunitario e posti dalle tabelle 1, 2 e 3 dell allegato 3 al D.Lgs. 30/09. Lo Stato Chimico, viene definito Buono Stato Chimico (colore convenzionale blu) oppure Scarso Stato Chimico (colore convenzionale rosso) in base al superamento o meno degli Standard di Qualità (tabella 2, allegato 3 al D.Lgs. 30/09) e/o dei valori soglia (tabella 3, allegato 3 al D.Lgs. 30/09) previsti per le singole sostanze. La conformità del valore soglia e dello standard di qualità ambientale devono essere calcolati attraverso la media dei valori ottenuti nel ciclo di monitoraggio. I parametri presi riguardano una serie di inquinanti tra cui i nitrati, pesticidi, inquinanti organici, composti organici aromatici e policiclici aromatici, pesticidi. Nel ciclo di monitoraggio sessennale, , si è ritenuto utile programmare il monitoraggio di sorveglianza con cadenza annuale. Tutti i siti di monitoraggio, che già erano stati analizzati in passato, sono stati monitorati con frequenza semestrale nel periodo , mentre i nuovi siti sono stati campionati quattro volte nel 2010, per iniziare negli anni successivi il monitoraggio con cadenza semestrale. I risultati ottenuti nei siti scelti sono rappresentati nella Tabella 11 che descrive lo Stato Chimico attribuito nei singoli anni. 23
24 RAPPORTO SULLO STATO DELL AMBIENTE Tabella 11: Stato Chimico dei siti di monitoraggio Corpo Idrico CODICE sito SGS20100 Pozzo Albere Buono Buono Buono Buono Buono Buono SGS20170 Pozzo Spini Buono Buono Buono Buono Buono Buono IT22-AVTN01 SGS20230 Pozzo profondo Vegre Buono Buono Buono Buono Buono Buono SGS20290 Pozzo Navicello Scarso Scarso Al limite Scarso Scarso Scarso SGS20710 Pozzo Campo sportivo Buono Buono Scarso Buono SGS20350 Risorgive Vena Buono Buono Buono Buono Buono Buono IT22-AVTN02 SGS20380 Pozzo ittica Resenzuola Buono Buono Buono Buono Buono Buono SGS20440 Pozzo Pompermaier Buono Buono Buono Buono SGS20500 Sorgente Sass del Diaol Buono Buono Buono Buono Buono Buono IT22-AVTN04 SGS20510 Pozzo Prabi Buono Buono Buono Buono Buono Buono SGS20530 Troticoltura Mandelle Buono Buono Buono Buono Buono Buono SGS20730 Piezometro Riva Arena Buono Buono Buono Buono SGS20080 Sorgente Acquasanta Buono Buono Buono Buono Buono Buono SGS20030 Sorgente Centonia Buono Buono Buono Buono Buono Buono SGS20460 Sorgente Rio Bianco Buono Buono Buono Buono Buono Buono SGS20630 Sorgente Sperone/Galleria Buono Buono Buono Buono IT22-CATN01 SGS20700 Sorgente Trementina Buono Buono Buono Buono SGS20610 Sorgente Salin Alta Buono Buono Buono Buono SGS20650 Sorgente Vigile Bassa Buono Buono Buono Buono SGS20490 Sorgente Rio Freddo Buono Buono Buono Buono Buono Buono SGS20670 Sorgente Pian della Cenere Buono Buono Buono Buono SGS20240 Sorgente Acquaviva Buono Buono Buono Buono Buono Buono IT22-CATN02 SGS20280 Sorgente Spino Buono Buono Buono Buono Buono Buono SGS20620 Sorgente Acquasacra Buono Buono Buono Buono SGS20600 Sorgente Pizzo Buono Buono Buono Buono IT22-CATN03 SGS20690 Sorgente Fontanazzi Buono Buono Buono Buono SGS20410 Sorgente Acque Nere Buono Buono Buono Buono Buono Buono IT22-CATN04 SGS20130 Sorgente Crepa Buono Buono Buono Buono Buono Buono IT22-VUTN01 SGS20660 Sorgente Pra dell Era Buono Buono Buono Buono SGS20040 Sorgente Fontanon Buono Buono Buono Buono Buono Buono IT22-VUTN02 SGS20680 Sorgente Cristo Cadino Buono Buono Buono Buono IT22-VUTN03 SGS20540 Pozzo Storo/Gaggio Buono Buono Buono Buono Buono Buono Dalla tabella 11 è possibile evincere come tutti i siti monitorati nei corpi idrici appartenenti al bacino del Sarca e del Brenta siano risultati in Buono Stato Chimico. Nel bacino dell Adige invece è presente il sito SGS pozzo Navicello - nel comune di Rovereto che evidenzia un certo livello di contaminazione dovuto alla presenza di tetracloroetilene. Nel complesso però a tutti i corpi idrici indagati è stato possibile attribuire un Buono Stato Chimico, anche a quello dell Adige, in quanto le aree critiche per alterazione della falda qualitativa rappresentano circa il 3,5% del corpo idrico e pertanto inferiore al 20% che rappresenta la soglia massima ammissibile per l attribuzione di un giudizio favorevole. 24
Bilanci idrici e qualità dei corsi d acqua Elaborazione dei dati della rete di monitoraggio APPA (2010-2012)
 Agenzia Provinciale per la Protezione dell Ambiente Settore Informazione e Monitoraggi Bilanci idrici e qualità dei corsi d acqua Elaborazione dei dati della rete di monitoraggio APPA (2010-2012) Marzo
Agenzia Provinciale per la Protezione dell Ambiente Settore Informazione e Monitoraggi Bilanci idrici e qualità dei corsi d acqua Elaborazione dei dati della rete di monitoraggio APPA (2010-2012) Marzo
La pianificazione di settore nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: elementi di coerenza con il Piano di Gestione
 La pianificazione di settore nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: elementi di coerenza con il Piano di Gestione Il Piano di tutela delle acque SCOPO Costituisce uno specifico piano di settore
La pianificazione di settore nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: elementi di coerenza con il Piano di Gestione Il Piano di tutela delle acque SCOPO Costituisce uno specifico piano di settore
Il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee
 Seminario «Aggiornamenti sull applicazione della Direttiva Nitrati» Il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee mercoledì 14 dicembre 2016 Settore Monitoraggi Ambientali CRQA (Centro Regionale
Seminario «Aggiornamenti sull applicazione della Direttiva Nitrati» Il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee mercoledì 14 dicembre 2016 Settore Monitoraggi Ambientali CRQA (Centro Regionale
2lA RELAZIONE SOCIALE
 2lA RELAZIONE SOCIALE BILANCIO SOCIALE COMUNI E COMUNITÀ DI VALLE Il Comune è l ente territoriale ed amministrativo che rappresenta più da vicino i bisogni dei cittadini ed è il principale interlocutore
2lA RELAZIONE SOCIALE BILANCIO SOCIALE COMUNI E COMUNITÀ DI VALLE Il Comune è l ente territoriale ed amministrativo che rappresenta più da vicino i bisogni dei cittadini ed è il principale interlocutore
Glossario e architettura del piano
 Ing. Andrea Braidot dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta- Bacchiglione dei fiumi Isonzo, Tagliamento, del fiume Adige Glossario essenziale del piano dei fiumi Isonzo, Tagliamento, del
Ing. Andrea Braidot dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta- Bacchiglione dei fiumi Isonzo, Tagliamento, del fiume Adige Glossario essenziale del piano dei fiumi Isonzo, Tagliamento, del
Ciclo idrico e governo delle acque Titolo contratti Sottotitolo di fiume con particolare riguardo alle attività di monitoraggio e controllo
 Ciclo idrico e governo delle acque Il Titolo ruolo di ARPA Lombardia in materia di contratti Sottotitolo di fiume con particolare riguardo alle attività di monitoraggio e controllo Dr.ssa Paola Bossi Sede
Ciclo idrico e governo delle acque Il Titolo ruolo di ARPA Lombardia in materia di contratti Sottotitolo di fiume con particolare riguardo alle attività di monitoraggio e controllo Dr.ssa Paola Bossi Sede
Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche
 Nel bacino sono presenti ghiacciai che occupano una superficie pari a 25,48 km 2 e sono concentrati per lo più attorno al gruppo del monte Cevedale e della Presanella. I.6.2.8 Sarca I confini del bacino
Nel bacino sono presenti ghiacciai che occupano una superficie pari a 25,48 km 2 e sono concentrati per lo più attorno al gruppo del monte Cevedale e della Presanella. I.6.2.8 Sarca I confini del bacino
foto di Alessio Coser
 foto di Alessio Coser La provincia di Trento è particolarmente ricca di acqua e la sua utilizzazione sostenibile, la sua protezione e difesa rappresentano elementi costitutivi per una corretta governance
foto di Alessio Coser La provincia di Trento è particolarmente ricca di acqua e la sua utilizzazione sostenibile, la sua protezione e difesa rappresentano elementi costitutivi per una corretta governance
Piano di Tutela delle Acque e Direttiva 2000/60/CE: Quali gli obblighi e le azioni per il futuro
 Piano di Tutela delle Acque e Direttiva 2000/60/CE: Quali gli obblighi e le azioni per il futuro Corrado Soccorso Dipartimento Difesa del Suolo Sezione Geologia e Georisorse Settore Tutela Acque Iniziativa
Piano di Tutela delle Acque e Direttiva 2000/60/CE: Quali gli obblighi e le azioni per il futuro Corrado Soccorso Dipartimento Difesa del Suolo Sezione Geologia e Georisorse Settore Tutela Acque Iniziativa
INDICE. Bacino dello Slizza I
 Bacino dello Slizza I INDICE 5.1. OBIETTIVI AMBIENTALI PER LE ACQUE SUPERFICIALI... 1 5.1.2. Proroga dei termini fissati dall articolo 4, comma 1, della Direttiva 2000/60/CE allo scopo del graduale conseguimento
Bacino dello Slizza I INDICE 5.1. OBIETTIVI AMBIENTALI PER LE ACQUE SUPERFICIALI... 1 5.1.2. Proroga dei termini fissati dall articolo 4, comma 1, della Direttiva 2000/60/CE allo scopo del graduale conseguimento
Situazioni ambientali critiche per prelievi e sbalzi di portata
 9 Situazioni ambientali critiche per prelievi e sbalzi di portata L Unione dei Pescatori del Trentino ha inviato alla Provincia di Trento, sulle più critiche situazioni di degrado d acqua della provincia
9 Situazioni ambientali critiche per prelievi e sbalzi di portata L Unione dei Pescatori del Trentino ha inviato alla Provincia di Trento, sulle più critiche situazioni di degrado d acqua della provincia
Revisione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola Acque superficiali
 Workshop Stato di avanzamento dei lavori per la revisione delle zone vulnerabili Milano, 13 febbraio 2014 Revisione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola Acque superficiali ARPA LOMBARDIA
Workshop Stato di avanzamento dei lavori per la revisione delle zone vulnerabili Milano, 13 febbraio 2014 Revisione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola Acque superficiali ARPA LOMBARDIA
LE ACQUE SOTTERRANEE
 LE ACQUE SOTTERRANEE Le forme dell acqua In un territorio alpino l acqua è presente come: ghiacciaio ad alta quota acqua corrente nei fiumi e nei torrenti acqua ferma nei laghi acqua fluente nel sottosuolo
LE ACQUE SOTTERRANEE Le forme dell acqua In un territorio alpino l acqua è presente come: ghiacciaio ad alta quota acqua corrente nei fiumi e nei torrenti acqua ferma nei laghi acqua fluente nel sottosuolo
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI ASPETTI ECOLOGICI E NORMATIVA PER IL CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE ACQUE CORRENTI: CONFRONTO TRA
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI ASPETTI ECOLOGICI E NORMATIVA PER IL CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE ACQUE CORRENTI: CONFRONTO TRA
Carta dei servizi. Acqua
 Carta dei servizi Acqua L acqua rappresenta una delle risorse più importanti della Lombardia ed il suo impiego riguarda gli usi potabili, industriali, agricoli, idroelettrici e ricreativi. La Lombardia
Carta dei servizi Acqua L acqua rappresenta una delle risorse più importanti della Lombardia ed il suo impiego riguarda gli usi potabili, industriali, agricoli, idroelettrici e ricreativi. La Lombardia
Affidabilitàdel dato nella classificazione ecologica dei corpi idrici della Regione Piemonte
 Stato ecologico dei fiumi ai sensi della Direttiva 2000/60/CE: valutazione della qualità del dato Affidabilitàdel dato nella classificazione ecologica dei corpi idrici della Regione Piemonte Antonietta
Stato ecologico dei fiumi ai sensi della Direttiva 2000/60/CE: valutazione della qualità del dato Affidabilitàdel dato nella classificazione ecologica dei corpi idrici della Regione Piemonte Antonietta
2lA RELAZIONE SOCIALE
 2lA RELAZIONE SOCIALE BILANCIO SOCIALE COMUNI E COMUNITÀ DI VALLE Il Comune è l ente territoriale ed amministrativo che rappresenta più da vicino i bisogni dei cittadini ed è il principale interlocutore
2lA RELAZIONE SOCIALE BILANCIO SOCIALE COMUNI E COMUNITÀ DI VALLE Il Comune è l ente territoriale ed amministrativo che rappresenta più da vicino i bisogni dei cittadini ed è il principale interlocutore
I confini del bacino imbrifero Il bacino del fiume Chiese si estende per 409,94 km 2 di cui 408,63 km 2 compresi nella provincia di Trento.
 I.6.2.4 Chiese I confini del bacino imbrifero Il bacino del fiume Chiese si estende per 409,94 km 2 di cui 408,63 km 2 compresi nella provincia di Trento. Figura I.6.51: Bacino del fiume Chiese: in verde
I.6.2.4 Chiese I confini del bacino imbrifero Il bacino del fiume Chiese si estende per 409,94 km 2 di cui 408,63 km 2 compresi nella provincia di Trento. Figura I.6.51: Bacino del fiume Chiese: in verde
Progetto INHABIT Lo stato dell implementazione della WFD in Sardegna quadro conoscitivo e necessità di approfondimento
 Presidenza Direzione generale agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità Progetto
Presidenza Direzione generale agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità Progetto
Il monitoraggio delle acque sotterranee sul territorio valdostano
 Il monitoraggio delle acque sotterranee sul territorio valdostano Piano di Tutela delle Acque 2016 8 aprile 2016 - Primo Forum di partecipazione pubblica Pietro Capodaglio, Fulvio Simonetto ARPA VdA Inquadramento
Il monitoraggio delle acque sotterranee sul territorio valdostano Piano di Tutela delle Acque 2016 8 aprile 2016 - Primo Forum di partecipazione pubblica Pietro Capodaglio, Fulvio Simonetto ARPA VdA Inquadramento
DEFINIZIONE DELL ALGORITMO DI CALCOLO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA
 DEFINIZIONE DELL ALGORITMO DI CALCOLO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA DANIELA IERVOLINO Regione Friuli Venezia Giulia TOLMEZZO 5 maggio 2015 Linee di indirizzo Corsi d acqua/tratti
DEFINIZIONE DELL ALGORITMO DI CALCOLO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA DANIELA IERVOLINO Regione Friuli Venezia Giulia TOLMEZZO 5 maggio 2015 Linee di indirizzo Corsi d acqua/tratti
ORDINE DEI GEOLOGI DELL ORDINE DEI GEOL A TOSCANA
 ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA 9 dicembre 2008 Elaborato a se stante, autonomo La relazione idrogeologica Mirata al tipo di progetto da supportare ma deve comunque sempre contenere informazioni sulla
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA 9 dicembre 2008 Elaborato a se stante, autonomo La relazione idrogeologica Mirata al tipo di progetto da supportare ma deve comunque sempre contenere informazioni sulla
Lo stato quantitativo e qualitativo delle acque in Trentino
 Convegno: Acqua, energia, ambiente Lo stato quantitativo e qualitativo delle acque in Trentino Sanzeno (TN) Casa De Gentili, 25 ottobre 2014 Fabio Berlanda - Agenzia provinciale per le risorse idriche
Convegno: Acqua, energia, ambiente Lo stato quantitativo e qualitativo delle acque in Trentino Sanzeno (TN) Casa De Gentili, 25 ottobre 2014 Fabio Berlanda - Agenzia provinciale per le risorse idriche
Allegato parte integrante Allegato A2)
 ALLEGATO A2) PROSPETTO ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER RISORSE STUDENTI CON BES A.S. 2016-17 PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PROVINCIALI ISTITUTO COMPRENSIVO ALA "Antonio Bresciani"
ALLEGATO A2) PROSPETTO ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER RISORSE STUDENTI CON BES A.S. 2016-17 PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PROVINCIALI ISTITUTO COMPRENSIVO ALA "Antonio Bresciani"
Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque
 Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque dei bacini idrografici delle Alpi Orientali Dott. Alberto Cisotto Autorità di bacino dell Alto Adriatico L articolo 14 della direttiva
Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque dei bacini idrografici delle Alpi Orientali Dott. Alberto Cisotto Autorità di bacino dell Alto Adriatico L articolo 14 della direttiva
CAMPIONATO PULCINI AUTUNNALI
 CALENDARIO ORARIO GARE TORNEO PULCINI A 7 FASE AUTUNNALE DI MERCOLEDI CALENDARIO ORARIO GARE DEL 23 SETTEMBRE 2015 Torneo pulcini - GIRONE A - GIORNATA n.1 - ANDATA Ore 18.00 AVIO CALCIO A - BESENELLO
CALENDARIO ORARIO GARE TORNEO PULCINI A 7 FASE AUTUNNALE DI MERCOLEDI CALENDARIO ORARIO GARE DEL 23 SETTEMBRE 2015 Torneo pulcini - GIRONE A - GIORNATA n.1 - ANDATA Ore 18.00 AVIO CALCIO A - BESENELLO
PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE RELAZIONE DI SINTESI
 Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente Settore tecnico per la tutela dell ambiente U.O. acqua PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE RELAZIONE DI SINTESI Direttiva 2000/60/CE Decreto legislativo n. 152/2006
Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente Settore tecnico per la tutela dell ambiente U.O. acqua PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE RELAZIONE DI SINTESI Direttiva 2000/60/CE Decreto legislativo n. 152/2006
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
 GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE Protezione degli ecosistemi: assicurarne l integrità attraverso una gestione sostenibile delle risorse idriche promuovere la cooperazione tra paesi nella gestione dei bacini
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE Protezione degli ecosistemi: assicurarne l integrità attraverso una gestione sostenibile delle risorse idriche promuovere la cooperazione tra paesi nella gestione dei bacini
L Indice di Funzionalità Fluviale (IFF): applicazione al fiume Soligo
 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER GEOMETRI A.A. 2004-05 Corso di Estimo ambientale, riqualificazione fluviale ed ingegneria naturalistica- II sezione: riqualificazione fluviale ed ingegneria naturalistica
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER GEOMETRI A.A. 2004-05 Corso di Estimo ambientale, riqualificazione fluviale ed ingegneria naturalistica- II sezione: riqualificazione fluviale ed ingegneria naturalistica
UTILIZZO DEGLI ODONATI COME INDICATORI DELLO STATO ECOLOGICO DEI CORSI D ACQUA E STRUMENTO DI MONITORAGGIO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE
 2 Convegno italiano sulla riqualificazione fluviale Riqualificazione fluviale e gestione del territorio 6-7 novembre 2012, Bolzano UTILIZZO DEGLI ODONATI COME INDICATORI DELLO STATO ECOLOGICO DEI CORSI
2 Convegno italiano sulla riqualificazione fluviale Riqualificazione fluviale e gestione del territorio 6-7 novembre 2012, Bolzano UTILIZZO DEGLI ODONATI COME INDICATORI DELLO STATO ECOLOGICO DEI CORSI
Elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale aventi sede legale in provincia di Trento (riferito alla data del 31 dicembre 2015)
 Bollettino Ufficiale n. 26/I-II del 28/06/2016 / Amtsblatt Nr. 26/I-II vom 28/06/2016 0150 178527 Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2016 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Bollettino Ufficiale n. 26/I-II del 28/06/2016 / Amtsblatt Nr. 26/I-II vom 28/06/2016 0150 178527 Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2016 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Management dell Adige nel contesto nazionale
 nel contesto nazionale Ing. dell Autorità di bacino del fiume Adige L Autorità di bacino del fiume Adige Istituita con la legge 18 maggio 1989, n. 183 Costituita con DPCM 10 agosto 1989 Superficie totale
nel contesto nazionale Ing. dell Autorità di bacino del fiume Adige L Autorità di bacino del fiume Adige Istituita con la legge 18 maggio 1989, n. 183 Costituita con DPCM 10 agosto 1989 Superficie totale
Le misure del Piano di Gestione delle Acque per i corpi idrici in relazione all uso idroelettrico
 Le misure del Piano di Gestione delle Acque per i corpi idrici in relazione all uso idroelettrico Andrea Braidot Autorità di Bacino fiumi Alto Adriatico Tolmezzo, 5 maggio 2015 Altre misure di base (art.
Le misure del Piano di Gestione delle Acque per i corpi idrici in relazione all uso idroelettrico Andrea Braidot Autorità di Bacino fiumi Alto Adriatico Tolmezzo, 5 maggio 2015 Altre misure di base (art.
Università degli Studi di Napoli Federico II
 Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO
Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO
ARPA Sezione di Rimini
 ARPA Sezione di Rimini Melo Rio Melo 211 B Ponte Via Venezia Riccione Bacino idrografico Corso d acqua Codice Tipo Localizzazione Pagina 76 Pagina 77 Livello di Inquinamento da Macrodescrittori Anche per
ARPA Sezione di Rimini Melo Rio Melo 211 B Ponte Via Venezia Riccione Bacino idrografico Corso d acqua Codice Tipo Localizzazione Pagina 76 Pagina 77 Livello di Inquinamento da Macrodescrittori Anche per
Indice. Approccio concettuale. Procedura operativa
 Introduzione... pag. 1 Parte A Approccio concettuale 1 Tipi di monitoraggio... pag. 13 1.1 Stato attuale... pag. 13 2 Monitoraggio operativo finalizzato... pag. 19 2.1 Obiettivi del monitoraggio... pag.
Introduzione... pag. 1 Parte A Approccio concettuale 1 Tipi di monitoraggio... pag. 13 1.1 Stato attuale... pag. 13 2 Monitoraggio operativo finalizzato... pag. 19 2.1 Obiettivi del monitoraggio... pag.
Dr. Valeria Roella. Varese 16 marzo 2013 Sala Montanari
 Dr. Valeria Roella Varese 16 marzo 2013 Sala Montanari Rete idrica provinciale Il quadro normativo a tutela delle risorse idriche è molto complesso e in evoluzione e ha introdotto sostanziali innovazioni
Dr. Valeria Roella Varese 16 marzo 2013 Sala Montanari Rete idrica provinciale Il quadro normativo a tutela delle risorse idriche è molto complesso e in evoluzione e ha introdotto sostanziali innovazioni
IL MONITORAGGIO AMBIENTALE
 Valorizzare la qualità ambientale dei territori IL MONITORAGGIO AMBIENTALE Modulo A introduzione al monitoraggio il caso del monitoraggio in falda Istituto Istruzione Superiore A. Spinelli 2013-2014 monitoraggio
Valorizzare la qualità ambientale dei territori IL MONITORAGGIO AMBIENTALE Modulo A introduzione al monitoraggio il caso del monitoraggio in falda Istituto Istruzione Superiore A. Spinelli 2013-2014 monitoraggio
Monitoraggio. Incontro tematico per la partecipazione pubblica a supporto dell elaborazione elaborazione del PBI. Parma, 6 luglio 2011
 Monitoraggio Incontro tematico per la partecipazione pubblica a supporto dell elaborazione elaborazione del PBI Parma, 6 luglio 2011 via Giuseppe Garibaldi, 75-43121 Parma - tel. 0521 2761 www.adbpo.it
Monitoraggio Incontro tematico per la partecipazione pubblica a supporto dell elaborazione elaborazione del PBI Parma, 6 luglio 2011 via Giuseppe Garibaldi, 75-43121 Parma - tel. 0521 2761 www.adbpo.it
Andamento dei mercati di legname tondo in Trentino
 Osservatorio del Legno Andamento dei mercati di legname tondo in Trentino 2016 I trimestre Aprile 2016 Camera di Commercio I.A.A. di Trento Ufficio Prodotti e Promozione Via S.Trinità, 24 Palazzo Roccabruna
Osservatorio del Legno Andamento dei mercati di legname tondo in Trentino 2016 I trimestre Aprile 2016 Camera di Commercio I.A.A. di Trento Ufficio Prodotti e Promozione Via S.Trinità, 24 Palazzo Roccabruna
IL RUOLO DEL POLITICA REGIONALE PER LA TUTELA DELLA DELLE ACQUE
 IL RUOLO DEL MONITORAGGIO NELLA POLITICA REGIONALE PER LA TUTELA DELLA DELLE ACQUE Bari, novembre 2010 Regione Puglia Servizio Tutela delle Acque Dott.ssa M.A. Iannarelli LA TUTELA DELLE ACQUE ANALISI
IL RUOLO DEL MONITORAGGIO NELLA POLITICA REGIONALE PER LA TUTELA DELLA DELLE ACQUE Bari, novembre 2010 Regione Puglia Servizio Tutela delle Acque Dott.ssa M.A. Iannarelli LA TUTELA DELLE ACQUE ANALISI
Contenuti della sezione ACQUE
 Contenuti della sezione ACQUE La Qualità delle acque superficiali Azioni del Dipartimento di Como Punti di monitoraggio delle acque superficiali Descrittore: Stato ecologico dei corsi d acqua Descrittore:
Contenuti della sezione ACQUE La Qualità delle acque superficiali Azioni del Dipartimento di Como Punti di monitoraggio delle acque superficiali Descrittore: Stato ecologico dei corsi d acqua Descrittore:
MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELLE ACQUE SOTTERRANEE
 MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELLE ACQUE SOTTERRANEE Dr.ssa M. Rosa, Dr. A. Pozzobon Servizio Stato dell Ambiente Dipartimento ARPAV Provinciale di Treviso Valdobbiadene 23 Novembre 2013 tra le attività
MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELLE ACQUE SOTTERRANEE Dr.ssa M. Rosa, Dr. A. Pozzobon Servizio Stato dell Ambiente Dipartimento ARPAV Provinciale di Treviso Valdobbiadene 23 Novembre 2013 tra le attività
Tutela della rete idrografica e delle relative pertinenze e sicurezza idraulica. Norme di Attuazione: Titolo 4
 Tutela della rete idrografica e delle relative pertinenze e sicurezza idraulica Norme di Attuazione: Titolo 4 Elaborati grafici di riferimento: Tavola 1 OBIETTIVI DEL PTCP COORDINAMENTO dei diversi STRUMENTI
Tutela della rete idrografica e delle relative pertinenze e sicurezza idraulica Norme di Attuazione: Titolo 4 Elaborati grafici di riferimento: Tavola 1 OBIETTIVI DEL PTCP COORDINAMENTO dei diversi STRUMENTI
la stagione turistica estiva 2016
 8 novembre 2016 la stagione turistica estiva 2016 negli esercizi alberghieri e complementari Arrivi e presenze nella stagione estiva per mese arrivi variazione % 2016/2015 presenze variazione % 2016/2015
8 novembre 2016 la stagione turistica estiva 2016 negli esercizi alberghieri e complementari Arrivi e presenze nella stagione estiva per mese arrivi variazione % 2016/2015 presenze variazione % 2016/2015
Deflusso minimo vitale: il caso del Friuli Venezia Giulia. G. Favrin, V. Stocca, G. Mattassi
 Workshop: «Dal DMV al flusso ecologico: stato dell arte nel distretto padano ed esigenze future di rilevanza europea» Deflusso minimo vitale: il caso del Friuli Venezia Giulia G. Favrin, V. Stocca, G.
Workshop: «Dal DMV al flusso ecologico: stato dell arte nel distretto padano ed esigenze future di rilevanza europea» Deflusso minimo vitale: il caso del Friuli Venezia Giulia G. Favrin, V. Stocca, G.
Andamento dei mercati di legname tondo in Trentino
 Osservatorio del Legno Andamento dei mercati di legname tondo in Trentino 2015 I trimestre Marzo 2015 Camera di Commercio I.A.A. di Trento Ufficio Prodotti e Promozione Via S.Trinità, 24 Palazzo Roccabruna
Osservatorio del Legno Andamento dei mercati di legname tondo in Trentino 2015 I trimestre Marzo 2015 Camera di Commercio I.A.A. di Trento Ufficio Prodotti e Promozione Via S.Trinità, 24 Palazzo Roccabruna
Andamento dei mercati di legname tondo in Trentino
 Osservatorio del Legno Andamento dei mercati di legname tondo in Trentino 2017 2 trimestre luglio 2017 Camera di Commercio I.A.A. di Trento Ufficio Prodotti e Promozione Via S.Trinità, 24 Palazzo Roccabruna
Osservatorio del Legno Andamento dei mercati di legname tondo in Trentino 2017 2 trimestre luglio 2017 Camera di Commercio I.A.A. di Trento Ufficio Prodotti e Promozione Via S.Trinità, 24 Palazzo Roccabruna
Andamento dei mercati di legname tondo in Trentino
 Osservatorio del Legno Andamento dei mercati di legname tondo in Trentino 2016 IV trimestre gennaio 2017 Camera di Commercio I.A.A. di Trento Ufficio Prodotti e Promozione Via S.Trinità, 24 Palazzo Roccabruna
Osservatorio del Legno Andamento dei mercati di legname tondo in Trentino 2016 IV trimestre gennaio 2017 Camera di Commercio I.A.A. di Trento Ufficio Prodotti e Promozione Via S.Trinità, 24 Palazzo Roccabruna
Agritur con marchio Family
 Agritur con marchio Family N. Denominazione Indirizzo Comune Comunità 001 COMUNE DI ARCO Piazza III Novembre, 3 Arco 9 Comunità Alto Garda e Ledro 002 COMUNE DI VILLA LAGARINA Piazza S. Maria Assunta,
Agritur con marchio Family N. Denominazione Indirizzo Comune Comunità 001 COMUNE DI ARCO Piazza III Novembre, 3 Arco 9 Comunità Alto Garda e Ledro 002 COMUNE DI VILLA LAGARINA Piazza S. Maria Assunta,
2011 IMPRENDITORI ISCRITTI PER SEZIONE
 Anno 2011 IMPRENDITORI ISCRITTI PER SEZIONE comunità comprensorio Comune Imprenditore singolo Imprenditori associati totale imprenditori cod denominazione cod denominazione cod denominazione Totale 1^
Anno 2011 IMPRENDITORI ISCRITTI PER SEZIONE comunità comprensorio Comune Imprenditore singolo Imprenditori associati totale imprenditori cod denominazione cod denominazione cod denominazione Totale 1^
ACQUA ANOMALIE AMBIENTALI: SCHIUME E COLORAZIONI NELLE ACQUE SUPERFICIALI
 ACQUA ANOMALIE AMBIENTALI: SCHIUME E COLORAZIONI NELLE ACQUE SUPERFICIALI Periodicamente ad APPA giungono segnalazioni da parte dei cittadini riguardo alla presenza di schiume o colorazioni anomale nelle
ACQUA ANOMALIE AMBIENTALI: SCHIUME E COLORAZIONI NELLE ACQUE SUPERFICIALI Periodicamente ad APPA giungono segnalazioni da parte dei cittadini riguardo alla presenza di schiume o colorazioni anomale nelle
Inquadramento ittiofaunistico
 Dicembre 2014 CARATTERIZZAZIONE DELL ITTIOFAUNA E VERIFICA DELLE CONDIZIONI IDROMORFOLOGICHE NECESSARIE PER LA PROGETTAZIONE DI UN PASSAGGIO PER PESCI SU UN OPERA DI PRESA SUL TORRENTE TOSSIET (BACINO
Dicembre 2014 CARATTERIZZAZIONE DELL ITTIOFAUNA E VERIFICA DELLE CONDIZIONI IDROMORFOLOGICHE NECESSARIE PER LA PROGETTAZIONE DI UN PASSAGGIO PER PESCI SU UN OPERA DI PRESA SUL TORRENTE TOSSIET (BACINO
Bollettino Ufficiale n. 5/I-II del 31/01/2017 / Amtsblatt Nr. 5/I-II vom 31/01/
 Bollettino Ufficiale n. 5/I-II del 31/01/2017 / Amtsblatt Nr. 5/I-II vom 31/01/2017 0125 180349 Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2017 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Bollettino Ufficiale n. 5/I-II del 31/01/2017 / Amtsblatt Nr. 5/I-II vom 31/01/2017 0125 180349 Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2017 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Andamento dei mercati di legname tondo in Trentino
 Osservatorio del Legno Andamento dei mercati di legname tondo in Trentino Aprile 2013 Tabella riassuntiva per trimestre Nr. lotti, quantità totali vendute e prezzi medi ponderati (*) nel trimestre considerato.
Osservatorio del Legno Andamento dei mercati di legname tondo in Trentino Aprile 2013 Tabella riassuntiva per trimestre Nr. lotti, quantità totali vendute e prezzi medi ponderati (*) nel trimestre considerato.
2.1 Descrizione dell'area di balneazione
 1.1 Dati identificativi 1 Denominazione acqua di balneazione Grado - Isola Volpera 4 Categoria acque di transizione 5 Regione Friuli Venezia Giulia 6 Provincia Gorizia 7 Comune Grado 8 Corpo idrico* Ara
1.1 Dati identificativi 1 Denominazione acqua di balneazione Grado - Isola Volpera 4 Categoria acque di transizione 5 Regione Friuli Venezia Giulia 6 Provincia Gorizia 7 Comune Grado 8 Corpo idrico* Ara
Lavoro Agile in Italia
 2.0 Lavoro Agile in Italia L esperienza della Provincia Autonoma di Trento Convegno di Kick-Off del Progetto E.L.E.N.A. Aprile 2016 Roma Servizio per il personale Ufficio sviluppo risorse umane Paola Borz
2.0 Lavoro Agile in Italia L esperienza della Provincia Autonoma di Trento Convegno di Kick-Off del Progetto E.L.E.N.A. Aprile 2016 Roma Servizio per il personale Ufficio sviluppo risorse umane Paola Borz
LA NORMATIVA SULLA DIFESA DEL SUOLO
 LA NORMATIVA SULLA DIFESA DEL SUOLO R.D. 25 luglio 1904, n. 523 - Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie. R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Testo Unico
LA NORMATIVA SULLA DIFESA DEL SUOLO R.D. 25 luglio 1904, n. 523 - Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie. R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Testo Unico
Analisi delle caratteristiche delle acque superficiali nel bacino del fiume Adige: corpi idrici superficiali e condizioni di riferimento
 Analisi delle caratteristiche delle acque superficiali nel bacino del fiume Adige: corpi idrici superficiali e condizioni di riferimento TRENTO Museo tridentino di scienze naturali 17 gennaio 2007 dott.
Analisi delle caratteristiche delle acque superficiali nel bacino del fiume Adige: corpi idrici superficiali e condizioni di riferimento TRENTO Museo tridentino di scienze naturali 17 gennaio 2007 dott.
LA GIUNTA REGIONALE. SU PROPOSTA dell Assessore all Ambiente;
 Oggetto: Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola in attuazione della direttiva 91/676/CEE e del D.lgs. 152/99, successivamente modificato con D.lgs. 258/2000. LA GIUNTA REGIONALE
Oggetto: Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola in attuazione della direttiva 91/676/CEE e del D.lgs. 152/99, successivamente modificato con D.lgs. 258/2000. LA GIUNTA REGIONALE
2.3. FATTORI CLIMATICI
 2.3. FATTORI CLIMATICI Il Rapporto sullo stato dell ambiente (ARPAV 2004) classifica il clima della provincia di Verona quale clima temperato senza stagione secca e con estate calda con influenza mediterranea..
2.3. FATTORI CLIMATICI Il Rapporto sullo stato dell ambiente (ARPAV 2004) classifica il clima della provincia di Verona quale clima temperato senza stagione secca e con estate calda con influenza mediterranea..
Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena
 STRUTTURA COMPLESSA Dipartimento di Torino Sede di Torino Struttura Semplice Attività di produzione Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena MONITORAGGIO
STRUTTURA COMPLESSA Dipartimento di Torino Sede di Torino Struttura Semplice Attività di produzione Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena MONITORAGGIO
Piano Regionale di Tutela Acque
 Piano Regionale di Tutela Acque Fonte normativa: decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale articolo 121 Strutture coinvolte: Servizio infrastrutture civili e tutela acque dall'inquinamento
Piano Regionale di Tutela Acque Fonte normativa: decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale articolo 121 Strutture coinvolte: Servizio infrastrutture civili e tutela acque dall'inquinamento
Indagine ambientale Villa Lagarina Scuola P. Lodron Maggio - Luglio 2010
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per la Protezione dell'ambiente Settore Informazione e monitoraggi U.O. per le Attività di monitoraggio ambientale Rete provinciale di controllo della qualità
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per la Protezione dell'ambiente Settore Informazione e monitoraggi U.O. per le Attività di monitoraggio ambientale Rete provinciale di controllo della qualità
Il monitoraggio e il controllo delle acque nel bacino del fiume Olona
 Contratto di fiume Olona-Bozzente-Lura Comitato di Coordinamento lunedì 17 ottobre 2016 Il monitoraggio e il controllo delle acque nel bacino del fiume Olona Fagnano Olona, febbraio 2010 Settore Monitoraggi
Contratto di fiume Olona-Bozzente-Lura Comitato di Coordinamento lunedì 17 ottobre 2016 Il monitoraggio e il controllo delle acque nel bacino del fiume Olona Fagnano Olona, febbraio 2010 Settore Monitoraggi
Andamento dei mercati di legname tondo in Trentino
 20 I trimestre Osservatorio del Legno Andamento dei mercati di legname tondo in Trentino 20 Itrimestre Dicembre 20 Con la collaborazione del Servizio Foreste e Fauna P.A.T. e del Dott. for. Enrico Tonezzer
20 I trimestre Osservatorio del Legno Andamento dei mercati di legname tondo in Trentino 20 Itrimestre Dicembre 20 Con la collaborazione del Servizio Foreste e Fauna P.A.T. e del Dott. for. Enrico Tonezzer
SCHEDA Rischio Sismico (sulla base delle banche dati provinciali) Versione DICEMBRE 2014
 SCHEDA Rischio Sismico (sulla base delle banche dati provinciali) Versione DICEMBRE 2014 Referente in Provincia autonoma di Trento: Servizio Geologico La sismicità indica la frequenza e la forza con cui
SCHEDA Rischio Sismico (sulla base delle banche dati provinciali) Versione DICEMBRE 2014 Referente in Provincia autonoma di Trento: Servizio Geologico La sismicità indica la frequenza e la forza con cui
Stagione Sportiva 2010/2011 Comunicato Ufficiale N 14 del 10 settembre 2010
 Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti Settore Giovanile e Scolastico COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO Via G.B. Trener, 2/2-38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 98.42.62 - Fax:
Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti Settore Giovanile e Scolastico COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO Via G.B. Trener, 2/2-38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 98.42.62 - Fax:
Capitolo 3 Caratterizzazione delle aree protette
 Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali Bacino dello slizza Capitolo 3 I INDICE 3. CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTE... 1 3.1. AREE PER L ESTRAZIONE DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO
Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali Bacino dello slizza Capitolo 3 I INDICE 3. CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTE... 1 3.1. AREE PER L ESTRAZIONE DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO
ARPA Sezione di Rimini
 ARPA Sezione di Rimini 5.3 STAZIONE DI MONITORAGGIO 19000500 PONTE VIA MARECCHIESE RIMINI Caratteristiche del punto: Questo punto di campionamento è situato sul torrente Ausa, immediatamente prima della
ARPA Sezione di Rimini 5.3 STAZIONE DI MONITORAGGIO 19000500 PONTE VIA MARECCHIESE RIMINI Caratteristiche del punto: Questo punto di campionamento è situato sul torrente Ausa, immediatamente prima della
Azione 5: Progettazione di interventi di miglioramento degli habitat fluviali. Relatore: Ing. Massimo Sartorelli
 Azione 5: Progettazione di interventi di miglioramento degli habitat fluviali Relatore: Ing. Massimo Sartorelli Sondrio, 15 marzo 2012 RIPRISTINO DELL ECOCOMPATIBILIT ECOCOMPATIBILITÀ DEL TRATTO FINALE
Azione 5: Progettazione di interventi di miglioramento degli habitat fluviali Relatore: Ing. Massimo Sartorelli Sondrio, 15 marzo 2012 RIPRISTINO DELL ECOCOMPATIBILIT ECOCOMPATIBILITÀ DEL TRATTO FINALE
Distretto idrografico delle Alpi orientali. Piano di gestione delle acque Aggiornamento
 Distretto idrografico delle Alpi orientali Piano di gestione delle acque Aggiornamento 2015-2021 Comitato Istituzionale congiunto Roma, 3 marzo 2016 Contenuti dell aggiornamento del piano Revisione della
Distretto idrografico delle Alpi orientali Piano di gestione delle acque Aggiornamento 2015-2021 Comitato Istituzionale congiunto Roma, 3 marzo 2016 Contenuti dell aggiornamento del piano Revisione della
Gestione della pesca e ripopolamenti con trote nelle acque della provincia di Trento
 Provincia Automa di Trento Servizio Foreste e Fauna Ufficio Faunistico Gestione della pesca e ripopolamenti con trote nelle acque della provincia di Trento ASSOCIAZIONE ITALIANA ITTIOLOGI ACQUE DOLCI Workshop:
Provincia Automa di Trento Servizio Foreste e Fauna Ufficio Faunistico Gestione della pesca e ripopolamenti con trote nelle acque della provincia di Trento ASSOCIAZIONE ITALIANA ITTIOLOGI ACQUE DOLCI Workshop:
Pericolosità idraulica a valle delle dighe
 Convegno nazionale Longarone (BL) 13 settembre 2013 Pericolosità idraulica a valle delle dighe L utilizzo delle dighe per la laminazione delle piene in Provincia di Trento ing. Roberto Bertoldi Dirigente
Convegno nazionale Longarone (BL) 13 settembre 2013 Pericolosità idraulica a valle delle dighe L utilizzo delle dighe per la laminazione delle piene in Provincia di Trento ing. Roberto Bertoldi Dirigente
Autorità di bacino del fiume Po
 Analisi e proposte tecnico-scientifiche per la conoscenza e la pianificazione integrata del distretto del fiume Po: presentazione del progetto Rete di Monitoraggio del Po (Re.Mo. del Po) Lunedì, 15 maggio
Analisi e proposte tecnico-scientifiche per la conoscenza e la pianificazione integrata del distretto del fiume Po: presentazione del progetto Rete di Monitoraggio del Po (Re.Mo. del Po) Lunedì, 15 maggio
Elementi idromorfologici: indice di alterazione del regime idrologico (IARI)
 Direttiva 2000/60/CE: Struttura delle reti e dei programmi di monitoraggio sui corsi d acqua Indici di classificazione dello stato di qualità Elementi idromorfologici: indice di alterazione del regime
Direttiva 2000/60/CE: Struttura delle reti e dei programmi di monitoraggio sui corsi d acqua Indici di classificazione dello stato di qualità Elementi idromorfologici: indice di alterazione del regime
1.1 Dati identificativi. 2.1 Descrizione dell'area di balneazione
 1.1 Dati identificativi 1 Denominazione acqua di balneazione Sistiana - Sotto il Camping 4 Categoria acque marino costiere 5 Regione Friuli Venezia Giulia 6 Provincia Trieste 7 Comune Duino-Aurisina 8
1.1 Dati identificativi 1 Denominazione acqua di balneazione Sistiana - Sotto il Camping 4 Categoria acque marino costiere 5 Regione Friuli Venezia Giulia 6 Provincia Trieste 7 Comune Duino-Aurisina 8
Gli aspetti di sistemazione idrogeologica e idraulica nel loro rapporto con il PdG Po. Ing. Lorenzo Masoero Geol. Giorgio Gaido
 Gli aspetti di sistemazione idrogeologica e idraulica nel loro rapporto con il PdG Po Ing. Lorenzo Masoero Geol. Giorgio Gaido SCALETTA INTERVENTO principali strumenti di pianificazione ed i loro obiettivi
Gli aspetti di sistemazione idrogeologica e idraulica nel loro rapporto con il PdG Po Ing. Lorenzo Masoero Geol. Giorgio Gaido SCALETTA INTERVENTO principali strumenti di pianificazione ed i loro obiettivi
NUOVE PROSPETTIVE PER LA GESTIONE DELLE ACQUE DEL PIAVE
 SMART WATERS COOPERAZIONE E SICUREZZA IDRICA NELLE AREE FRAGILI NUOVE PROSPETTIVE PER LA GESTIONE DELLE ACQUE DEL PIAVE Antonio Rusconi Università IUAV Venezia Gruppo 183 Rovigo, 21-22 marzo 2014 I bacini
SMART WATERS COOPERAZIONE E SICUREZZA IDRICA NELLE AREE FRAGILI NUOVE PROSPETTIVE PER LA GESTIONE DELLE ACQUE DEL PIAVE Antonio Rusconi Università IUAV Venezia Gruppo 183 Rovigo, 21-22 marzo 2014 I bacini
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
 8 AGGIORNAMENTO CARTA DI SINTESI GEOLOGICA: RELAZIONE Le disposizioni normative contenute nel nuovo Piano Urbanistico Provinciale approvato con la legge provinciale n. 5 del 27 maggio 2008, all articolo
8 AGGIORNAMENTO CARTA DI SINTESI GEOLOGICA: RELAZIONE Le disposizioni normative contenute nel nuovo Piano Urbanistico Provinciale approvato con la legge provinciale n. 5 del 27 maggio 2008, all articolo
REALIZZAZIONE NUOVO BACINO PER L'INNEVAMENTO PROGRAMMATO DELLA VOLUMETRIA DI 60'000 MC IN LOC. «BUSE DE TRESCA» IN C.C.PREDAZZO STUDIO PRELIMINARE
 COMUNE DI PREDAZZO PROVINCIA DI TRENTO REALIZZAZIONE NUOVO BACINO PER L'INNEVAMENTO PROGRAMMATO DELLA VOLUMETRIA DI 60'000 MC IN LOC. «BUSE DE TRESCA» IN C.C.PREDAZZO STUDIO PRELIMINARE PREMESSA NELL ULTIMO
COMUNE DI PREDAZZO PROVINCIA DI TRENTO REALIZZAZIONE NUOVO BACINO PER L'INNEVAMENTO PROGRAMMATO DELLA VOLUMETRIA DI 60'000 MC IN LOC. «BUSE DE TRESCA» IN C.C.PREDAZZO STUDIO PRELIMINARE PREMESSA NELL ULTIMO
TITOLO II MISURE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ
 7 TITOLO II MISURE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ Cap. 1 Programmi di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici (art. 5, Titolo II, Capo I, DLgs
7 TITOLO II MISURE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ Cap. 1 Programmi di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici (art. 5, Titolo II, Capo I, DLgs
Le iniziative del Ministero dell Ambiente in materia di difesa delle coste dal 2006 e gli obiettivi di indirizzo generali
 Le iniziative del Ministero dell Ambiente in materia di difesa delle coste dal 2006 e gli obiettivi di indirizzo generali Leonardo Di Maggio Consulente Sogesid presso la Direzione Generale per la Salvaguardia
Le iniziative del Ministero dell Ambiente in materia di difesa delle coste dal 2006 e gli obiettivi di indirizzo generali Leonardo Di Maggio Consulente Sogesid presso la Direzione Generale per la Salvaguardia
Tematismi e Cartografie del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione e del Piano Provinciale di Emergenza.
 Tematismi e Cartografie del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione e del Piano Provinciale di Emergenza Tematismi importanti Rischio Idraulico - Censimento degli eventi di esondazione interessanti
Tematismi e Cartografie del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione e del Piano Provinciale di Emergenza Tematismi importanti Rischio Idraulico - Censimento degli eventi di esondazione interessanti
Nel territorio comunale sono presenti i seguenti corsi d acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche:
 Nel territorio comunale sono presenti i seguenti corsi d acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: 1. Corsi d acqua appartenenti all Elenco Principale delle Acque Pubbliche D.Luog. 23.5.1918:
Nel territorio comunale sono presenti i seguenti corsi d acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: 1. Corsi d acqua appartenenti all Elenco Principale delle Acque Pubbliche D.Luog. 23.5.1918:
I CONTRATTI DI FIUME IN LOMBARDIA
 I CONTRATTI DI FIUME E DI LAGO I CONTRATTI DI FIUME IN LOMBARDIA PROGETTI E POLITICHE INTEGRATE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E LA RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE Napoli, 18 dicembre 2013 Mario
I CONTRATTI DI FIUME E DI LAGO I CONTRATTI DI FIUME IN LOMBARDIA PROGETTI E POLITICHE INTEGRATE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E LA RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE Napoli, 18 dicembre 2013 Mario
COMUNE DI PONTE DELL'OLIO Provincia di Piacenza
 COMUNE DI PONTE DELL'OLIO Provincia di Piacenza COMUNE DI PONTE DELL'OLIO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO 1^ Edizione - Marzo 2012: Dott. Geol. Paolo Mancioppi Studio
COMUNE DI PONTE DELL'OLIO Provincia di Piacenza COMUNE DI PONTE DELL'OLIO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO 1^ Edizione - Marzo 2012: Dott. Geol. Paolo Mancioppi Studio
CONNESSO ALLE DERIVAZIONI IDRICHE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DI QUALITA AMBIENTALE DEFINITI DAL PIANO DI GESTIONE DISTRETTO IDROGRAFICO PO»
 NUOVE DISPOSIZIONI DEL COMITATO ISTITUZIONALE AUTORITA DI BACINO PO: DELIBERAZIONI DI DICEMBRE 2015 DIRETTIVA «VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE CONNESSO ALLE DERIVAZIONI IDRICHE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI
NUOVE DISPOSIZIONI DEL COMITATO ISTITUZIONALE AUTORITA DI BACINO PO: DELIBERAZIONI DI DICEMBRE 2015 DIRETTIVA «VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE CONNESSO ALLE DERIVAZIONI IDRICHE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI
Classificazione relativa allo stato di qualità ambientale e idoneità alla vita dei pesci
 Classificazione relativa allo stato di qualità ambientale e idoneità alla vita dei pesci Dott.. Ferdinando De Rosa, Presidente Ordine Regionale dei Chimici delle Marche Direttore Tecnico Scientifico ARPAM
Classificazione relativa allo stato di qualità ambientale e idoneità alla vita dei pesci Dott.. Ferdinando De Rosa, Presidente Ordine Regionale dei Chimici delle Marche Direttore Tecnico Scientifico ARPAM
REGGIO CALABRIA 29 ottobre 2015
 III Convegno Nazionale sulla Riqualificazione Fluviale Sessione Internazionale Riqualificare i corsi d acqua nella regione mediterranea ispirazione dalle buone pratiche - impegno per le sfide correnti
III Convegno Nazionale sulla Riqualificazione Fluviale Sessione Internazionale Riqualificare i corsi d acqua nella regione mediterranea ispirazione dalle buone pratiche - impegno per le sfide correnti
DECISIONE DELLA COMMISSIONE (2003/376/CE) del 22 maggio 2003
 DECISIONE DELLA COMMISSIONE (2003/376/CE) del 22 maggio 2003 che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/304/CE concernente i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute
DECISIONE DELLA COMMISSIONE (2003/376/CE) del 22 maggio 2003 che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/304/CE concernente i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute
Torino, Ottobre 2011
 per i progetti di gestione degli invasi e per l esecuzione delle operazioni: contenuti ed esperienze di applicazione Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione
per i progetti di gestione degli invasi e per l esecuzione delle operazioni: contenuti ed esperienze di applicazione Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione
GESTIONE delle RISORSE IDRICHE
 Corso di laurea specialistica in Ingegneria delle Acque e della Difesa del Suolo Corso di GESTIONE delle RISORSE IDRICHE a.a. 2003-2004 Lezione 4 Prof. Luca Lanza Dipartimento di Ingegneria Ambientale
Corso di laurea specialistica in Ingegneria delle Acque e della Difesa del Suolo Corso di GESTIONE delle RISORSE IDRICHE a.a. 2003-2004 Lezione 4 Prof. Luca Lanza Dipartimento di Ingegneria Ambientale
03) Via Frascani QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO. Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione...2
 03) Via Frascani QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione...2 Pericolosità idraulica, acque superficiali e depurazione...6 Clima acustico e piano
03) Via Frascani QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione...2 Pericolosità idraulica, acque superficiali e depurazione...6 Clima acustico e piano
CONTRATTO DI FIUME "Arielli"
 CONTRATTO DI FIUME "Arielli" Ortona a Mare, Tollo, Canosa Sannita, Crecchio, Arielli, Poggiofiorito e Orsogna (Provincia di Chieti) Primo Programma d'azione Ottobre 2014 Il primo programma d'azione del
CONTRATTO DI FIUME "Arielli" Ortona a Mare, Tollo, Canosa Sannita, Crecchio, Arielli, Poggiofiorito e Orsogna (Provincia di Chieti) Primo Programma d'azione Ottobre 2014 Il primo programma d'azione del
Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, art. 21, comma 3 Approvazione della Carta delle risorse idriche. a) Relazione b) Norme di attuazione
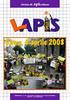 Provincia Autonoma di Trento Assessorato all Urbanistica, Ambiente e Lavori pubblici Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, art. 21, comma 3 Approvazione della Carta delle risorse idriche a) Relazione
Provincia Autonoma di Trento Assessorato all Urbanistica, Ambiente e Lavori pubblici Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, art. 21, comma 3 Approvazione della Carta delle risorse idriche a) Relazione
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO (Classe delle lauree in Ingegneria Civile ed Ambientale, Classe N. L-7) DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO (Classe delle lauree in Ingegneria Civile ed Ambientale, Classe N. L-7) DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI
 SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI Copertura: regionale Periodicità: annuale www. arpa.veneto.it Rapporto di sintesi sugli andamenti dei principali parametri oceanografici e meteo-marini delle
SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI Copertura: regionale Periodicità: annuale www. arpa.veneto.it Rapporto di sintesi sugli andamenti dei principali parametri oceanografici e meteo-marini delle
IL RUOLO DEL GEOLOGO NEI PROCESSI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
 IL RUOLO DEL GEOLOGO NEI PROCESSI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE Corso di Aggiornamento Professionale Viterbo, 24 maggio 2010 - Palazzo della Provincia Prima Sessione Le componenti geologiche nello SIA: ambiente
IL RUOLO DEL GEOLOGO NEI PROCESSI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE Corso di Aggiornamento Professionale Viterbo, 24 maggio 2010 - Palazzo della Provincia Prima Sessione Le componenti geologiche nello SIA: ambiente
IL DIRIGENTE DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI. determina
 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 19/06/2012 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 19/06/2012 212 79787 Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 19/06/2012 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 19/06/2012 212 79787 Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
