Evoluzione gestionale e valorizzazione economica dei parchi
|
|
|
- Giorgio Rosso
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Università degli Studi di Udine Dipartimento di Scienze Economiche Evoluzione gestionale e valorizzazione economica dei parchi FRANCESCO MARANGON TIZIANO TEMPESTA Working Paper No eco Working Paper Series in Economics
2 Università degli Studi di Udine Dipartimento di Scienze Economiche Via Tomadini 30/A, Udine, Italy Tel Fax Url: web.uniud.it/dse/welcome.html WORKING PAPER SERIES IN ECONOMICS This Working Paper series aims to provide a means for stimulating discussion and critical comments on preliminary research results by staff or visitors to the Department. It is a Department policy that of adopting its web site as a primary means for publishing. Paper copies will be provided only upon request. This Department complies with Italian Law obligations on publishing (Art.1, D.L.L. 31/08/1945, N.660).
3 Evoluzione gestionale e valorizzazione economica dei parchi Francesco Marangon a e Tiziano Tempesta b a Dipartimento di Scienze Economiche - Università di Udine Via Tomadini 30/a Udine marangon@dse.uniud.it b Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali - Università di Padova Agripolis - via Romea Legnaro (PD) tiziano.tempesta@unipd.it Abstract Il presente lavoro affronta criticamente alcune questioni economico-gestionali da tempo nell agenda degli economisti ambientali che si interessano di management, in senso lato, delle aree naturali protette. In primo luogo vengono fatti alcuni richiami alla teoria economica per avere uno schema concettuale di riferimento utile per una migliore comprensione delle considerazioni successive. Vengono poi richiamati i risultati di alcune esperienze fatte in Italia in materia di rapporti tra aree protette e benefici sociali ed economici. Da ultimo vengono forniti alcuni richiami ad una interessantissima sperimentazione effettuata negli USA nel campo dell autofinanziamento dei parchi federali e verranno formulate alcune indicazioni operative per l avvio di nuove modalità di gestione dei parchi italiani. Keywords Ecoturismo, Parchi naturali, Pricing, Domanda turistica. JEL Classification Q200, Q260, Q280. Ripartizione delle parti La ricerca è frutto congiunto degli autori. Tuttavia Francesco Marangon ha realizzato i paragrafi 1, 2, 3, e Tiziano Tempesta i paragrafi 4, 5, 6 e 7. Comuni sono invece le conclusioni. 3
4 1. Introduzione L istituzione delle aree protette ha assunto oramai da lungo tempo una pluralità di funzioni che vanno ben oltre la necessità di conservare la natura. Il parco, nella sua concezione moderna, svolge anche importanti e imprescindibili funzioni di carattere sociale (Rey, 1984). Si possono richiamare, ad esempio, il ruolo educativo e culturale, quello scientifico e quello ricreativo. Quest ultimo, in particolare, è stato oggetto di particolare attenzione poiché si è osservato che l istituzione di un area protetta può avere una forte capacità attrattiva nei confronti dei flussi turistici e ricreativi. La presenza di un parco può funzionare come una sorta di marchio di qualità ambientale in grado di attrarre quel segmento della domanda turistica che viene designato con il termine di ecoturismo (Ceballos-Lascurain, 1996; Marangon et al., 2002). Il riconoscimento esplicito o implicito di tale importante funzione ha comportato una progressiva estensione del campo di operatività dell Ente Parco che ha modificato la sua stessa ragione d essere: da istituto di controllo del rispetto dei vincoli ambientali a istituto volto a favorire un uso sostenibile del territorio e dell ambiente naturale. Tale riconsiderazione della funzione del parco è stata del resto favorita dalla necessità di compensare in qualche modo le comunità locali dei costi (veri o presunti) che sulle stesse vengono fatti gravare al fine di conservare la natura. Il campo di operatività dell Ente Parco si è quindi di molto esteso, inglobando nuove attività che rendono necessarie sempre maggiori capacità manageriali e gestionali rendendo di fatto imprescindibili considerazioni di carattere economico. In particolare ha assunto sempre maggiore rilevanza il problema dell efficienza e dell efficacia della spesa e, non meno importante, quello del reperimento dei fondi necessari per finanziare i parchi. E infatti evidente che, mentre della conservazione della natura beneficia indistintamente tutta la collettività che quindi è chiamata a finanziare tale azione tramite il prelievo fiscale, la valorizzazione turistica e ricreativa (in senso lato) riguarda particolari categorie di soggetti che, in qualche modo, dovrebbero pagare i servizi forniti dal parco e dal territorio in cui esso si estende. Per certi versi si può affermare che i parchi italiani si sono trovati del tutto impreparati ad affrontare tale nuova sfida. La necessità di svolgere le nuove 4
5 funzioni richiamate ha indotto alla formulazione di vari progetti che sono stati finanziati a livello pubblico, trascurando però che, in assenza di una adeguata dotazione di risorse umane e gestionali, le capacità di spesa e di controllo sulla spesa dei parchi divengono assai limitate. Sono stati talvolta finanziati interventi più per la disponibilità di fondi che per reali necessità gestionali. Si sono così avute situazioni assolutamente paradossali: parchi fortemente indebitati, forti carenze di organici (specie riguardo ad alcune mansioni) e giacenze di spesa pari a 150 milioni di euro! Non è un caso che in tale contesto vi sia stata una forte ripresa del dibattito politico in tema di gestione dei parchi. Lo stesso Ministro dell Ambiente Matteoli nel suo intervento alla conferenza nazionale sulle aree protette di Torino tenutasi nell ottobre 2002 ha posto con chiarezza la necessità di superare la prima fase della politica delle aree protette in Italia (volta essenzialmente alla istituzione di nuovi Parchi e Riserve Naturali), per passare ad una nuova fase tesa prevalentemente al miglioramento della qualità degli interventi e delle capacità di spesa e autofinanziamento. Del resto già lo stesso Valerio Giacomini nel 1981, scrivendo forse il più bel libro sulle aree protette italiane aveva affermato che il parco, dopo un adeguato periodo di avvio, deve mirare ad essere autosufficiente e produttivo, in forza delle sue attrezzature e delle sue iniziative, almeno in relazione alle necessità interne di mantenimento funzionale, ai problemi occupazionali, ai servizi sociali (Giacomini, 2002). Affrontare compiutamente il problema della capacità di spesa significa necessariamente analizzarne anche l efficacia e l efficienza e ciò pone in primo luogo il problema della quantificazione e del monitoraggio dei risultati conseguiti. Ciò è tanto più vero se il parco deve individuare forme di autofinanziamento e impegnarsi fattivamente nella realizzazione di progetti di sviluppo del territorio. In questi casi è impensabile che in qualche modo non siano definiti i modi ed i tempi per la verifica dei risultati conseguiti. 5
6 Il presente lavoro 1 affronta criticamente alcune questioni economico-gestionali da tempo nell agenda degli economisti ambientali che si interessano di management, in senso lato, delle aree naturali protette. Il working paper è stato pertanto organizzato come segue. In primo luogo vengono fatti alcuni richiami alla teoria economica per avere uno schema concettuale di riferimento utile per una migliore comprensione delle considerazioni successive. Vengono poi richiamati i risultati di alcune esperienze fatte in Italia in materia di rapporti tra aree protette e benefici sociali ed economici. Da ultimo vengono forniti alcuni richiami ad una interessantissima sperimentazione effettuata negli USA nel campo dell autofinanziamento dei parchi federali e verranno formulate alcune indicazioni operative per l avvio di nuove modalità di gestione dei parchi italiani. 2. Teoria economica e parchi naturali: alcuni riferimenti di base L intervento pubblico nel campo della gestione delle risorse ambientali trova una motivazione economica in tutti i casi in cui il mercato non è in grado di garantirne un utilizzo corretto ed efficiente. Si tratta dei ben noti fallimenti del mercato che possono essere ricondotti essenzialmente a cinque casistiche principali: beni pubblici; esternalità della produzione; irriproducibilità delle risorse; monopoli; selezione avversa e rischio morale. Qualora si sia in presenza di queste problematiche l intervento pubblico diviene necessario per correggere l inefficienza del mercato, intervento che può seguire strade diverse ma riconducibili essenzialmente al controllo dell operato dei privati o alla gestione/produzione in proprio delle risorse e dei beni pubblici. 1 Una sintesi dello studio è stata presentata il da Francesco Marangon alla Commissione VIII (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera dei Deputati, nell ambito dell Indagine conoscitiva sul sistema di gestione amministrativa degli enti parco nazionali ( 6
7 La teoria economica suggerisce peraltro che accanto ai fallimenti del mercato sussistono anche i fallimenti del pubblico (Del Bono e Zamagni, 1997) a intendere che l azione pubblica non comporta automaticamente un miglioramento della gestione delle risorse rispetto al mercato. Anche l efficienza dell azione pubblica deve essere attentamente valutata comparando i costi ed i benefici che ne conseguono onde evitare inutili e pericolosi fenomeni di spreco. La protezione del territorio e dell ambiente mediante l istituzione di aree protette è vista dalla teoria economica come un caso particolare di offerta di un bene pubblico che il mercato non garantisce: il soggetto pubblico può intervenire per correggere questa distorsione imponendo autoritativamente i vincoli e gli obiettivi. Anche nel caso dell istituzione di parchi e aree protette devono essere attentamente analizzati i costi ed i benefici dell intervento pubblico al fine di favorirne efficienza ed efficacia (Dixon e Sherman, 1990). Al riguardo va richiamato che poiché la quantità di risorse finanziarie da impiegare a questo scopo è sempre limitata, un loro utilizzo inefficiente si traduce inevitabilmente in una minore azione di tutela dell ambiente. Con riferimento ai parchi ed alle aree protette i principali costi ed i benefici si possono così sintetizzare: A) Costi A1) Diretti (esborsi per il funzionamento del parco, realizzazione di progetti, ecc.) A2) Indiretti o costi opportunità (minori utili e benefici per i privati connessi all imposizione di vincoli nell uso delle risorse) B) Benefici B1) Conservazione delle risorse ambientali B2) Ricreativi e culturali a favore dei visitatori B3) Economici a favore delle comunità locali (spesa turistica, spesa pubblica, aumento degli utili nella produzione di beni e servizi a seguito di azioni di valorizzazione) B4) Introiti per il parco 7
8 La quantificazione di costi e benefici (non necessariamente monetaria) è uno strumento indispensabile per poter valutare correttamente l operato dei parchi nonché l opportunità di intraprendere azioni di valorizzazione della funzione turistica e ricreativa del territorio (Marangon e Massarutto, 2000). Particolarmente importante diviene quindi conoscere la domanda che gravita su ogni parco e adottare strumenti di gestione mirati all'aumento del benessere sociale. Va sottolineato al riguardo che l importanza dei parchi e la loro stessa capacità di spesa non va misurata astrattamente, bensì in relazione all efficacia ed all efficienza con cui tali obiettivi vengono raggiunti. Per quanto attiene il tema della capacità di autofinanziamento dei parchi, la teoria economica fornisce alcuni spunti di riferimento. L economia afferma che quando si offre un bene pubblico, quale ad esempio un area naturale protetta, non è corretto discriminare nessuno e, quindi, non si dovrebbe fa pagare l ingresso o i servizi forniti. In questo contesto un parco dovrebbe funzionare esclusivamente tramite i contributi statali derivati dall imposizione fiscale e non dovrebbero essere previste forme di prelievo a carico dei visitatori. Il benessere è massimo quando non ci sono barriere all'entrata (ossia l accesso è gratuito). Questa affermazione di principio perde di validità quando (Marangon e Tempesta, 1998): vi sono fenomeni di congestione (sovrautilizzo della risorsa); gli importi ricavati dall'introduzione di barriere economiche vengono reinvestiti nella valorizzazione dell'ambiente (viene aumentato il beneficio medio a fronte di una riduzione potenziale dei fruitori e quindi si ha un aumento del benessere sociale); i fruitori determinano un indotto economico di un certo rilievo che ha importanti effetti redistributivi a favore di zone marginali, ossia vi è una redistribuzione del reddito a favore di persone e aree meno ricche e sviluppate. La possibilità che il parco disponga di fonti proprie di finanziamento ottenute facendo pagare permessi d uso di varia natura ai fruitori diviene quindi assolutamente necessaria e giustificata almeno con riferimento ai primi due punti. 8
9 E però da rilevare che la riduzione del numero dei fruitori determinata dall introduzione di permessi di accesso onerosi può entrare in conflitto con il terzo obiettivo. Quando siamo in presenza di queste problematiche non possiamo più limitarci ad offrire il bene pubblico parco, dobbiamo perciò anche occuparci degli effetti di politiche alternative di gestione sul benessere sociale. La sola conservazione non è più sufficiente, bisogna passare ad una fase di gestione e programmazione degli interventi. In definitiva i parchi devono dimostrare corrette capacità gestionali non solo riuscendo a spendere le risorse finanziarie che sono loro trasferite, ma anche facendo vedere che i soldi che spendono aumentano il benessere per la collettività che possiamo misurare su alcuni fattori (conservazione dell'ambiente; valorizzazione della funzione sociale e culturale del territorio; miglioramento delle condizioni di vita della popolazione). Inutile dire che per raggiungere queste finalità ci vogliono anche discrete capacità manageriali. E, si badi bene, non si tratta di giungere a banali aziendalizzazioni dei parchi! 3. Conoscere per gestire: l ecoturismo e le quattro W Negli ultimi anni la problematica relativa agli impatti ambientali del turismo e alla possibilità che quest'ultimo possa contribuire al più ampio processo di sviluppo sostenibile ha riscosso crescente interesse. Un'elevata qualità dell'ambiente è il supporto necessario per la maggior parte delle attività turistiche e, allo stesso tempo, può rappresentare un importante vantaggio competitivo. Bisogna pertanto evitare il rischio che il turismo, a causa di politiche di sviluppo mal calibrate, distrugga la risorsa stessa su cui basa la propria esistenza. Ed è per questo che da tempo l attenzione viene concentrata sull ecoturismo, inteso come attività che favorisce la conservazione dell ambiente e lo sviluppo sostenibile, creando allo stesso tempo un flusso significativo di risorse finanziarie per le aree naturali protette e per le comunità che in esse o attorno ad esse vivono (Marangon et al., 2002). Inoltre gli impatti negativi sull'ambiente (naturale, socioculturale, economico) visitato devono essere resi minimi così come devono essere spinti al massimo gli impatti positivi. 9
10 Ciò appare tanto più rilevante nei parchi e nelle riserve naturali, aree che accomunano la maggiore qualità ambientale e, per converso, la maggiore fragilità ecologica. Come noto, la legge quadro sulle aree protette (n.394 del 1991) pone tra le proprie finalità la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili (art.1). Tale obiettivo è stato ulteriormente rafforzato dalla legge 426 del 1998 (art.2 comma 22) che dà facoltà al Ministro dell'ambiente di promuovere, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati. Ovviamente, perché si possano sviluppare forme di turismo sostenibile è necessario conoscere sia gli impatti generati dal turismo sia i benefici economici e sociali che ne conseguono. Seguendo l approccio proposto nella letteratura anglosassone, si può affermare che per gestire in modo coerente e programmato le problematiche connesse alla presenza di rilevanti flussi di visitatori in un determinato territorio è necessario rispondere alle cosiddette quattro W (Who is Where When doing What?). Il quadro conoscitivo nazionale sia sui flussi di visitatori che sui benefici economici e sociali che ne conseguono è allo stato attuale desolante. Si può forse riscontrare una sorta di idiosincrasia nazionale per tutto quello che riguarda l analisi scientifica della domanda turistico-ricreativa. Il turismo nei parchi è al massimo accettato come un male non evitabile e non come una risorsa per la collettività. Si badi, con ciò non si vuole affermare che non siano mai state svolte ricerche sul turismo e le attività ricreative nelle aree protette, anzi si contano alcune pregevoli ricerche. Si deve però sottolineare che i dati disponibili sono stati rilevati in modo sporadico e fanno riferimento solo a pochissime realtà italiane. Raramente inoltre è stata analizzata la spesa sostenuta dai visitatori (e quindi 10
11 l indotto economico) e ancor più raramente i benefici sociali (ricreativi e culturali). Ma a cosa serve conoscere l entità dei flussi di visitatori e le loro caratteristiche? La risposta è ovviamente assai complessa, ma, in estrema sintesi, rispondere alle quattro W consente di gestire correttamente il territorio naturale per massimizzare i benefici e minimizzare gli impatti. D altronde un attenta analisi della domanda e della sua articolazione spaziale e temporale può far comprendere compiutamente gli effetti di interventi di valorizzazione del territorio o dell imposizione di forme di controllo dell accesso (attuate sia tramite barriere fisiche che monetarie). E chiaro quindi che l idea del turismo come motore dello sviluppo nei parchi deve essere attentamente rimeditata e ponderata tenendo nel debito conto le caratteristiche dei visitatori. In ogni caso quello che sembra emergere è che l estrema variabilità delle situazioni riscontrabili rende necessario un approfondimento conoscitivo della domanda per ogni singola area. La conoscenza dell entità della domanda turistica e ricreativa è pertanto un esigenza non procrastinabile anche alla luce del rilevante gap che separa da questo punto di vista l Italia da molte altre nazioni. Le politiche di tutela della natura potranno trovare maggiore slancio una volta che ne saranno quantificati i benefici. Inoltre, sarà possibile impostare correttamente eventuali politiche di pricing che possano aumentare le entrate degli Enti Parco, garantendo loro una maggiore operatività e la possibilità di disporre di risorse da investire nel miglioramento dell offerta culturale e ricreativa. Va richiamato comunque il fatto che l attuale legislazione italiana non sembra attribuire, di fatto, alcuna reale autonomia finanziaria ai parchi che non hanno facoltà di imporre il pagamento di biglietti di ingresso o permessi d uso ma solo di vendere servizi. 4. Conoscere la domanda per aumentare il benessere sociale La conoscenza delle caratteristiche quantitative e qualitative della domanda si può considerare, come osservato, un momento centrale per una corretta implementazione delle politiche gestionali. Da essa dipendono in buona sostanza 11
12 una parte non trascurabile dei benefici sociali e dell indotto per le economie locali. A ben vedere del resto, la stessa possibilità di successo di eventuali azioni di autofinanziamento è strettamente connesse alle caratteristiche della domanda ed in particolare alla cosiddetta disponibilità a pagare per poter fruire di un bene ambientale. Il problema che si pone in quest ottica è quello di trovare degli strumenti per assegnare un valore economico alla protezione; valore che, almeno in parte, una volta misurato, si può poi cercare di comunicare al mercato attraverso opportune strategie di marketing. Soccorrono in questo esercizio le metodologie di valutazione economica delle esternalità ambientali e di contabilità ambientale (Marangon e Tempesta, 2001), sia l analisi dell approccio volontario alla politica ambientale e dell utilizzo dei marchi di qualità ambientale (Marangon e Massarutto, 2000). É nota la difficoltà di definire compiutamente i benefici connessi alla valorizzazione dell'ambiente a fini ricreativi, mentre, al contrario, è risaputo che è relativamente agevole ricostruire i costi sostenuti per la realizzazione di tali interventi. D altro canto, per molti anni si è erroneamente ritenuto che l intervento pubblico in campo economico e sociale potesse essere completamente avulso dall analisi dei criteri di convenienza economica e finanziaria. L accumularsi di un crescente debito pubblico ha posto chiaramente in evidenza come anche l azione pubblica sia soggetta a vincoli di bilancio che impongono l adozione di criteri di efficienza gestionale. Ovviamente con ciò non si vuole affermare che l equilibrio di bilancio debba essere l unico criterio di riferimento dell intervento pubblico, specie in un settore, quale la conservazione e valorizzazione dell ambiente naturale, in cui, oltre a rilevanti implicazioni etiche, sono coinvolte problematiche assai ampie che vanno dalla conservazione delle risorse naturali per le future generazioni all importanza sociale dell educazione ambientale. E però altrettanto evidente che anche nella politica ambientale dovranno essere analizzati vincoli di bilancio e benefici sociali nel modo più attento possibile. In base a studi non più recenti è stato stimato che la ricreazione nei parchi e nelle riserve naturali in senso stretto genera un indotto di oltre mille miliardi di lire con una occupazione superiore alle 17 mila unità lavorative. Va però ribadito quanto 12
13 detto in precedenza e che cioé in Italia si ha ancora una conoscenza episodica e superficiale del numero complessivo di visitatori delle aree protette e dei benefici economici e sociali che ne conseguono. Non va comunque dimenticato che l attività ricreativa in un ambiente naturale può portare a squilibri con le diverse componenti degli ecosistemi naturali. Un incremento della pressione turistica che superi le previsioni effettuate in sede di pianificazione può infatti comportare rilevanti impatti ambientali (ad es. impoverimento floristico da calpestamento, disturbo alle popolazioni faunistiche). Per tale motivo il conflitto tra fruizione turistica e conservazione dell ambiente naturale rappresenta uno dei più importanti problemi di pianificazione nell ambito della gestione delle aree protette. In questo contesto, il problema della valutazione economica dei benefici connessi alla fruizione delle aree di interesse naturalistico, nonché la definizione di corrette strategie di gestione economica, sono venuti assumendo una crescente importanza, come pare di ricavare anche dall avvio da parte del Ministro dell Ambiente di un indagine conoscitiva sul sistema di gestione amministrativa degli Enti parco nazionali. In primo luogo perché in assenza di un adeguata disponibilità di risorse da investire in azioni di valorizzazione e riqualificazione turistico-ambientale, i parchi e le riserve naturali si traducono esclusivamente in un insieme di vincoli e di costi che sono fatti gravare sulle comunità locali senza alcuna contropartita in termini di sviluppo di attività economiche e creazione di posti di lavoro. Il dibattito che vede da lungo tempo contrapposte le associazioni ambientalistiche alle organizzazioni imprenditoriali ed alle comunità locali circa gli effetti sull economia dell istituzione di parchi deriva essenzialmente dall assenza di informazioni certe sulla reale capacità di mobilitare risorse di un area protetta. Da un lato si insiste sugli effetti positivi che il parco può esercitare sull economia locale. Dall altro si pongono in evidenza i costi connessi ai vincoli e le esperienze non sempre positive in termini di sviluppo sia dei parchi nazionali che esteri. Poiché appare oramai chiaro che le risorse necessarie alle azioni di valorizzazione non potranno in alcun caso derivare interamente da finanziamenti pubblici, risulta evidente che solo la presenza di un elevata domanda del bene parco potrà 13
14 garantire il successo o l insuccesso di azioni di tutela. La conoscenza delle caratteristiche della domanda appare pertanto sempre più una variabile strategica per il successo della politica di conservazione della natura. Da essa derivano sia il valore sociale dell area protetta, sia l entità della spesa per la sua utilizzazione turistico-ricreativa e culturale e, in definitiva, il flusso di risorse finanziarie di cui potranno beneficiare le economie locali. La conoscenza delle caratteristiche della domanda è una premessa indispensabile per il calcolo del valore di un area protetta, almeno per quanto attiene la componente relativa alla fruizione ricreativa. Essa può consentire quindi di accertare, in un ottica di Analisi Costi-Benefici, l opportunità sociale di sottoporre a norme di salvaguardia le parti del territorio di maggiore interesse ambientale. Inoltre, le informazioni sulla domanda permettono di meglio comprendere le caratteristiche dei fruitori e quindi di attuare interventi che non siano incentrati esclusivamente in un ottica di stretta efficienza allocativa ma siano bensì mitigati da considerazioni di tipo distributivo. Si possono anche avere importanti informazioni circa le conseguenze economiche complessive delle azioni di tutela e valorizzazione in termini di ricadute dirette e indirette per l economia locale. Un secondo aspetto, che non va trascurato, riguarda in modo più specifico le problematiche strettamente gestionali dell area. E chiaro che un oculata gestione può consentire sia di aumentare l entità del flusso di fruitori, sia di definire l eventuale importo di biglietti d ingresso o, più in generale, di permessi d uso. Questo tipo di informazione è per molti versi di importanza maggiore rispetto alla mera conoscenza del valore ricreativo dell area. Una corretta gestione finanziaria può consentire di migliorare il rapporto costi-benefici e quindi aumentare l opportunità sociale dell azione di tutela. In secondo luogo, per questa via si potranno liberare risorse da destinare eventualmente alla salvaguardia di altre aree. Da ultimo, il ricorso a barriere all accesso finanziarie (quali il pagamento di biglietti d ingresso o permessi d uso onerosi) può consentire di ridurre il numero di visitatori entro i limiti consentiti dalle capacità di carico di un area sensibile dal punto di vista ambientale. Le barriere finanziarie rispetto a quelle puramente fisiche (quali il contingentamento del numero di visitatori) presentano 14
15 il vantaggio di consentire il recupero dei costi sostenuti per esercitare la necessaria azione di controllo dell accesso dei visitatori. Al riguardo va comunque osservato che allo stato attuale la ricerca in campo economico si è interessata in prevalenza delle problematiche relative alla stima del valore trascurando nella maggior parte dei casi i problemi più tipicamente gestionali. Per molti versi, le metodologie di ricerca comunemente impiegate per stimare il valore economico delle risorse ambientali, possono essere utilizzate anche per affrontare problematiche di tipo più propriamente gestionale, tenendo però nel debito conto i notevoli problemi operativi ed i limiti di tali metodologie. 5 Obiettivi gestionali e definizione dei prezzi per la fruizione dei beni ambientali La misurazione dei benefici prodotti dall istituzione di un area protetta da impiegare a fini ricreativi dipende dalle caratteristiche dell ente gestore e dagli obiettivi che esso intende perseguire. Benché usualmente nel nostro ordinamento giuridico l istituzione e la gestione delle aree protette sia demandata ad enti pubblici, nulla vieta, in linea di principio, che organizzazioni private possano farsi carico sia di interventi di protezione della natura che, eventualmente, della gestione delle aree protette. D altro canto, anche un ente pubblico potrà perseguire finalità di tipo strettamente finanziario e privatistico quali la massimizzazione dell utile di esercizio, o quanto meno, di pareggio del bilancio. Non va infatti trascurato che mentre l ambiente naturale costituisce un bene pubblico puro, le aree utilizzabili a fini ricreativi sono intrinsecamente assimilabili a beni di club, cioè beni per cui può esistere (ed esiste) un mercato. Del resto, anche azioni rivolte esclusivamente alla conservazione dell ambiente naturale finiscono inevitabilmente per avere una natura redistribuiva del reddito poiché riorientano nel territorio la domanda di aree da utilizzare a fini ricreativi e culturali con effetti non trascurabili sull economia locale. Inoltre l obiettivo della massimizzazione del beneficio sociale netto può essere assunto solo quando vi sia una piena identità tra coloro che finanziano l intervento e coloro che ne beneficiano. In altri termini, nel caso dei beni pubblici, la massimizzazione del beneficio sociale netto costituisce il parametro da considerare nella fattibilità di progetti di investimento se coloro che finanziano il 15
16 progetto tramite l imposizione fiscale sono anche i beneficiari dell investimento. Qualora, come nel nostro sistema fiscale, ciò non avvenga, si possono determinare squilibri finanziari a carico dell ente cui è demandata l istituzione e la gestione dell area protetta. Ciò avviene molto spesso per tutte le aree le cui valenze ricreative, culturali e ambientali comportano il formarsi di bacini di utenza sovracomunali o sovraregionali. In questo caso si determina un evidente squilibrio tra la comunità che è chiamata a finanziare la realizzazione dell area protetta e la globalità dei fruitori che della stessa beneficiano. Per sopperire a tale evidente fonte di inefficienza normalmente viene fatto ricorso a due tipi di soluzioni: l imposizione di biglietti d ingresso e il trasferimento di parte degli oneri gestionali ad amministrazioni pubbliche di grado superiore a livello territoriale (ad esempio dal Comune alla Regione o dalla Regione allo Stato). Lo squilibrio ora evidenziato giustifica pertanto l adozione di una pluralità di possibili strategie che possono condurre all adozione di politiche gestionali tra loro conflittuali che si tradurranno nell introduzione di eventuali biglietti d ingresso, o, più in generale, di altre barriere di accesso, nell adozione di vere e proprie politiche di marketing, e così via. Al riguardo si può ipotizzare che gli obiettivi da perseguire possano essere i seguenti (Marangon e Tempesta, 1998): 1. massimizzazione del beneficio sociale netto; 2. massimizzazione degli utili dell ente gestore; 3. massimizzazione dei benefici per l economia locale; 4. pareggio di bilancio nella gestione. La valutazione dell opportunità di istituire un area protetta con valenze ricreative e la definizione di strategie gestionali potrà far riferimento ad una pluralità di funzioni obiettivo da massimizzare che potranno assumere una caratterizzazione intermedia rispetto a quelle delineate. In particolare, tra i due estremi costituiti dalla massimizzazione del benessere sociale e dalla massimizzazione del profitto del monopolista puro, si possono individuare altre soluzioni dettate dalla rilevanza sociale del bene che si intende tutelare (definita in parte dal suo bacino di utenza ma, in prevalenza, da considerazioni di carattere ambientale quali le caratteristiche ecologiche del sito, la sua unicità a livello nazionale o internazionale, ecc.) e dalla 16
17 natura dell ente gestore o delle amministrazioni che concorrono alla istituzione ed alla gestione del parco o della riserva. In questo caso l aggregato economico da massimizzare sarà la risultante di una scelta di compromesso tra beneficio sociale netto, ricadute per l economia locale e capacità di autofinanziamento dell ente gestore. 6. Benefici ricreativi e flussi di spesa in alcune aree protette italiane A puro titolo esemplificativo nelle tabelle 1 e 2 vengono illustrati i dati emersi da alcune ricerche effettuate nel nord-est d Italia in tema di benefici ricreativi e spesa sostenuta dai turisti (Marangon et al., 2002). La spesa sostenuta per visitare i parchi e le riserve riguarda quasi esclusivamente i costi di viaggio e per l acquisto di alimenti (Tab.1), con la rilevante eccezione delle aree dolomitiche fortemente sviluppate sul piano turistico. In taluni casi però è il biglietto d ingresso a costituire il capitolo più sostanzioso di spesa. Tab.1 - I flussi di spesa Area Spesa media per gita ( ) Viaggio Biglietto* Alimenti Alloggio Totale Spesa ( ) Totale Per ha Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 3,6 7,9 0,3 11, ,7 105,5 Parco Naturale Dolomiti Ampezzane 3,5 3,4 9,7 16,1 32, , ,0 Proprietà Regole Ampezzane sud Cortina 19,3 3,0 7,0 14,2 43, , ,7 Vincheto Celarda 3,4 0,4 3, ,1 377,0 Cascate di Molina 2,5 2,0 3,2 7, , ,1 Foce dell'isonzo 2,0 3,5 0,5 6, ,7 79,9 Valle Canal Novo 2,3 2,3 6,3 10, , ,1 Oasi dei Quadris (Fagagna) 1,0 1,7 2, , ,2 Lago di Cornino - Progetto grifoni 2,2 4,8 0,6 7, ,8 120,1 Grotte di Villanova (Lusevera) 1,9 3,7 3,3 9, , ,9 Parco di Villa Varda (Brugnera) 2,9 0,3 3, , ,8 * Costo biglietto d'ingresso o funivia in aree montane Fonte: Marangon et al.,
18 La spesa media è molto variabile, ma ciò pare attribuibile principalmente alla presenza o all assenza di un biglietto d ingresso. Un indicatore interessante della capacità delle aree naturalistiche di generare flussi di spesa è costituito dal costo sostenuto dal totale dei visitatori per ettaro di superficie. Si può notare anche in questo caso una estrema variabilità tra le aree considerate: si passa da importi di pochi euro a oltre per ettaro. Specie nelle aree montane e collinari il flusso di spesa è comunque molto elevato, in taluni casi a causa del forte sviluppo turistico del territorio, in altri grazie all azione di valorizzazione dell ambiente naturale posta in essere anche dai privati. Tab.2 I benefici ricreativi Area Benefici ricreativi Benefici ( ) per gita ( ) Totali Per ha Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 5, ,3 48,3 Parco Naturale Dolomiti Ampezzane 4, ,2 237,8 Proprietà Regole Ampezzane sud Cortina 3, ,6 102,7 Vincheto Celarla 3, ,3 357,2 Cascate di Molina 4, , ,0 Foce dell'isonzo 5, ,8 66,5 Valle Canal Novo 7, , ,3 Oasi dei Quadris (Fagagna) 1, , ,2 Lago di Cornino - Progetto grifoni 4, ,2 66,6 Grotte di Villanova (Lusevera) 10, , ,3 Parco di Villa Varda (Brugnera) 3, , ,8 Fonte: Marangon et al., I benefici ricreativi medi per gita sono stati stimati ricorrendo a varie metodologie (Tab.2). Una simile variabilità si riscontra anche per la capacità del territorio di generare benefici ricreativi, anche se i benefici medi per gita, a testimonianza del notevole valore ricreativo delle aree studiate, sono abbastanza simili essendo compresi tra 3,4 e 7,0, se si esclude l outlier delle Grotte. Il flusso totale di benefici per unità di superficie risente ovviamente del carico totale dei visitatori e quindi risulta essere nuovamente molto variabile. Si noti però che è in generale superiore a quello di molti altri usi economici alternativi, sia che essi siano costituiti dall attività forestale, che dalle stesse attività agricole. 18
19 7. Aumentare la capacità di autofinanziamento dei parchi: il Fee Demonstration Program nei parchi USA Gli USA sono, come noto, il paese al mondo che vanta la più lunga tradizione in fatto di istituzione di parchi naturali. Oltre al sistema dei parchi naturali sono presenti innumerevoli altre aree di proprietà pubblica che sono oggetto ogni anno di circa un miliardo di eventi ricreativi. Il pagamento di permessi per l uso ricreativo ai parchi nel 1995 copriva solo il 7%. A quella data solo un parco aveva il bilancio in pareggio e non gravava sulle casse federali. Benché l autofinanziamento non fosse del tutto assente, copriva una frazione modesta delle spese di gestione. Tale dato in sé non avrebbe condotto all avvio di una riflessione sulle modalità di finanziamento delle aree protette se non fosse accompagnato da alcune evidenti distorsioni: cattivo stato di manutenzione delle strutture e infrastrutture; presenza di spese spesso immotivate (extravagant spending); declino della qualità ambientale e assenza di un sistema di contabilizzazione delle risorse ambientali; sovrautilizzo e sovraffollamento; offerta di servizi non conformi alle aspettative dei visitatori; disincentivo alla realizzazione di servizi ricreativi da parte dei privati. Si è così verificato che dal 1978 al 1997 a fronte di un incremento medio annuo della spesa dei parchi del 2,3%, vi è stato un aumento della spesa per il pagamento dei dipendenti dell 8,7%, un aumento dei visitatori del 1,2% e una riduzione delle spese di manutenzione del 3,6% (Fretwel, 1999)! Per cercare di porre un rimedio a questi problemi il Congresso ha autorizzato un programma di sperimentazione denominato Fee Demonstration Program (FDP) che consentiva a 4 agenzie (National Park Service, USDA Forest Service, U.S. Fish and Wildlife Service, Bureau of Land Management) di imporre il pagamento di nuovi permessi d uso o di aumentare quelli già esistenti. Il Programma ha avuto durata quadriennale, dal 1997 al 2000, e i fondi raccolti possono essere spesi fino al
20 La novità del FDP non sta tanto nell aver consentito l imposizione del pagamento di permessi d uso (fatto già consentito) quanto piuttosto nell aver posto due condizioni: la necessità di sperimentare nuove forme per la raccolta dei permessi d uso; l obbligo di reinvestire l 80% dei fondi raccolti (al netto dei costi) nell area dove sono stati prelevati, dando comunque facoltà alle singole agenzie di reinvestire il 20% in altre zone. Il Congresso ha anche posto la condizione che fossero attentamente monitorati gli effetti del programma sull autofinanziamento, sulla capacità di spesa e sull atteggiamento dei visitatori. Nel progetto sono state coinvolte complessivamente 376 aree protette (di cui 100 parchi). I principali risultati sono stati riassunti di recente da un rapporto al Congresso: il FDP ha consentito di aumentare notevolmente gli introiti diretti delle aree protette che sono più che raddoppiati rispetto al triennio precedente la sperimentazione; ciò ha consentito un crescente margine di autonomia nella gestione finanziaria e un aumento della responsabilizzazione degli enti gestori; la raccolta dei permessi comporta peraltro dei costi assai variabili da situazione a situazione, mediamente pari al 20% degli introiti; i fondi raccolti hanno già determinato impegni di spesa per il 69% delle disponibilità; le agenzie hanno sperimentato varie forme per la raccolta dei permessi verificando che la loro introduzione risultava tanto più accettata quanto più semplici erano le modalità di pagamento; l emissione di permessi d uso si è rivelata essere un interessante strumento per il controllo dei problemi di sovraffollamento; ha consentito infatti di meglio programmare le presenze nel tempo e nello spazio. Si è anche visto che politiche differenziate di pricing possono favorire spontaneamente un più equilibrato flusso di visitatori; vi è stata una sostanziale accettazione dell introduzione dei pagamenti o dell aumento del costo di quelli esistenti verificata sia tramite indagini sulla popolazione che sui frequentatori delle aree protette; 20
21 nel periodo di operatività del FDP non vi è stata una riduzione dei visitatori nei siti oggetto di sperimentazione. 8. Conclusioni La presenza di una pluralità di obiettivi nella gestione ricreativa delle aree protette rende difficile la definizione su base astratta del tipo di azioni attuabili per massimizzare il benessere sociale. Sembra indispensabile che gli enti pubblici che effettuano azioni di valorizzazione turistico-ricreativa dell'ambiente naturale definiscano chiaramente le finalità del proprio intervento. In assenza di tale riflessione di fondo gli interventi troverebbero come unico vincolo le capacità immediate di spesa col pericolo, tutt'altro che remoto, che al diminuire della disponibilità finanziaria dovuta a fattori esterni e non dominabili (vedi l'indebitamento pubblico) non possa essere più possibile garantire l'apertura al pubblico, o venga meno la produzione di alcuni servizi fondamentali alla fruizione stessa. Gli investimenti effettuati finirebbero per tradursi in uno spreco assai ingente di risorse pubbliche. Val la pena di riflettere sul fatto che anche le politiche di valorizzazione dell'uso dell'ambiente possono rispondere a logiche che sono simili a quelle che hanno condotto in passato all'esplosione della spesa pubblica in Italia. La valorizzazione, infatti, è tutt'altra cosa dalla conservazione, né la seconda presuppone necessariamente la prima. Mentre la conservazione dell'ambiente può rispondere in larga parte a motivazioni di carattere etico non monetizzabili, la valorizzazione deve rispondere anche a criteri di efficienza sul piano sociale e quindi deve in qualche modo tener conto dei costi e dei benefici che ne conseguono. Di più, mentre la conservazione comporta al più un costo opportunità in termini di rinunce a redditi privati immediati, la valorizzazione comporta costi che gravano generalmente sulla collettività. In questo contesto la conoscenza della domanda e quindi dei benefici sociali si rivela una informazione strategica nel momento in cui si debba progettare un intervento. Passando da un'ottica di azione limitata unicamente da vincoli di bilancio, ad un'ottica di programmazione diviene indispensabile ancorare le proprie scelte all'analisi dei costi e dei benefici, avendo del resto bene a mente che anche obiettivi assolutamente plausibili dal punto di vista sociale possono risultare in contrasto tra loro. 21
22 Pare quindi indispensabile che a questo punto dell esperienza nazionale in materia di istituzione di aree protette sia avviata una fase di riflessione sulle modalità di gestione e organizzazione dei parchi sia a livello nazionale che regionale. Il raggiungimento di una percentuale del territorio nazionale sottoposta a tutela prossima al 10% impone sicuramente una maggiore attenzione al problema della gestione e del reperimento delle risorse da utilizzare per la loro gestione e valorizzazione. A fronte di un così esteso patrimonio da tutelare le scarse risorse disponibili devono essere impiegate nel modo più efficiente ed efficace possibile. Seguendo l esempio degli USA sembra necessario che tale revisione nei modi di gestione sia affrontata in modo estremamente pragmatico evitando per quanto possibile inutili ed aprioristici atteggiamenti di tipo conservazionista o, all estremo opposto, di tipo liberista. La revisione dovrà sicuramente operare su due fronti: la modificazione della legislazione esistente; il perseguimento di maggiori capacità di autofinanziamento da parte dei parchi benché il pareggio di bilancio sia da considerare un obiettivo di fatto irraggiungibile per la maggioranza delle aree protette. In particolare per questo secondo punto potrebbe essere opportuno avviare una fase di sperimentazione nei parchi italiani rivolta ad individuare: i principali canali di autofinanziamento; l entità degli importi ottenibili; l impatto sul numero di visitatori; i problemi organizzativi. Sembra altresì auspicabile che quanto prima i parchi avviino forme di monitoraggio del numero dei frequentatori nonché dei costi (economici e ambientali) e dei benefici che ne conseguono. Solo un adeguata conoscenza dei fenomeni potrà consentire l adozione di politiche gestionali efficaci e socialmente accettate. Da ultimo va richiamata la necessità che nuove professionalità siano acquisite negli organismi cui è deputata la gestione delle aree protette. L impianto della legge 394/91 e l attenzione posta alla funzione del parco quale promotore dello sviluppo fa sì che sia sempre più necessario che la gestione dei parchi sia supportata da esperti nel campo del management e del controllo degli 22
23 investimenti. Si va quindi delineando una nuova figura professionale, quella del manager delle aree protette la cui preparazione dovrà essere un tema prioritario nell agenda delle politiche ambientali italiane. Bibliografia Ceballos-Lascurain, H. (1996), Tourism, Ecotourism and Protected Areas, IUCN, Gland, Switzerland. Commission on Protected Areas (WCPA) of IUCN (2000), Financing Protected Areas Guidelines for Protected Area Managers. Financing Protected Areas Task Force of the World in collaboration with the Economics Unit of IUCN Adrian Phillips, Series Editor, Cardiff University. Del Bono F. e Zamagni S. (1997), Microeconomia, Il Mulino, Bologna. Dixon J.A. e Sherman P.B. (1990), Economics of Protected Areas. A New Look at Benefits and Costs, East-West Center, Washington. Fretwell H.P. (1999), Paying to Play: The Fee Demonstration Program, PERC Issue n.ps-17. Giacomini V. (2002), Uomini e parchi, FrancoAngeli, Milano. Marangon F. e Tempesta T. (1998), La gestione economica delle aree protette tra pubblico e privato. Il caso di una zona umida costiera a Marano Lagunare, Forum, Udine. Marangon F. e Massarutto A. (2000), L uso sostenibile delle risorse ambientali e delle aree protette, Forum, Udine. Marangon F. e Tempesta T. (2001), La valutazione dei beni ambientali come supporto alle decisioni pubbliche. Una riflessione alla luce della normativa comunitaria e nazionale, Forum, Udine. Marangon F., Tempesta T. e Visintin F. (2002), La domanda di ecoturismo nell'italia Nord-Orientale, in Genio Rurale Estimo e Territorio, n.5. Rey M. (1984), La gestione dei parchi naturali, in Muraro G. ( a cura di), Criteri di efficienza per le politiche ambientali, Franco Angeli, Milano. 23
F.Marangon - Università di Udine Facoltà di Economia
 Università di Udine Facoltà di Economia in collaborazione con Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UCID) Associazione Etica ed Economia ETICA ED ECONOMIA AMBIENTE VALORE Francesco Marangon Ordinario
Università di Udine Facoltà di Economia in collaborazione con Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UCID) Associazione Etica ed Economia ETICA ED ECONOMIA AMBIENTE VALORE Francesco Marangon Ordinario
L albero nell ambiente urbano
 Consiglio di Quartiere 4 Assessorato all Ambiente Assessorato alla Partecipazione democratica e ai rapporti con i Quartieri In collaborazione con ARSIA L albero nell ambiente urbano Firenze 31 Maggio 1
Consiglio di Quartiere 4 Assessorato all Ambiente Assessorato alla Partecipazione democratica e ai rapporti con i Quartieri In collaborazione con ARSIA L albero nell ambiente urbano Firenze 31 Maggio 1
+ 0,91% ( ) - 6,72% ( ) + 1,85% ( ) Proventi. Raccolta fondi. Risorse investite
 + 1,85% (2014-2013) Proventi + 0,91% (2014-2013) - 6,72% (2014-2013) Risorse investite 3,12% (nel 2014) Ritorno degli investimenti (ROI) 0,24 Rapporto euro spesi/euro raccolti (per raccolta fondi) BILANCIO
+ 1,85% (2014-2013) Proventi + 0,91% (2014-2013) - 6,72% (2014-2013) Risorse investite 3,12% (nel 2014) Ritorno degli investimenti (ROI) 0,24 Rapporto euro spesi/euro raccolti (per raccolta fondi) BILANCIO
Il potenziale turistico per una crescita economica sostenibile dello spazio alpino
 Turismo sostenibile nella green economy alpina Il potenziale turistico per una crescita economica sostenibile dello spazio alpino Cortina d Ampezzo, 26 giugno 2013 Magda Antonioli Corigliano Direttore
Turismo sostenibile nella green economy alpina Il potenziale turistico per una crescita economica sostenibile dello spazio alpino Cortina d Ampezzo, 26 giugno 2013 Magda Antonioli Corigliano Direttore
FORMA.TEMP. - FONDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI TEMPORANEI. L attività nel periodo una prima anticipazione dei dati
 FORMA.TEMP. - FONDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI TEMPORANEI L attività nel periodo 2004-2006 una prima anticipazione dei dati Maggio 2007 Le tipologie formative di FORMA.TEMP La formazione di base:
FORMA.TEMP. - FONDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI TEMPORANEI L attività nel periodo 2004-2006 una prima anticipazione dei dati Maggio 2007 Le tipologie formative di FORMA.TEMP La formazione di base:
Crescita economica, produttività e tenore di vita
 Crescita economica, produttività e tenore di vita Introduzione Negli ultimi due secoli ci sono stati ingenti cambiamenti nel benessere della popolazione i fattori alla base del tenore di vita di una nazione
Crescita economica, produttività e tenore di vita Introduzione Negli ultimi due secoli ci sono stati ingenti cambiamenti nel benessere della popolazione i fattori alla base del tenore di vita di una nazione
1. Collegamenti fra i siti d'interesse presenti nel parco e nelle vicinanze
 1. Collegamenti fra i siti d'interesse presenti nel parco e nelle vicinanze Referente o soggetto esecutore: Enti pubblici, associazioni Turismo, sport e servizi; Innovazione nella gestione delle risorse
1. Collegamenti fra i siti d'interesse presenti nel parco e nelle vicinanze Referente o soggetto esecutore: Enti pubblici, associazioni Turismo, sport e servizi; Innovazione nella gestione delle risorse
La finanza locale. Grafico La composizione delle entrate provinciali. (anno 2006) Entrate derivanti da. accensioni di prestiti 11%
 La finanza locale 1. A partire dall introduzione dell Imposta Comunale sugli Immobili nel 1992, gli Enti Locali sono gradualmente passati da un sistema di finanza derivata ad un sistema basato principalmente
La finanza locale 1. A partire dall introduzione dell Imposta Comunale sugli Immobili nel 1992, gli Enti Locali sono gradualmente passati da un sistema di finanza derivata ad un sistema basato principalmente
ETICA DEI COMPORTAMENTI E UMANIZZAZIONE DELL ASSISTENZA NELLE AZIENDE SANITARIE
 ETICA DEI COMPORTAMENTI E UMANIZZAZIONE DELL ASSISTENZA NELLE AZIENDE SANITARIE SEMINARIO DI ALTA FORMAZIONE L ETICA NELLE PROFESSIONI SANITARIE. ROMA 6 MAGGIO 2013 Elio Borgonovi Università Bocconi UNA
ETICA DEI COMPORTAMENTI E UMANIZZAZIONE DELL ASSISTENZA NELLE AZIENDE SANITARIE SEMINARIO DI ALTA FORMAZIONE L ETICA NELLE PROFESSIONI SANITARIE. ROMA 6 MAGGIO 2013 Elio Borgonovi Università Bocconi UNA
La fattibilità dei progetti
 La fattibilità dei progetti 12.XII.2005 La fattibilità dei progetti La fattibilità di un progetto dipende dalla capacità che quest ultimo ha di determinare condizioni per un effettiva cooperazione fra
La fattibilità dei progetti 12.XII.2005 La fattibilità dei progetti La fattibilità di un progetto dipende dalla capacità che quest ultimo ha di determinare condizioni per un effettiva cooperazione fra
PIANIFICAZIONE E BUDGET
 PIANIFICAZIONE E BUDGET Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale Economia aziendale, bilancio, business plan Anno accademico 2016/2017 Prof. Antonio Staffa Prof. Mario Venezia Analisi della Gestione
PIANIFICAZIONE E BUDGET Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale Economia aziendale, bilancio, business plan Anno accademico 2016/2017 Prof. Antonio Staffa Prof. Mario Venezia Analisi della Gestione
Valutazione economica del progetto Corso del prof. Stefano Stanghellini. Elementi di Analisi Costi benefici
 Valutazione economica del progetto Corso del prof. Stefano Stanghellini Elementi di Analisi Costi benefici Dall Acr all Acb L operatore privato decide la realizzazione o meno di un determinato investimento
Valutazione economica del progetto Corso del prof. Stefano Stanghellini Elementi di Analisi Costi benefici Dall Acr all Acb L operatore privato decide la realizzazione o meno di un determinato investimento
ECONOMIA, SOSTENIBILITÀ E RESILIENZA: VALUTARE LA QUALITÀ DEI SISTEMI LOCALI ALLEGATO: REALIZZARE UN ANALISI SWOT Giulia Pesaro
 n.1 Fondazione Cariplo progetto Capacity building REesilienceLAB http://www.resiliencelab.eu Incontri di formazione Resilienza urbana e territoriale incontri di formazione 1 aprile 2014 APPROCCI E STRUMENTI
n.1 Fondazione Cariplo progetto Capacity building REesilienceLAB http://www.resiliencelab.eu Incontri di formazione Resilienza urbana e territoriale incontri di formazione 1 aprile 2014 APPROCCI E STRUMENTI
Il VALORE : dal mondo economico a quello sanitario: significato e generazione del valore nelle aziende sanitarie
 Il VALORE : dal mondo economico a quello sanitario: significato e generazione del valore nelle aziende sanitarie Agenda Premessa Il VALORE : dal mondo economico a quello sanitario Creazione del valore
Il VALORE : dal mondo economico a quello sanitario: significato e generazione del valore nelle aziende sanitarie Agenda Premessa Il VALORE : dal mondo economico a quello sanitario Creazione del valore
Monaco, 3 aprile 2017
 1 Discours M. Gian Luca Galletti Ministre de l environnement Italien Intervento Monaco Blue Initiative Monaco, 3 aprile 2017 Sua altezza Serenissima, Caro Carmenu Illustri ospiti, buon giorno a tutti.
1 Discours M. Gian Luca Galletti Ministre de l environnement Italien Intervento Monaco Blue Initiative Monaco, 3 aprile 2017 Sua altezza Serenissima, Caro Carmenu Illustri ospiti, buon giorno a tutti.
Interventi per la raccolta nei porti e negli approdi turistici dei rifiuti prodotti sulle unità da diporto.
 Interventi per la raccolta nei porti e negli approdi turistici dei rifiuti prodotti sulle unità da diporto. L A.M.P. Capo Rizzuto istituita con D.M. il 27.12.1991, così come modificato con D.M. del 19.02.2002,
Interventi per la raccolta nei porti e negli approdi turistici dei rifiuti prodotti sulle unità da diporto. L A.M.P. Capo Rizzuto istituita con D.M. il 27.12.1991, così come modificato con D.M. del 19.02.2002,
Riserva Naturale Regionale Orientata Dune di Campomarino. Aspetti normativi
 Riserva Naturale Regionale Orientata Dune di Campomarino Aspetti normativi Il quadro normativo Le Aree Protette Beni paesaggistici Politiche e strumenti di sostegno dell UE Le Direttive CEE Il quadro normativo
Riserva Naturale Regionale Orientata Dune di Campomarino Aspetti normativi Il quadro normativo Le Aree Protette Beni paesaggistici Politiche e strumenti di sostegno dell UE Le Direttive CEE Il quadro normativo
acquisti sostenibili
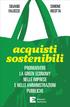 SILVANO FALOCCO SIMONE RICOTTA acquisti sostenibili PROMUOVERE LA GREEN ECONOMY NELLE IMPRESE E NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE prefazione per Acquisti Sostenibili La domanda pubblica di lavori, beni e
SILVANO FALOCCO SIMONE RICOTTA acquisti sostenibili PROMUOVERE LA GREEN ECONOMY NELLE IMPRESE E NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE prefazione per Acquisti Sostenibili La domanda pubblica di lavori, beni e
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOCCI, GINOBLE, GRASSI
 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 602 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BOCCI, GINOBLE, GRASSI Disposizioni per la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 602 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BOCCI, GINOBLE, GRASSI Disposizioni per la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri
LE AREE PROTETTE, LUOGHI DI TURISMO SOSTENIBILE
 LE AREE PROTETTE, LUOGHI DI TURISMO SOSTENIBILE Strategie e opportunità nell Anno internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo 27 Giugno 2017 - Roma Edo Ronchi Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
LE AREE PROTETTE, LUOGHI DI TURISMO SOSTENIBILE Strategie e opportunità nell Anno internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo 27 Giugno 2017 - Roma Edo Ronchi Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
La previdenza complementare: a che punto siamo?
 In Italia rappresenta una risorsa importante: 104 miliardi di euro accumulati, pari al 6,7% del PIL, 536 forme di previdenza complementare esistenti (39 fondi negoziali, 59 fondi aperti, 361 fondi preesistenti,
In Italia rappresenta una risorsa importante: 104 miliardi di euro accumulati, pari al 6,7% del PIL, 536 forme di previdenza complementare esistenti (39 fondi negoziali, 59 fondi aperti, 361 fondi preesistenti,
Isfol-SNV / Area Valutazione Politiche Risorse Umane
 Scheda tecnica per il calcolo del target dell indicatore LLL (I LLL ) al 2013 Premessa In questa scheda si forniscono alcuni suggerimenti per la definizione e/o revisione di un target (regionale o attribuibile
Scheda tecnica per il calcolo del target dell indicatore LLL (I LLL ) al 2013 Premessa In questa scheda si forniscono alcuni suggerimenti per la definizione e/o revisione di un target (regionale o attribuibile
Definizioni 7. Elementi dell iniziativa di APS
 Definizioni 7 Elementi dell iniziativa di APS Iniziativa Ogni azione o operazione di varia natura (politica, programma, misura o progetto) intrapresa dall autorità pubblica. Progetto Insieme di operazioni
Definizioni 7 Elementi dell iniziativa di APS Iniziativa Ogni azione o operazione di varia natura (politica, programma, misura o progetto) intrapresa dall autorità pubblica. Progetto Insieme di operazioni
CARTA EUROPEA PER IL TURISMO SOSTENIBILE
 Forum - 4 incontro CARTA EUROPEA PER IL TURISMO SOSTENIBILE Parco Nazionale dell Aspromonte 26.10.2016 Il percorso di costruzione del Piano Valutazione della situazione attuale Patrimonio naturale, storico
Forum - 4 incontro CARTA EUROPEA PER IL TURISMO SOSTENIBILE Parco Nazionale dell Aspromonte 26.10.2016 Il percorso di costruzione del Piano Valutazione della situazione attuale Patrimonio naturale, storico
Il bilancio di previsione dello Stato: un introduzione. Questo materiale didattico riporta contenuti del sito della Ragioneria Generale dello Stato
 Il bilancio di previsione dello Stato: un introduzione Questo materiale didattico riporta contenuti del sito della Ragioneria Generale dello Stato Natura del bilancio di previsione Rappresenta il principale
Il bilancio di previsione dello Stato: un introduzione Questo materiale didattico riporta contenuti del sito della Ragioneria Generale dello Stato Natura del bilancio di previsione Rappresenta il principale
Definizione, Finalità e Metodo della disciplina
 Definizione, Finalità e Metodo della disciplina Parte Prima: Problemi e Intuizioni (30 ) Parte Seconda: Approfondimenti tecnici (60 ) Parte Terza: Applicazioni e verifica (30 ) Lezione 1: Parte Prima Problemi
Definizione, Finalità e Metodo della disciplina Parte Prima: Problemi e Intuizioni (30 ) Parte Seconda: Approfondimenti tecnici (60 ) Parte Terza: Applicazioni e verifica (30 ) Lezione 1: Parte Prima Problemi
PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA, CAMPIGNA. PIANO del PARCO
 PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA, CAMPIGNA PIANO del PARCO Rapporto Ambientale ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS): rinvii ai contenuti di cui all Allegato VI
PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA, CAMPIGNA PIANO del PARCO Rapporto Ambientale ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS): rinvii ai contenuti di cui all Allegato VI
PROTOCOLLO D INTESA PER LA VALORIZZAZIONE DELL ISOLA PALMARIA MINISTERO DELLA DIFESA REGIONE LIGURIA COMUNE DI PORTO VENERE AGENZIA DEL DEMANIO
 PROTOCOLLO D INTESA PER LA VALORIZZAZIONE DELL ISOLA PALMARIA tra MINISTERO DELLA DIFESA REGIONE LIGURIA COMUNE DI PORTO VENERE AGENZIA DEL DEMANIO PREMESSO CHE - l articolo 307, del decreto legislativo
PROTOCOLLO D INTESA PER LA VALORIZZAZIONE DELL ISOLA PALMARIA tra MINISTERO DELLA DIFESA REGIONE LIGURIA COMUNE DI PORTO VENERE AGENZIA DEL DEMANIO PREMESSO CHE - l articolo 307, del decreto legislativo
Abstract dello Studio a cura di Gianni Moriani e Melania Buset
 STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO ALIMENTARE DELLA VENEZIA ORIENTALE Abstract dello Studio a cura di Gianni Moriani e Melania Buset Lo Studio di fattibilità è frutto dell attività di
STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO ALIMENTARE DELLA VENEZIA ORIENTALE Abstract dello Studio a cura di Gianni Moriani e Melania Buset Lo Studio di fattibilità è frutto dell attività di
Lezione La politica fiscale
 Lezione 26 1 Vediamo in questa lezione gli strumenti a disposizione dei governi per influenzare il sistema economico. In tutti i paesi le spese pubbliche costituiscono una gran parte del PIL del paese,
Lezione 26 1 Vediamo in questa lezione gli strumenti a disposizione dei governi per influenzare il sistema economico. In tutti i paesi le spese pubbliche costituiscono una gran parte del PIL del paese,
CRITICITA DEL SISTEMA DELLE A.M.P. ITALIANE E PROBLEMATICHE DI GESTIONE: IL CASO DELL A.M.P. DI TAVOLARA PUNTA CODA CAVALLO
 CRITICITA DEL SISTEMA DELLE A.M.P. ITALIANE E PROBLEMATICHE DI GESTIONE: IL CASO DELL A.M.P. DI TAVOLARA PUNTA CODA CAVALLO Dr. Augusto Navone Direttore A.M.P. Tavolara Punta Coda Cavallo Le aree marine
CRITICITA DEL SISTEMA DELLE A.M.P. ITALIANE E PROBLEMATICHE DI GESTIONE: IL CASO DELL A.M.P. DI TAVOLARA PUNTA CODA CAVALLO Dr. Augusto Navone Direttore A.M.P. Tavolara Punta Coda Cavallo Le aree marine
Organismo paritetico sulla formazione. La cornice di riferimento: la realizzazione del Piano d Impresa e le linee guida
 Organismo paritetico sulla formazione La cornice di riferimento: la realizzazione del Piano d Impresa e le linee guida Milano, 16 aprile 2009 Agenda Introduzione La cornice di riferimento I nostri principi
Organismo paritetico sulla formazione La cornice di riferimento: la realizzazione del Piano d Impresa e le linee guida Milano, 16 aprile 2009 Agenda Introduzione La cornice di riferimento I nostri principi
Economia del turismo
 Economia del turismo Anno Accademico 2016/2017 Dott. Ivan Etzo Economia del Turismo - Dott. Ivan Etzo 1 SEZIONE 5 Il turismo internazionale ARGOMENTI 5.1 Gli elementi caratteristici del turismo internazionale
Economia del turismo Anno Accademico 2016/2017 Dott. Ivan Etzo Economia del Turismo - Dott. Ivan Etzo 1 SEZIONE 5 Il turismo internazionale ARGOMENTI 5.1 Gli elementi caratteristici del turismo internazionale
MARKETING IN ITALIA CAPITOLO 1 DI CHERUBINI S., EMINENTE G. FRANCOANGELI EDITORE
 MARKETING IN ITALIA CAPITOLO 1 DI CHERUBINI S., EMINENTE G. FRANCOANGELI EDITORE Materiale didattico riservato agli studenti. ISTITUZIONI IMPRESE TECNOLOGIA PERSONE FASI PRODOTTI SERVIZI EVENTI Tipologie
MARKETING IN ITALIA CAPITOLO 1 DI CHERUBINI S., EMINENTE G. FRANCOANGELI EDITORE Materiale didattico riservato agli studenti. ISTITUZIONI IMPRESE TECNOLOGIA PERSONE FASI PRODOTTI SERVIZI EVENTI Tipologie
Capitolo 7 IL TURISMO
 Capitolo 7 IL TURISMO 73 7.1 Quadro generale Il turismo è stato il settore produttivo che in Islanda ha avuto maggior crescita negli ultimi anni arrivando ad essere dopo la pesca il settore che contribuisce
Capitolo 7 IL TURISMO 73 7.1 Quadro generale Il turismo è stato il settore produttivo che in Islanda ha avuto maggior crescita negli ultimi anni arrivando ad essere dopo la pesca il settore che contribuisce
PROTOCOLLO D INTESA TRA. e la. LEGA NAVALE ITALIANA - Sezione Reggio Calabria Sud
 ARPACAL Sezione REGGIO CALABRIA SUD PROTOCOLLO D INTESA TRA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENTE (di seguito denominato A.R.P.A.CAL.) e la LEGA NAVALE ITALIANA - Sezione Reggio Calabria Sud
ARPACAL Sezione REGGIO CALABRIA SUD PROTOCOLLO D INTESA TRA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENTE (di seguito denominato A.R.P.A.CAL.) e la LEGA NAVALE ITALIANA - Sezione Reggio Calabria Sud
ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA DI BENI DI CONSUMO NON ALIMENTARI
 ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA DI BENI DI CONSUMO NON ALIMENTARI Nell attuale scenario di mercato, il terziario si manifesta come il settore
ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA DI BENI DI CONSUMO NON ALIMENTARI Nell attuale scenario di mercato, il terziario si manifesta come il settore
Cooperative e società di capitali: due modi diversi di reagire alla crisi
 Eddi Fontanari *, Carlo Borzaga ** Cooperative e società di capitali: due modi diversi di reagire alla crisi * Euricse, University of Missouri - visiting scholar. ** Università degli Studi di Trento, Euricse.
Eddi Fontanari *, Carlo Borzaga ** Cooperative e società di capitali: due modi diversi di reagire alla crisi * Euricse, University of Missouri - visiting scholar. ** Università degli Studi di Trento, Euricse.
IL CARPOOLING IN ITALIA: ANALISI DELL OFFERTA
 TRASPOL REPORT 2/16 IL CARPOOLING IN ITALIA: ANALISI DELL OFFERTA SINTESI DEI RISULTATI Le pratiche di mobilità innovativa (carsharing, carpooling, mobilità elettrica, etc.) mostrano una sempre maggiore
TRASPOL REPORT 2/16 IL CARPOOLING IN ITALIA: ANALISI DELL OFFERTA SINTESI DEI RISULTATI Le pratiche di mobilità innovativa (carsharing, carpooling, mobilità elettrica, etc.) mostrano una sempre maggiore
LA SPESA PUBBLICA IN SICILIA DAL 1996 AL 2007 SECONDO I CONTI PUBBLICI TERRITORIALI
 on lliine REGIONE SICILIANA Servizio Statistica LA SPESA PUBBLICA IN SICILIA DAL 1996 AL 27 SECONDO I CONTI PUBBLICI TERRITORIALI La Banca Dati Conti Pubblici Territoriali (CPT) è il risultato di un progetto
on lliine REGIONE SICILIANA Servizio Statistica LA SPESA PUBBLICA IN SICILIA DAL 1996 AL 27 SECONDO I CONTI PUBBLICI TERRITORIALI La Banca Dati Conti Pubblici Territoriali (CPT) è il risultato di un progetto
Turismo sostenibile. La mia breve presentazione di oggi. 1. Un richiamo al concetto di sviluppo sostenibile (2)
 Turismo sostenibile Questo sconosciuto! Luca Dalla Libera La mia breve presentazione di oggi 1. Un richiamo al concetto di sviluppo sostenibile (2) 2. Un introduzione al turismo sostenibile (2) 3. Alcune
Turismo sostenibile Questo sconosciuto! Luca Dalla Libera La mia breve presentazione di oggi 1. Un richiamo al concetto di sviluppo sostenibile (2) 2. Un introduzione al turismo sostenibile (2) 3. Alcune
STRUTTURA E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA DELLE IMPRESE INDUSTRIALI E DEI SERVIZI
 27 novembre 2014 Anno 2012 STRUTTURA E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA DELLE IMPRESE INDUSTRIALI E DEI SERVIZI Nel 2012, le imprese attive dell industria e dei servizi di mercato sono 4,4 milioni e occupano
27 novembre 2014 Anno 2012 STRUTTURA E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA DELLE IMPRESE INDUSTRIALI E DEI SERVIZI Nel 2012, le imprese attive dell industria e dei servizi di mercato sono 4,4 milioni e occupano
APPLICAZIONE PILOTA DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE NELLE AREE PROTETTE
 APPLICAZIONE PILOTA DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE NELLE AREE PROTETTE Cosa devono sapere le organizzazioni responsabili di aree protette che vogliono sviluppare un sistema di gestione ambientale per
APPLICAZIONE PILOTA DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE NELLE AREE PROTETTE Cosa devono sapere le organizzazioni responsabili di aree protette che vogliono sviluppare un sistema di gestione ambientale per
PRESENTAZIONE: G. Forestieri. INTRODUZIONE: E. Borgonovi e G. Forestieri...
 PRESENTAZIONE: G. Forestieri INTRODUZIONE: E. Borgonovi e G. Forestieri... P A R T E P RIMA ANALISI DEI PROFILI ISTITUZIONALI, ECONOMICI, ORGANIZZATIVI E GESTIONALI Capitolo 1 I PARCHI NAZIONALI NELL'ANALISI
PRESENTAZIONE: G. Forestieri INTRODUZIONE: E. Borgonovi e G. Forestieri... P A R T E P RIMA ANALISI DEI PROFILI ISTITUZIONALI, ECONOMICI, ORGANIZZATIVI E GESTIONALI Capitolo 1 I PARCHI NAZIONALI NELL'ANALISI
Indagine conoscitiva sul livello di. BENESSERE ORGANIZZATIVO Della CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA Edizione 2016
 Indagine conoscitiva sul livello di BENESSERE ORGANIZZATIVO Della CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA Edizione 2016 a cura dello Staff Sistema Qualità e del Servizio Studi della CCIAA di Verona Indice Introduzione.
Indagine conoscitiva sul livello di BENESSERE ORGANIZZATIVO Della CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA Edizione 2016 a cura dello Staff Sistema Qualità e del Servizio Studi della CCIAA di Verona Indice Introduzione.
PROTOCOLLO D INTESA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. (di seguito Regione)
 PROTOCOLLO D INTESA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (di seguito Regione) e Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l UNESCO (di seguito Comitato Giovani) PER LA COOPERAZIONE TESA ALLA REALIZZAZIONE
PROTOCOLLO D INTESA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (di seguito Regione) e Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l UNESCO (di seguito Comitato Giovani) PER LA COOPERAZIONE TESA ALLA REALIZZAZIONE
Webinar. Una ipotesi di Piano di sviluppo culturale: la segmentazione della domanda dei visitatori
 PON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA 2007-2013 ASSE E - PIANO FORMEZ 2013 Progetto pilota Revisione dei processi e riorganizzazione di una struttura territoriale del ministero dei beni e delle attività culturali
PON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA 2007-2013 ASSE E - PIANO FORMEZ 2013 Progetto pilota Revisione dei processi e riorganizzazione di una struttura territoriale del ministero dei beni e delle attività culturali
Equilibrio finanziario
 I BUDGET FINANZIARI Equilibrio finanziario L equilibrio finanziario consiste nella seguente relazione: ENTRATE = USCITE Con riferimento alla variabile temporale distinguiamo due aspetti dell eq. finanziario:
I BUDGET FINANZIARI Equilibrio finanziario L equilibrio finanziario consiste nella seguente relazione: ENTRATE = USCITE Con riferimento alla variabile temporale distinguiamo due aspetti dell eq. finanziario:
IL PAREGGIO DI BILANCIO COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 164/2016 ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLA CONTABILITA'
 IL PAREGGIO DI BILANCIO COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 164/2016 ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLA CONTABILITA' IL SUPERAMENTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E LE NUOVE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ENTI
IL PAREGGIO DI BILANCIO COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 164/2016 ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLA CONTABILITA' IL SUPERAMENTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E LE NUOVE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ENTI
IL PAREGGIO DI BILANCIO COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 164/2016 ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLA CONTABILITA'
 IL PAREGGIO DI BILANCIO COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 164/2016 ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLA CONTABILITA' IL SUPERAMENTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E LE NUOVE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ENTI
IL PAREGGIO DI BILANCIO COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 164/2016 ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLA CONTABILITA' IL SUPERAMENTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E LE NUOVE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ENTI
Osservazioni sulla valutazione economica relativa alla costruzione di un Ponte sullo Stretto di Messina
 Osservazioni sulla valutazione economica relativa alla costruzione di un Ponte sullo Stretto di Messina Autore: Sabetta Sergio In: Sociologia e Psicologia del diritto Recentemente si è riparlato del ponte
Osservazioni sulla valutazione economica relativa alla costruzione di un Ponte sullo Stretto di Messina Autore: Sabetta Sergio In: Sociologia e Psicologia del diritto Recentemente si è riparlato del ponte
MISSIONE 001: Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri
 CDR 16 Gioventù e Servizio civile nazionale MISSIONE 001: Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri Programma 003: Presidenza del Consiglio dei Ministri MISSIONE
CDR 16 Gioventù e Servizio civile nazionale MISSIONE 001: Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri Programma 003: Presidenza del Consiglio dei Ministri MISSIONE
L indotto di Expo 2015
 Progetto di ricerca per Camera di Commercio Milano ed Expo 2015 S.p.A. L indotto di Expo 2015 Analisi di impatto economico Milano, 20 Dicembre 2013 Alberto Dell Acqua, Senior Professor SDA Bocconi Giacomo
Progetto di ricerca per Camera di Commercio Milano ed Expo 2015 S.p.A. L indotto di Expo 2015 Analisi di impatto economico Milano, 20 Dicembre 2013 Alberto Dell Acqua, Senior Professor SDA Bocconi Giacomo
L zione n 3.2 E tens n ione n e de d l m o m de d llo R dd d i d to-sp S e p sa: il settore pubblico
 Lezione 3.2 Estensione del modello Reddito-Spesa: il settore pubblico Non abbiamo fatto cenno ad una questione fondamentale: l intervento dello Stato influisce o no nella crescita economica di un Paese?
Lezione 3.2 Estensione del modello Reddito-Spesa: il settore pubblico Non abbiamo fatto cenno ad una questione fondamentale: l intervento dello Stato influisce o no nella crescita economica di un Paese?
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca Repubblica Italiana Regione Siciliana
 Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca Repubblica Italiana Regione Siciliana Primo Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media Leonardo Da Vinci Via Concetto Marchesi
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca Repubblica Italiana Regione Siciliana Primo Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media Leonardo Da Vinci Via Concetto Marchesi
Centri di spesa e di ricavo
 CORSO DI «MANAGEMENT DELLE AZIENDE E DEGLI EVENTI TURISTICI» LEZIONE 3 01.03.2017 Corso di LM in Progettazione e Management dei sistemi turistici e culturali Dott. Francesco Badia francesco.badia@uniba.it
CORSO DI «MANAGEMENT DELLE AZIENDE E DEGLI EVENTI TURISTICI» LEZIONE 3 01.03.2017 Corso di LM in Progettazione e Management dei sistemi turistici e culturali Dott. Francesco Badia francesco.badia@uniba.it
Per essere sempre più vicino al cliente: il Customer Interaction Center Canon. Ernesto Bonfanti, Giorgio Di Giovanni, Elena Tosca
 Per essere sempre più vicino al cliente: il Customer Interaction Center Canon Ernesto Bonfanti, Giorgio Di Giovanni, Elena Tosca 1 Uno degli obiettivi che Canon Italia si è posta per affrontare la sfida
Per essere sempre più vicino al cliente: il Customer Interaction Center Canon Ernesto Bonfanti, Giorgio Di Giovanni, Elena Tosca 1 Uno degli obiettivi che Canon Italia si è posta per affrontare la sfida
SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO- ECONOMICA DEL PROGETTO
 SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO- ECONOMICA DEL PROGETTO BANDO per la concessione di contributi a favore delle agenzie formative che concorrono ad assicurare l assolvimento dell obbligo di istruzione nonché
SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO- ECONOMICA DEL PROGETTO BANDO per la concessione di contributi a favore delle agenzie formative che concorrono ad assicurare l assolvimento dell obbligo di istruzione nonché
ISTITUZIONI DI ECONOMIA (a.a ) PROVE D ESAME
 Giuseppe Garofalo Dipartimento di Economia pubblica Facoltà di Economia Università degli studi di Roma La Sapienza ISTITUZIONI DI ECONOMIA (a.a. 1999-2000) PROVE D ESAME Prova intermedia di Macro (4-3-2000)
Giuseppe Garofalo Dipartimento di Economia pubblica Facoltà di Economia Università degli studi di Roma La Sapienza ISTITUZIONI DI ECONOMIA (a.a. 1999-2000) PROVE D ESAME Prova intermedia di Macro (4-3-2000)
CONFERENZA DEL TURISMO ITALIANO GENOVA SETTEMBRE 2004 INTERVENTO DEL MINISTRO ATTUAZIONE PROGRAMMA DI GOVERNO ON.
 CONFERENZA DEL TURISMO ITALIANO GENOVA 20 21 SETTEMBRE 2004 INTERVENTO DEL MINISTRO ATTUAZIONE PROGRAMMA DI GOVERNO ON.LE CLAUDIO SCAJOLA Magazzini del Cotone - Genova Lunedì 20 settembre 2004 ore 9,30
CONFERENZA DEL TURISMO ITALIANO GENOVA 20 21 SETTEMBRE 2004 INTERVENTO DEL MINISTRO ATTUAZIONE PROGRAMMA DI GOVERNO ON.LE CLAUDIO SCAJOLA Magazzini del Cotone - Genova Lunedì 20 settembre 2004 ore 9,30
Osservazioni al piano strutturale dell associazione Reno-Galliera
 ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA Osservazioni al piano strutturale dell associazione Reno-Galliera 1. Presmessa Le presenti osservazioni al P.S.C. dell associazione Reno-Galliera
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA Osservazioni al piano strutturale dell associazione Reno-Galliera 1. Presmessa Le presenti osservazioni al P.S.C. dell associazione Reno-Galliera
La contabilità finanziaria
 La contabilità finanziaria E il sistema contabile principale e fondamentale per i fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione: rileva le obbligazioni attive/passive, gli incassi ed i pagamenti
La contabilità finanziaria E il sistema contabile principale e fondamentale per i fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione: rileva le obbligazioni attive/passive, gli incassi ed i pagamenti
Valutazione economico sociale
 Valutazione Economica del Progetto Corso del prof. Stefano Stanghellini Valutazione economico sociale Contributo didattico: prof. Sergio Copiello Il progetto di Città della Pace Valutazione economico sociale
Valutazione Economica del Progetto Corso del prof. Stefano Stanghellini Valutazione economico sociale Contributo didattico: prof. Sergio Copiello Il progetto di Città della Pace Valutazione economico sociale
sostenibilità ...sostenibilità e strumenti volontari... Agenda 21 locale
 sostenibilità Enti locali, qualità dell ambiente e governo del territorio tra agenda 21 locale e sistemi di certificazione e di registrazione ambientale La gestione sostenibile del territorio nei parchi
sostenibilità Enti locali, qualità dell ambiente e governo del territorio tra agenda 21 locale e sistemi di certificazione e di registrazione ambientale La gestione sostenibile del territorio nei parchi
La Rete Natura 2000 in Liguria. Paola Carnevale Regione Liguria - Settore Progetti e programmi per la tutela e la valorizzazione ambientale
 La Rete Natura 2000 in Liguria Paola Carnevale Regione Liguria - Settore Progetti e programmi per la tutela e la valorizzazione ambientale SIC e Rete Ecologica direttiva habitat - 43/1992/CEE individua
La Rete Natura 2000 in Liguria Paola Carnevale Regione Liguria - Settore Progetti e programmi per la tutela e la valorizzazione ambientale SIC e Rete Ecologica direttiva habitat - 43/1992/CEE individua
PIANO DELLE AZIONI POSITIVE (P.A.P.) PER IL TRIENNIO
 COMUNE DI SUMMONTE Provincia di Avellino PIANO DELLE AZIONI POSITIVE (P.A.P.) PER IL TRIENNIO 2017-2019 ai sensi dell art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
COMUNE DI SUMMONTE Provincia di Avellino PIANO DELLE AZIONI POSITIVE (P.A.P.) PER IL TRIENNIO 2017-2019 ai sensi dell art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
LA GESTIONE DEGLI UNGULATI. Principi generali e problematiche DENTRO E FUORI LE AREE PROTETTE: Andrea Monaco Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi
 LA GESTIONE DEGLI UNGULATI DENTRO E FUORI LE AREE PROTETTE: Principi generali e problematiche Andrea Monaco Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi Premessa La normativa che regola il rapporto tra territorio,
LA GESTIONE DEGLI UNGULATI DENTRO E FUORI LE AREE PROTETTE: Principi generali e problematiche Andrea Monaco Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi Premessa La normativa che regola il rapporto tra territorio,
DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI (5 cfu I semestre) Prof. Monica Cocconi
 DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI (5 cfu I semestre) Prof. Monica Cocconi Il corso di Diritto degli enti locali è diretto a descrivere e fa comprendere la disciplina del modo di essere e di funzionare delle autonomie
DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI (5 cfu I semestre) Prof. Monica Cocconi Il corso di Diritto degli enti locali è diretto a descrivere e fa comprendere la disciplina del modo di essere e di funzionare delle autonomie
La certificazione ambientale come opportunità per una gestione partecipata e in qualità delle aree protette
 Agenda 21 Locale EMAS: qualità, innovazione, partecipazione per un futuro sostenibile La certificazione ambientale come opportunità per una gestione partecipata e in qualità delle aree protette Lucia Naviglio,
Agenda 21 Locale EMAS: qualità, innovazione, partecipazione per un futuro sostenibile La certificazione ambientale come opportunità per una gestione partecipata e in qualità delle aree protette Lucia Naviglio,
Milano, 23 aprile 2009
 Milano, 23 aprile 2009 Il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po via Garibaldi, 75-43100 Parma - tel. 0521 2761 www.adbpo.it - partecipo@adbpo.it Piano distrettuale di gestione delle
Milano, 23 aprile 2009 Il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po via Garibaldi, 75-43100 Parma - tel. 0521 2761 www.adbpo.it - partecipo@adbpo.it Piano distrettuale di gestione delle
SVIMEZ. Roma, 14 marzo 2016. 1. Le analisi della SVIMEZ (cenni)
 Roma, 14 marzo 2016 SVIMEZ Note al ddl Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali 1. Le analisi della SVIMEZ
Roma, 14 marzo 2016 SVIMEZ Note al ddl Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali 1. Le analisi della SVIMEZ
La Rete Natura 2000 in Sicilia: tra tutela e sviluppo PALERMO, 28 NOVEMBRE 2007
 La Rete Natura 2000 in Sicilia: tra tutela e sviluppo PALERMO, 28 NOVEMBRE 2007 La Rete Natura 2000 nel nuovo ciclo di programmazione 2007-2013: quali opportunità? Il Programma Operativo FESR dott.ssa
La Rete Natura 2000 in Sicilia: tra tutela e sviluppo PALERMO, 28 NOVEMBRE 2007 La Rete Natura 2000 nel nuovo ciclo di programmazione 2007-2013: quali opportunità? Il Programma Operativo FESR dott.ssa
Carta di Ottawa per la promozione della salute
 Carta di Ottawa per la promozione della salute 1 Conferenza Internazionale sulla Promozione della Salute del 1986 per stimolare l azione l a favore della Salute per Tutti per l anno l 2000 e oltre Promozione
Carta di Ottawa per la promozione della salute 1 Conferenza Internazionale sulla Promozione della Salute del 1986 per stimolare l azione l a favore della Salute per Tutti per l anno l 2000 e oltre Promozione
Le conseguenze della crisi per le famiglie e le imprese
 Le conseguenze della crisi per le famiglie e le imprese Di Monica Montella, Franco Mostacci In assenza di una politica fiscale comune, e privi di sovranità sulla loro politica monetaria e del cambio, gli
Le conseguenze della crisi per le famiglie e le imprese Di Monica Montella, Franco Mostacci In assenza di una politica fiscale comune, e privi di sovranità sulla loro politica monetaria e del cambio, gli
Il controllo economico e il ruolo del budget: aspetti organizzativi
 Capitolo 11 Il controllo economico e il ruolo del budget: aspetti organizzativi di Laura Zoni Il controllo economico e il ruolo del budget: aspetti organizzativi (Cap. 11) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Comprendere
Capitolo 11 Il controllo economico e il ruolo del budget: aspetti organizzativi di Laura Zoni Il controllo economico e il ruolo del budget: aspetti organizzativi (Cap. 11) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Comprendere
Piano di Miglioramento Prime indicazione in ordine agli effetti sulla spesa degli enti del sistema pubblico provinciale
 Piano di Miglioramento Prime indicazione in ordine agli effetti sulla spesa degli enti del sistema pubblico provinciale Provincia Autonoma di Trento Trento, luglio 2012 Piano di miglioramento 2 Deloitte
Piano di Miglioramento Prime indicazione in ordine agli effetti sulla spesa degli enti del sistema pubblico provinciale Provincia Autonoma di Trento Trento, luglio 2012 Piano di miglioramento 2 Deloitte
Le graduatorie basate su una molteplicità di indicatori. I pericoli della sintesi di variabili disomogenee.
 Le graduatorie basate su una molteplicità di indicatori. I pericoli della sintesi di variabili disomogenee. Sovente è necessario stabilire delle graduatorie tra unità statistiche. In azienda il problema
Le graduatorie basate su una molteplicità di indicatori. I pericoli della sintesi di variabili disomogenee. Sovente è necessario stabilire delle graduatorie tra unità statistiche. In azienda il problema
Giustificazione dell intervento pubblico
 Giustificazione dell intervento pubblico Giustificazione dell intervento pubblico Oggetto: Analizzare i contributi della teoria economica per spiegare gli interventi pubblici a livello microeconomico Giustificazione
Giustificazione dell intervento pubblico Giustificazione dell intervento pubblico Oggetto: Analizzare i contributi della teoria economica per spiegare gli interventi pubblici a livello microeconomico Giustificazione
GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E IL CONCETTO DI SALUTE
 GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E IL CONCETTO DI SALUTE Il concetto di salute OMS 1946: "la salute non è semplicemente l'assenza di malattia, ma uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale 5
GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E IL CONCETTO DI SALUTE Il concetto di salute OMS 1946: "la salute non è semplicemente l'assenza di malattia, ma uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale 5
La certificazione forestale. Un valore aggiunto per la materia prima sughero. Agostino Pintus, Pino Angelo Ruiu. Stazione Sperimentale del Sughero
 La certificazione forestale. Un valore aggiunto per la materia prima sughero Agostino Pintus, Pino Angelo Ruiu Stazione Sperimentale del Sughero Alla ricerca della qualità nella filiera sughero-vino. Oristano
La certificazione forestale. Un valore aggiunto per la materia prima sughero Agostino Pintus, Pino Angelo Ruiu Stazione Sperimentale del Sughero Alla ricerca della qualità nella filiera sughero-vino. Oristano
Il modello agricolo europeo per una agricoltura sostenibile
 Il modello agricolo europeo per una agricoltura sostenibile Andrea Arzeni Associazione Alessandro Bartola Sommario La politica ambientale comunitaria La politica agricola comune Il modello agricolo europeo
Il modello agricolo europeo per una agricoltura sostenibile Andrea Arzeni Associazione Alessandro Bartola Sommario La politica ambientale comunitaria La politica agricola comune Il modello agricolo europeo
Le associazioni sportive
 Il bilancio (o rendiconto) nelle ASD Relativamente agli enti non commerciali (tra cui le ASD), il termine «bilancio» può assumere due significati. BILANCIO ECONOMICO - FINANZIARIO documento, di fatto,
Il bilancio (o rendiconto) nelle ASD Relativamente agli enti non commerciali (tra cui le ASD), il termine «bilancio» può assumere due significati. BILANCIO ECONOMICO - FINANZIARIO documento, di fatto,
INNOVAZIONE, R&S E STRUTTURA DI MERCATO
 INNOVAZIONE, R&S E STRUTTURA DI MERCATO ECONOMIA INDUSTRIALE Università LIUC Christian Garavaglia - Maggio 2004 Finora il corso ha analizzato modelli di concorrenza che assumevano che la struttura dei
INNOVAZIONE, R&S E STRUTTURA DI MERCATO ECONOMIA INDUSTRIALE Università LIUC Christian Garavaglia - Maggio 2004 Finora il corso ha analizzato modelli di concorrenza che assumevano che la struttura dei
Biomasse agroforestali nel conto termico: opportunità per il settore primario
 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Biomasse agroforestali nel conto termico: opportunità per il settore primario Roberto Murano Verona 8 febbraio 2013 Il Decreto 28 dicembre 2012,
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Biomasse agroforestali nel conto termico: opportunità per il settore primario Roberto Murano Verona 8 febbraio 2013 Il Decreto 28 dicembre 2012,
IL BILANCIO D ESERCIZIO
 IL BILANCIO D ESERCIZIO funzione,analisi equilibri e attestazioni 1 L AZIENDA COME SISTEMA DI RISCHI LA GESTIONE AZIENDALE: - si svolge in un contesto di incessante cambiamento in presenza di RISCHI (esterni
IL BILANCIO D ESERCIZIO funzione,analisi equilibri e attestazioni 1 L AZIENDA COME SISTEMA DI RISCHI LA GESTIONE AZIENDALE: - si svolge in un contesto di incessante cambiamento in presenza di RISCHI (esterni
Gli investimenti, il tempo e il mercato dei capitali
 Capitolo 15 Gli investimenti, il tempo e il mercato dei capitali A.A. 2010-2011 Microeconomia - Cap. 15-1 Argomenti Stock e flussi (par. 15.1) Il valore attuale scontato (par. 15.2) Il valore di un obbligazione
Capitolo 15 Gli investimenti, il tempo e il mercato dei capitali A.A. 2010-2011 Microeconomia - Cap. 15-1 Argomenti Stock e flussi (par. 15.1) Il valore attuale scontato (par. 15.2) Il valore di un obbligazione
Azienda può essere vista come: - ORGANIZZAZIONE ECONOMICA - SISTEMA SOCIALE - STRUTTURA PATRIMONIALE
 Fini aziendali Azienda può essere vista come: - ORGANIZZAZIONE ECONOMICA - SISTEMA SOCIALE - STRUTTURA PATRIMONIALE ORGANIZZAZIONE ECONOMICA Scopo: il soddisfacimento dei bisogni umani attraverso l utilizzo
Fini aziendali Azienda può essere vista come: - ORGANIZZAZIONE ECONOMICA - SISTEMA SOCIALE - STRUTTURA PATRIMONIALE ORGANIZZAZIONE ECONOMICA Scopo: il soddisfacimento dei bisogni umani attraverso l utilizzo
Scheda PASL Azioni di valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali
 Scheda PASL 1.2.3.1 - Azioni di valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali ASSE STRATEGICO DI INTERVENTO DEL PROTOCOLLO D INTESA Asse 1 Sistema delle imprese, dell'innovazione e dei beni culturali;
Scheda PASL 1.2.3.1 - Azioni di valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali ASSE STRATEGICO DI INTERVENTO DEL PROTOCOLLO D INTESA Asse 1 Sistema delle imprese, dell'innovazione e dei beni culturali;
I criteri di valutazione:
 I criteri di valutazione: il VAN e il TIR 06.04.2016 La fattibilità economica del progetto La valutazione di fattibilità consiste nella verifica della convenienza economica del developer a promuovere l
I criteri di valutazione: il VAN e il TIR 06.04.2016 La fattibilità economica del progetto La valutazione di fattibilità consiste nella verifica della convenienza economica del developer a promuovere l
Il contesto PROGETTO AALBORG 10 PRESUD CARTA DELLA TERRA
 Venezia, 14.11.2014 L Accordo Comune di Venezia-MATTM per lo sviluppo di interventi di efficienza energetica e l utilizzo di fonti di energia rinnovabile: un opportunità di sviluppo per Venezia Il contesto
Venezia, 14.11.2014 L Accordo Comune di Venezia-MATTM per lo sviluppo di interventi di efficienza energetica e l utilizzo di fonti di energia rinnovabile: un opportunità di sviluppo per Venezia Il contesto
I principi generali del bilancio di esercizio civilistico
 I principi generali del bilancio di esercizio civilistico 1 IL BILANCIO DI ESERCIZIO: clausole generali, principi di redazione e criteri di valutazione CLAUSOLE GENERALI PRINCIPI DI REDAZIONE CRITERI DI
I principi generali del bilancio di esercizio civilistico 1 IL BILANCIO DI ESERCIZIO: clausole generali, principi di redazione e criteri di valutazione CLAUSOLE GENERALI PRINCIPI DI REDAZIONE CRITERI DI
1. Come si vive e lavora in Umbria: il posizionamento della regione nell ultimo decennio
 Estratto dal capitolo 1 della Relazione sullo stato di attuazione del programma di governo e sull amministrazione regionale RESOCONTO DI LEGISLATURA (Pubblicata nel S.S. del B.U.R. n. 10 del3 marzo 2010)
Estratto dal capitolo 1 della Relazione sullo stato di attuazione del programma di governo e sull amministrazione regionale RESOCONTO DI LEGISLATURA (Pubblicata nel S.S. del B.U.R. n. 10 del3 marzo 2010)
Nozione di patrimonio
 Nozione di patrimonio In prima approssimazione possiamo definire il patrimonio aziendale come un insieme coordinato di risorse finalizzate allo svolgimento di un attività economica di creazione di valore.
Nozione di patrimonio In prima approssimazione possiamo definire il patrimonio aziendale come un insieme coordinato di risorse finalizzate allo svolgimento di un attività economica di creazione di valore.
LA DIRETTIVA QUADRO ACQUE 2000/60/CE
 Valutazione dei costi ambientali e della risorsa - GIORNATA di STUDIO Roma, 16 aprile 2015 - Sala Auditorium - Via C. Colombo, 44 00154 Roma LA DIRETTIVA QUADRO ACQUE 2000/60/CE Giuseppe Blasi CONDIZIONALITA
Valutazione dei costi ambientali e della risorsa - GIORNATA di STUDIO Roma, 16 aprile 2015 - Sala Auditorium - Via C. Colombo, 44 00154 Roma LA DIRETTIVA QUADRO ACQUE 2000/60/CE Giuseppe Blasi CONDIZIONALITA
Cosa determina l inflazione? Quali costi comporta per la società?
 L INFLAZIONE E molto variabile: da periodo a periodo (negli anni 90 e inizi 2000 in Gran Bretagna è stata di circa il 2% all anno, a metà degli anni 70, misurata sull indice dei prezzi al dettaglio, è
L INFLAZIONE E molto variabile: da periodo a periodo (negli anni 90 e inizi 2000 in Gran Bretagna è stata di circa il 2% all anno, a metà degli anni 70, misurata sull indice dei prezzi al dettaglio, è
premesso che Coldiretti Lipu Coldiretti Lipu
 Coldiretti & Lipu premesso che Coldiretti è una forza sociale che rappresenta le imprese agricole e valorizza l agricoltura come risorsa economica, umana ed ambientale Lipu è un Associazione che opera
Coldiretti & Lipu premesso che Coldiretti è una forza sociale che rappresenta le imprese agricole e valorizza l agricoltura come risorsa economica, umana ed ambientale Lipu è un Associazione che opera
Primo trimestre 2014 numero 2/ dicembre 2014
 Il primo trimestre del 2014 1 IN SINTESI E cresciuto il credito agrario di medio-lungo termine in Veneto nei primi tre mesi del 2014. Rispetto al primo trimestre del 2013, in termini assoluti, le somme
Il primo trimestre del 2014 1 IN SINTESI E cresciuto il credito agrario di medio-lungo termine in Veneto nei primi tre mesi del 2014. Rispetto al primo trimestre del 2013, in termini assoluti, le somme
SVILUPPO DI UN NUOVO PRODOTTO IL CASO CTI
 SVILUPPO DI UN NUOVO PRODOTTO IL CASO CTI Informazioni preliminari La CTI è una società del settore tessile che sta valutando l opportunità di introdurre un nuovo prodotto di alta gamma (Lux). L idea di
SVILUPPO DI UN NUOVO PRODOTTO IL CASO CTI Informazioni preliminari La CTI è una società del settore tessile che sta valutando l opportunità di introdurre un nuovo prodotto di alta gamma (Lux). L idea di
Stato di avanzamento del programma al 31 marzo 2005 e Previsioni di spesa al 31 dicembre 2005
 REGIONE DELL UMBRIA GIUNTA REGIONALE Area programmazione strategica e socio-economica Servizio 2 - Programmazione strategica e comunitaria DOCUP Ob. 2 (2000-2006) Comitato di Sorveglianza del 9-10 giugno
REGIONE DELL UMBRIA GIUNTA REGIONALE Area programmazione strategica e socio-economica Servizio 2 - Programmazione strategica e comunitaria DOCUP Ob. 2 (2000-2006) Comitato di Sorveglianza del 9-10 giugno
Una prospettiva innovativa sul lavoro
 La vocazione professionale in Poste Italiane Una prospettiva innovativa sul lavoro novembre 2008 Premessa Nell incontro del 20 maggio 2008 l Osservatorio sulla Responsabilità Sociale d Impresa ha iniziato
La vocazione professionale in Poste Italiane Una prospettiva innovativa sul lavoro novembre 2008 Premessa Nell incontro del 20 maggio 2008 l Osservatorio sulla Responsabilità Sociale d Impresa ha iniziato
