Nuovi modelli di comunicazione nella ricerca scientifica e tecnologica europea
|
|
|
- Ambra Salvatori
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI DIPARTIMENTO DI GENETICA "CHARLES DARWIN" UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LA SAPIENZA DI ROMA MASTER DI I LIVELLO "LE SCIENZE DELLA VITA NEL GIORNALISMO E NEI RAPPORTI POLITICO- ISTITUZIONALI" Nuovi modelli di comunicazione nella ricerca scientifica e tecnologica europea Candidato Dott. Matteo Di Rosa Relatore Dott. Nicola Bergonzi Correlatore Dott.ssa Mara Gualandi anno accademico
2 Sommario Introduzione... 4 CAP. I - L importanza della comunicazione Legittimarsi per sopravvivere Finanziare la ricerca Espandersi...10 CAP. II - La comunicazione nel Settimo Programma Quadro di ricerca e sviluppo della UE Importanza della disseminazione dei risultati...14 CAP. III - Modelli di comunicazione adottata Identificare l obiettivo Definire il messaggio Identificare l interlocutore Scegliere il mezzo di comunicazione Televisione Radio Carta Stampata Attività di Public Relations Internet...25 CAP. IV - Modelli di comunicazione scientifica Nuovi modelli di comunicazione scientifica La rivoluzione del web Parallelismo comunicazione scienza e web Blog Network di Blog Wikipedia
3 6. Social network LinkedIN Twitter Facebook Altri social network Social network specifici...58 Conclusioni...59 Bibliografia
4 Introduzione Calibrando la propria attività di comunicazione sul proprio lavoro e sulla comunità scientifica lo scienziato agisce (con più o meno coscienza) al fine di perseguire due principali obiettivi. Il primo è quello dell autopromozione. Lo scienziato vive costantemente per la propria ricerca e, per questo, è possibile che voglia che la propria attività sia generalmente conosciuta e riconosciuta dagli altri in modo tale da ricevere il loro plauso. Il secondo è quello della promozione delle proprie scoperte. Lo scienziato può volere che la propria ricerca sia diffusa il più largamente possibile, a prescindere dall ottenimento dei diritti sulla sua proprietà intellettuale. Internet offre agli scienziati una serie di canali di comunicazione attraverso cui perseguire questi obiettivi: blog, social network, wiki, forum, newsletter ecc Non tutti i canali, però, sono capaci di garantire il raggiungimento di tali obiettivi allo stesso modo, indifferentemente. Ogni canale è dotato di una serie molto personalizzata di caratteristiche che lo collocano su piani diversi rispetto agli scopi dei ricercatori e la scommessa è di selezionare il set di strumenti più funzionale al raggiungimento dell obiettivo che il ricercatore vuole e deve raggiungere. I canali di comunicazione 4
5 disponibili su internet possono dunque essere utilizzati in modo strategico: selezionati, integrati e perché no eliminati e modificati in conformità a quello che il ricercatore vuole fare delle proprie scoperte e della comunicazione scientifica in generale. 5
6 CAP. I - L importanza della comunicazione. Per un ricercatore comunicare costantemente con il pubblico ha il vantaggio soprattutto di essere visibile al di là della ristretta cerchia degli addetti ai lavori. (Amedeo Balbi Ricercatore e blogger) Nell ambito del rapporto tra Scienza e Società, la comunicazione pubblica della scienza ha un importante funzione strategica. Un ricercatore o un gruppo di ricerca che svolge una costante attività di comunicazione scientifica ha la possibilità di aprire nuovi e importanti scenari, già solo rendendo pubblici il risultato della propria ricerca, il progresso di quest ultima e il campo di studi nel quale lavora. In altre parole, attraverso un attenta strategia di comunicazione scientifica un ricercatore può creare i presupposti per legittimarsi e guadagnare consenso al fine di: Figura 1 Concetto tratto e adattato da Farsi Capire di Annamaria Testa - Rizzoli, Legittimarsi per sopravvivere Un primo aspetto da tenere in considerazione è come, sia la comunicazione pubblica della scienza 6
7 che la disseminazione dei risultati raggiunti in questo campo, possano aiutare i ricercatori a legittimare le proprie ricerche, al fine di poterle difendere da eventuali attacchi esterni. Se vuole guadagnare consenso presso l opinione pubblica, quindi, lo scienziato è costretto ad uscire dal chiuso della sua torre d avorio per comunicare al cittadino le proprie attività, l importanza della propria ricerca e le ricadute che questa può avere nella vita di tutti i giorni. Per comprendere come la comunicazione scientifica possa aiutare un ricercatore a legittimarsi per sopravvivere, possiamo analizzare le grandi discussioni nate intorno a quelle tematiche di studio che avendo un grande impatto sulla società attuale (OGM, cellule staminali, nucleare, ecc ) e scatenato fronti di protesta e per questo sono messe costantemente i discussione da referendum, interrogazioni parlamentari o azioni di lobby. Spesso, i movimenti di protesta sono mossi da fini politici: altre volte, invece, sono guidati da associazioni di categoria o da ideologie nate spontaneamente; tutte però, per creare consensi, fanno leva sullo scarso background informativo che una buona parte della popolazione ha su certi temi e su certe ricerche. D altronde, la capacità di questi gruppi di protesta di forviare parte della popolazione e portarla sotto il vessillo della propria causa è direttamente proporzionale alla lacuna conoscitiva dei cittadini su quello specifico studio. Un esempio evidente di questa teoria è rappresentato dalla formazione di un fronte 7
8 compatto di protesta che denunciava la formazione di buchi neri e la conseguente fine del mondo 1 dovuta all inaugurazione dell Large Handron Collider (LHC). Walter Wagner e Luis Sancho (i massimi esponenti del fronte di protesta) arrivarono addirittura nel marzo 2008 a citare in giudizio presso una corte delle Hawaii il CERN, il Fermilab di Chicago e il Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti (che avevano partecipato alla costruzione dell'acceleratore), nel tentativo di impedire l'entrata in funzione del LHC. L insieme di questi eventi costrinse il CERN a pubblicare un report sulla valutazione dei rischi 2 e ad avviare una massiccia campagna di comunicazione per invitare i cittadini a restare calmi, spiegando il funzionamento dell LHC, l importanza della sua esistenza e le ricadute sociali e scientifiche di tale ricerca. La strategia adottata dalla CERN, infine, risultò vincente: comunicatori della struttura svizzera riuscirono, infatti a sfaldare il fronte degli oppositori. Il maggior sforzo comunicativo fu espresso per colmare la lacuna conoscitiva dei cittadini, su cui facevano leva gli oppositori per convincere la popolazione della validità delle proprie idee. In pratica, tutte le attività comunicative svolte dal CERN riuscirono in breve tempo a trasformare il singolo cittadino da partecipante passivo alla controversia in partecipante attivo. Liberato, infatti, 1 Per maggiori dettagli consultare evaluation- forum.org/ oppure 2 Ellis J, Giudice G, Mangano ML, Tkachev I, Wiedemann U (LHC Safety Assessment Group) (20 June 2008). Review of the Safety of LHC Collisions. CERN record. arxiv:
9 dal giogo del gruppo di protesta, ciascun individuo fu in condizione di poter compiere una scelta consapevole e quindi scegliere da quale parte schierarsi. 2. Finanziare la ricerca Lo scienziato non deve solo difendersi dagli attacchi dei gruppi di opposizione ma, per salvaguardare la proprie ricerche, deve anche fornire ad esse un adeguato sostegno finanziario e tecnologico. Catalizzando sui propri studi l attenzione di governi nazionali, autorità locali e investitori privati lo scopo dell attività di comunicazione, in questo caso, è di creare una serie di potenziali partnership capaci di garantire un continuo flusso di risorse verso il proprio progetto di ricerca. Sviluppare una strategia comunicativa vincente consente di creare i giusti ponti fra i vari protagonisti del sistema tecno- scienza (ricercatori, politici, cittadini e imprenditori). A ciascun ponte corrisponde un interlocutore differente e di conseguenza anche i canali comunicativi, adottati dal ricercatore per le diverse interazioni, saranno modulati al fine di costruire un terreno comune dove possano esistere specifiche complementarietà e potenziali sinergie. Un caso significativo è rappresentato dal ricercatore John Craig Venter, capace di coniugare caratteristiche, fino a pochi anni fa, decisamente rare in uno scienziato: non lavora per l università ne per l industria ne per un ente governativo; riesce a vivere a cavallo tra due mondi, quello accademico, 9
10 in cui la notorietà si costruisce attraverso le pubblicazioni e quello industriale, in cui si devono rispettare le regole di mercato; si sente perfettamente a suo agio sotto i riflettori dei media. Grazie a queste caratteristiche Venter è dipinto quasi come l incarnazione del sogno americano 3 : un ricercatore capace di scegliere le proprie ricerche, trovare i finanziamenti per svilupparle e a risultati raggiunti cercare di trarne profitto Espandersi Nell ambito del rapporto tra scienza e società un altro aspetto da tenere in considerazione è l espansione del gruppo di ricerca. Questo processo può avvenire in due modi. Il primo modo prevede il potenziamento della struttura di ricerca e l assunzione di nuovo personale a seguito di nuove risorse finanziare a cui si può attingere. Il secondo modo per garantire l espansione del gruppo di ricerca passa, invece, attraverso l apertura all esterno del gruppo di lavoro. In questo caso la comunicazione pubblica della scienza può aiutare perché riesce ad informare gli altri ricercatori delle sue attività di ricerca, creando sinergie e network 3 Y.Castelfranchi N.Pitrelli, Come si comunica la scienza?, Editori La Terza, Roma Bari, Famoso è il caso della Celera Genomics, l'azienda statunitense fondata nel 1998 da Craig Venter, con lo scopo di sequenziare il genoma umano prima del Progetto Genoma Umano, per poter vendere successivamente i dati acquisiti. 10
11 lavorativi altrimenti difficilmente instaurabili. Le barriere che delimitano ambiti disciplinari differenti e la velocità con cui il progresso tecnologico e scientifico li distanzia spesso non permette ai ricercatori di interessarsi oltre la propria nicchia di sapere. 11
12 CAP. II - La comunicazione nel Settimo Programma Quadro di ricerca e sviluppo della UE Comunicare costantemente quello che faccio con il pubblico mi ha permesso di far conoscere il mio lavoro didattico e di essere contattata per richieste di consulenza didattica e collaborazioni importanti. Scientificando, inoltre, è stato selezionato dal progetto scientifico europeo STELLA per rappresentare, insieme ad altri tre progetti scientifici, le buone pratiche scientifiche italiane in Europa. Annarita Ruberto (Insegnante e Blogger) La scienza e la tecnologia rivestono un ruolo chiave in una società e un economia basata sulla conoscenza (la knowledge based economy teorizzata dal Consiglio di Lisbona). Di conseguenza, la disseminazione dei risultati scientifici e tecnologici e la partecipazione dell opinione pubblica in questo processo costituiscono parte integrante e preponderante dello sviluppo sociale. A tal riguardo, anche la Commissione Europea, nell ambito del Settimo Programma Quadro (7PQ), si è mostrata particolarmente sensibile. Come si evince dal Seventh Framework Programme (FP7) grant agreement - clauses relevant to communication, infatti, il partenariato di ricerca è chiamato, durante l intera durata del progetto, ad avviare una serie d iniziative per comunicare al pubblico e ai media i risultati work in progress e le finalità della propria ricerca. 12
13 Per comprendere appieno l importanza che la Commissione Europea attribuisce alla comunicazione scientifica si deve però partire da più lontano. Nell ambito del Settimo Programma Quadro, infatti, tutte le proposte presentate sono valutate da una giuria di valutatori indipendenti, che sono specialisti riconosciuti del campo pertinente. Il ruolo del panel è confrontare la proposta con una serie di criteri per verificare se la qualità della ricerca proposta merita di essere finanziata. Tra questi criteri, oltre all eccellenza scientifica del progetto e all efficienza della gestione del finanziamento comunitario ricevuto dal consorzio (il Management), si considera anche l Impatto (i benefici socio economici a lungo termine per tutta l Europa e la diffusione e lo sfruttamento risultati) della proposta, all interno del quale è prevista la verifica di tutte le attività predisposte per la disseminazione dei risultati. L enfasi della Commissione Europea è tutta in questa direzione: il Settimo Programma Quadro non finanzia solamente attività di ricerca scientifica, ma progetti multidisciplinari in grado di coinvolgere e raggiungere un ampio strato di addetti ai lavori (sia del mondo accademico sia del mondo imprenditoriale privato), portatori d interessi particolari (gli stakeholders), policy makers e i cittadini europei. L importanza della diffusione e dello sfruttamento dei risultati dei progetti di ricera scientifica è tale che la Commissione Europea rimborasa questa 13
14 tipologia di costi fino al 100% dei costi derivati da tutte le attività di disseminazione. E per tanto normale che i progetti europei attivino un sito web sin dall inizio della propria attività, che partecipino a fiere e congressi nel settore di riferimento, pubblichino poster e brochure e altro materiale pubblicitario e, a conclusione dell attività di ricerca, presentino i propri risultati in un evento pubblico destinato a coinvolgere un ampio numero di utenti interessati all argomento. Condividere la conoscenza, diffondere i risultati ma anche spiegare al pubblico il fine di della ricerca, in conclusione, ha lo scopo di regolare il rapporto fra i ricercatori che sfruttano le risorse pubbliche per produrre conoscenza e i cittadini che invece, pagando le tasse, le sovvenzionano. 1. Importanza della disseminazione dei risultati La comunicazione fra scienza e società ha il ruolo fondamentale di informare l opinione pubblica circa gli aspetti del mondo della ricerca. Nello stesso tempo, permette alla scienza di misurare com è percepita nella società e quali sono le aspettative a cui deve rispondere. In quest ottica, i partenariati di ricerca nell ambito delle attività sovvenzionate dal 7PQ hanno il compito di realizzare una serie di 14
15 iniziative basate sugli stessi principi: condivisione della conoscenza, educazione e trasparenza 5. Solo attraverso il superamento del vecchio modello di comunicazione, basato sul flusso unidirezionale dell informazione e lo sviluppo di un flusso bidirezionale è possibile una condivisione reale dell informazione. L obiettivo principale di queste iniziative è creare una compenetrazione fra scienza e società, per la realizzazione di un terreno comune dove il dialogo e l interazione siano i veri protagonisti 6. Il primo passo in questo scambio di conoscenze va fatto dai ricercatori che, dopo aver sfruttato le risorse pubbliche per creare conoscenza, hanno il dovere morale di condividere le nuove competenze scientifiche acquisite. La disseminazione dei risultati è quasi il biglietto da visita (o se vogliamo il pretesto) con cui il mondo della ricerca può affacciarsi sulla società per iniziare un dialogo. Questo processo d interazione porta alla piena democratizzazione del sapere e della conoscenza e, allo stesso tempo, consente agli scienziati di legittimare le proprie ricerche presso l opinione pubblica grazie alla comunicazione dei risultati scientifici raggiunti. Si ha, quindi, la piena democratizzazione del sapere e della conoscenza e nello stesso tempo, grazie ai 5 European Research - A guide to successful communication - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities p. 5 6 Nel 1985 il Rapporto Bodmer aveva associate la «responsabilità professionale di ogni scienziato» alla «promozione della comprensione pubblica della scienza». Nel 2000, la House of Lords aveva invece affermato che la parola chiave era «dialogo» e che stava emergendo «una nuova umiltà da parte della scienza nei confronti degli atteggiamenti pubblici, e una nuova assertività da parte del pubblico» - Tratto da Y.Castelfranchi N.Pitrelli, Come si comunica la scienza?, Editori La Terza, Roma Bari, 2007 pp115 15
16 risultati scientifici raggiunti, gli scienziati hanno la possibilità di legittimare le propria ricerche presso l opinione pubblica. La società, dal canto suo, può godere delle nuove competenze acquisite, aumentare il proprio grado di alfabetizzazione scientifica e, in alcuni casi, anche il proprio stile di vita. Le attività avviate dal partenariato nell ambito delle ricerche sovvenzionate dal Settimo Programma Quadro devono saper coniugare, quindi, l aspetto educativo con quello informativo, e nello stesso tempo, essere orientati verso la public relation, per favorire un upstream engagement, in altre parole una partecipazione dal basso del pubblico. L attenzione della Comunità Europea non è concentrata, però, solo sulla comunicazione pubblica della scienza ma anche sulla comunicazione interna a tutti i membri della ricerca. I partenariati, infatti, devono dare alla Commissione Europea una prova tangibile che mostri non solo che la collaborazione tra i ricercatori esiste, ma che paga anche in termini di eccellenze accademiche, competitività industriale, sviluppo delle opportunità, miglioramenti ambientali e aumento della qualità della vita 7. Una buona comunicazione fra ricercatori permette di poggiare su basi solide l interdisciplinarietà del progetto di ricerca. In pratica, aiuta a superare le barriere poste tra ambiti disciplinari differenti e che spesso aumentano le distanze tra i ricercatori. 7 European Research - A guide to successful communication - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities p. 5 16
17 CAP. III - Modelli di comunicazione adottata. Quanto è importante comunicare la scienza attraverso internet? Da 0 a 1000, potenzialmente 1000 perché è un potente mezzo di autopromozione. Poi dipende molto dalle finalità che il ricercatore vuole, per esempio da un blog. Internet comunque è straordinario particolarmente per gli argomenti di nicchia. Claudia Di Giorgio (Giornalista e Blogger) lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/ La comunicazione pubblica della scienza è caratterizzata da molteplici canali di comunicazione bidirezionale posti tra costellazioni di gruppi sociali diversi che sono chiamati ad assumere, in compartecipazione, decisioni rilevanti per lo sviluppo della scienza 8. La scienza è trasmessa e circola, quindi, attraverso questi canali, che cambiano a seconda di chi invia il messaggio, di chi lo riceve e in relazione all obiettivo che si vuole raggiungere. Ciascun canale può essere considerato un ponte tra chi comunica e chi invece ascolta. Questo significa che esistono innumerevoli ponti fra gruppi di esperti e di non esperti che si creano e si ricostruiscono continuamente e dinamicamente 9. La variabilità dei temi da comunicare, ma anche dei canali e degli interlocutori spinge chi si occupa di 8,2 Greco, P. (2004), Il modello Venezia. La comunicazione nell era post-accademica della scienza, in N. Pitrelli e G. Sturloni (a cura di), La comunicazione della scienza- Atti del I e II Convegno Nazionale, Zadigroma, Roma. 17
18 comunicazione a pianificare l intero processo comunicativo prima di mettersi concretamente al lavoro. È necessario, quindi, in fase di progettazione prestare molta attenzione ad aspetti quali: l obiettivo il messaggio l interlocutore il mezzo di comunicazione i vincoli le opportunità 1. Identificare l obiettivo Il primo step di ogni attività comunicativa è definire l obiettivo della comunicazione. Perché comunicare? I motivi possono essere vari e possono essere raggruppati in queste categorie: trasferimento d informazione visibilità / awareness dialogo persuasione Definire i propri obiettivi è fondamentale per costruire un messaggio efficace e identificare l interlocutore, anche quando si comunica la scienza. 18
19 In genere, l obiettivo principale di una efficace attività di comunicazione della scienza è da identificare nella costruzione di un clima di reciproca conoscenza e fiducia tra scienza e società, stabilendo un dialogo nel quale l atteggiamento di apertura sia autentico Definire il messaggio Dopo aver identificato l obiettivo della propria attività di comunicazione è necessario definire il messaggio da veicolare. In fase di progettazione del processo comunicativo è fondamentale, infatti, capire cosa si vuole comunicare ai propri interlocutori. Una buona strategia è di evidenziare uno o più concetti chiave che esprimono il raggiungimento di un beneficio o, più in generale, di un aspetto positivo. E fondamentale ricordare però che la comunicazione è efficace soltanto se emittente e ricevente danno lo stesso significato al messaggio. 3. Identificare l interlocutore Identificare il proprio interlocutore è un aspetto fondamentale nella comunicazione. Il pubblico 10 Annamia Carbone - Open GRID DayFacoltà di Ingegneria Università di Catania, 9 maggio
20 infatti è eterogeneo da un punto di vista sociale, economico e culturale. Saper identificare gli interlocutori a cui bisogna comunicare rappresenta un valido strumento con cui calibrare il proprio messaggio. È essenziale quindi capire non solo a chi è necessario rivolgere il proprio messaggio ma anche l età, il sesso, l educazione, lo status economico, la localizzazione geografica, i gusti, gli interessi, gli orientamenti culturali e le reazioni del proprio pubblico. Chi è? Che cosa sa già dell argomento? Che cosa ne pensa? Va ricordato, inoltre, che (molto più di quanto si possa immaginare) non è necessario parlare a tutti. Basta, il più delle volte, rivolgersi direttamente solo ai propri stakolders (gruppi di interesse pubblico, movimenti di protesta, comunità locali, enti di governo, associazioni imprenditoriali, concorrenti, sindacati e la stampa) per raggiungere gli obiettivi prefissati. 4. Scegliere il mezzo di comunicazione Ad influenzare la scelta del mezzo di comunicazione con cui veicolare il proprio messaggio concorrono numerosi aspetti. Oltre agli obiettivi, al messaggio e al tipo di interlocutore, in fase di progettazione del processo comunicativo, è necessario prendere in considerazioni anche le barriere e i condizionamenti che possono limitare la capacità ricettiva del pubblico a cui ci rivolgiamo. In fase 20
21 progettuale, quindi, sono da considerare una serie di vincoli: le distrazione o i disturbi, gli interventi di meccanismi inconsci, le differenze di attribuzione di senso, il ruolo e l autorevolezza della fonte, la situazione ambientale, le condizioni psicologiche e i fattori sociali. In pratica il mezzo di comunicazione scelto deve raggiungere l obiettivo prefissato, e veicolare il messaggio al proprio interlocutore superando le barriere e i condizionamenti. 4.1 Televisione Nella società contemporanea la televisione è ormai un modello di riferimento per la rappresentazione della realtà che ci circonda: è vista dal 98,5% degli italiani e può essere considerata a tutti gli effetti come il mezzo di comunicazione più potente, perché capace di parlare a tutti. La comunicazione televisiva avviene per immagini e suoni, più che per testi e di conseguenza si presta maggiormente a raccontare fatti ed eventi, più che a spiegare concetti. Ne consegue che, in televisione, la sintesi degli argomenti è estrema e le tematiche poco approfondite. In conclusione la televisione come mezzo di comunicazione è utile quando si ha la necessità di raggiungere una vasta fetta di popolazione per stimolare gli interessi e invogliare a conoscere determinati argomenti, istradando il pubblico verso altri mezzi come riviste o libri. 21
22 In realtà c è anche da considerare che il pubblico non è disposto in ogni caso ad impegnarsi in eccessivi ragionamenti vedendo la tv come un mezzo prevalentemente d intrattenimento. 4.2 Radio La radio è un altro mezzo di comunicazione di massa, che a differenza della televisione, comunica con parole, musiche e suoni d ambiente e non come immagini. Rispetto alla televisione, inoltre, la radio rappresenta un mezzo più leggero, caratterizzato da tempi più rilassati e riflessivi, dove il filtro che inevitabilmente separa l'ascoltatore dai giornalisti e dagli scienziati appare meno solido e in sintesi il suo punto di forza risiede nella modalità espressiva che la caratterizza: la conversazione 11. Per molti anni sottovalutata e considerata alla stregua di una sorella minore della tv, la comunicazione radiofonica negli ultimi tempi sta sempre più attirando l attenzione di chi ha la necessità di veicolare delle informazioni. Se il tempo- schermo del pubblico sta diminuendo, c è ancora molto spazio per i suoni, specialmente per quelli più discreti, controllabili e personali della radio. 11 Matteo Merzagora, Science on air: the role of radio in science communication, Jcom, 3 (4), December 2004 (jcom.sissa.it/comment/com pdf) 22
23 In generale la scelta di una comunicazione via radio può premiare chi ha la necessità di rivolgersi al grande pubblico, in maniera più confidenziale e usufruendo di minore risorse. 4.3 Carta Stampata La carta stampata gioca tutto il suo potere comunicativo sull uso della parola scritta e in alcuni casi sulle immagini. E un mondo particolarmente vasto e che comprende diversi protagonisti: dai giornali a tiratura nazionale a quelli locali, dai giornali generalisti alle riviste specialistiche. In fase di progettazione del processo comunicativo è necessario calibrare il tipo di carta stampata su cui veicolare il proprio messaggio, rispetto all interlocutore ma anche all ambiente in cui si vuole operare. I giornali nazionali, per esempio, hanno una tiratura maggiore, ma è molto complicato comparire sulle loro pagine: la concorrenza con le altre notizie è spietata e nelle pagine a disposizione si deve competere con notizie provenienti da tutto il territorio nazionale. Per apparire su questo tipo di carta stampata è necessario quindi appoggiarsi su un valido ufficio stampa, che abbia i contatti giusti e che sappia quali sono i meccanismi dietro alla scelta di una notizia. Ovviamente, la situazione cambia nei giornali a tiratura locale che possono risultare particolarmente utili se si vuole promuovere un 23
24 evento limitatamente al loro territorio d appartenenza. Decidere su quale giornale si vuole apparire dipende ovviamente dagli obiettivi: essere pubblicati sui grandi quotidiani nazionale, infatti, può risultare utile se si cerca visibilità nei confronti dei policy makers. Se gli obiettivi sono altri, come per esempio sensibilizzare una comunità montana su un determinato tema allora sarebbe più idoneo rivolgersi alla carta stampata locale. Occorre ulteriormente differenziare il caso della stampa specialistica. Essere pubblicati sulla stampa che tratta solo di scienza è più semplice perché la concorrenza tra le notizie è minore; il pubblico in questo caso cambia: solitamente di cultura medio- altra legge per intero l articolo per arricchire il proprio sapere e non per essere semplicemente informati su un fatto o un avvenimento. Un aspetto da non sottovalutare è che, nella carta stampata, quasi sempre è necessario confrontarsi con un giornalista scientifico. E buona norma, quindi, mantenere ottimi rapporti con questa figura professionale e fidarsi principalmente di giornalisti competenti che sappiano conservare rigore e precisione, pena la perdita parziale (o completa) del contenuto del messaggio scientifico o addirittura la sua mistificazione. 4.4 Attività di Public Relations Quando si parla di attività di public relations si fa riferimento a convegni, seminari, workshop o 24
25 meeting. La comunicazione attraverso questo genere di eventi rappresenta un canale dispendioso e che ha un alto rapporto tra risorse investite e numero di contatti acquisiti. E tuttavia personalizzabile e si usa quando è necessario comunicare ad una ristretta cerchia di persone per coinvolgerle verso una particolare ricerca, per attività reperire fondi o trovare semplicemente nuovi contatti. Per raggiungere questi scopi, garantire un maggior coinvolgimento risulta determinante molto più di un distante articolo di giornale o di un appello fatto alla radio. In fase di progettazione è doveroso considerare che un attività di public relations rappresenta un ricettacolo di vari veicoli comunicative. In un evento come un seminario, infatti, il ricercatore, per esempio, avrà modo di comunicare con il proprio pubblico in forma verbale (con magari l ausilio di diapositive), ma attraverso la proiezione di un video o, ancora, attraverso la distribuzione di materiale informativo. 4.5 Internet Internet è attualmente il mezzo di comunicazione in ascesa e, grazie alle sue potenzialità (molte delle quali ancora da esprimere), sta drenando costantemente pubblico da due media tradizionali come la televisione ed i giornali. Uno dei motivi di tale successo è da identificare nel fatto che la comunicazione sul web è particolarmente libera e 25
26 può avvenire sia attraverso immagini e suoni (come in TV) sia attraverso i testi. Inoltre, pubblicare è alla portata di tutti, per la semplicità tecnica e per i bassi costi del software e dell hardware necessario. Il costo per contatto, inoltre, è pressoché nullo: non esistono costi di distribuzione e stampa ma nello stesso tempo è accessibili a tutti. Certo, non basta creare una pagina ed inserirla su internet per avere una grande visibilità, ma potenzialmente questa può essere vista da chiunque. I progetti di comunicazione basati su internet hanno quindi il vantaggio di essere low budget e di garantire (sulla carta) un buon risultato. La strategia di puntare sul web paga in particolar modo in termini di visibilità quando è necessario comunicare in maniera costate e con una certa frequenza dati ed informazioni, per creare una linea di contatto diretta con il proprio pubblico. 26
27 CAP. IV - Modelli di comunicazione scientifica Avere un proprio blog e comunicare costantemente con il pubblico aiuta il ricercatore ad esercitarsi a divulgare, spiegare cio che si sa alla Casalinga di Voghera, oltre al pubblico esperto Massimo Pinto (Ricercatore e Blogger) Negli ultimi anni 12, il processo di democratizzazione del pensiero scientifico ha spinto la scienza a modificare il proprio rapporto con la società. In particolare, sono cambiati i modelli comunicativi con cui i ricercatori s interfacciano con i cittadini. Lo scienziato è chiamato a relazionarsi con i non esperti, rappresentati dai cittadini e dai politici, per assumere insieme a loro decisioni importanti per il proprio lavoro. E necessario, quindi, che la società sia alfabetizzata scientificamente per rendere il messaggio inviato dalla scienza quanto più comprensibile possibile. L insieme di questi processi ha spinto la relazione tra scienza e società su un piano comunicativo differente rispetto al passato. Sono stati ideati, dunque, nuovi modelli di comunicazione scientifica che casualmente sono nati, però, nello stesso periodo in cui si sono sviluppati anche nuovi canali comunicativi. 12 L origine in Europa per un rinnovato interesse al rapporto tra scienza e pubblico, e soprattutto alla comprensione della scienza da parte di quest ultimo, è legata alla pubblicazione nel 1985 di un rapporto della Royal Society noto come rapporto Bodmer 27
28 Difatti, mentre la divulgazione scientifica degli anni novanta era effettuata tramite i tradizionali mass media e i musei, oggi a questi va aggiunto il web: un mezzo di comunicazione dai confini ancora non definiti e dalle potenzialità enormi. In particolare, decisivo è stato il passaggio tra il web 1.0 e il web 2.0 che ha aperto alla comunicazione della scienza delle prospettive comunicative enormi, sebbene ancora tutte da esplorare. 1. Nuovi modelli di comunicazione scientifica Prima che la comunicazione scientifica abbia assunto una connotazione moderna è stato necessario, in prima istanza, superare completamente il modello di comunicazione pubblica della scienza (nato nella seconda metà del XIX secolo e strutturatosi nei primi tre decenni del secolo XX), definito dalla maggior parte degli autori come Modello Standard o anche detto Deficit Model 13,14, in voga sino agli anni '90. Il Modello Standard, in realtà, non è un modello di comunicazione, ma più semplicemente un modello di divulgazione scientifica giacché adotta uno schema comunicativo di tipo top-down. La comunità scientifica, in quella fase storica, 13J. Gregory, S. Miller, Science in Public - Communication, Culture and Credibility, Plenum Trade, New York, M. Weigold, "Communicating Science : A Review of the Literature", Science Communication, volume 23, n.2, dicembre
29 viveva, infatti, isolata dalla società e da essa si divideva attraverso una sorta di membrana semipermeabile. Questa permetteva la fuoriuscita d informazioni secondo un flusso unidirezionale dall'alto verso il basso: un processo divulgativo che si spiegava con un mero travaso di conoscenza da A verso B, dove A era rappresentata dalla comunità scientifica e B era il pubblico di massa, considerato dagli scienziati al pari di un agglomerato passivo, portatore di una conoscenza molto limitata. Ovviamente perché fosse compresa da un pubblico del genere, l informazione scientifica doveva quindi essere banalizzata, approssimata. Figura 2 Modello standard della comunicazione pubblica della scienza - da: Come si comunica la scienza di Castelfranchi e Pitrelli Il Modello Standard è dunque un modello che tende a basare il flusso informativo non tanto sulle competenze, le credenze, i bisogni del pubblico (o dei pubblici), quanto (al contrario) sulle sue lacune culturali e cognitive, ipotizzate o misurate 15. Da qui il Modello Standard prende la sua denominazione 15 Yurij Castelfranchi, Scienziati in piazza - Scienza, politica e pubblico verso nuove osmosi, Jekyll.comm n. 2, giugno
30 più diffusa di Deficit Model: proprio dal flusso di informazione che crea e che per osmosi inversa viaggia da un punto con alta concentrazione culturale ad un punto con bassa concentrazione culturale e di nozioni. In tempi recentissimi però, al tradizionale modello top-down, si sta affiancando un più moderno e più idoneo one-up versus one-down, in cui le parole chiave diventano interazione, engagment, bidirezionalità, comunicazione partecipativa e dibattito 16. Si assiste quindi al superamento 17 del Public Understanding of Science (PUS), l etichetta sotto la quale tradizionalmente è descritta, soprattutto nel mondo anglosassone, la riflessione sul rapporto tra scienza, tecnologia e società, a favore del Public Engagement with Science and Technology (PEST). Non si tratta solo di una questione terminologica: si ha difatti lo spostamento dalla semplice promozione della comprensione dei fatti scientifici, secondo quanto indica il PUS, alla necessità della partecipazione del pubblico per recuperare una crescente perdita di fiducia nei confronti della scienza Yurij Castelfranchi, Scienziati in piazza - Scienza, politica e pubblico verso nuove osmosi, Jekyll.comm n. 2, giugno From PUS to PEST, Science, vol. 298, 4 ottobre 2002, p Nico Pitrelli - La crisi del Public Understanding of Science in Gran Bretagna - JCOM 2 (1), March
31 Con il nuovo modo con cui la scienza si rapporta alla società, il cittadino diviene, infatti, il vero protagonista dei flussi d informazione scientifica e i suoi interessi e bisogni finiscono per condizionare, spesso, le attività di ricerca. La comunicazione occupa il posto dell informazione: la trasmissione delle conoscenze scientifiche si basa su una forte interazione e il feedback è usato come un potente mezzo di valutazione da parte degli scienziati, che possono quindi calibrare meglio la propria attività comunicativa. La scienza, infatti, non è tutta uguale e non si comunica di conseguenza allo stesso modo. E necessario dunque utilizzare le strategie più idonee per favorire il dialogo fra scienza e pubblico. 2. La rivoluzione del web 2.0 Il termine "Web 2.0" fu usato per la prima volta durante una sessione di brainstorming tra O'Reilly e MediaLive International. Dale Dougherty, pioniere del web e Vice Presidente di O'Reilly, in quell occasione fece notare come il collasso delle dot-com 19 avesse segnato un punto di svolta per la rete, tale da portare a una vera e propria 19 da Wikipedia: «Con Dot-com si definiscono quelle società di servizi che sviluppano la maggior parte del loro business tramite un sito internet. Il nome deriva dal diffuso utilizzo, da parte di queste, di siti appartenenti al dominio di primo livello.com. Le Dot-com furono le protagoniste, in negativo, della bolla speculativa della new-economy all'inizio degli anni 2000, quando, numerose di esse, fallirono generando una vera e propria recessione della New Economy». 31
32 rivoluzione del web e allo sviluppo di un nuovo modo di concepire internet chiamato web A seminare i prodromi del cambiamento, furono proprio le dot- com sopravvissute alla crisi che investì la new- economy nei primi anni del Tutte le aziende e le società che superarono il collasso economico, sembravano tutte avere una caratteristica comune: la partecipazione. E proprio la partecipazione, oggi, risulta essere il primo elemento fondante e di differenzazione più marcato tra il web 2.0 e il web 1.0. Nel World Wide Web moderno ciascun utente grazie ad una miriade di servizi user friendly, ha la possibilità di generare contenuti e pubblicarli sulla rete, senza la necessità di avere particolari competenze di programmazione. Un cambiamento non da poco se si considera come, di conseguenza, è cambiato anche il modo in cui viaggia l informazione. Mentre prima infatti si spostava in un flusso unidirezionale da un punto A a tanti punti B, adesso invece tutta l informazione segue un percorso virale e bidirezionale. L utente, quindi, diviene un vero e proprio interattore, attivo nella produzione di contenuti e nello stesso tempo protagonista dell ecosistema comunicazione. Tutti possono creare contenuti e pubblicarli affrancandosi dalla fruizione passiva di informazione. Inoltre, la tecnologia che sta alla base 20 Liberamente riveduto e tradotto dall articolo di Tim O'Reilly is- web- 20.html 32
33 di questo nuovo modo di fare internet sgancia il contenuto dal suo creatore permettendo a ciascun utente di arricchire di nuove informazioni quelle già esistenti, di selezionare e diffondere quelle, secondo il proprio interesse, di maggiore valore e aggregare e riaggregare l informazione secondo i propri bisogni, rendendola fruibile sulle diverse piattaforme di distribuzione. La comunicazione tende a essere, quindi, maggiormente flessibile e adattabile ai contesti e ai comportamenti di fruizione degli utenti, sempre più attivi e interattivi, e a trasformare in ultima analisi il web da web da leggere a web da usare. Un secondo elemento fondante del web 2.0 è la democratizzazione del sapere e della produzione dello stesso. Con un parallelismo politico, il passaggio tra il web 1.0 al web 2.0 può essere rappresentato come il passaggio da un oligarchia 21 ad una democrazia. Da un sistema governato da pochi (la comunicazione era gestita da chi aveva particolari competenze tecniche) si è passati ad un sistema in cui tutti possono far valere il loro peso (senza la necessità di avere specifiche competenze). Figlio più importante della democratizzazione della produzione del sapere è l User-Generated Content (ovvero il contenuto generato dagli utenti) con cui si indica il materiale disponibile sul web prodotto da utenti invece che da società specializzate. Alcuni esempi di siti web che si basano su questa filosofia 21 Da wikipedia: L'oligarchia (dal greco "oligoi" (ὀλίγοι) = pochi e "archè" (ἀρχή) = potere, comando) è il sistema di governo di una minoranza, di un gruppo ristretto di persone ed è anche detto Governo d i Pochi. 33
34 sono Flickr, YouTube, Second Life e Wikipedia. Tutti questi siti si basano sull assunto di creare il contenitore e lasciare agli utenti il ruolo di riempirlo. Il Web 2.0 e l UGC, dunque, affermano un contesto completamente nuovo in cui ogni singolo utente diviene un emittente in grado di aggregare una sua audience, che singolarmente, è spesso trascurabile ma, sommata a quella di altri utenti, diviene di assoluto rilievo 22,23. Oltre al carattere partecipativo e al sapere condiviso democraticamente, un altro elemento fondamentale da sottolineare nel web 2.0 è il nuovo modo di gestire le dinamiche relazionali fra gli utenti. Il mondo delle comunicazioni sul web sta unificando l umanità perché la Rete si è trasformata in un network sociale, in un luogo di partecipazione e di condivisione. In questo caso la tecnologia non è una esperienza avulsa dalla più autentica umanità dell uomo ma risponde al desiderio fondamentale delle persone di entrare in rapporto le une con le altre, rispondono a un desiderio di comunicazione e amicizia che è radicato nella nostra stessa natura di esseri umani In questo scenario, si inserisce con sempre maggiore forza il concetto di coda lunga, espresso nel 2004 da Chris Anderson, editor della rivista Wired. In rete, eventi poco frequenti o di bassa ampiezza - la coda lunga, appunto - possano cumulativamente superare in numero o in importanza la porzione iniziale della curva, così che considerati complessivamente arrivino addirittura a rappresentare la maggioranza. 23 Articolo di Anderson: 24 Antonio Spadaro. Web 2.0 Reti di relazione, Milano, Paoline, 2010, pp
35 3. Parallelismo comunicazione scienza e web 2.0 Yurij Castelfranchi e Nico Pitrelli nel loro recente libro Come comunicare la scienza? sono concordi nell affermare che non esiste scienza laddove non c è comunicazione. Non si fa più scienza, infatti, nel chiuso della torre d avorio: ricercatori e centri di ricerca che non riescono ad uscire e a comunicare al pubblico le proprie attività rischiano di non proseguire i propri studi, per mancanza di sostegno economico o morale. Figura 3 La mappa del web 2.0 In questo contesto, la comunicazione pubblica della scienza riveste un ruolo sempre più importante perché ha lo scopo di creare ponti fra i vari protagonisti del sistema tecno- scienza (ricercatori, 35
36 politici, cittadini e imprenditori). In pochi anni, poi, nuovi e importanti scenari si sono aperti grazie al passaggio dal vecchio modello di comunicazione scientifica, il Public Understanding of Science (PUS), al nuovo modello di comunicazione, il Public Engagement with Science and Technology (PEST). Mentre nel modello PUS il flusso d informazione era unidirezionale e andava dal ricercatore al cittadino, nel PEST il flusso diviene invece bidirezionale: non solo è importante l input di conoscenza che il mondo accademico invia alla società, ma è determinante anche la risposta che quest ultima dà di rimando. Lo staticismo del Public Understanding of Science, dove lo scopo primario è alfabetizzare scientificamente la società è superato di slancio dalla filosofia 2.0 del Public Engagement with science e technology: un feedback continuo permette al mondo accademico di modulare la strategia di comunicazione scientifica che meglio si adatta a una società in continua mutazione. L analogia con il web 2.0 non è ovviamente un caso. L evoluzione della comunicazione della scienza ha numerosi elementi in comune con l evoluzione del web. Anche in internet, dalle pagine statiche con cui non si poteva interagire, si è passati a sistemi complessi in cui le parole d ordine sono interazione e condivisione dei contenuti; che fanno il paio con il concetto di conoscenza condivisa tipica dei nuovi modelli di comunicazione scientifica. E dunque plausibile che gli strumenti 2.0 che hanno reso il web uno dei maggiori mezzi di diffusione del sapere 36
37 possano essere utili anche alla comunicazione della scienza. Blog, forum, chat, sistemi quali Wikipedia, YouTube, Facebook, Twitter, Google Docs o Flickr trovano già largo impiego in progetti di comunicazione pubblica della scienza nei paesi anglosassoni: la NASA, ad esempio, molto sensibile verso il Public Outreach, attraverso Twitter aggiorna in tempo reale i propri lettori sul proseguimento delle sue missioni spaziali e grazie a YouTube condivide video didattici dall alto contenuto scientifico. Gli strumenti del web 2.0 sono una risorsa da sfruttare per affiancare e agevolare (grazie ai dovuti accorgimenti) il lavoro di musei, science center, ricercatori e centri di ricerca. Un ricercatore che lavora nel campo delle cellule staminali, attraverso un blog potrebbe spiegare ai lettori (solo per fare un esempio) gli aspetti cardine della propria ricerca e capire, grazie ai commenti ricevuti, quali sono i punti che maggiormente preoccupano l opinione pubblica. Scrivendo post potrebbe migliorare la propria immagine e valorizzare quella del proprio lavoro, nonché chiedere ai propri lettori un sostegno nell eventuale attività di found raising. Con twitter potrebbe creare una rete agile di condivisione di brevi messaggi di aggiornamento, mentre le foto del lavoro su Flickr gli permetterebbero di evidenziare l aspetto umano della ricerca. Per condividere le conoscenze acquisite, il ricercatore potrebbe usare Wikipedia; per creare rapporti e sinergie con altri ricercatori e cittadini potrebbe fare uso di Facebook. 37
38 Sono solo ipotesi, ma in breve l esempio fornisce prova di quali siano le potenzialità degli strumenti offerti dal web 2.0. L obiettivo per il futuro, quindi, dovrebbe essere investire di più negli strumenti offerti dal web 2.0, che attualmente costituiscono l unico modello comunicativo bidirezionale a basso costo e di ampia diffusione. 4. Blog Uno dei trend più pubblicizzati dell era web 2.0 è la crescita registrata dai blog e l importanza del loro ruolo come mezzi d informazione in apparenza liberi ed indipendenti. In realtà le homepage personali (o dette anche personal landing page) sono note dagli inizi del web, mentre i diari personali e gli editoriali quotidiani sono popolari da molto prima. Eppure, solo negli ultimi anni i blog hanno visto una crescita letteralmente esponenziale. Secondo il famoso informatico statunitense Rich Skrenta uno dei fattori che ha fatto la differenza è stata la tecnologia RSS, un architettura fondamentale del web che non solo consente non solo di collegarsi a una pagina, ma permette anche di abbonarsi ad essa, in modo da ricevere un avviso ogni volta che la pagina viene modificata. Un feed RSS è quindi molto più potente di un link (sia esso un bookmark o un link a una 38
39 singola pagina) perché permette di essere sempre sincronizzati a website dinamici come i blog 25. La crescita dei fenomeno blog naturalmente non è da ascrivere soltanto all adozione della nuova tecnologia RSS ma anche alla loro capacità che hanno di fare di Internet un medium «informale per idee informate, anarchico, commercialmente ingenuo e affascinante» 26 - così come sostiene Jeremy Wagstaff - all interno del quale si può pubblicare di tutto: pensieri, idee, opinioni, studi, ricerche, informazioni, notizie, curiosità, link, storie e articoli. Nonostante sia una homepage personale strutturata in forma di diario, non bisogna sottovalutare l aspetto sociale del blog: il blog rappresenta anche un potente strumento che mette in connessione diretta un autore con la sua audience e forse soprattutto, un luogo in cui navigatori con interessi comuni possono incontrarsi e scambiarsi opinioni. A seconda dello stile, del formato e del contenuto i blog possono differenziarsi molto fra di loro, ma tutti rappresentano uno spazio per la riflessione condivisa grazie alla diffusione di materiale che va dal testo, alle immagini, dai filmati al sonoro. I blog scientifici sono descritti di solito come blog che focalizzano la propria attenzione sulla scienza o più specificatamente sui risultati della ricerca e che 25 Liberamente riveduto e tradotto dall articolo di Tim O'Reilly is- web- 20.html 26 Francesca Simionato, Il nuovo contenitore delle proprie idee direttamente sul Web, in Dada.net, 2003, su comunicazione/interventi/2003/05/ shtml. 39
40 sono di solito gestiti da scienziati o da giornalisti scientifici. I bloggers scientifici, siano essi ricercatori o più semplicemente giornalisti, hanno la possibilità di: Informare i propri lettori circa le news provenienti dal mondo della scienza Spiegare materie complicate per renderle comprensibile anche ai meno esperti Analizzare i risultati di una ricerca e sostenere i lavori scientifici svolti Articolare la propria posizione rispetto a materie controverse. Attualmente una buona parte di esperti del settore considerano i blog scientifici come un nuovo modello di giornalismo scientifico, e più nello specifico, come un potente tool che può essere usato dalle istituzioni accademiche per disseminare informazione scientifica e facilitare la conversazione circa la scienza 27. Un altro gruppo, non meno, cospicuo di esperti del settore è convinto invece che i blog non rappresentino il modello emergente della comunicazione scientifica. Il loro limite sarebbe da identificare nella caratteristica peculiare di un blog: la sua unicità. Un blog, infatti, rappresenta spesso la mano di chi lo scrive: il pensiero dell autore, il suo punto di vista e le sue affiliazioni politiche- religiose 27 Batts SA, Anthis NJ, Smith TC (2008) Advancing Science through Conversations: Bridging the Gap between Blogs and the Academy. PLoS Biol 6(9): e240. doi: /journal.pbio
41 non sono mai nascoste ma anzi diventano la caratteristica preponderante del blog. Nonostante tutto questo, la comunicazione scientifica attraverso il blog sembra godere di buona salute. Quando si tratta di scienza, infatti, gli italiani si affidano sempre più all informazione che proviene direttamente da ricercatori e istituzioni di ricerca; spesso veicolate attraverso i blog. 28. Il segreto del successo dei blog è da identificare probabilmente nella loro capacità di superare il deficit model della divulgazione scientifica. Un blog ha la capacità, infatti, di trasformare la comunicazione della scienza dalla semplice promozione della comprensione dei fatti scientifici, (secondo quanto indica il PUS), ad una partecipazione del pubblico secondo quanto indicato dal Public Engagement with Science and Technology (PEST). Basti pensare al valore aggiunto offerto dai commenti. Quando un ricercatore pubblica una news sul proprio blog, gli utenti possono rispondere alla notizia. Il commento in questo caso rappresenta un feedback che l autore del blog può utilizzare per ricalibrare il messaggio inviato o crearne nuovi basati sui bisogni di chi lo segue di chi lo segue. Attraverso l interazione e il dibattito si instaura un flusso bidirezionale dell informazione che va al di là della mera diffusione di concetti scientifici e che rende protagonista non solo chi legge, ma anche chi scrive. 28 Daniela Doremi, Informazione scientifica: più credibili i contatti diretti (o via web) con i ricercatori, fonte Observa Science in Society, 41
42 In quest ottica, anche la mancanza di commenti rappresenta un chiaro segnale: nel caso non riceva feedback dai lettori è possibile che il messaggio non abbia raggiunto il bersaglio o non sia stato recepito dal destinatario. In quel caso, allora, l autore del blog sarà chiamato a riformulare il modo con cui l informazione è stata data al proprio pubblico per renderla maggiormente fruibile. I blog scientifici, a seconda della linea editoriale che il proprio autore (o più autori nel caso di blog collaborativi) vuole seguire, possono differenziasi in: Blog di rassegna e di segnalazione: lo scopo principale è di segnalare notizie o risorse reperibili sul web dedicati alla scienza in generale o a specifici ambiti disciplinari. Blog di commento: gli articoli sviluppati hanno l obiettivo di illustrare il punto di vista dell autore su un determinato argomento. Blog di narrazione: l autore attraverso il blog racconta la cronaca personale della sua attività di laboratorio. Spesso è scritto in prima persona e lo stile è di tipo diaristico. Blog di progetto: l autore o gli autori raccolgono e distribuiscono informazioni su un determinato progetto. 42
43 4.1 Network di Blog Può capitare (e succede spesso) che un singolo blog scientifico non abbia la forza di emergere dal marasma della rete. In questo caso per creare un fronte comune e imporsi al grande pubblico, molti blogger decidono di unirsi in un network o più semplicemente di creare il proprio spazio virtuale su un network di blog già esistente. Nel mondo ci sono diversi esempi di queste realtà, basti pensare al network di Nature o a Scienceblogs.com. Ogni utente che vuole parlare di scienza, semplicemente registrandosi può creare (spesso gratuita) e gestire un proprio blog. In Italia un sistema simile, ma non uguale, è rappresentato da Le Scienze (in cui non è possibile però aprire un proprio blog), e da Nova100 (che non tratta solo di scienza). Appartenere ad un network ovviamente ha i suoi vantaggi, specialmente per blog di nicchia come quelli scientifici: non solo è possibile sfruttare la notorietà del network e le attività promozionali svolte dallo stesso per diffondere maggiormente il proprio prodotto, ma si potrà fare affidamente anche su una rete già collaudata di autori. Inoltre ogni network di solito fornisce una pagina che aggrega tutte le notizie proveniente da tutti i blog del proprio sistema garantendo una grande visibilità ai post pubblicati. 43
44 5. Wikipedia Nell elenco delle applicazioni web 2.0 che hanno cambiato il modo di usare internet un posto di sicuro prestigio è occupato da Wikipedia. Nata da un progetto omonimo intrapreso da Wikimedia Foundation, (un organizzazione non a scopo di lucro statunitense), Wikipedia è un enciclopedia online interamente scritta con il contributo dal basso di migliaia e migliaia di collaboratori. Il metodo di lavoro è in questo caso l elemento innovatore: chiunque può aggiungere o modificare il contenuto (testo, immagini e video) presente in una Wiki e non c'è un comitato di redazione né alcun controllo preventivo sul materiale inviato. La partecipazione libera del singolo utente permette quindi di produrre un bene culturale comune, fruibile da tutti gratuitamente. Attualmente le voci di Wikipedia sono spesso citate dai mass media tradizionali e da istituti accademici ed il sito è uno dei dieci più visitati al mondo: riceve, in media, circa 60 milioni di accessi al giorno 29 e può vantare la collaborazione di oltre 350 mila autori diversi, che hanno prodotto circa 2 milioni di voci in più di 180 lingue. La creatura di Jimmy Donal Wales viene considerata, a tutti gli effetti, uno degli esempi più riusciti di servizio partecipativo, dove la collaborazione rappresenta il segreto del successo. 29 Fonte Alexa.com (dettagli) - agg. 15 giugno Il Rapporto Nielsen- netratings (febbraio 2007) indica Wikipedia all'ottavo posto fra i siti internet maggiormente visitati in Italia. 44
45 Comparando il modello Wikipedia con la comunicazione scientifica basata sul Public Engagement with science and technology è possibile osservare numerosi punti di contatto. In particolare, appare evidente come Wikipedia e il modello PEST condividano un fine comune: la democratizzazione del sapere. Figura 4 La sezione Astronomia di Wikipedia I wiki, infatti, rappresentano, l espressione più democratica della collaborazione e della diffusione della conoscenza scientifica attraverso la tecnologia: il sapere è condiviso e distribuito direttamente online a tutte le persone che possono accedere al sito e, nello stesso tempo, nasce grazie al contributo di tutti. Anche i contenuti scientifici prodotti su Wikipedia possono essere considerati come il risultato finale o temporaneo di un lavoro condiviso da tutti quelli che (ricercatori e non) in corso d opera integrano informazioni ed esperienze, così come saperi e conoscenze, liberamente e senza barriere. 45
46 In riferimento alla redazione di contenuti di tipo scientifico, su Wikipedia i ricercatori possono giocare un ruolo diverso rispetto all utente generico, perché rappresentano il valore aggiunto capace di validare le informazioni relative alla scienza raccolte nei wiki. Tale attività di controllo sui wiki scientifici sembrerebbe non non recare vantaggi immediati ai singoli ricercatori: questo perché un controllo diffuso e anonimo (qual è quello compiuto dagli utenti di wikipedia) non paga subito e direttamente in termini di fama e di promozione personale. La famosa enciclopedia online non è un canale attraverso cui il ricercatore può raggiungere l obiettivo dell autopromozione: difficilmente uno scienziato potrà alimentare il circuito di referring su se stesso e le proprie ricerche usando Wikipedia: semmai, wikipedia può essere utile allo scienziato solo quando egli arriva ad un punto stabile della propria carriera per aiutarlo a rafforzare il proprio nome quando è già un personaggio pubblico. In questo caso, al ricercatore basta aprire una propria pagina personale in cui citare i propri lavori. Il ruolo svolto dai ricercatori su Wikipedia, nella realtà dei fatti, investe (invece) prima di tutto il controllo della qualità dell informazione scientifica che circola sulla rete. Essendo uno dei primi luoghi di raccolta di dati a cui i navigatori fanno riferimento quando cercano risposte alle proprie curiosità, è importante per la sopravvivenza di tutta la comunità scientifica che le informazioni scientifiche inserite su Wikipedia corrispondano al 46
47 vero e si poggiano su solide basi scientifiche. Wikipedia può rappresentare il giusto canale a cui i ricercatori possono ricorrere per separare il contenuto appartenente alla sfera fantascientifica da quello propriamente scientifico. Il rischio di raggiungere pericolose derive, nella rete, è sempre in agguato: basti pensare a tutte quelle fantomatiche teorie ideate da sedicenti scienziati o presunti tali che spesso condizionano la società 30. Grazie a buone strategie di comunicazione, le teorie alternative finiscono per imporsi sulle teorie comprovate anche se non si basano su alcun dato scientifico. In questo modo aprono fronti di protesta, in grado di mettere in difficoltà comunità scientifiche o gruppi di ricerca. Basti pensare a tutte quelle fantomatiche ipotesi che appartengono più alla sfera della fantascienza che alla sfera della scienza e che, facendo leva sulle poco approfondite conoscenze scientifiche della società ed essendo facilmente comprensibili, presto finiscono con il condizionare il comportamento dei cittadini. Quest ultimi siccome spostano i fondi della ricerca attraverso il voto possono mettere a rischio proprio le ricerche e i ricercatori. In questo caso meglio allora informare la popolazione con delle cose vere e smentire le cose false: così si salva anche la propria ricerca. 6. Social network 30 Un esempio su tutti sono le cosiddette profezie sul 21 dicembre 2012, che su Wikipedia sono addirittura declinate in più pagine 47
48 I social network rappresentano i figli più interessati dell internet del nuovo millennio nati dalla spinta acceleratrice impressa dal web 2.0, in breve tempo hanno rivoluzionato il modo con cui gli utenti s interfacciano alla rete e tra di loro, affermandosi come uno dei modelli di comunicazione più interessanti degli ultimi anni. I social network infatti fondano il loro successo su due fattori di successo entrambi user generated: la collaborazione e la condivisione. La prima, è intesa come un attività svolta in comune da uno specifico gruppo di utenti che hanno come obiettivo quello di generare contenuti; la seconda attività è l atto di condivisione di questi contenuti con la collettività al fine di confrontare idee, passioni, punti di vista e più, in generale, conoscenze. In linea di massima i social network sono caratterizzati da complesse reti sociali, composte da individui collegati tra loro: per questo si evince come la condivisione d idee, interessi e conoscenza abbia una preponderanza e una potenzialità maggiore rispetto all aspetto collaborativo. Approfondendo più attentamente è possibile identificare un altro aspetto che ha determinato il successo dei social network. La condivisione e la collaborazione senz altro sono dei fattori vincenti ma importante è stata anche la rottura rispetto alle community antecedenti. Prima, infatti, l utente (seppure condivideva e collaborava per produrre dal basso nuovo contenuto) era allocato in un determinato spazio i cui limiti erano facilmente identificabili, ma non modificabili. Ora, invece, con i 48
49 social network gli utenti non fanno più parte di una community in senso stretto ma più che altro di una rete. Di conseguenza, hanno la possibilità di definire sul web un proprio spazio molto personalizzabile nei processi comunicativi e nelle relazionali. Inoltre, non appartenendo ad una community (che rappresenta l elemento di riferimento) ciascun utente con il suo spazio può essere identificato a seconda delle circostanze come nodo di una rete più ampia o come elemento cardine di una rete di cui è promotore. Attraverso uno spazio personale (che appare sempre più come la parte abitata della rete 31 ), e lo sviluppo di una rete sociale estesa e dai numerosi nodi tra loro interconnessi si consolida online un forte individualismo, fatto però di condivisione e collaborazione, come una comunità aperta (e non circoscritta) che ben si plasma sulla collettività individualista 32 che Manuel Castells ha descritto in riferimento alla società del XXI secolo. I social network collegano persone realmente affini, e facilitano relazioni e legami attraverso i meccanismi di profilazione. Esiste però l altra faccia della medaglia: Bill Gates ha deciso di eliminare il suo profilo da Facebook (dove aveva ben 10 mila inviti) motivando l atto con l idea che «nonostante i vantaggi della rivoluzione digitale alcuni social network possono rivelarsi una grande perdita di tempo». Tuttavia l uso proprio dei social network può evitare questi problemi: come spiegano molti 31 S. Maistrello, La parte abitata della Rete, Tecniche Nuove, Milano M. Castells, Galassia Internet, Feltrinelli Milano
50 operatori, i social network possono essere anche un luogo dove parlare di lavoro, trovarne uno o fare employer branding. Anche nel campo della comunicazione scientifica i social network possono essere utili. Tutti i figli del web 2.0, infatti, si incastrano a perfezione con le logiche adottate dal nuovo modo di diffondere il pensiero scientifico (PEST). I social network, allora, quale massimo esponente del web grazie alle proprie caratteristiche specifiche rappresentano attualmente l eldorado a cui ricercatori, centri di ricerca (ecc) possono attingere per comunicare fra di loro ma anche per interfacciarsi con il grande pubblico. A seconda degli obiettivi che ciascuna realtà scientifica vuole raggiungere, ci sono degli specifici social network che per strutturazione e caratteristiche possono essere più o meno utilizzati in maniera proficua. 6.1 LinkedIN LinkedIN è un social network usato principalmente per la realizzazione di reti professionali. Lo scopo principale del sito è consentire agli utenti registrati il mantenimento di una lista di persone conosciute e ritenute affidabili in ambito lavorativo: dopotutto la rete è ricca di esperti di settore pronti a condividere le proprie conoscenze. Attualmente LinkedIn conta 50
51 oltre 75 milioni di membri registrati in più di 200 paesi in tutto il mondo. Nel campo della comunicazione scientifica, un social network come LinkeIn può risultare utile per mettere in contatto ricercatori geograficamente lontani ma che possono avere interesse a collaborare su una determinata tematica. Istruzioni tratte da LinkedIn Dopo aver effettuato l'iscrizione, potrai creare un profilo che sintetizzi la tua carriera professionale e le tue competenze. Puoi stabilire collegamenti duraturi invitando contatti affidabili a iscriversi a LinkedIn e a collegarsi con te. La tua rete è formata dai tuoi collegamenti, dai collegamenti di questi ultimi e dalle persone che loro conoscono, e ti consente di entrare in contatto con un gran numero di esperti e professionisti qualificati. Grazie alla tua rete, potrai: Gestire le tue informazioni come professionista che sono disponibili pubblicamente. Trovare e presentarsi a potenziali clienti, fornitori di servizi, ed esperti che sono stati segnalati. Creare e collaborare per la realizzazione di progetti, raccogliere dati, condividere file e risolvere problemi. Essere trovato per opportunità professionali e trovare potenziali partner 51
52 Raccogliere nuove informazioni da discussioni private con professionisti che condividono le tue stesse idee. Scoprire i collegamenti all'interno delle società che possono aiutarti a trovare lavoro e a stringere degli accordi. Pubblicare e distribuire offerte di lavoro per trovare i talenti migliori per la tua azienda Twitter Creato nel marzo 2006 dalla Obvious Corporation di San Francisco, Twitter è un servizio gratuito di social network e microblogging che fornisce agli utenti una pagina personale aggiornabile tramite messaggi di testo con una lunghezza massima di 140 caratteri. Con il tempo Twitter si è trasformato in un network di informazioni in tempo reale sviluppatosi grazie ad utenti provenienti da tutti il mondo. Twitter, infatti, consente di condividere e di scoprire ciò che sta accadendo in un determinato momento; non a caso il suo slogan è what s happening 34. Grazie all immediatezza e alla semplicità d uso, Twitter rappresenta uno strumento alla portata di tutti e viene utilizzato spesso anche nel campo del giornalismo partecipativo. 33 Liberamente tratto da 34 Liberamente tratto da 52
53 Nel campo della comunicazione scientifica, uno strumento come twitter potrebbe risultare comodo a tutti quei ricercatori o centri di ricerca che hanno la necessità di comunicare ad un vasto pubblico in real time o con brevi messaggi di testo. Figura 5 La pagina Twitter della NASA, con la quale aggiorna il pubblico sullo stato delle missioni La Nasa, ad esempio, durante la riparazione del telescopio Hubble, utilizzò Twitter per aggiornare il proprio pubblico circa le diverse fasi della missione: dal lancio al rientro, comprese le passeggiate spaziali. Ovviamente quella del telescopio Hubble non rappresenta un esperienza isolata: la stessa agenzia spaziale americana utilizza Twitter come strumento di comunicazione già da diverso tempo. Gli stessi ricercatori, possono trovare in questo social network un valido strumento, per raccontare costantemente e con una discreta perdita di tempo, la vita nel laboratorio. In quest ottica l uso di twitter potrebbe aiutare a fidelizzare il pubblico su una certa ricerca. Twitter, inoltre, non è usato soltanto per trasmettere ma anche per ricevere. E possibile 53
54 infatti poter seguire anche il flusso informativo di altri ricercatori o centri di ricerca per restare aggiornati su determinati argomenti. Se la rapidità d utilizzo è un punto di forza in Twitter, il limite di 140 caratteri, l uso unicamente testuale e l impossibilità di inserire immagini o video se non in forma di link, e la mancanza di un sistema di dialogo semplice ne inficiano l utilizzo in un settore (quello della comunicazione scientifica) dove questi elementi sono indispensabili alleati. Una valida alternativa potrebbe essere Meemi.com un prodotto creato in Italia da italiani che ha cercato nel tempo di valicare i limiti di twitter e strutturare un social network che abbia le potenzialità e la facilità d uso di twitter ma che supporti maggiormente la condivisione di video, immagini e importante, il dialogo tra gli utenti più diretto e semplice. 6.3 Facebook Fondato nel 2004 da Mark Zuckerberg, all'epoca studente diciannovenne presso l'università Harvard, Facebook aveva lo scopo di mettere in contatto la popolazione studentesca della stessa università. Oggi probabilmente è il social network più conosciuto al mondo (dopo Google il suo sito è il più visitato del 2010) e conta più di 500 milioni di 54
55 persone iscritte e attive 35. Dopo essersi registrati è possibile connettersi e restare connessi con i propri amici, condividere notizie, link, video e foto senza particolari limiti. Ciascun utente ha la possibilità di creare un proprio profilo, configurarlo secondo le proprie esigenze e partecipare attivamente ai gruppi di discussioni (o crearne di nuovi) che più si avvicinano ai propri interessi. Facebook come buona parte dei social network, ha tra i punti di forza la semplicità d uso e la possibilità di condividere con i propri amici qualsiasi aspetto della propria vita. Un aspetto da non sottovalutare è infatti il numero di utenti registrati. Su facebook infatti, è possibile grazie alla grande quantità di iscritti raggiungere un vasto pubblico in maniera semplice e diretta e sfruttare poi la potenza della viralizzazione per diffondere una propria idea o in generale il proprio contenuto. Figura 6 La pagina Facebook di Radio Tre Scienza Nel campo della comunicazione scientifica, Facebook risulta per molte delle proprie funzione
56 uno strumento che non si può far a meno di utilizzare. Oltre a creare un proprio profilo e interagire con i colleghi (ma anche con i propri fans), un ricercatore può innanzitutto aprire gruppi di discussione relativamente ad un dato argomento. In secondo luogo può lanciare cause e diffondere una certa tematica scottante in maniera virale ad un vasto numero di persone. Altre funzioni interessanti di Facebook sono le pagine eventi con cui si possono promuovere proprie iniziative scientifiche a cui il pubblico può partecipare; e le cosiddette fan page, che possono essere considerate delle pagine istituzionali, attraverso le quali istituti di ricerca, musei, zoo o simili possono comunicare con i propri sostenitori. Facebook si adatta benissimo al modello PEST della comunicazione scientifica. Favorisce, infatti, l interazione e il dialogo e crea un flusso d informazione sempre bidirezionale. Uno dei punti di debolezza è invece rappresentato spesso dalla scarsa tematicità di questo social network, con la grande dispersione di argomenti e un flusso di notizie che spesso non rappresenta il reale interesse dell utente ma rappresenta lo streaming continuo della società reale. 56
57 6.4 Altri social network Oltre ai social network più generalisti ne esiste una serie maggiormente specializzata su determinate funzioni. Basti pensare a YouTube (ma anche Vimeo o blip.tv) che concentra la sua attenzione sulla condivisione di video e filmati. Nel campo della comunicazione scientifica uno strumento del genere potrebbe essere applicato per la distribuzione di video o notiziari creati da istituti di ricerca, musei o strutture affini. Un esempio è rappresentato da Urania, il notiziario video su astronomia e spazio prodotto dall INAF. Figura 7 Il canale YouTube di Urania Nel caso in cui servisse condividere le immagini di qualche reperto, di centri di ricerca o di qualche evento organizzato, esistono alcuni social network dedicati alle fotografie. Primo fra tutti Flickr, un potente strumento che permette a tutti gli utenti profilati di condividere immagini e fotografie, geolocalizzarle, raggrupparle per argomenti, località 57
58 o quant altro. Anche in questo caso le occasioni per sfruttare questo strumento per la comunicazione scientifica non mancano. 6.5 Social network specifici Una delle tendenze che si sta affermando negli ultimi tempi è la creazione di social network tematici e di nicchia da affiancare a quelli generalisti. Uno dei vantaggi di un social network tematico è di avere un pool di utenti che si registrano perché hanno un determinato e molto settoriale interesse in comune. Anche nel campo scientifico esistono diversi esempi anche se nessun italiano: Figura 8 Il network di Nature 58
Modelli ed elementi di comunicazione scientifica
 Modelli ed elementi di comunicazione scientifica Matteo Di Rosa - APRE 02 Dicembre 2014 Teramo www.apre.it APRE 2013 Deficit Model Modello PUS Nell ottobre del 2002, gli scienziati britannici, in una breve
Modelli ed elementi di comunicazione scientifica Matteo Di Rosa - APRE 02 Dicembre 2014 Teramo www.apre.it APRE 2013 Deficit Model Modello PUS Nell ottobre del 2002, gli scienziati britannici, in una breve
Comunicare al pubblico. Giancarlo Sturloni, Master in Comunicazione della Scienza, SISSA Trieste, 8 novembre 2010
 Comunicare al pubblico Giancarlo Sturloni, Master in Comunicazione della Scienza, SISSA Trieste, 8 novembre 2010 Premessa A cosa serve comunicare al pubblico? Comunicare non è un optional, è una necessità
Comunicare al pubblico Giancarlo Sturloni, Master in Comunicazione della Scienza, SISSA Trieste, 8 novembre 2010 Premessa A cosa serve comunicare al pubblico? Comunicare non è un optional, è una necessità
Strumenti per comunicare lo sviluppo rurale: l esperienza del GAL Marghine
 Strumenti per comunicare lo sviluppo rurale: l esperienza del GAL Marghine Il Gal Marghine Il GAL Marghine coinvolge 10 comuni del Centro Sardegna (Prov. Nuoro), per un area di 534 Kmq ed una popolazione
Strumenti per comunicare lo sviluppo rurale: l esperienza del GAL Marghine Il Gal Marghine Il GAL Marghine coinvolge 10 comuni del Centro Sardegna (Prov. Nuoro), per un area di 534 Kmq ed una popolazione
La comunicazione con il supporto dei social network Settembre 2011
 La comunicazione con il supporto dei social network Settembre 2011 Documento confidenziale riservato Come siamo nati? 2011 Gruppo Manara All rights reserved 2 2011 Gruppo Manara All rights reserved 2011
La comunicazione con il supporto dei social network Settembre 2011 Documento confidenziale riservato Come siamo nati? 2011 Gruppo Manara All rights reserved 2 2011 Gruppo Manara All rights reserved 2011
Di Adriana Rava Lunedì 28 Dicembre :45 - Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Novembre :50
 Comunicazione Italiana è il primo Business Social Media italiano e realizza progetti editoriali, servizi online, ed eventi mettendo in relazione i decision maker e gli opinion leader di imprese ed istituzioni.
Comunicazione Italiana è il primo Business Social Media italiano e realizza progetti editoriali, servizi online, ed eventi mettendo in relazione i decision maker e gli opinion leader di imprese ed istituzioni.
L obiettivo. Facilitare. Non è convincere. La comunicazione per una scelta consapevole
 La vaccinazione tra diritto e dovere Quale comunicazione per facilitare la scelta L obiettivo Non è convincere Ma Istituto Superiore di Sanità 10 Gennaio 2011 La comunicazione per una scelta consapevole
La vaccinazione tra diritto e dovere Quale comunicazione per facilitare la scelta L obiettivo Non è convincere Ma Istituto Superiore di Sanità 10 Gennaio 2011 La comunicazione per una scelta consapevole
10/12/2015.
 1 10/12/2015 www.anteassicilia.org 2 Cosa è un sito internet? Un sito Internet o sito web (anche abbreviato in sito se chiaro il contesto informatico) è un insieme di pagine web correlate, ovvero una struttura
1 10/12/2015 www.anteassicilia.org 2 Cosa è un sito internet? Un sito Internet o sito web (anche abbreviato in sito se chiaro il contesto informatico) è un insieme di pagine web correlate, ovvero una struttura
Capitolo 15. La pubblicità e le pubbliche relazioni. Capitolo 15 - slide 1
 Capitolo 15 La pubblicità e le pubbliche relazioni Capitolo 15 - slide 1 La pubblicità e le pubbliche relazioni Obiettivi di apprendimento Il ruolo della pubblicità nel mix promozionale Le principali decisioni
Capitolo 15 La pubblicità e le pubbliche relazioni Capitolo 15 - slide 1 La pubblicità e le pubbliche relazioni Obiettivi di apprendimento Il ruolo della pubblicità nel mix promozionale Le principali decisioni
Il termine web nasce dalla contrazione di world wide web (ampia ragnatela mondiale). Questa piattaforma consente a tutti di accedere a informazioni,
 Il termine web nasce dalla contrazione di world wide web (ampia ragnatela mondiale). Questa piattaforma consente a tutti di accedere a informazioni, consultare innumerevoli contenuti ecc. Sintetizziamo
Il termine web nasce dalla contrazione di world wide web (ampia ragnatela mondiale). Questa piattaforma consente a tutti di accedere a informazioni, consultare innumerevoli contenuti ecc. Sintetizziamo
CI SONO STORIE DIFFICILI DA RACCONTARE Conferenza europea di presentazione dei risultati e delle prospettive del progetto
 CI SONO STORIE DIFFICILI DA RACCONTARE Conferenza europea di presentazione dei risultati e delle prospettive del progetto 29 GENNAIO 2013 CIRCOLO DELLA STAMPA Corso Venezia, 48 MILANO STOPVIEW UN PERCORSO
CI SONO STORIE DIFFICILI DA RACCONTARE Conferenza europea di presentazione dei risultati e delle prospettive del progetto 29 GENNAIO 2013 CIRCOLO DELLA STAMPA Corso Venezia, 48 MILANO STOPVIEW UN PERCORSO
GUIDE Google+ e Hootsuite. Promuovi il tuo brand su Google+
 GUIDE Google+ e Hootsuite Promuovi il tuo brand su Google+ Google+ e Hootsuite Promuovi il tuo brand su Google+ Google+, il secondo social più usato al mondo dopo Facebook, offre interessanti potenzialità
GUIDE Google+ e Hootsuite Promuovi il tuo brand su Google+ Google+ e Hootsuite Promuovi il tuo brand su Google+ Google+, il secondo social più usato al mondo dopo Facebook, offre interessanti potenzialità
Social Network - Università e imprese. Andrea De Marco - Marketing e Social Media - 24 Maggio 2011
 Social Network - Università e imprese Andrea De Marco - Marketing e Social Media - 24 Maggio 2011 Qualche numero su Internet in Italia 2 L impatto di Internet sul PIL italiano http://www.bcg.it/documents/file75272.pdf
Social Network - Università e imprese Andrea De Marco - Marketing e Social Media - 24 Maggio 2011 Qualche numero su Internet in Italia 2 L impatto di Internet sul PIL italiano http://www.bcg.it/documents/file75272.pdf
Progetto Integrazione Social Network
 Progetto Integrazione Social Network Indice slides Stato Attuale: 1. Analisi accessi e fasce orarie 2. Contenuti 3. Attuale uso passivo social network Uso attivo del social network in ottica Seo (Search
Progetto Integrazione Social Network Indice slides Stato Attuale: 1. Analisi accessi e fasce orarie 2. Contenuti 3. Attuale uso passivo social network Uso attivo del social network in ottica Seo (Search
Strumenti collaborativi online per la valorizzazione del patrimonio. Premessa
 Alessandro Bogliolo Università degli Studi di Urbino Carlo Bo alessandro.bogliolo@uniurb.it Premessa Le nuove tecnologie informatiche offrono opportunità straordinarie per valorizzare il patrimonio artistico
Alessandro Bogliolo Università degli Studi di Urbino Carlo Bo alessandro.bogliolo@uniurb.it Premessa Le nuove tecnologie informatiche offrono opportunità straordinarie per valorizzare il patrimonio artistico
Buone Prassi Farnesina che innova
 Buone Prassi Farnesina che innova «Il portale degli studenti, ricercatori, accademici e imprenditori innovativi del New England» Responsabili del Progetto Cons. Amb. Nicola De Santis Roberta Maisano stagista
Buone Prassi Farnesina che innova «Il portale degli studenti, ricercatori, accademici e imprenditori innovativi del New England» Responsabili del Progetto Cons. Amb. Nicola De Santis Roberta Maisano stagista
MARKETING (Principi e strumenti)
 Corso di Laurea in Economia Aziendale Management internazionalizzazione e qualità A.A. 2017-2018 MARKETING (Principi e strumenti) Prof.ssa Silvia Ranfagni L EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI MARKETING NELL IMPRESA
Corso di Laurea in Economia Aziendale Management internazionalizzazione e qualità A.A. 2017-2018 MARKETING (Principi e strumenti) Prof.ssa Silvia Ranfagni L EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI MARKETING NELL IMPRESA
La casa della conoscenza
 Assemblea plenaria Commissione degli utenti dell informazione statistica XI Conferenza nazionale di statistica La casa della conoscenza Patrizia Cacioli La Conferenza nazionale di statistica Istituita
Assemblea plenaria Commissione degli utenti dell informazione statistica XI Conferenza nazionale di statistica La casa della conoscenza Patrizia Cacioli La Conferenza nazionale di statistica Istituita
Twitter.com/giorgiotave
 Twitter.com/giorgiotave Di cosa parleremo oggi Il Social Network di Google Social Search: cos'è e come funziona Plus, Search Your World Pagine Business Dare visibilità ai contenuti Social Search: cos'è
Twitter.com/giorgiotave Di cosa parleremo oggi Il Social Network di Google Social Search: cos'è e come funziona Plus, Search Your World Pagine Business Dare visibilità ai contenuti Social Search: cos'è
Comunicare nel volontariato. Elementi di marketing nel nonprofit Cisvol 2009
 PERCHE COMUNICARE? Mettere in risalto l immagine Presentare servizi e iniziative Raccogliere fondi Creare un posizionamento nel mercato non profit Allacciare rapporti con i beneficiari dell offerta (volontari,
PERCHE COMUNICARE? Mettere in risalto l immagine Presentare servizi e iniziative Raccogliere fondi Creare un posizionamento nel mercato non profit Allacciare rapporti con i beneficiari dell offerta (volontari,
Programmi di Finanziamento dell Unione Europea Le Politiche Comunitarie di interesse per il Consiglio dell Ordine degli Psicologi dell Abruzzo
 Programmi di Finanziamento dell Unione Europea Le Politiche Comunitarie di interesse per il Consiglio dell Ordine degli Psicologi dell Abruzzo Il Consiglio degli Psicologi dell Abruzzo - organizza il corso
Programmi di Finanziamento dell Unione Europea Le Politiche Comunitarie di interesse per il Consiglio dell Ordine degli Psicologi dell Abruzzo Il Consiglio degli Psicologi dell Abruzzo - organizza il corso
Definire una strategia per l impresa online: dagli obiettivi al piano operativo
 CAPITOLO PMI online MODULO Definire una strategia per l impresa online: dagli obiettivi al piano operativo A CURA DI Miriam Bertoli - Consulente di marketing digitale Obiettivi del modulo Entro la fine
CAPITOLO PMI online MODULO Definire una strategia per l impresa online: dagli obiettivi al piano operativo A CURA DI Miriam Bertoli - Consulente di marketing digitale Obiettivi del modulo Entro la fine
Carta di Ottawa per la promozione della salute
 Carta di Ottawa per la promozione della salute 1 Conferenza Internazionale sulla Promozione della Salute del 1986 per stimolare l azione l a favore della Salute per Tutti per l anno l 2000 e oltre Promozione
Carta di Ottawa per la promozione della salute 1 Conferenza Internazionale sulla Promozione della Salute del 1986 per stimolare l azione l a favore della Salute per Tutti per l anno l 2000 e oltre Promozione
Come scrivere un dissemination plan
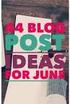 Come scrivere un dissemination plan Di Rosa Matteo dirosa@apre.it H2020 NCP - Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials (SC5) 21 Gennaio Pavia Prima di iniziare è essenziale un
Come scrivere un dissemination plan Di Rosa Matteo dirosa@apre.it H2020 NCP - Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials (SC5) 21 Gennaio Pavia Prima di iniziare è essenziale un
Allegato 4 Indicatori del Programma
 Allegato 4 Indicatori del Programma 20 marzo 2017 4. Indicatori del programma Introduzione metodologica alle tabelle. Indicatori di output Per ciò che concerne la identificazione dei valori target degli
Allegato 4 Indicatori del Programma 20 marzo 2017 4. Indicatori del programma Introduzione metodologica alle tabelle. Indicatori di output Per ciò che concerne la identificazione dei valori target degli
Protocollo dei saperi imprescindibili
 Protocollo dei saperi imprescindibili Ordine di scuola: professionale grafico DISCIPLINA: TECNICHE DI COMUNICAZIONE (Servizi Commerciali indirizzo grafico) TERZE RESPONSABILE: PARRUCCI ALESSANDRA Competenze:saper
Protocollo dei saperi imprescindibili Ordine di scuola: professionale grafico DISCIPLINA: TECNICHE DI COMUNICAZIONE (Servizi Commerciali indirizzo grafico) TERZE RESPONSABILE: PARRUCCI ALESSANDRA Competenze:saper
Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali
 A.N.A.R.P.E. Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali costituita a Milano il 30 Agosto 1951 scopi dell Associazione : rappresentanza e tutela dei promotori editoriali 1 ORGANIZZAZIONE
A.N.A.R.P.E. Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali costituita a Milano il 30 Agosto 1951 scopi dell Associazione : rappresentanza e tutela dei promotori editoriali 1 ORGANIZZAZIONE
ARGOMENTI. Il Sistema Impresa. La logica Competitiva. L Impresa. L imprenditore e le sue caratteristiche
 L IDEA IMPRENDITORIALE ed il SISTEMA IMPRESA ARGOMENTI Il Sistema Impresa La logica Competitiva L Impresa L imprenditore e le sue caratteristiche Il Sistema Impresa L impresa è un sistema cioè un insieme
L IDEA IMPRENDITORIALE ed il SISTEMA IMPRESA ARGOMENTI Il Sistema Impresa La logica Competitiva L Impresa L imprenditore e le sue caratteristiche Il Sistema Impresa L impresa è un sistema cioè un insieme
Relazioni Istituzionali e Comunicazione
 Relazioni Istituzionali e Comunicazione CHISIAMO COMUNICARE PER INNOVARE Inrete è una società dinamica che sviluppa progetti di Comunicazione e azioni a supporto di attività di Lobbying e Public Affairs.
Relazioni Istituzionali e Comunicazione CHISIAMO COMUNICARE PER INNOVARE Inrete è una società dinamica che sviluppa progetti di Comunicazione e azioni a supporto di attività di Lobbying e Public Affairs.
LinkedIn per il B2B. Progettare un efficace presenza aziendale in LinkedIn
 LinkedIn per il B2B Progettare un efficace presenza aziendale in LinkedIn Le relazioni contano Profili e Pagine Profilo Il ruolo del profilo In rete, la differenza tra personal brand e brand aziendale
LinkedIn per il B2B Progettare un efficace presenza aziendale in LinkedIn Le relazioni contano Profili e Pagine Profilo Il ruolo del profilo In rete, la differenza tra personal brand e brand aziendale
numero cinque ottobre 2017
 numero cinque ottobre 2017 PRIMO PIANO Venetoclusters e Innoveneto, i due nuovi siti regionali a supporto del sistema veneto dell innovazione. Intervento dell Assessore Roberto Marcato. NEWS Online il
numero cinque ottobre 2017 PRIMO PIANO Venetoclusters e Innoveneto, i due nuovi siti regionali a supporto del sistema veneto dell innovazione. Intervento dell Assessore Roberto Marcato. NEWS Online il
Donne e networking. Il networking è donna
 Donne e networking Il networking è donna Il networking cos è? Networking Una rete sociale consiste di un qualsiasi gruppo di individui connessi tra loro da diversi legami sociali. Per gli esseri umani
Donne e networking Il networking è donna Il networking cos è? Networking Una rete sociale consiste di un qualsiasi gruppo di individui connessi tra loro da diversi legami sociali. Per gli esseri umani
ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO. MODELLO PROGETTUALE secondo le Indicazioni Nazionali 2012
 ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO MODELLO PROGETTUALE secondo le Indicazioni Nazionali 2012 Scuola Primaria Paritaria Santa Luisa de Marillac Anno scolastico 2015 2016 PREMESSA L organizzazione del curricolo
ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO MODELLO PROGETTUALE secondo le Indicazioni Nazionali 2012 Scuola Primaria Paritaria Santa Luisa de Marillac Anno scolastico 2015 2016 PREMESSA L organizzazione del curricolo
Spunti, esempi, logiche del comunicare nelle organizzazioni La comunicazione in azienda
 Spunti, esempi, logiche del comunicare nelle organizzazioni La comunicazione in azienda Marina Maderna L incontro è l occasione per Esplorare il tema della comunicazione nelle organizzazioni: Perché si
Spunti, esempi, logiche del comunicare nelle organizzazioni La comunicazione in azienda Marina Maderna L incontro è l occasione per Esplorare il tema della comunicazione nelle organizzazioni: Perché si
SOCIAL IDEA LA TUA STRATEGIA ONLINE
 SOCIAL IDEA LA TUA STRATEGIA ONLINE CHI SONO TEOBALDO SEMOLI Fondatore e web editor di Socialidea, web agency specializzata nello studiare e implementare strategie di web marketing. Le mie principali mansioni:
SOCIAL IDEA LA TUA STRATEGIA ONLINE CHI SONO TEOBALDO SEMOLI Fondatore e web editor di Socialidea, web agency specializzata nello studiare e implementare strategie di web marketing. Le mie principali mansioni:
RISULTATI DELLA RICERCA IN SANITÀ PUBBLICA: processo editoriale e open access
 www.necobelac.eu RISULTATI DELLA RICERCA IN SANITÀ PUBBLICA: processo editoriale e open access Roma, 18-20 ottobre 2010 MODULO Programma di formazione e ruolo dei formatori NECOBELAC Paola De Castro Istituto
www.necobelac.eu RISULTATI DELLA RICERCA IN SANITÀ PUBBLICA: processo editoriale e open access Roma, 18-20 ottobre 2010 MODULO Programma di formazione e ruolo dei formatori NECOBELAC Paola De Castro Istituto
Ruolo e performance dei Social Media nella gestione aziendale II Edizione. Milano, 21 giugno 2017 Università degli Studi di Milano-Bicocca
 Ruolo e performance dei Social Media nella gestione aziendale II Edizione 1 Milano, 21 giugno 2017 Università degli Studi di Milano-Bicocca Roberto Chierici Barbara Del Bosco Alice Mazzucchelli 2 Milano,
Ruolo e performance dei Social Media nella gestione aziendale II Edizione 1 Milano, 21 giugno 2017 Università degli Studi di Milano-Bicocca Roberto Chierici Barbara Del Bosco Alice Mazzucchelli 2 Milano,
EFFICACY. Per la Scuola, per i Docenti, per gli Studenti. In collaborazione con l Università Bocconi
 EFFICACY Per la Scuola, per i Docenti, per gli Studenti In collaborazione con l Università Bocconi EFFICACY PROGETTI PILOTA GIÀ SVOLTI SUL DIGITALE Progetti pilota: Marzo Giugno 2014 Set-up Chi: scuole
EFFICACY Per la Scuola, per i Docenti, per gli Studenti In collaborazione con l Università Bocconi EFFICACY PROGETTI PILOTA GIÀ SVOLTI SUL DIGITALE Progetti pilota: Marzo Giugno 2014 Set-up Chi: scuole
Comportamenti problema: il supporto delle tecnologie
 La gestione educativa delle crisi comportamentali Comportamenti problema: il supporto delle tecnologie 27 Marzo 2015 CTS MARCONI Grazia Mazzocchi Francesco Valentini Il punto di partenza E possibile intendere
La gestione educativa delle crisi comportamentali Comportamenti problema: il supporto delle tecnologie 27 Marzo 2015 CTS MARCONI Grazia Mazzocchi Francesco Valentini Il punto di partenza E possibile intendere
Salto di felicità, salto di qualità.
 Salto di felicità, salto di qualità. La felicità d impresa porta la competitività. Un salto di qualità! È un invito rivolto a tutti noi, che ci esorta a cambiare atteggiamento, rompendo gli schemi a cui
Salto di felicità, salto di qualità. La felicità d impresa porta la competitività. Un salto di qualità! È un invito rivolto a tutti noi, che ci esorta a cambiare atteggiamento, rompendo gli schemi a cui
Complementarietà e sviluppo di sinergie con il programma per l ambiente e l azione per il clima LIFE a supporto dei PSR 2014/2020
 Complementarietà e sviluppo di sinergie con il programma per l ambiente e l azione per il clima LIFE a supporto dei PSR 2014/2020 1. Istituzione proponente Consiglio per la ricerca in agricoltura e l analisi
Complementarietà e sviluppo di sinergie con il programma per l ambiente e l azione per il clima LIFE a supporto dei PSR 2014/2020 1. Istituzione proponente Consiglio per la ricerca in agricoltura e l analisi
Un sorriso non basta: strategie di accoglienza per fare marketing al museo
 Vetrina del territorio e strumento di business: linee guida per un Museum Shop di qualità Convegno Firenze, Sala della Scherma, Fortezza da Basso Salone dell Arte e del Restauro, 11 novembre 2016 Un sorriso
Vetrina del territorio e strumento di business: linee guida per un Museum Shop di qualità Convegno Firenze, Sala della Scherma, Fortezza da Basso Salone dell Arte e del Restauro, 11 novembre 2016 Un sorriso
Attività di Ufficio Stampa, modalità operative
 Attività di Ufficio Stampa, modalità operative L Ufficio Stampa dell Università di Firenze si occupa dei rapporti fra l istituzione e l universo dei media, come previsto dalla L. 150/2000. La funzione
Attività di Ufficio Stampa, modalità operative L Ufficio Stampa dell Università di Firenze si occupa dei rapporti fra l istituzione e l universo dei media, come previsto dalla L. 150/2000. La funzione
WEB 2.0: Utilità dei Social Network Nella comunicazione sanitaria. Mauro Bonomini Medicina di Gruppo Rose Selvatiche Parma
 : Utilità dei Social Network Nella comunicazione sanitaria Mauro Bonomini Medicina di Gruppo Rose Selvatiche Parma 18-12-2010 Introduzione Information and Communication Technology Informazione (NON semplicemente
: Utilità dei Social Network Nella comunicazione sanitaria Mauro Bonomini Medicina di Gruppo Rose Selvatiche Parma 18-12-2010 Introduzione Information and Communication Technology Informazione (NON semplicemente
CAPITOLO CAPIT 0 Cultura organizzativa e valori ganizza etici
 CAPITOLO 10 Cultura organizzativa e valori etici Agenda Cultura organizzativa Cultura e progettazione Cultura e performance Valori etici nelle organizzazioni Responsabilità sociale d impresa Formare cultura
CAPITOLO 10 Cultura organizzativa e valori etici Agenda Cultura organizzativa Cultura e progettazione Cultura e performance Valori etici nelle organizzazioni Responsabilità sociale d impresa Formare cultura
PIANO DI COMUNICAZIONE DEL GOVERNO LINEE GUIDA
 PIANO DI COMUNICAZIONE DEL GOVERNO LINEE GUIDA Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Dei Ministri con delega all Informazione, la Comunicazione istituzionale, l Editoria e il Coordinamento
PIANO DI COMUNICAZIONE DEL GOVERNO LINEE GUIDA Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Dei Ministri con delega all Informazione, la Comunicazione istituzionale, l Editoria e il Coordinamento
PIANO STRATEGICO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE CAMPANIA
 PIANO STRATEGICO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE CAMPANIA 1 Premessa: La Regione Campania punta su un disegno strategico unitario, integrato e incentrato su azioni concrete a favore di cittadini,
PIANO STRATEGICO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE CAMPANIA 1 Premessa: La Regione Campania punta su un disegno strategico unitario, integrato e incentrato su azioni concrete a favore di cittadini,
Cittadinanza digitale e qualità della vita
 Cittadinanza digitale e qualità della vita Questo materiale didattico è stato realizzato da Formez PA nel Progetto PerformancePA, Ambito A Linea 1, in convenzione con il Dipartimento della Funzione Pubblica,
Cittadinanza digitale e qualità della vita Questo materiale didattico è stato realizzato da Formez PA nel Progetto PerformancePA, Ambito A Linea 1, in convenzione con il Dipartimento della Funzione Pubblica,
La.Pro.Di. TREKKING A PONZA
 Via Caio Ponzio Telesino, 26 82037 Telese Terme (BN) tel.0824 976246 - fax 0824 975029 Codice scuola: BNIS00200T - e-mail: bnis00200t@istruzione.it sito web www.iistelese.it Il Dirigente Scolastico Domenica
Via Caio Ponzio Telesino, 26 82037 Telese Terme (BN) tel.0824 976246 - fax 0824 975029 Codice scuola: BNIS00200T - e-mail: bnis00200t@istruzione.it sito web www.iistelese.it Il Dirigente Scolastico Domenica
29/09/2014. Etica e comunicazione del rischio: il ruolo delle istituzioni. Licia Ravarotto. sicurezza alimentare comunicazione
 Corso di formazione «La comunicazione e l informazione in rete dei SIAN e SVet: obblighi normativi» Bologna, 30 settembre 2014 Etica e : il ruolo delle istituzioni Licia Ravarotto lravarotto@izsvenezie.it
Corso di formazione «La comunicazione e l informazione in rete dei SIAN e SVet: obblighi normativi» Bologna, 30 settembre 2014 Etica e : il ruolo delle istituzioni Licia Ravarotto lravarotto@izsvenezie.it
Con questa tesi quindi si vuole dimostrare quanto sia importante anche nel settore pubblico la valorizzazione di quegli asset intangibili che
 Introduzione Con questa tesi si mira a dimostrare come un analisi accurata e specifica del capitale intellettuale possa far progredire l azienda sanitaria del futuro al fine di migliorare le prestazioni
Introduzione Con questa tesi si mira a dimostrare come un analisi accurata e specifica del capitale intellettuale possa far progredire l azienda sanitaria del futuro al fine di migliorare le prestazioni
LA GESTIONE PROFESSIONALE DELLE RELAZIONI DI RUOLO
 LA GESTIONE PROFESSIONALE DELLE RELAZIONI DI RUOLO Essere una squadra è prima di tutto un modo di pensare 1. Lo scenario Nell attuale situazione caratterizzata da una crescente complessità e discontinuità
LA GESTIONE PROFESSIONALE DELLE RELAZIONI DI RUOLO Essere una squadra è prima di tutto un modo di pensare 1. Lo scenario Nell attuale situazione caratterizzata da una crescente complessità e discontinuità
CURRICOLO TRASVERSALE SCUOLA PRIMARIA a.s. 2015-16
 CURRICOLO TRASVERSALE SCUOLA PRIMARIA a.s. 2015-16 Competenza n 1: Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. Utilizza la lingua italiana per comprendere semplici enunciati e raccontare esperienze
CURRICOLO TRASVERSALE SCUOLA PRIMARIA a.s. 2015-16 Competenza n 1: Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. Utilizza la lingua italiana per comprendere semplici enunciati e raccontare esperienze
Comunicazione e gestione del rischio attraverso la partecipazione della popolazione
 Centro Sanitario Amianto Comunicazione e gestione del rischio attraverso la partecipazione della popolazione Dott. Massimo D Angelo La gestione del rischio Processo decisionale che prende in considerazione
Centro Sanitario Amianto Comunicazione e gestione del rischio attraverso la partecipazione della popolazione Dott. Massimo D Angelo La gestione del rischio Processo decisionale che prende in considerazione
LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
 LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE Scheda didattica a cura di Laura Limido 1 LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE Il concetto di gestione di risorse umane (HRM Human Resource Management) è stato a lungo discusso
LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE Scheda didattica a cura di Laura Limido 1 LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE Il concetto di gestione di risorse umane (HRM Human Resource Management) è stato a lungo discusso
LINKEDIN Il Social professionale per eccellenza. Linkedin DressCode. Tutto quello che devi sapere per entrare nel salotto buono dei social.
 LINKEDIN Il Social professionale per eccellenza Linkedin DressCode. Tutto quello che devi sapere per entrare nel salotto buono dei social. IL MONDO NUOVO Sempre più termini come Facebook, LinkedIn, Youtube,
LINKEDIN Il Social professionale per eccellenza Linkedin DressCode. Tutto quello che devi sapere per entrare nel salotto buono dei social. IL MONDO NUOVO Sempre più termini come Facebook, LinkedIn, Youtube,
Social Media Engagement. Imprese, Enti, Utenti e Social Media: come informare, promuovere, coinvolgere
 Imprese, Enti, Utenti e Social Media: come informare, promuovere, coinvolgere 1. Perché Abbiamo realizzato una serie di esperienze importanti nel mondo del web e dei social media che ci hanno insegnato
Imprese, Enti, Utenti e Social Media: come informare, promuovere, coinvolgere 1. Perché Abbiamo realizzato una serie di esperienze importanti nel mondo del web e dei social media che ci hanno insegnato
I social media per la comunicazione delle università: l'esperienza della Sapienza Danny Cinalli
 I social media per la comunicazione delle università: Danny Cinalli I social media per la comunicazione delle università: Excursus sui nostri profili e la nostra attività editoriale Analisi della crescita
I social media per la comunicazione delle università: Danny Cinalli I social media per la comunicazione delle università: Excursus sui nostri profili e la nostra attività editoriale Analisi della crescita
PIANO GENERALE DI SVILUPPO
 PIANO GENERALE DI SVILUPPO Nel sistema di governo degli Enti Locali i principi di programmazione, valutazione, controllo e rendicontazione sono oggi l inevitabile percorso di buona amministrazione nella
PIANO GENERALE DI SVILUPPO Nel sistema di governo degli Enti Locali i principi di programmazione, valutazione, controllo e rendicontazione sono oggi l inevitabile percorso di buona amministrazione nella
DIREZIONE DIDATTICA DI RACCONIGI CURRICOLO DI LINGUA INGLESE
 DIREZIONE DIDATTICA DI RACCONIGI CURRICOLO DI LINGUA INGLESE PREMESSA Il Curricolo di lingua straniera attualmente in uso nel nostro circolo è stato elaborato tenendo presenti le indicazioni del Progetto
DIREZIONE DIDATTICA DI RACCONIGI CURRICOLO DI LINGUA INGLESE PREMESSA Il Curricolo di lingua straniera attualmente in uso nel nostro circolo è stato elaborato tenendo presenti le indicazioni del Progetto
Docente: Alessandra Fralleoni
 Università Roma Tre Facoltà di Scienze della formazione Corso di laurea in Servizio Sociale e Sociologia L.39 A.A. 2016-2017 13 marzo 2017 Documentazione e scrittura di servizio sociale Strumento fondamentale
Università Roma Tre Facoltà di Scienze della formazione Corso di laurea in Servizio Sociale e Sociologia L.39 A.A. 2016-2017 13 marzo 2017 Documentazione e scrittura di servizio sociale Strumento fondamentale
Il mio voto in Europa: la scelta per il mio futuro
 Il mio voto in Europa: la scelta per il mio futuro RELAZIONE FINALE Progetto di rete dei CDE italiani per le elezioni europee 2014 con il contributo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia
Il mio voto in Europa: la scelta per il mio futuro RELAZIONE FINALE Progetto di rete dei CDE italiani per le elezioni europee 2014 con il contributo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia
PNL, un decalogo per la gestione efficace dell aula
 SEMINARIO DI SVILUPPO PROFESSIONALE DEI FORMATORI IPAF 2016 PNL, un decalogo per la gestione efficace dell aula Pier Angelo Cantù Bologna, 21 Gennaio 2016 Savoia Regency Hotel La PNL E lo studio della
SEMINARIO DI SVILUPPO PROFESSIONALE DEI FORMATORI IPAF 2016 PNL, un decalogo per la gestione efficace dell aula Pier Angelo Cantù Bologna, 21 Gennaio 2016 Savoia Regency Hotel La PNL E lo studio della
La vocazione professionale e la carriera accademica. Report della prima fase di ricerca
 La vocazione professionale e la carriera accademica Report della prima fase di ricerca 1 Obiettivi dell indagine Il focus della nostra ricerca è la vocazione professionale: l esperienza di una passione
La vocazione professionale e la carriera accademica Report della prima fase di ricerca 1 Obiettivi dell indagine Il focus della nostra ricerca è la vocazione professionale: l esperienza di una passione
BORGHI E TURISMO IL CASO BANDIERE ARANCIONI TOURING
 BORGHI E TURISMO IL CASO BANDIERE ARANCIONI TOURING 18 Ottobre 2012 Isabella Andrighetti Area Campagne e Programmi Territoriali Touring Club Italiano bandiere.arancioni@touringclub.it Tel. 02.8526828 Il
BORGHI E TURISMO IL CASO BANDIERE ARANCIONI TOURING 18 Ottobre 2012 Isabella Andrighetti Area Campagne e Programmi Territoriali Touring Club Italiano bandiere.arancioni@touringclub.it Tel. 02.8526828 Il
ATTIVITÀ & CORSI DI FORMAZIONE
 ATTIVITÀ & CORSI DI FORMAZIONE 2017 SFIDE DI OGGI PER COMMERCIANTI E PMI DEL TERRITORIO Commercianti, artigiani e piccole - medie imprese devono essere oggi in grado di sviluppare strategie innovative
ATTIVITÀ & CORSI DI FORMAZIONE 2017 SFIDE DI OGGI PER COMMERCIANTI E PMI DEL TERRITORIO Commercianti, artigiani e piccole - medie imprese devono essere oggi in grado di sviluppare strategie innovative
RESOCONTO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S.2015/16
 Istituto Pontificio Sant'Apollinare Licei paritari indirizzi Classico Scientifico Linguistico Palazzo extraterritoriale Viale Vaticano, 42 00165 ROMA (RM) Tel: +39 06 6987 1265 Fax: +39 06 3936 7700 email:
Istituto Pontificio Sant'Apollinare Licei paritari indirizzi Classico Scientifico Linguistico Palazzo extraterritoriale Viale Vaticano, 42 00165 ROMA (RM) Tel: +39 06 6987 1265 Fax: +39 06 3936 7700 email:
PROPOSTE FORMATIVE LINEE ADA
 ANNO 2016 PROPOSTE FORMATIVE LINEE ADA CRESCITA DELL ADATTABILITÀ DEI LAVORATORI ATTRAVERSO LA FORMAZIONE CONTINUA - REGIONE LAZIO: ASSESSORATO FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA E UNIVERSITÀ ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
ANNO 2016 PROPOSTE FORMATIVE LINEE ADA CRESCITA DELL ADATTABILITÀ DEI LAVORATORI ATTRAVERSO LA FORMAZIONE CONTINUA - REGIONE LAZIO: ASSESSORATO FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA E UNIVERSITÀ ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
Informazioni preliminari AZIENDA B1
 Informazioni preliminari AZIENDA B1 28 Settembre 2017 h.17.00 Il Sole 24 Ore - Via Monte Rosa 91 - Milano Profilo aziendale L azienda mira a creare un servizio innovativo, nei campi del wellness e del
Informazioni preliminari AZIENDA B1 28 Settembre 2017 h.17.00 Il Sole 24 Ore - Via Monte Rosa 91 - Milano Profilo aziendale L azienda mira a creare un servizio innovativo, nei campi del wellness e del
Risorse umane e Diversity Management nelle PMI
 Risorse umane e Diversity Management nelle PMI Gestione delle risorse umane Matrice nord americana Evoluzione negli ultimi 10 anni: Operativo Teorico Dott.ssa Maria Zifaro 2 Gestione delle risorse umane
Risorse umane e Diversity Management nelle PMI Gestione delle risorse umane Matrice nord americana Evoluzione negli ultimi 10 anni: Operativo Teorico Dott.ssa Maria Zifaro 2 Gestione delle risorse umane
INCONTRO CON I COMUNI BANDIERA ARANCIONE Il Network 2017
 INCONTRO CON I COMUNI BANDIERA ARANCIONE Il Network 2017 MILANO, 26 NOVEMBRE 2016 Direzione Strategie Territoriali Novembre 2016 2016 Touring Club Italiano COS È IL NETWORK FOCUS 2017 TUTTE LE ATTIVITÀ
INCONTRO CON I COMUNI BANDIERA ARANCIONE Il Network 2017 MILANO, 26 NOVEMBRE 2016 Direzione Strategie Territoriali Novembre 2016 2016 Touring Club Italiano COS È IL NETWORK FOCUS 2017 TUTTE LE ATTIVITÀ
Reputazione e visibilità online delle destinazioni: raccomandazioni e influencer, nuove leve di promozione
 Reputazione e visibilità online delle destinazioni: raccomandazioni e influencer, nuove leve di promozione BIT 2013 Forum Federturismo 15 febbraio 2013 Josep Ejarque, CEO Four Tourism IL NUOVO RAPPORTO
Reputazione e visibilità online delle destinazioni: raccomandazioni e influencer, nuove leve di promozione BIT 2013 Forum Federturismo 15 febbraio 2013 Josep Ejarque, CEO Four Tourism IL NUOVO RAPPORTO
Corso di SPECIALIZZAZIONE METODOLOGIE E STRATEGIE PER L INSEGNAMENTO INFANTILE
 Proposta 2 Corso di SPECIALIZZAZIONE METODOLOGIE E STRATEGIE PER L INSEGNAMENTO INFANTILE PERCORSO DI FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITA DOCENTE PER L INFANZIA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DEL
Proposta 2 Corso di SPECIALIZZAZIONE METODOLOGIE E STRATEGIE PER L INSEGNAMENTO INFANTILE PERCORSO DI FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITA DOCENTE PER L INFANZIA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DEL
Lezione maggio 2010
 Lezione 17 14 maggio 2010 Promotion Insieme di iniziative che stimolano, sostengono, spingono le vendite di un prodotto Tali iniziative presuppongono sempre attività di comunicazione Comunicazione di marketing,
Lezione 17 14 maggio 2010 Promotion Insieme di iniziative che stimolano, sostengono, spingono le vendite di un prodotto Tali iniziative presuppongono sempre attività di comunicazione Comunicazione di marketing,
Comunicazione d'impresa
 Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Corso di Laurea in Lingue e Culture Straniere (LIN-AZ) Comunicazione d'impresa Anno Accademico 20112-2013 Prof. Fabio Forlani Per contatti: fabio.forlani@uniurb.it
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Corso di Laurea in Lingue e Culture Straniere (LIN-AZ) Comunicazione d'impresa Anno Accademico 20112-2013 Prof. Fabio Forlani Per contatti: fabio.forlani@uniurb.it
New Media Events and Communication
 Corso di specializzazione New Media Events and Communication Obiettivi del corso Il corso di specializzazione New Media Events and Communication mira a trasferire ai partecipanti gli strumenti e le tecniche
Corso di specializzazione New Media Events and Communication Obiettivi del corso Il corso di specializzazione New Media Events and Communication mira a trasferire ai partecipanti gli strumenti e le tecniche
Teorie organizzative, relazioni inter-organizzative e ambiente
 Teorie organizzative, relazioni inter-organizzative e ambiente Lo studio delle organizzazioni come disciplina Negli anni 60 si assiste ad un primo tentativo di raggruppamento di riflessioni organizzative
Teorie organizzative, relazioni inter-organizzative e ambiente Lo studio delle organizzazioni come disciplina Negli anni 60 si assiste ad un primo tentativo di raggruppamento di riflessioni organizzative
ZETAFORM Servizi di formazione, orientamento e consulenza. presentazione aziendale
 ZETAFORM Servizi di formazione, orientamento e consulenza presentazione aziendale Chi siamo Zetaform è un Ente di formazione, orientamento e consulenza aziendale che opera sul territorio locale e nazionale:
ZETAFORM Servizi di formazione, orientamento e consulenza presentazione aziendale Chi siamo Zetaform è un Ente di formazione, orientamento e consulenza aziendale che opera sul territorio locale e nazionale:
COMUNICAZIONE D IMPRESA
 COMUNICAZIONE D IMPRESA - La Comunicazione d Impresa - Overview ALESSANDRA POGGIANI - COMUNICAZIONE D IMPRESA LA COMUNICAZIONE D'IMPRESA La comunicazione d impresa consiste principalmente in un attività
COMUNICAZIONE D IMPRESA - La Comunicazione d Impresa - Overview ALESSANDRA POGGIANI - COMUNICAZIONE D IMPRESA LA COMUNICAZIONE D'IMPRESA La comunicazione d impresa consiste principalmente in un attività
PROF. RAFFAELLA AMICUCCI MATERIA: GEOGRAFIA CLASSE: IIA
 PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DOCENTE ANNO SCOLASTICO 2013-14 PROF. RAFFAELLA AMICUCCI MATERIA: GEOGRAFIA CLASSE: IIA DATA DI PRESENTAZIONE: 30/11/2013 FINALITÀ E OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA La geografia
PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DOCENTE ANNO SCOLASTICO 2013-14 PROF. RAFFAELLA AMICUCCI MATERIA: GEOGRAFIA CLASSE: IIA DATA DI PRESENTAZIONE: 30/11/2013 FINALITÀ E OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA La geografia
IL SENSO DELLA PSICOLOGIA
 INSEGNAMENTO DI: PSICOLOGIA GENERALE IL SENSO DELLA PSICOLOGIA PROF.SSA ANNAMARIA SCHIANO Indice 1 IL SENSO DELLA PSICOLOGIA -----------------------------------------------------------------------------------------
INSEGNAMENTO DI: PSICOLOGIA GENERALE IL SENSO DELLA PSICOLOGIA PROF.SSA ANNAMARIA SCHIANO Indice 1 IL SENSO DELLA PSICOLOGIA -----------------------------------------------------------------------------------------
L importanza di un approccio strategico ai fondi europei a gestione diretta
 L importanza di un approccio strategico ai fondi europei a gestione diretta Delegazione di Confindustria presso l Ue LEONARDO PINNA Le principali fonti di finanziamento EU BUDGET GESTIONE CENTRALIZZATA
L importanza di un approccio strategico ai fondi europei a gestione diretta Delegazione di Confindustria presso l Ue LEONARDO PINNA Le principali fonti di finanziamento EU BUDGET GESTIONE CENTRALIZZATA
Istituto Superiore di Sanità Osservatorio Fumo, Alcol e Droga
 CARATTERISTICHE DELL ATTIVITÀ SVOLTA DAL SERVIZIO DI TELEFONO VERDE CONTRO IL FUMO 800 554088 DELL ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ: I DATI DELLE TELEFONATE DAL 2000 AL 2004 Alessandra Di Pucchio, Enrica Pizzi,
CARATTERISTICHE DELL ATTIVITÀ SVOLTA DAL SERVIZIO DI TELEFONO VERDE CONTRO IL FUMO 800 554088 DELL ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ: I DATI DELLE TELEFONATE DAL 2000 AL 2004 Alessandra Di Pucchio, Enrica Pizzi,
Lavorare con l Europa negli enti locali Percorso di assistenza tecnica rivolto alla Provincia di Mantova
 Lavorare con l Europa negli enti locali Percorso di assistenza tecnica rivolto alla Provincia di Mantova Provincia di Mantova, 23 marzo 2017 Giuseppe Caruso - Project Manager Ufficio Politiche europee
Lavorare con l Europa negli enti locali Percorso di assistenza tecnica rivolto alla Provincia di Mantova Provincia di Mantova, 23 marzo 2017 Giuseppe Caruso - Project Manager Ufficio Politiche europee
CSR E VALORE DELLE RETI D IMPRESA Rossella Sobrero - 23 maggio 2017
 CSR E VALORE DELLE RETI D IMPRESA Rossella Sobrero - 23 maggio 2017 COSA SONO LE RETI D IMPRESA La CSR è la capacità dell impresa di coniugare business e attenzione all ambiente e al sociale e di coinvolgere
CSR E VALORE DELLE RETI D IMPRESA Rossella Sobrero - 23 maggio 2017 COSA SONO LE RETI D IMPRESA La CSR è la capacità dell impresa di coniugare business e attenzione all ambiente e al sociale e di coinvolgere
2015 ANNO EUROPEO PER LO SVILUPPO un opportunità da perseguire
 2015 ANNO EUROPEO PER LO SVILUPPO un opportunità da perseguire 13 Aprile 2015 Regione Molise Relatore: Dr.ssa Maria Grazia Rando Funzionario MAECI DGCS referente per il coordinamento della Cooperazione
2015 ANNO EUROPEO PER LO SVILUPPO un opportunità da perseguire 13 Aprile 2015 Regione Molise Relatore: Dr.ssa Maria Grazia Rando Funzionario MAECI DGCS referente per il coordinamento della Cooperazione
Social media management Social Media Strategy Proff. Giovanni Ciofalo, Stefano Epifani a.a. 2016/2017
 Social media management Social Media Strategy Proff. Giovanni Ciofalo, Stefano Epifani a.a. 2016/2017 4 Le fasi 1. Pianificazione 1.1 Strategica 1.2 consiste nell identificazione degli obiettivi strategici,
Social media management Social Media Strategy Proff. Giovanni Ciofalo, Stefano Epifani a.a. 2016/2017 4 Le fasi 1. Pianificazione 1.1 Strategica 1.2 consiste nell identificazione degli obiettivi strategici,
La mappa degli Stakeholder
 La mappa degli Stakeholder Edward Freeman, autore del libro Strategic Management: A Stakeholder Approach, fu il primo a coniare la definizione della parola Stakeholder (to hold a stake), che significa
La mappa degli Stakeholder Edward Freeman, autore del libro Strategic Management: A Stakeholder Approach, fu il primo a coniare la definizione della parola Stakeholder (to hold a stake), che significa
D E L E G A Z I O N E D I B R U X E L L E S LA NUOVA STRATEGIA EUROPEA PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI
 D E L E G A Z I O N E D I B R U X E L L E S LA NUOVA STRATEGIA EUROPEA PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI Serie La lente sull Ue n 14 Nota di presentazione del documento pubblicato dalla Commissione
D E L E G A Z I O N E D I B R U X E L L E S LA NUOVA STRATEGIA EUROPEA PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI Serie La lente sull Ue n 14 Nota di presentazione del documento pubblicato dalla Commissione
Gestire la differenza nelle organizzazioni: dalla teoria alla pratica
 Gestire la differenza nelle organizzazioni: dalla teoria alla pratica Barbara De Micheli Fondazione Giacomo Brodolini La Fondazione Giacomo Brodolini La Fondazione Giacomo Brodolini, nasce nel 1971 come
Gestire la differenza nelle organizzazioni: dalla teoria alla pratica Barbara De Micheli Fondazione Giacomo Brodolini La Fondazione Giacomo Brodolini La Fondazione Giacomo Brodolini, nasce nel 1971 come
IL MERCATO IMMOBILIARE CAMBIA - CONTINUAMENTE
 IL MERCATO IMMOBILIARE CAMBIA - CONTINUAMENTE OOGNI VOLTA CHE SI CREA UNO SCENARIO DIVERSO NASCE L ESIGENZA DI UNA REAZIONE ADEGUATA PERCHE IL MERCATO CI. PROVOCA, E NOI DOBBIAMO REAGIRE E. CAMBIARE LE
IL MERCATO IMMOBILIARE CAMBIA - CONTINUAMENTE OOGNI VOLTA CHE SI CREA UNO SCENARIO DIVERSO NASCE L ESIGENZA DI UNA REAZIONE ADEGUATA PERCHE IL MERCATO CI. PROVOCA, E NOI DOBBIAMO REAGIRE E. CAMBIARE LE
Servizi HR. Servizi personalizzati per la crescita delle organizzazioni e delle persone che le compongono
 Servizi personalizzati per la crescita delle organizzazioni e delle persone che le compongono Soluzioni concrete per lo sviluppo delle imprese. Le vostre domande Il dinamismo dei mercati e i continui mutamenti
Servizi personalizzati per la crescita delle organizzazioni e delle persone che le compongono Soluzioni concrete per lo sviluppo delle imprese. Le vostre domande Il dinamismo dei mercati e i continui mutamenti
Progetto DSA: Guida al metodo di studio
 Progetto DSA: Guida al metodo di studio CESPD - Centro Studi e Ricerche per la Disabilità Scuola di Psicologia Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia Scuola di Ingegneria Dipartimento di
Progetto DSA: Guida al metodo di studio CESPD - Centro Studi e Ricerche per la Disabilità Scuola di Psicologia Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia Scuola di Ingegneria Dipartimento di
PRESENTAZIONE SOCIAL
 PRESENTAZIONE SOCIAL SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATI Social Network Tools di analisi dati Analisi Target e Competitors Campagne sponsorizzate SOCIAL MEDIA STRATEGY Piano Editoriale Hashtag Contenuti
PRESENTAZIONE SOCIAL SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATI Social Network Tools di analisi dati Analisi Target e Competitors Campagne sponsorizzate SOCIAL MEDIA STRATEGY Piano Editoriale Hashtag Contenuti
PROF. Silvia Tiribelli MATERIA: GEOGRAFIA CLASSE: II D
 PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DOCENTE ANNO SCOLASTICO 2013-14 PROF. Silvia Tiribelli MATERIA: GEOGRAFIA CLASSE: II D DATA DI PRESENTAZIONE: 30/11/2013 FINALITÀ E OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA La geografia
PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DOCENTE ANNO SCOLASTICO 2013-14 PROF. Silvia Tiribelli MATERIA: GEOGRAFIA CLASSE: II D DATA DI PRESENTAZIONE: 30/11/2013 FINALITÀ E OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA La geografia
LAVORO COLLABORATIVO PARTE 1 - MODALITÀ' PER PROMUOVERE LA RISORSA COMPAGNI
 LAVORO COLLABORATIVO PARTE 1 - MODALITÀ' PER PROMUOVERE LA RISORSA COMPAGNI 1 CREARE UN CLIMA INCLUSIVO 2 CONOSCERE LA DIFFICOLTÀ DEL COMPAGNO 4 linee operative: - abbassare i livelli di competitività:
LAVORO COLLABORATIVO PARTE 1 - MODALITÀ' PER PROMUOVERE LA RISORSA COMPAGNI 1 CREARE UN CLIMA INCLUSIVO 2 CONOSCERE LA DIFFICOLTÀ DEL COMPAGNO 4 linee operative: - abbassare i livelli di competitività:
Giornalismo e social media
 Giornalismo e social media Innovazione e analisi dei modelli di giornalismo Laboratorio di tecniche e linguaggi del giornalismo Prof. ssa Elena Valentini Roma, 31 ottobre 2014 Obiettivi formativi e competenze
Giornalismo e social media Innovazione e analisi dei modelli di giornalismo Laboratorio di tecniche e linguaggi del giornalismo Prof. ssa Elena Valentini Roma, 31 ottobre 2014 Obiettivi formativi e competenze
L ERA INFORMATICA: RISCHI E POTENZIALITA
 L ERA INFORMATICA: RISCHI E POTENZIALITA Un percorso con genitori, educatori e giovani tra luci e ombre delle nuove tecnologie della comunicazione 21/02/2011 Dr. Alberto Valsecchi NEW MEDIA LE IMPLICAZIONI
L ERA INFORMATICA: RISCHI E POTENZIALITA Un percorso con genitori, educatori e giovani tra luci e ombre delle nuove tecnologie della comunicazione 21/02/2011 Dr. Alberto Valsecchi NEW MEDIA LE IMPLICAZIONI
Fai centro con i tuoi annunci info:
 Fai centro con i tuoi annunci Trova subito chi cerchi! INSIEME STUDIAMO LA MIGLIORE STRATEGIA FVJOB Portale Social del lavoro del Friuli Venezia Giulia Sede operativa: Via Don Bosco 2, 33100 Udine cell.
Fai centro con i tuoi annunci Trova subito chi cerchi! INSIEME STUDIAMO LA MIGLIORE STRATEGIA FVJOB Portale Social del lavoro del Friuli Venezia Giulia Sede operativa: Via Don Bosco 2, 33100 Udine cell.
Verso nuove forme di energia
 Verso nuove forme di energia Un nuovo scenario energetico Il modo di produrre elettricità sta cambiando. L evoluzione del mercato, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il progresso tecnologico della rete
Verso nuove forme di energia Un nuovo scenario energetico Il modo di produrre elettricità sta cambiando. L evoluzione del mercato, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il progresso tecnologico della rete
Inaugurazione Training Centre Roma, 24 febbraio 2017
 Inaugurazione Training Centre Roma, 24 febbraio 2017 L importanza della formazione: lo stato dell arte in Italia Barbara Quacquarelli Vicedirettore del Centro di Ricerca Bicocca Training & Development,
Inaugurazione Training Centre Roma, 24 febbraio 2017 L importanza della formazione: lo stato dell arte in Italia Barbara Quacquarelli Vicedirettore del Centro di Ricerca Bicocca Training & Development,
