Università degli studi di Udine
|
|
|
- Cinzia De Angelis
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Università degli studi di Udine VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI Prof. Nidia Batic febbraio marzo 2015
2 PERCHÉ SI VALUTA MIGLIORARE MONITORARE EDUCARE COMUNICARE Apprendimento Progetto educativo didattico Intervento dell insegnante sul piano didattico, educativo e formativo Motivazione Relazioni Servizi POF Processi di apprendimento e sviluppo Raggiungimento degli obiettivi educativi, formativi e didattico disciplinari (efficacia del progetto e dell intervento) Continuità verticale (passaggio da un ordine di scuola a quello successivo) Continuità orizzontale (alle famiglie)
3 Ogni valutazione è legata ad un momento decisionale in quanto, sulla base della valutazione, l alunno o l istituzione si troveranno a dover prendere delle decisioni.
4 COSA SI VALUTA ALUNNI apprendimento (conoscenze, abilità) processi di apprendimento competenze aspetti educativi (comportamenti sociali/relazionali) aspetti formativi (dimensione individuale: autostima, capacità riflessive, autocritiche, ecc.) potenzialità INSEGNANTI POF SCUOLA metodo di insegnamento stile di insegnamento efficacia dell insegnamento progetti Piano dell offerta formativa organizzazione servizi
5 VALUTAZIONE INIZIALE = V. DIAGNOSTICA VALUTAZIONE INTERMEDIA = V. FORMATIVA QUANDO SI VALUTA Capire i prerequisiti al fine di avviare eventuali azioni di recupero e per sapere da dove partire per il percorso di insegnamento Verificare il processo di insegnamento / apprendimento per valutare l adeguatezza del metodo ed eventualmente modificarlo Verificare il raggiungimento di obiettivi intermedi Verificare i tempi di apprendimento Verificare le difficoltà di apprendimento Verificare l adeguatezza del progetto VALUTAZIONE FINALE = V. SOMMATIVA VALUTAZIONE PREDITTIVA Verificare il raggiungimento degli obiettivi finali Predire il risultato che un alunno potrà conseguire seguendo un itinerario di studi.
6 COME SI VALUTA STRUMENTI QUALITATIVI Colloquio clinico: valutazione diagnostica Colloquio euristico: valutazione sommativa STRUMENTI QUANTITATIVI Osservazione di comportamenti: valutazione diagnostica, formativa, sommativa Strumenti strutturati per conoscenze e competenze: valutazione diagnostica, formativa, sommativa
7 valutazione Dare valore Esprimere un parere Misura Mettere in condizione di prendere decisioni Verifica raggiungimento traguardo Osservazione Giudizio
8 DEFINIZIONE La valutazione è la verifica di conformità tra risultati attesi e risultati ottenuti min max
9 VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI COGNITIVI Obiettivi indotti Percorso progettuale: 1. Valutazione diagnostica 2. Individuazione dei risultati attesi 3. Pianificazione delle attività 4. Attuazione del progetto 5. Valutazione
10 1. Valutazione diagnostica Ricognizione delle conoscenze, abilità, competenze dei bambini. Le carenze, gli errori, le misconoscenze diventano il punto di partenza per l attività didattica Strumenti: colloquio clinico, prova 2. Individuazione dei risultati attesi Si definiscono i contenuti che gli alunni dovranno acquisire e che rappresenteranno i riferimenti su cui si baserà la valutazione.
11 3. Pianificazione delle attività Individuazione di: Risorse umane in termini di conoscenze / competenze necessarie Risorse materiali Risorse finanziarie Durata Temporizzazione (diagramma di Gantt) Attività da svolgere per il raggiungimento degli obiettivi
12 DIAGRAMMA DI GANTT Progetto A fase 1 attività attività attività attività fase 2 attività attività attività attività.. fine progetto Progetto B fase 1 attività attività attività attività fase 2 attività attività attività attività.. fine progetto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto
13 4. Attuazione del progetto Rigore nell attuazione Flessibilità nel ridefinire gli obiettivi, il metodo, ecc. 5. Valutazione: verifica del raggiungimento degli obiettivi A livello individuale A livello di classe Valutazione del percorso Valutazione sommativa
14 PERCORSO DELLA VALUTAZIONE Obiettivo Risultati attesi Prova Standard di meta* Unità di misura Regola e Descrittore Criterio * INVALSI, Quadro di riferimento teorico del sistema scolastico e delle scuole (ValSiS), giugno 2010, pag.142.
15 Esempio Obiettivo: imparare a fare le somme (coincide con il risultato atteso) Prova: ai bambini vengono distribuite delle schede in cui sono presentati 10 esercizi: 10 somme con numeri a due cifre Standard: 10 somme corrette su 10 Unità di misura: il risultato della somma Regola (individuale) descrittore sintetico 10 somme corrette su somme corrette su somme corrette su somme corrette su somme corrette su o meno di 5 somme corrette su 10 5 Criterio (di classe) valutazione se il 100% ha ottenuto 9 o 10 obiettivo pienamente raggiunto diversamente obiettivo non raggiunto
16 Esempio Obiettivo: comprensione di un testo in una classe seconda Risultati attesi: a) significati delle parole b) ordine cronologico c) ruolo dei personaggi d) fatti e azioni
17 a) Conoscere i significati delle parole Prova: ai bambini è stato consegnato un foglio su cui trovano l elenco di 8 parole nuove presenti nel testo esichiededispecificarneilsignificato Standard: 8 parole conosciute su 8 Unità di misura: la definizione Regola descrittore 8 parole conosciute su parole conosciute su parole conosciute su parole conosciute su 8 6 meno di 5 parole conosciute su 8 5
18 b) ordine cronologico Prova: ai bambini è stata distribuita una scheda in cui sono rappresentate le 5 fasi del testo e si chiede di ordinarle. Standard: 5 fasi in ordine corretto Unità di misura: posizionamento delle fasi Regola descrittore 5 fasi in ordine corretto su fasi in ordine corretto su 5 7 diversamente 5
19 c) ruolo dei personaggi Prova: ai bambini è stato consegnato un foglio su cui sono stati predisposti due elenchi, uno con i nomi dei personaggi e l altro con i loro ruoli. I bambini devono unire correttamente personaggi e ruoli Standard: 5 abbinamenti corretti Unità di misura: abbinamento Regola descrittore 5 abbinamenti corretti su 5 10 diversamente 5
20 d) fatti e azioni riconoscimento Prova: ai bambini è stato consegnato un elenco di fatti / azioni, anche non presenti nel brano, e si chiede di riconoscere quelle presenti nel brano. Ad esempio si elencano 10 fatti / azioni di cui 5 presenti. Standard: 5 fatti/azioni su 5 corretti Unità di misura: la scelta Regola descrittore 5 fatti/azioni su fatti/azioni su 5 più 1 altra azione 7 4 fatti/azioni su 5 6 meno di 4o più di 6 fatti/azioni 5
21 d) fatti e azioni immagini Prova: ai bambini sono state distribuite 3 immagini e devono descrivere l azione con 3 parole chiave ciascuna. Standard: 9 parole chiave corrette Unità di misura: la parola utilizzata Regola descrittore 9 su 9 parole chiave corrette 10 almeno 2 parole chiave per immagine 8 almeno 1 parole chiave per immagine 7 diversamente 5
22 MATRICE DI PERCORSO Obiettivo: COMPRENSIONE DEL TESTO fatti / azioni significato sequenza ruoli riconoscimento immagini totale b su 50 b su 50 b su 50 b su 50 totale 33 su su su su su 40
23 LETTURA DELLA MATRICE Colonna: Consente di individuare quali bambini hanno avuto più difficoltà sul singolo indicatore / obiettivo. Il totale di colonna indica il livello globalmente raggiunto dalla classe. Consente di capire dove i bambini hanno trovato più o meno difficoltà e di valutare se l obiettivo èstatoraggiunto. Riga: Consentedianalizzareirisultatiottenutidaogni singolo bambino nelle diverse prove e di capire quali sono i traguardi raggiunti e quelli da raggiungere. Il totale di riga indica il livello totale di apprendimento raggiunto individualmente da ciascun bambino.
24 VALUTAZIONE FINALE DEL PROGETTO Criterio a livello individuale descrittore se totale 49 o se totale da 45 a 48 9 se totale da 40 a 44 8 se totale da 35 a 40 7 se totale da 30 a 34 6 se totale inferiore a 30 5 Criterio a livello di classe valutazione se 80% ha 9 o 10 ob. pienamente raggiunto se 80% ha almeno 8 ob. parzialmente raggiunto diversamente obiettivo non raggiunto
25 Caratteristiche delle prove di verifica Validità. E' riferita agli aspetti qualitativi delle prove. Le prove sono valide se sono strutturate per misurare ciò che devono misurare, e quindi se spaziano su un campione sufficientemente rappresentativo delle conoscenze e/o abilità che si intendono indagare. Attendibilità. E' riferita alla fedeltà delle misurazioni. Le prove sono attendibili se utilizzano sistemi di misura stabili ed omogenei e se hanno determinato preventivamente e senza ambiguità i criteri di interpretazione dei risultati. Se sono replicabili, precise e fedeli. Oggettività e soggettività
26 L'oggettività consiste nella possibilità di predeterminare l esattezza delle risposte e nell' attribuzione del punteggio uguale da parte di tutti gli insegnanti (attendibilità). Rimane comunque un dato di soggettività, che sta nelle decisioni relative alla scelta e alla costruzione della prova. Per diminuire tali rischi è opportuno lavorare in gruppo. Maggiore è il numero di docenti che converge nelle stesse decisioni minore sarà il livello di soggettività.
27 Come costruire un item appropriato? È necessario che: la domanda tenda ad accertare se è stato raggiunto l obiettivo e se rispetta i contenuti che sono stati sviluppati; la domanda sia formulata in maniera univoca e, quindi, si presti ad una sola interpretazione; rispecchi la metodologia didattica usata. i distrattori siano plausibili cosicchélarispostafornita dallo studente rappresenti il risultato di un articolato processo di discriminazione fra le alternative offerte.
28 VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI Bisogni (e quindi Obiettivi) manifesti o latenti Percorso progettuale: 1. Analisi del contesto 2. Valutazione diagnostica 3. Decisione 4. Individuazione degli obiettivi: bisogni => obiettivi 5. Risultati attesi: indicatori di bisogno => risultati attesi 6. Pianificazione delle attività 7. Attuazione del progetto 8. Valutazione: verifica del raggiungimento degli obiettivi
29 BISOGNI LATENTI Parla poco Arrossisce Prestazioni scritte migliori di quelle orali Non è tra i primi nelle attività pratiche Non partecipa alle attività di gruppo DIAGNOSI TIMIDEZZA Comportamenti verbali e gestuali violenti Leader di un gruppo di bulli Prende in giro gli altri Disturba DIAGNOSI AGGRESSIVITÀ
30 TIMIDEZZA AGGRESSIVITÀ INSICUREZZA
31 1) ANALISI DEL CONTESTO L OSSERVAZIONE Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 «Lostileeducativodeidocentisiispiraacriteridiascolto, accompagnamento, interazione partecipata, mediazione comunicativa, con una continua capacità di osservazione del bambino, di presa in carico del suo «mondo», di lettura delle sue scoperte, di sostegno e incoraggiamento all evoluzione dei suoi apprendimenti verso forme di conoscenza sempre più autonome e consapevoli. L osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l originalità, l unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione»
32 Nella scuola dell infanzia l osservazione riveste un ruolo centrale per la programmazione curricolare, fornendo quelle informazioni sullo sviluppo dei bambini che stanno alla base di qualunque intervento didattico ed educativo. Al contempo fornisce elementi utili per la verifica e valutazione del percorso svolto. L osservazione è indispensabile per documentare il percorso formativo di ciascun bambino.
33 Osservare per CONOSCERE Conoscere per COMPRENDERE Comprendere per PROGETTARE e PROGRAMMARE Programmare per INTERVENIRE Intervenire e poi VALUTARE
34 La procedura di osservazione può essere così definita: l osservazione è un operazione di selezione e di strutturazione dei dati in modo da far emergere una rete di significati. La selezione dei dati può essere funzionale ad una ipotesi o all obiettivo dell analisi. La strutturazione dei dati consiste nel loro ripartirli in categorie e classificarli secondo criteri di equivalenza. (Tessaro)
35 Il docente non deve semplicemente chiedersi che cosa osservare, ma prima di tutto perché deve osservare, a quale scopo? Sono diverse le funzioni attribuite all osservazione, e ciascuna converge su specifiche attività valutative: funzione descrittiva è quella più neutrale ed è adatta per l accertamento o per il monitoraggio; funzione formativa si osserva per agire sulla situazione osservata e si agisce per formare (col medesimo obiettivo della valutazione formativa); funzione valutativo sistemica si entra nella seguente spirale: si osserva per valutare,sivaluta per decidere,sidecide per agire; funzione euristica (o osservazione invocata) punta a far emergere ipotesi pertinenti da sottoporre successivamente a controllo; funzione di verifica (o osservazione provocata, attraverso uno stimolo domanda) presenta lo scopo di verificare o di falsificare un ipotesi. (Tessaro)
36 L accertamento intenzionale si ha quando l osservatore si interroga in modo esplicito sui processi analizzati. Con l accertamento intenzionale, attraverso tecniche di osservazione sistematica, le operazioni di rilevazione e misurazione sono predisposte in modo da sapere cosa cercare (indicatori e soglie), quando e dove cercare (in tempi/durate e spazi/luoghi predefiniti). Le fasi fondamentali dell accertamento intenzionale sono: 1. l osservazione sistematica delle situazioni, dei comportamenti, delle azioni; 2. la rilevazione elaregistrazione delle caratteristiche significative (e nell attribuire significato troviamo il collegamento con la valutazione) e dei dati necessari e sufficienti per formulare e verificare le ipotesi di lavoro (collegamento con la verifica), 3. la descrizione delle informazioni qualitative che si considerano significative (processi, atteggiamenti, stili personali, modi specifici di porsi), 4. la misura degli elementi quantitativi, individuando i differenziali (o gli scarti) tra il prima e il dopo, tra un alunno e gli altri. (Tessaro)
37 L accertamento spontaneo, a differenza di quello intenzionale, rientra in una logica di processo; ilsuo compito, infatti, è di rilevare l imprevisto, la novità, ciò che esce gli schemi. Lo scopo dell accertamento spontaneo è di consegnare alla valutazione gli interrogativi di sviluppo per le azioni didattiche e formative. L inatteso è molto importante; spesso viene sommariamente stigmatizzato come un errore, frutto dell ignoranza o del mancato studio; ma non è sempre così: talvolta può risultare frutto della creatività, dell originalità, del pensiero produttivo divergente. Perciò l imprevisto va rilevato e accuratamente ponderato poiché, per migliorare l efficacia formativa, esso può mettere in crisi il progetto didattico, chiedendone modifiche o adattamenti.
38 Griglie di osservazione Registrazioni audio Registrazioni video Diario di bordo Scale di valutazione Disegno Problem solving
39 2. Valutazione diagnostica Dall osservazione si estrapolano quei comportamenti sociali che presentano difformità del rispetto delle regole di convivenza civile e di cittadinanza ma anche quei comportamenti problematici che riguardano il singolo alunno e il suo sviluppo, il suo benessere. Seicomportamenti difformiosservatisipresentano con ricorrenza = indicatori di «bisogno» Tali indicatori saranno collocati entro un quadro di sistema che consentirà di formulare una diagnosi di «bisogno», espressa come «carenza / mancanza di», «incapacità di»
40 3. Decisione A seconda del tipo di problema la decisione se attivare o meno un progetto deve essere presa dall insegnante ma può anche coinvolgere gli insegnanti di classe o l intero collegio docenti. Importante: consapevolezza della scelta condivisione dei valori conoscenza della cultura e del sistema di valori degli alunni non italiani
41 Decisione Il progetto rientra nelle competenze della scuola? Sì No rinvio ai servizi Verifica delle risorse interne (conoscenze, competenze)? Sì No rinvio ai servizi Decisione: c è qualcuno disponibile ad impegnarsi per seguire il caso? Sì No rinvio ai servizi progetto
42 4. Individuazione degli obiettivi: bisogni => obiettivi 5. Risultati attesi: indicatori di bisogno => risultati attesi Il processo è circolare: Comportamento difforme=indicatore di «bisogno» Diagnosi di «bisogno» Obiettivo: «risolvere / rispondere al bisogno» Risultati attesi: i comportamenti si sono modificati e possiamo verificarlo osservando e misurando gli indicatori di bisogno
43 6. Pianificazione delle attività Individuazione di: Risorse umane in termini di conoscenze / competenze necessarie Risorse materiali Risorse finanziarie Durata Temporizzazione (diagramma di Gantt) Attività da svolgere per il raggiungimento degli obiettivi
44 7. Attuazione del progetto Rigore nell attuazione Flessibilità nel ridefinire gli obiettivi, il metodo, ecc. a seguito della valutazione formativa 8. Valutazione: verifica del raggiungimento degli obiettivi A livello individuale A livello di classe Valutazione del percorso Valutazione sommativa
45 PERCORSO DELLA VALUTAZIONE Obiettivo Indicatori Contesto di osservazione Standard Unità di misura Regola e Descrittore Criterio
46 MATRICE DINAMICA DI PERCORSO PER MISURAZIONI RIPETUTE b1 b2 b3 b4... b n totale indicatore A indicatore B t t
47 LETTURA DELLA MATRICE Si ripete l osservazione del medesimo indicatore dalla data 1 alla data t. Colonna: Consente di individuare quali bambini hanno avuto più difficoltà sul singolo indicatore / obiettivo. Il totale di colonna indica il livello globalmente raggiunto dalla classe. Consente di capire dove i bambini hanno trovato più o meno difficoltà e di valutare se l obiettivo èstatoraggiunto. Riga: consente di seguire il percorso fatto da ogni singolo bambino fino al raggiungimento del suo traguardo nell ultima rilevazione in data «t». È una lettura dinamica che consente di capire se e quando il bambino ha raggiunto l obiettivo e con quali difficoltà.
48 nome Ob. 1 Alzare la mano per parlare Ob. 2 Aspettare il turno di parola senza Ob. 3 Intervenire con osservazioni eob. 4 Attenzione ad alzarsi dal banco solo interrompere pertinenti se necessario L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 nome nome no m A A ) A A B B B B C C C C D D D D E E E E F F F F G G G G H H H H I I I I L L L L M M M M N N N N O O O O P P P P Q Q Q Q R R R R S S S S T T T T U U U U T ot T T Tot ot o t
49 Analisi esempio Lavoro di gruppo sul progetto «potenziamento del valore «rispetto» fra gli studenti incremento tendenzialmente crescente a livello di classe nei 4 obiettivi Il picco massimo si osserva alla penultima lezione per tutti e 4 gli obiettivi Solo l obiettivo 4 è stato completamente raggiunto nella nona lezione L obiettivo 1 è quello che ha raggiunto complessivamente punteggi più bassi, l obiettivo 4 quello con risultati minori
50 L alunno Q è quello con i risultati migliori su tutti e 4 gli obiettivi, mentre gli alunni I e U sono quelli che presentano i risultati peggiori Anche gli alunni A e D osservano in modo corretto le regole. Invece gli alunni H e U dimostrano di avere un comportamento irrispettoso.
51 VALUTARE I DIVERSAMENTE ABILI Il curricolo dei bambini diversamente abili prevede la definizione degli obiettivi di apprendimento (cognitivo e comportamentale) sulla base delle potenzialità specifiche di ciascun bambino. Il metodo della valutazione è sempre lo stesso ma quello che cambia sono gli standard, ovvero i risultati attesi.
52 IL VOTO IN PAGELLA Sintesi di aspetti quantitativi e qualitativi. Questione aperta: valutazione «oggettiva» (assoluta) o «personalizzata» (relativa al percorso individuale). Valutazione «oggettiva»: considera i risultati raggiunti, indipendentemente dal percorso individuale (media ponderata dei voti conseguiti nelle prove strutturate o meno) Valutazione «personalizzata»: considera non solo i risultati raggiunti ma valuta l alunno nella sua globalità: percorso formativo individuale, difficoltà e superamento delle stesse, progressi, maturazione personale, conoscenze competenze abilità acquisite
53 LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE Competenza: può essere definita come l'insieme delle conoscenze, abilità e atteggiamenti che consentono ad un individuo di ottenere risultati utili al proprio adattamento negli ambienti per lui significativi e che si manifesta come capacità di affrontare e padroneggiare problemi attraverso l'uso di abilità cognitive e sociali. Le competenze si configurano inoltre come strutturalmente capaci di trasferire la loro valenza in diversi campi generando così dinamicamente anche una spirale di altre conoscenze e competenze. Le competenze, intese come risorse strategiche di diversa natura che il soggetto può sviluppare, si distinguono in:
54 LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE competenze di base: sono gli elementi riconosciuti consensualmente come prerequisiti per l'accesso alla formazione e considerati imprescindibili per inserirsi o reinserirsi positivamente nel mondo del lavoro e per fronteggiare in modo positivo le situazioni di cambiamento (informatica di base, lingua straniera, sicurezza e antinfortunistica, economia, organizzazione, diritto legislativo). competenze tecnico professionali: sono costituite dai saperi e dalle tecniche connessi all'esercizio delle attività operative richiesti da funzioni e processi di lavoro (conoscenze specifiche o procedurali di un determinato settore lavorativo). competenze trasversali (competenze in senso stretto): comprendono l'abilità di diagnosi, di relazione, di problem solving, di decisione, ecc. e in generale, quelle caratteristiche personali che entrano in gioco quando un soggetto si attiva a fronte di una richiesta dell'ambiente organizzativo e che sono ormai ritenute essenziali al fine di produrre la trasformazione di un sapere professionale in un comportamento lavorativo efficace.
55 Nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006, riguardante il tema del «Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli» sono stati messi a confronto tre termini: conoscenze, abilità e competenze. Conoscenze: Indicano il risultato dell assimilazione di informazioni attraverso l apprendimento. Le conoscenze sono l insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro. Abilità: Indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare knowhow per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono suddivise in cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l abilità manuale e l uso di metodi, materiali, strumenti). Competenze: Indicano la capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.
56 IL PERCORSO DELLA CONOSCENZA
57 I livello APPRENDIMENTO DI BASE input Dimensione personale (in continuo divenire) personalità intelligenze risorse interne attitudini conoscenze cultura valori ecc. output = >CONOSCENZE > ABILITA' ELABORAZIONE
58 II livello METACOGNIZIONE = ASTRAZIONE CONSAPEVOLEZZA input Dimensione personale output = > REGOLE > MODELLI > METODI > PROCEDURE > STRATEGIE > MECCANISMI RI-ELABORAZIONE
59 III livello COMPETENZA = transfer di apprendimento che mobilita i tre saperi: sapere, saper fare, saper essere (si verifica in contesto di PROBLEM SOLVING) input Dimensione personale output = > SOLUZIONE DEL PROBLEMA ANALISI = SCOMPOSIZIONE DEL PROBLEMA RICONOSCIMENTO dei termini del problema SELEZIONE (di conoscenze, metodi, regole, modelli, procedure, strategie. e risorse interne ed esterne) VALUTAZIONE delle conseguenze COMBINAZIONE di quanto è stato selezionato INTEGRAZIONE con il sistema di valori APPLICAZIONE
60 IV livello PADRONANZA input Dimensione personale output = > SPIEGAZIONE > TRASMISSIONE INTERIORIZZAZIONE
61 V livello INNOVAZIONE input Dimensione personale output = > SPERIMENTAZIONE > SCOPERTA > PRODUZIONE DI VALORE AGGIUNTO
62 Come valutare le competenze: dalla valutazione dell apprendimento alla valutazione per l apprendimento
63 Nasce negli Stati Uniti degli anni 90 il movimento della valutazione autentica o alternativa con l obiettivo di consentire di esprimere un giudizio esteso sull apprendimento e cioè considerare la capacità di pensiero critico, risolvere problemi, svolgere attività di metacognizione, ragionamento, apprendimento permanente svolgere lavoro in gruppo.
64 La proposta di una prospettiva di valutazione alternativa è stata effettuata da Wiggins (1993) con lo scopo di verificare non solo ciò che uno studente sa, ma CIÒ CHE SA FARE CON QUELLO CHE SA, basandola su una prestazione reale e adeguata all apprendimento, in modo da dare a tutti la possibilità di compiere prestazioni di qualità.
65 Gli studenti assimilano meglio quando hanno a che fare con situazioni reali, rispetto a quando devono apprendere in situazioni decontestualizzate. Per questo motivo è corretto anche valutare l apprendimento non in modo astratto e artificiale, ma attraverso prestazioni creative e contestualizzate. In questa prospettiva l insegnante assume il ruolo di mediatore dell apprendimento, mentre gli studenti diventano esaminatori di se stessi. La valutazione si definisce autentica quando: è un vero accertamento della prestazione perché da essa apprendiamo se gli studenti possono in modo intelligente usare ciò che hanno appreso in situazioni che in modo considerevole li avvicinano a situazioni di adulti e se possono rinnovare nuove situazioni
66 Wiggins (1998) individua le seguenti caratteristiche della valutazione autentica (Teaching for Understanding): È realistica Richiede giudizio e innovazione Richiede agli studenti di costruire la disciplina Replica o simula i contesti nei quali gli adulti sono controllati sul luogo di lavoro, nella vita civile e nella vita personale Accerta l abilità dello studente ad usare efficientemente e realmente un repertorio di conoscenze e di abilità per negoziare un compito complesso. Permette appropriate opportunità di ripetere, di praticare, di consultare risorse, di avere feedback e di perfezionare la prestazione e i prodotti.
67 È realistica: Il compito o i compiti di una prestazione di comprensione replicano i modi nei quali le conoscenza e le abilità sviluppate da una persona sono utilizzate in situazioni del mondo reale. Richiede giudizio e innovazione: Lostudentedeve usare la conoscenza e le abilità saggiamente ed in modo efficace per risolvere problemi non strutturati, la cui soluzione richiede di più che seguire una routine, una procedura stabilita o l inserimento di una conoscenza. Il compito che viene proposto come valutazione non può richiedere solamente la ri esposizione di un argomento, ma l uso della conoscenza in un contesto nuovo che dimostri la comprensione profonda della disciplina.
68 Richiede agli studenti di costruire la disciplina: Invecediridireciòcheglièstatoinsegnatoociò che già conosce, lo studente deve essere in grado di utilizzare strumenti, creare prodotti, inventare soluzioni, giustificare decisioni. Gli studenti devono quindi sperimentare in modo attivo cosa vuol dire fare un compito. Replicaosimulaicontestineiqualigliadultisono controllati sul luogo di lavoro, nella vita civile e nella vita personale. I contesti richiedono situazioni specifiche che hanno costrizioni, finalità e spettatori particolari. I tipici test scolastici sono senza contesto. Glistudentihanno bisogno di sperimentare che cosa vuol dire fare un compito in un posto di lavoro o in altri contesti di vita reale.
69 Accerta l abilità dello studente ad usare efficientemente e realmente un repertorio di conoscenze e di abilità per negoziare un compito complesso. Verificando la qualità del possesso di conoscenze e abilità, l esecuzione di una prestazione reale deve consentire di esprimere un giudizio predittivo riguardo a ciò che lo studente sarebbe capace di fare qualora si trovasse nel contesto reale. Questa caratteristica della prestazione e della valutazione è di particolare importanza perché qualifica la valutazione scolastica come non autoreferenziale.
70 Permette appropriate opportunità di ripetere, di praticare, di consultare risorse, di avere feedback e di perfezionare la prestazione e i prodotti. Per essere educativa una valutazione deve tendere a migliorare la prestazione degli studenti. La complessità della prestazione autentica richiede l uso di conoscenze e abilità, ma soprattutto la loro integrazione in un ciclo di miglioramento continuo: prestazione verifica revisione ripetizione prestazione. Avendo come scopo quello di migliorare la prestazione degli studenti, la valutazione, più che un punto di giudizio terminale, diventa una valutazione per l apprendimento.
71 Wiggins (1990) ha individuato i seguenti tre criteri utilizzati per valutare compiti e/o attività reali: Il compito: deve esigere l uso di conoscenze o di abilità per realizzare un prodotto che è in se stesso completo. Per essere reali e sollecitare un pensiero elevato (argomentazioni, ragionamenti, inferenze, confronti, valutazioni, ecc.) le prestazioni dovrebbero prevedere più di una soluzione possibile.
72 Il contesto: il compito, e di conseguenza la prestazione richiesta, dovrebbe essere inserito entro un contesto reale (a differenza delle richieste delle prove decontestualizzate, oggettive). La prestazione deve indurre a ricercare, utilizzare e trasformare le conoscenze per la loro applicazione in un contesto ben determinato. I criteri di valutazione: non possono essere fondati sul numero di risposte corrette o errate, ma sull applicazione e integrazione di conoscenze e processi che possono essere posseduti dallo studente a livelli diversi.
73 METAVALUTAZIONE La valutazione scolastica si dovrebbe concludere con una riflessione critica: in altre parole sarà la valutazione stessa a farsi valutare. La metavalutazione è consapevolezza del valutare, apice e garanzia della pertinenza e della coerenza delle attività di valutazione. In pratica, ci si chiederà: i criteri di valutazione rispondono coerentemente agli scopi formativi concordati nel progetto? le procedure di verifica tengono conto delle differenze individuali nelle esperienze, negli stili, nelle competenze, nelle reazioni al cambiamento, ecc.? le operazioni e gli strumenti per l accertamento sono tarati e calibrati alle caratteristiche specifiche degli allievi? le metodologie utilizzate per valutare sono le stesse adottate per formare? le competenze e i contenuti sottoposti a valutazione sono coerenti con quelli effettivamente processati nell intervento? (Tessaro)
74 Errori di valutazione da parte dell insegnante La metavalutazione può servire per far emergere gli errori di valutazione che possono essere attribuiti a diverse cause: Errore sistematico Errore di autorappresentazione Errore di genere Errore per contiguità Effetto alone Errore logico errore di aspettativa: effetto Pigmalione o pregiudizio contagioso Errore di tendenza centrale (Tessaro)
75 L errore sistematico consiste nella tendenza spontanea a sopravvalutare o a sottovalutare le prestazioni dello studente. L errore sistematico può, quindi, manifestarsi in due modi antitetici: nell effetto di indulgenza o, all inverso, nell effetto di severità. L errore di autorappresentazione riguarda l influenza dell ideale di sé del valutatore,impostoo negato, nei confronti della personalità del valutato. Se l ideale di sé che il docente si autorappresenta è affermato in termini esclusivi ci possiamo trovare di fronte ad un errore per somiglianza; seinveceil docente ha un idea di sé negativa è probabile un errore per contrasto.
76 L errore di genere è riferito alla diversa attribuzione di valore nei confronti di studenti del proprio o dell altro sesso. Può essere una enfatizzazione dell errore sistematico e/o dell errore di autorappresentazione, dettata da elementi affettivo emotivi (connessi ai sentimenti) o da elementi socioculturali (connessi agli stereotipi: es., le ragazze studiano di più). L errore per contiguità riguarda l influenza reciproca tra valutazioni contemporanee o immediatamente successive e l interferenza di fattori contingenti. Ad esempio, nell interrogazione contemporanea di più soggetti: con molta probabilità le valutazioni risulteranno influenzate dal contesto. Oppure una prestazione leggermente scadente di un soggetto potrebbe, ad esempio, essere valutata sufficientemente se si presenta immediatamente dopo un interrogazione pessima.
77 L effetto di alone, secondo la classica definizione di Thorndike, si configura come l espansione indebita di giudizio: essa si verifica quando un aspetto noto e conosciuto condiziona la valutazione nei confronti di altri aspetti non dipendenti da esso. Per esempio, un linguaggio forbito usato dallo studente può influenzare la valutazione circa la preparazione, lo studio o la reale competenza; così come un compito scritto, preciso e ordinato, può condizionare la valutazione nelle successive interrogazioni orali. L errore logico, descritto da Newcomb e così definito da Guilford, può essere considerato come una particolare forma dell effetto di alone e consiste nello stabilire arbitrari legami logici tra eventi indipendenti o autonomi. Tragliesempidi errori logici ritroviamo note espressioni come: "non ha saputo rispondere perché non si è impegnato nello studio"; «se non ce la fa in latino, non ce la fa neppure in matematica"; "non leggono perché c'è la televisione", e così via.
78 L errore di aspettativa si ha dinanzi a un pregiudizio sulle capacità di colui che si deve valutare e ci si attende che le sue prestazioni vi corrispondano. In tal modo si selezionano le prestazioni estrapolando quelle che si adattano al giudizio precostituito. Rosenthal e Jacobson hanno, a questo proposito, dimostrato come l aspettativa, indipendentemente dalla sua origine, può funzionare come preveggenza che si autorealizza (effetto Pigmalione). L errore di aspettativa nel colloquio o nell interrogazione orale, può tradursi in pregiudizio contagioso (Ancona) il quale non solo comporta interpretazioni soggettive delle risposte, ma addirittura spinge a scegliere e a formulare le domande così da ottenere le risposte desiderate.
79 L errore di tendenza centrale, derivata dal linguaggio statistico, indica il raggrupparsi verso il centro di determinati valori, punteggi o giudizi. Chi valuta tende frequentemente ad utilizzare i valori mediani evitando compromissioni rischiose dando giudizi estremi, molto bassi o molto alti. Nel sistema di valutazione in decimali è netta la tendenza a raggruppare i voti tra il quattro e il sette; nelle check list o nelle scale di valutazione, in cui viene richiesto un giudizio scelto all interno di una scala di valori superiori a tre, siano essi quantitativi (da 1 a 5 oppure da 1 a 7, ecc.) o descrittivi (da nullo a ottimo oppure da sempre a mai, ecc.) si può facilmente riconoscere come la maggior parte delle scelte cada nei valori centrali.
80 Nell applicazione del metodo della valutazione è necessario adottare: Principio della condivisione del metodo con gli alunni (covalutazione) Principio della condivisione di metodo e strumenti con i colleghi (metavalutazione e triangolazione) Principio della condivisione con le famiglie.
81 Le otto Competenze chiave per l apprendimento permanente indicate nelle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sono: Comunicazione nella madrelingua Comunicazione nelle lingue straniere Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia Competenza digitale Imparare a imparare Competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica Imprenditorialità Espressione culturale.
82 LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLIO D ISTRUZIONE 13 febbraio 2015 La certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, rappresenta un atto educativo legato ad un processo di lunga durata e aggiunge informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i risultati del processo formativo, quinquennale e triennale, anche in vista della ulteriore certificazione delle competenze al termine dell obbligo di istruzione del secondo ciclo. Tale operazione, pertanto, piuttosto che come semplice trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, va intesa come valutazione complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini.
83 Da quanto detto emerge che: la maturazione delle competenze costituisce la finalità essenziale di tutto il curricolo; le competenze da certificare sono quelle contenute nel Profilo dello studente; le competenze devono essere promosse, rilevate e valutate in base ai traguardi di sviluppo disciplinari e trasversali riportati nelle Indicazioni; le competenze sono un costrutto complesso che si compone di conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni, potenzialità e attitudini personali; le competenze devono essere oggetto di osservazione, documentazione e valutazione; solo al termine di tale processo si può giungere alla certificazione delle competenze, che nel corso del primo ciclo va fatta due volte, al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.
84 «lo studente è posto al centro dell azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato» (p. 9). Par raggiungere tali finalità generali «le scuole sono chiamate a elaborare il proprio curricolo esercitando così una parte decisiva dell autonomia che la Repubblica attribuisce loro» (p. 13). Il curricolo di istituto è perciò «espressione della libertà d insegnamento e dell autonomia scolastica» e la sua costruzione è un «processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l innovazione educativa» (p. 17). Esso è esplicitato all interno del Piano dell offerta formativa. Principio della continuità: è opportuno definire e condividere, in verticale, sia i traguardi di competenze irrinunciabili alla fine della scuola primaria e alla fine della scuola secondaria di primo grado, sia i criteri e le modalità di valutazione delle competenze stesse.
85 Non è pensabile che si possano formare delle competenze in assenza di un solido bagaglio di contenuti e di saperi disciplinari. La competenza costituisce il livello di uso consapevole e appropriato di tutti gli oggetti di apprendimento, ai quali si applica con effetti elaborativi, metacognitivi e motivazionali. La certificazione delle competenze, oltre a presupporre una corretta e diffusa cultura della valutazione, richiede un azione didattica incisiva e specifica, adeguando le tre operazioni che sostanziano l insegnamento: progettazione attività didattica in classe valutazione.
86 La valutazione delle competenze deve innestarsi in un percorso didattico/formativo che, a monte, utilizza, nuove modalità di insegnamento e apprendimento (ad es. apprendimento cooperativo e laboratoriale). Si rende, pertanto, necessario ripensare il modo di fare scuola, integrando la didattica dei contenuti e dei saperi riferiti ai nuclei fondanti delle discipline con modalità interattive e costruttive di apprendimento. Fondando il proprio insegnamento su esperienze significative che mettono in gioco contenuti e procedure che consentano di imparare facendo, i docenti rendono l alunno protagonista del processo di acquisizione delle competenze. Una padronanza delle competenze di base richiede la riscopertadeinucleifondantidelledisciplineedelloro valore formativo, attraverso scelte orientate al potenziamento della motivazione e dell interesse degli alunni.
87 Per valutare le competenze, però, non si possono utilizzare gli strumenti comunemente usati per la rilevazione delle conoscenze: se l oggetto da valutare è complesso, altrettanto complesso dovrà essere il processo di valutazione, che non si può esaurire in un momento circoscritto e isolato, ma deve prolungarsi nel tempo attraverso una sistematica osservazione deglialunnidifronteallediversesituazionicheglisi presentano. Ai fini dello sviluppo delle competenze, la modalità più efficace è quella che vede l apprendimento situato e distribuito, collocato cioè in un contesto il più possibile reale e ripartito tra più elementi e fattori di comunicazione (materiali cartacei, virtuali, compagni, insegnante, contesti esterni e interni alla scuola, ecc.).
88 La valutazione rappresenta una dimensione importante dell insegnamento perché incide notevolmente sulla formazione della persona, contribuisce a determinare la costruzione dell identità nei ragazzi, può far crescere la fiducia in sé quale presupposto della realizzazione e della riuscita nella scuola e nella vita. Le funzioni da assegnare alla valutazione: formativa proattiva (capacità di percepire in anticipo tendenze o cambiamenti in modo da pianificare i propri interventi per tempo)
89 La valutazione è formativa, aiuta l alunno in un processo di autovalutazione e di autoorientamento (aiuta l alunno ad esplorare sé stesso, conoscersi nella sua interezza, riconoscere le proprie capacità e i propri limiti, conquistare la propria identità, migliorarsi continuamente). La valutazione è proattiva, in quanto mette in moto gli aspetti motivazionali che sorreggono le azioni umane. La valutazione proattiva riconosce ed evidenzia i progressi, anche piccoli, compiuti dall alunno nel suo cammino, gratifica ipassieffettuati,cercadifar crescere in lui le emozioni di riuscita che rappresentano il presupposto per le azioni successive. Le informazioni raccolte durante il processo sono utili anche per effettuare una verifica della qualità del lavoro svolto dall insegnante e per attivare eventuali aggiustamenti del percorso: la valutazione in questo modo diventa formativa anche per l insegnante.
90 Ai sensi del Regolamento della valutazione (DPR n. 122/09) gli insegnanti sono chiamati a valutare gli apprendimenti, in termini di conoscenze e abilità, il comportamento e a certificare le competenze. La certificazione delle competenze assume come sue caratteristiche peculiari la complessità e la processualità: la complessità, in quanto prende in considerazione i diversi aspetti della valutazione: conoscenze, abilità, traguardi per lo sviluppo delle competenze, atteggiamenti da utilizzare in un contesto problematico e più articolato rispetto alla semplice ripetizione e riesposizione dei contenuti appresi; la processualità, che deve sostanziarsi delle rilevazioni effettuate in tutti gli anni precedenti all ultimo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, che documentino, attraverso strumenti che le singole scuole nella loro autonomia possono costruirsi, il grado di avvicinamento degli alunni ai traguardi fissati per ciascuna disciplina e alle competenze delineate nel Profilo dello studente [MATRICE DINAMICA].
91 Parole chiave per guidare la valutazione delle competenze: autenticità dei compiti in rapporto ai contesti e ai problemi posti dal mondo reale processualità della valutazione responsabilità affidata allo studente nelle diverse fasi del processo valutativo globalità della valutazione che tiene conto dell integrazione delle dimensioni cognitive, sociali ed emotive
92 GLI STRUMENTI PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE le prove utilizzate per la valutazione degli apprendimenti non sono affatto adatte per la valutazione delle competenze. È ormai condiviso a livello teorico che la competenza si possa accertare facendo ricorso a a) compiti di realtà (prove autentiche, prove esperte, ecc.) b) osservazioni sistematiche c) autobiografie cognitive.
93 a) Compiti di realtà (prove autentiche, prove esperte, ecc.). I compiti di realtà si identificano nella richiesta rivolta allo studente di risolvere una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica. Pur non escludendo prove che chiamino in causa una sola disciplina, si ritiene opportuno privilegiare prove per la cui risoluzione l alunno debba richiamare in forma integrata, componendoli autonomamente, più apprendimenti acquisiti. Compiti di realtà e progetti però hanno dei limiti in quanto per il loro tramite noi possiamo cogliere la manifestazione esterna della competenza, ossia la capacità dell allievo di portare a termine il compito assegnato, ma veniamo ad ignorare tutto il processo che compie l alunno per arrivare a dare prova della sua competenza. Per tale motivo è opportuno integrare le informazioni con l osservazione.
94 b) Osservazioni sistematiche. Permettono agli insegnanti di rilevare il processo, ossia le operazioni che compie l alunno per interpretare correttamente il compito, per coordinare conoscenze e abilità già possedute, per ricercarne altre, qualora necessarie, e per valorizzare risorse esterne (libri, tecnologie, sussidi vari) e interne (impegno, determinazione, collaborazioni dell insegnante e dei compagni). Saranno osservati i seguenti indicatori di competenza: Autonomia Relazione Partecipazione Responsabilità Flessibilità Consapevolezza. Le osservazioni sistematiche però, in quanto condotte dall insegnante, non consentono di cogliere interamente altri aspetti che caratterizzano il processo: il senso o il significato attribuito dall alunno al proprio lavoro, le intenzioni che lo hanno guidato nello svolgere l attività, le emozioni o gli stati affettivi provati
95 c) Autobiografie cognitive. Si tratta di far raccontare allo stesso alunno: quali sono stati gli aspetti più interessanti per lui e perché, quali sono state le difficoltà che ha incontrato e in che modo le abbia superate, fargli descrivere la successione delle operazioni compiute evidenziando gli errori più frequenti e i possibili miglioramenti far esprimere l autovalutazione non solo del prodotto, ma anche del processo produttivo adottato. La valutazione attraverso la narrazione assume una funzione riflessiva e metacognitiva nel senso che guida il soggetto ad assumere la consapevolezza di come avviene l apprendimento.
96 FINALITÀ DELLA CERTIFICAZIONE la certificazione pone attenzione non solo alla dimensione educativa, ma anche a quella orientativa della scuola del primo ciclo. Pertanto nella redazione del documento sono assunti quali principi di riferimento: la prospettiva orientativa, da cui deriva la scelta di certificare le competenze previste dal Profilo che, nell ottica della valutazione autentica basata sul criterio dell attendibilità,ovverosuprestazionirealiedadeguate, considerano implicitamente ed esplicitamente l apprendimento disciplinare, l apprendimento formale, informale, non formale; la prospettiva di continuità, da cui consegue la scelta di mantenere la stessa struttura all interno del primo ciclo, creando una connessione anche con le prescrizioni in materia di adempimento dell obbligo di istruzione,
97 VALENZA DELLA CERTIFICAZIONE PER COMPETENZE per gli alunni e le loro famiglie un documento leggibile e comparabile per la sua trasparenza; una descrizione degli esiti del percorso formativo; un insieme di elementi espliciti sulla base dei quali gli alunni stessi si possano orientare ed effettuare scelte adeguate; per le istituzioni scolastiche che certificano la descrizione di risultati coerenti con un quadro comune nazionale ed europeo, riferiti ai livelli internazionali ISCED 1 (scuola primaria) e ISCED 2 (scuola secondaria di primo grado) nel rispetto dell autonoma progettazione delle singole scuole; la qualificazione finale del primo ciclo che corrisponde al primo livello EQF; la formulazione di giudizi basati su esiti comprensibili e spendibili anche in altri contesti educativi; una risposta alla domanda di qualità, di trasparenza e di rendicontazione dei risultati di apprendimento e dell offerta formativa; un maggiore riconoscimento sul territorio; per le istituzioni scolastiche che accolgono l alunno un elemento utile per un efficace azione di accompagnamento dell alunno in ingresso; un elemento per favorire la continuità dell offerta formativa, attraverso la condivisione di criteri/metodologie tra i diversi gradi di scuola.
Gli errori di valutazione
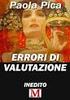 CORSO ITC TOSI Quando l insegnante sbaglia Gli errori di valutazione prof. Fiorino Tessaro Che cosa sono gli errori di valutazione? Sono i fattori soggettivi e personali che inficiano la correttezza valutativa.
CORSO ITC TOSI Quando l insegnante sbaglia Gli errori di valutazione prof. Fiorino Tessaro Che cosa sono gli errori di valutazione? Sono i fattori soggettivi e personali che inficiano la correttezza valutativa.
La certificazione delle competenze nel primo ciclo d istruzione: quali consapevolezze per l azione educativo-didattica?
 ICS G. Galilei Tradate (VA) La certificazione delle competenze nel primo ciclo d istruzione: quali consapevolezze per l azione educativo-didattica? 9 marzo 2016 A proposito di pratiche educative CONOSCENZA
ICS G. Galilei Tradate (VA) La certificazione delle competenze nel primo ciclo d istruzione: quali consapevolezze per l azione educativo-didattica? 9 marzo 2016 A proposito di pratiche educative CONOSCENZA
La ricerca di Black e William
 La ricerca di Black e William 1998 1 Esamina 250 ricerche internazionali su come si effettuano le valutazioni a scuola. L'indivisibilità di istruzione e pratiche di valutazione formativa. Fondamentale
La ricerca di Black e William 1998 1 Esamina 250 ricerche internazionali su come si effettuano le valutazioni a scuola. L'indivisibilità di istruzione e pratiche di valutazione formativa. Fondamentale
Programmazione educativo-didattica -anno scolastico 2011/2012
 Programmazione educativo-didattica -anno scolastico 2011/2012 Nota esplicativa A decorrere dal corrente anno scolastico entrerà in vigore il modello proposto dal D.M. 9/2010 che prevede, al termine del
Programmazione educativo-didattica -anno scolastico 2011/2012 Nota esplicativa A decorrere dal corrente anno scolastico entrerà in vigore il modello proposto dal D.M. 9/2010 che prevede, al termine del
PRESENTAZIONE CURRICOLO IN BASE ALLE COMPETENZE EUROPEE I RIFERIMENTI DELLE INDICAZIONI
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA G. MARCONI Viale G. Rossini, 87-05100 TERNI Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 Cod. Fisc. 80004470557 mail: tric80400t@istruzione.it PRESENTAZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA G. MARCONI Viale G. Rossini, 87-05100 TERNI Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 Cod. Fisc. 80004470557 mail: tric80400t@istruzione.it PRESENTAZIONE
CLASSE SECONDA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA
 CLASSE SECONDA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO SCIENZE DISCIPLINE TRASVERSALI TUTTE TRAGUARDI FORMATIVI COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE
CLASSE SECONDA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO SCIENZE DISCIPLINE TRASVERSALI TUTTE TRAGUARDI FORMATIVI COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE
CLASSE PRIMA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA
 CLASSE PRIMA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO SCIENZE DISCIPLINE TRASVERSALI SCIENZE TRAGUARDI FORMATIVI COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE
CLASSE PRIMA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO SCIENZE DISCIPLINE TRASVERSALI SCIENZE TRAGUARDI FORMATIVI COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE
COMPETENZA: UNA DEFINIZIONE CONDIVISA
 COMPETENZA: UNA DEFINIZIONE CONDIVISA La Commissione Europea ha adottato i termini competenze e competenze chiave preferendolo a competenze di base, in quanto quest ultimo è generalmente riferito alle
COMPETENZA: UNA DEFINIZIONE CONDIVISA La Commissione Europea ha adottato i termini competenze e competenze chiave preferendolo a competenze di base, in quanto quest ultimo è generalmente riferito alle
ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA A.S.2017/2018
 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA A.S.2017/2018 Elaborato ai sensi: delle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 dell allegato n. 2 D.M. n. 139 del 22 AGOSTO 2007 delle Indicazioni
ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA A.S.2017/2018 Elaborato ai sensi: delle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 dell allegato n. 2 D.M. n. 139 del 22 AGOSTO 2007 delle Indicazioni
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO D ISTRUZIONE
 LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO D ISTRUZIONE Certificare le competenze, occasione di miglioramento per riflettere sulla valutazione e per una nuova didattica Dott.ssa Monica MERONI,
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO D ISTRUZIONE Certificare le competenze, occasione di miglioramento per riflettere sulla valutazione e per una nuova didattica Dott.ssa Monica MERONI,
CORSO DI FORMAZIONE ORIENTAMENTO
 CORSO DI FORMAZIONE ORIENTAMENTO PARTNERS CRED (Centro Risorse Educative e Didattiche) zona pisana Scuole zona pisana: secondarie I e II grado a cura di: prof.ssa Serena Piccarducci e prof.ssa Lucia Marzia
CORSO DI FORMAZIONE ORIENTAMENTO PARTNERS CRED (Centro Risorse Educative e Didattiche) zona pisana Scuole zona pisana: secondarie I e II grado a cura di: prof.ssa Serena Piccarducci e prof.ssa Lucia Marzia
VALUTAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE DI SISTEMA
 VALUTAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE DI SISTEMA ( AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO) MASSIMO MORSELLI LABORATORI FORMATIVI PER DOCENTI NEOASSUNTI POLO FORMATIVO LAS A. MODIGLIANI GIUSSANO VALUTAZIONE DEGLI
VALUTAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE DI SISTEMA ( AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO) MASSIMO MORSELLI LABORATORI FORMATIVI PER DOCENTI NEOASSUNTI POLO FORMATIVO LAS A. MODIGLIANI GIUSSANO VALUTAZIONE DEGLI
Curricolo verticale d'istituto e co-progettazione: integrazione tra le competenze dell'esperto e le esigenze della scuola
 Curricolo verticale d'istituto e co-progettazione: integrazione tra le competenze dell'esperto e le esigenze della scuola Paolo Seclì Università di Modena e Reggio Emilia Dip. di Educazione e Scienze Umane
Curricolo verticale d'istituto e co-progettazione: integrazione tra le competenze dell'esperto e le esigenze della scuola Paolo Seclì Università di Modena e Reggio Emilia Dip. di Educazione e Scienze Umane
Obbligo di istruzione
 Art. 1 c. 622 L. 27/12/2006 n. 296 L istruzione impartita per almeno 10 anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di scuola secondaria superiore o di una qualifica
Art. 1 c. 622 L. 27/12/2006 n. 296 L istruzione impartita per almeno 10 anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di scuola secondaria superiore o di una qualifica
ISTITUTO COMPRENSIVO G.PASCOLI -SILVI. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI Sezione POF
 ISTITUTO COMPRENSIVO G.PASCOLI -SILVI OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI Sezione POF 2014-2015 OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI SCUOLA DELL INFANZIA Accoglienza della diversità, delle persone e delle culture Rafforzamento
ISTITUTO COMPRENSIVO G.PASCOLI -SILVI OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI Sezione POF 2014-2015 OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI SCUOLA DELL INFANZIA Accoglienza della diversità, delle persone e delle culture Rafforzamento
La valutazione del percorso scolastico.
 La valutazione del percorso scolastico http://iccarmagnola2.gov.it/ DECRETO MINISTERIALE 742/2017 Articolo l (Finalità della certificazione delle competenze) 1. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie
La valutazione del percorso scolastico http://iccarmagnola2.gov.it/ DECRETO MINISTERIALE 742/2017 Articolo l (Finalità della certificazione delle competenze) 1. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie
Le competenze e i compiti di realtà
 Le competenze e i compiti di realtà Mediaexpo 10 novembre 2016 Le competenze e i compiti di realtà La certificazione delle competenze Che cosa sono le competenze Gli strumenti per la valutazione e l autovalutazione
Le competenze e i compiti di realtà Mediaexpo 10 novembre 2016 Le competenze e i compiti di realtà La certificazione delle competenze Che cosa sono le competenze Gli strumenti per la valutazione e l autovalutazione
Progettazione per competenze
 Progettazione per competenze Fasi della progettazione Organizzazione dei concetti Definizione del percorso cognitivo Descrizione dei processi Definizione degli standard e modalità di certificazione Modalità
Progettazione per competenze Fasi della progettazione Organizzazione dei concetti Definizione del percorso cognitivo Descrizione dei processi Definizione degli standard e modalità di certificazione Modalità
L ORGANIZZAZIONE identità autonomia competenza cittadinanza identità autonomia competenza
 L ORGANIZZAZIONE La scuola dell infanzia vede il bambino in un processo di continua interazione con i pari, gli adulti e la cultura. A tale proposito l organizzazione si propone di promuovere la formazione
L ORGANIZZAZIONE La scuola dell infanzia vede il bambino in un processo di continua interazione con i pari, gli adulti e la cultura. A tale proposito l organizzazione si propone di promuovere la formazione
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
 LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 7-8-9 SETTEMBRE 2015 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO È il luogo dell apprendimen to significativo, della riflessione, della condivisione, della costruzione.... un luogo dove
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 7-8-9 SETTEMBRE 2015 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO È il luogo dell apprendimen to significativo, della riflessione, della condivisione, della costruzione.... un luogo dove
CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESPERIA (FR) SCUOLA DELL INFANZIA - PRIMARIA- SECONDARIA DI PRIMO GRADO CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA Anno Scolastico 2018 2019 INDICE COMPETENZE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESPERIA (FR) SCUOLA DELL INFANZIA - PRIMARIA- SECONDARIA DI PRIMO GRADO CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA Anno Scolastico 2018 2019 INDICE COMPETENZE
PROGETTO BIBLIOTECA. Anno Scolastico
 PROGETTO BIBLIOTECA Anno Scolastico 2016-2017 PREMESSA L'innovazione della scuola passa anche per le biblioteche scolastiche che dovrebbero diventare, nell'idea del Ministero dell'istruzione, dei laboratori
PROGETTO BIBLIOTECA Anno Scolastico 2016-2017 PREMESSA L'innovazione della scuola passa anche per le biblioteche scolastiche che dovrebbero diventare, nell'idea del Ministero dell'istruzione, dei laboratori
C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015
 C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015 - Certificazione delle competenze ha FUNZIONE EDUCATIVA di ATTESTAZIONE delle competenze in fase di acquisizione - La proposta del modello unico risponde alla necessità di
C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015 - Certificazione delle competenze ha FUNZIONE EDUCATIVA di ATTESTAZIONE delle competenze in fase di acquisizione - La proposta del modello unico risponde alla necessità di
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
 LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Aprile 2018 1 D.lgs. 62/2017 DM 741/2017 DM 742/2017 Nota Miur n. 1865/2017 RIFERIMENTI NORMATIVI Documento di orientamento per la redazione della prova d'italiano nell'esame
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Aprile 2018 1 D.lgs. 62/2017 DM 741/2017 DM 742/2017 Nota Miur n. 1865/2017 RIFERIMENTI NORMATIVI Documento di orientamento per la redazione della prova d'italiano nell'esame
VALUTAZIONE DEGLI ESITI FORMATIVI
 VALUTAZIONE DEGLI ESITI FORMATIVI Valutazione interna La valutazione degli alunni è parte integrante della programmazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento
VALUTAZIONE DEGLI ESITI FORMATIVI Valutazione interna La valutazione degli alunni è parte integrante della programmazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
 23 FEBBRAIO 2016 DIPARTIMENTI DISCIPLINARI IN VERTICALE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE GRUPPO DI LAVORO DIRIGENTE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA: M. Beatrice Baio, Cinzia Ricci SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
23 FEBBRAIO 2016 DIPARTIMENTI DISCIPLINARI IN VERTICALE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE GRUPPO DI LAVORO DIRIGENTE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA: M. Beatrice Baio, Cinzia Ricci SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
Indicazioni operative per l elaborazione di un curricolo verticale per competenze
 Indicazioni operative per l elaborazione di un curricolo verticale per competenze Da L organizzazione del curricolo A partire del curricolo d istituto verticale i docenti individuano le esperienze di apprendimento
Indicazioni operative per l elaborazione di un curricolo verticale per competenze Da L organizzazione del curricolo A partire del curricolo d istituto verticale i docenti individuano le esperienze di apprendimento
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. n- 139 del 22/08/2007 Documento tecnico Allegato 2)
 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. n- 139 del 22/08/2007 Documento tecnico Allegato 2) chiave europee Imparare a imparare di cittadinanza C1 Imparare ad imparare Indicatori Descrittori Livelli a.
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. n- 139 del 22/08/2007 Documento tecnico Allegato 2) chiave europee Imparare a imparare di cittadinanza C1 Imparare ad imparare Indicatori Descrittori Livelli a.
Sana e robusta costituzione
 Sana e robusta costituzione Le sfide di Cittadinanza e Costituzione per costruire le competenze sociali e civiche dai 3 ai 14 anni. Riflessioni, strumenti e metodi II^ parte Scuola dell infanzia e Primaria
Sana e robusta costituzione Le sfide di Cittadinanza e Costituzione per costruire le competenze sociali e civiche dai 3 ai 14 anni. Riflessioni, strumenti e metodi II^ parte Scuola dell infanzia e Primaria
CLASSE SECONDA E TERZA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI RIFERIMENTO CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
 CLASSE SECONDA E TERZA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI RIFERIMENTO CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE DISCIPLINA DI RIFERIMENTO ARTE E IMMAGINE DISCIPLINE TRASVERSALI TUTTE COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
CLASSE SECONDA E TERZA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI RIFERIMENTO CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE DISCIPLINA DI RIFERIMENTO ARTE E IMMAGINE DISCIPLINE TRASVERSALI TUTTE COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
CLASSE TERZA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
 CLASSE TERZA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO TECNOLOGIA E INFORMATICA DISCIPLINE TRASVERSALI TUTTE COMPETENZA CHIAVE
CLASSE TERZA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO TECNOLOGIA E INFORMATICA DISCIPLINE TRASVERSALI TUTTE COMPETENZA CHIAVE
Lezione Le prestazioni autentiche
 Lezione Le prestazioni autentiche Le Prestazioni Autentiche: Permettono allo studente di dimostrare ciò che sa fare con ciò che sa, utilizzando conoscenze, abilità e disposizioni in situazioni contestualizzate,
Lezione Le prestazioni autentiche Le Prestazioni Autentiche: Permettono allo studente di dimostrare ciò che sa fare con ciò che sa, utilizzando conoscenze, abilità e disposizioni in situazioni contestualizzate,
VERIFICA e VALUTAZIONE
 VERIFICA e I criteri della valutazione Modalità di verifica La valutazione disciplinare La valutazione del comportamento La certificazione delle competenze Le prove del sistema nazionale di valutazione
VERIFICA e I criteri della valutazione Modalità di verifica La valutazione disciplinare La valutazione del comportamento La certificazione delle competenze Le prove del sistema nazionale di valutazione
RUBRICHE DI VALUTAZIONE RIFERITE AL PROFILO IN USCITA DELLO STUDENTE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO R A D I C E - S A N Z I O - AMMATURO SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO Via R. CUOMO 78-80143 NAPOLI C. F. 95186580635 - Cod. Mecc. NAIC8F8007 - Tel. e Fax 081
ISTITUTO COMPRENSIVO R A D I C E - S A N Z I O - AMMATURO SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO Via R. CUOMO 78-80143 NAPOLI C. F. 95186580635 - Cod. Mecc. NAIC8F8007 - Tel. e Fax 081
Prove per competenze
 Rete AUTONOMIAeCURRICOLO - Trieste Prove per competenze Dalla valutazione alla certificazione Udine 13 novembre 2013 WORKSHOP N.4 Competenze e valutazione D. Ravalico Conosci l'arte con le statue prova
Rete AUTONOMIAeCURRICOLO - Trieste Prove per competenze Dalla valutazione alla certificazione Udine 13 novembre 2013 WORKSHOP N.4 Competenze e valutazione D. Ravalico Conosci l'arte con le statue prova
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LADISPOLI 1 CURRICOLO VERTICALE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SECONDO LE NUOVE INDICAZIONI
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LADISPOLI 1 CURRICOLO VERTICALE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SECONDO LE NUOVE INDICAZIONI Scuola Secondaria di primo grado Scuola Primaria Scuola dell infanzia Anno scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LADISPOLI 1 CURRICOLO VERTICALE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SECONDO LE NUOVE INDICAZIONI Scuola Secondaria di primo grado Scuola Primaria Scuola dell infanzia Anno scolastico
Costruire e/o Sviluppare, Valutare e Certificare competenze
 UNITÀ FORMATIVA : PREMESSA Costruire e/o Sviluppare, Valutare e Certificare competenze Prof. Esterno : Prof Gianni Marconato- Referente per IC Pra : Ins. Anfossi In relazione al PNFD riferita al punto
UNITÀ FORMATIVA : PREMESSA Costruire e/o Sviluppare, Valutare e Certificare competenze Prof. Esterno : Prof Gianni Marconato- Referente per IC Pra : Ins. Anfossi In relazione al PNFD riferita al punto
CRITERI GENERALI. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari:
 CRITERI GENERALI Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai componenti
CRITERI GENERALI Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai componenti
RUBRICA COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA
 RUBRICA COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA Competenze chiave europee 1 Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 2 Comunicazione nelle lingue straniere Competenze di cittadinanza
RUBRICA COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA Competenze chiave europee 1 Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 2 Comunicazione nelle lingue straniere Competenze di cittadinanza
LA VALUTAZIONE. Valutazione degli alunni (Cfr Indicazioni nazionali per il Curricolo del Settembre 2012) Traguardi per lo sviluppo delle competenze
 LA VALUTAZIONE Valutazione degli alunni (Cfr Indicazioni nazionali per il Curricolo del Settembre 2012) Traguardi per lo sviluppo delle competenze Al termine della Scuola Primaria vengono individuati traguardi
LA VALUTAZIONE Valutazione degli alunni (Cfr Indicazioni nazionali per il Curricolo del Settembre 2012) Traguardi per lo sviluppo delle competenze Al termine della Scuola Primaria vengono individuati traguardi
Nichelino Scuola media di via Sangone a.sc. 2008/09
 Nichelino Scuola media di via Sangone a.sc. 2008/09 Criteri di progettualità educativa e di descrivibilità delle competenze comuni alle diverse aree disciplinari Progetto di ricerca per l elaborazione
Nichelino Scuola media di via Sangone a.sc. 2008/09 Criteri di progettualità educativa e di descrivibilità delle competenze comuni alle diverse aree disciplinari Progetto di ricerca per l elaborazione
CURRICOLO VERTICALE E VALUTAZIONE
 CURRICOLO VERTICALE E VALUTAZIONE LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA NEL CURRICOLO VERTICALE Il curricolo verticale rappresenta lo strumento con cui la singola scuola organizza la formazione verticale
CURRICOLO VERTICALE E VALUTAZIONE LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA NEL CURRICOLO VERTICALE Il curricolo verticale rappresenta lo strumento con cui la singola scuola organizza la formazione verticale
ALLEGATO 6 Modulistica per la Progettazione e Attività Didattiche
 ALLEGATO 6 Modulistica per la Progettazione e Attività Didattiche Accoglienza Infanzia Scuola dell'infanzia di Anno Scolastico 2018-2019 Sezione Periodo: Consiglio di intersezione Docenti Osservare e descrivere
ALLEGATO 6 Modulistica per la Progettazione e Attività Didattiche Accoglienza Infanzia Scuola dell'infanzia di Anno Scolastico 2018-2019 Sezione Periodo: Consiglio di intersezione Docenti Osservare e descrivere
P R O G R A M M A Z I O N E D I D A T T I C A D I D I P A R T I M E N T O
 P R O G R A M M A Z I O N E D I D A T T I C A D I D I P A R T I M E N T O DIPARTIMENTO DISCIPLINA CLASSI SCIENZE UMANE SCIENZE UMANE Triennio Scienze Umane ANNO SCOLASTICO 2018-2019 DOCENTE Pessina Francesco
P R O G R A M M A Z I O N E D I D A T T I C A D I D I P A R T I M E N T O DIPARTIMENTO DISCIPLINA CLASSI SCIENZE UMANE SCIENZE UMANE Triennio Scienze Umane ANNO SCOLASTICO 2018-2019 DOCENTE Pessina Francesco
CLASSE SECONDA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
 CLASSE SECONDA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO TECNOLOGIA E INFORMATICA DISCIPLINE TRASVERSALI TUTTE COMPETENZA
CLASSE SECONDA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO TECNOLOGIA E INFORMATICA DISCIPLINE TRASVERSALI TUTTE COMPETENZA
CURRICOLO VERTICALE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA
 CURRICOLO VERTICALE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE DI CITTADINANZA OBIETTIVI FORMATIVI IN USCITA INFANZIA OBIETTIVI FORMATIVI IN USCITA PRIMARIA OBIETTIVI FORMATIVI
CURRICOLO VERTICALE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE DI CITTADINANZA OBIETTIVI FORMATIVI IN USCITA INFANZIA OBIETTIVI FORMATIVI IN USCITA PRIMARIA OBIETTIVI FORMATIVI
a) Organizzare situazioni di apprendimento DESCRITTORI DI COMPETENZA Il docente dichiara di. DOMANDE GUIDA
 I. AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALL INSEGNAMENTO (Didattica) a) Organizzare situazioni di apprendimento 1. Progettare le attività didattiche e le attività e gli strumenti di valutazione tenendo conto
I. AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALL INSEGNAMENTO (Didattica) a) Organizzare situazioni di apprendimento 1. Progettare le attività didattiche e le attività e gli strumenti di valutazione tenendo conto
I.P.S. MAFFEO PANTALEONI Via Brigida Postorino, 27 Frascati
 I.P.S. MAFFEO PANTALEONI Via Brigida Postorino, 27 Frascati PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE/DISCIPLINARE Anno Scolastico 2017 2018 DOCENTE Zicarelli Annamaria CLASSE TERZA SEZ. D DISCIPLINA STORIA ASSE CULTURALE
I.P.S. MAFFEO PANTALEONI Via Brigida Postorino, 27 Frascati PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE/DISCIPLINARE Anno Scolastico 2017 2018 DOCENTE Zicarelli Annamaria CLASSE TERZA SEZ. D DISCIPLINA STORIA ASSE CULTURALE
Seminario regionale Senigallia 15 aprile 2015
 Progettare per sviluppare competenze trasversali. Quale processo valutativo attivare? RENDERE OPERATIVO IL PROTOCOLLO D INTESA: verso le scuole che promuovono salute. Seminario regionale Senigallia 15
Progettare per sviluppare competenze trasversali. Quale processo valutativo attivare? RENDERE OPERATIVO IL PROTOCOLLO D INTESA: verso le scuole che promuovono salute. Seminario regionale Senigallia 15
TEST D INGRESSO A.S
 TEST D INGRESSO A.S. 2016-2017 L Istituto Comprensivo Alessandro Magno, in un ottica di miglioramento, al fine di garantire ai test per competenza una maggiore attendibilità e validità, nonché favorire
TEST D INGRESSO A.S. 2016-2017 L Istituto Comprensivo Alessandro Magno, in un ottica di miglioramento, al fine di garantire ai test per competenza una maggiore attendibilità e validità, nonché favorire
PROGETTO TRIENNALE DI ORIENTAMENTO PREMESSA
 PROGETTO TRIENNALE DI ORIENTAMENTO PREMESSA L Istituto Comprensivo Sondrio Paesi Retici pone a fondamento della propria azione formativa ed orientativa le linee educative e i principi sanciti dai documenti
PROGETTO TRIENNALE DI ORIENTAMENTO PREMESSA L Istituto Comprensivo Sondrio Paesi Retici pone a fondamento della propria azione formativa ed orientativa le linee educative e i principi sanciti dai documenti
Declinare le competenze di anno in anno
 Declinare le competenze di anno in anno Il nostro percorso 1. Il Centro Educativo e la Scuola S.P.E. Cerioli 2. Scenario culturale e pedagogico 3. La didattica per competenze 4. Progettare per competenze
Declinare le competenze di anno in anno Il nostro percorso 1. Il Centro Educativo e la Scuola S.P.E. Cerioli 2. Scenario culturale e pedagogico 3. La didattica per competenze 4. Progettare per competenze
C T S Centro. Piano di formazione per i docenti di sostegno non specializzati. a.s Territoriale di Supporto T R E V I S O
 C T S Centro Territoriale di Supporto T R E V I S O Piano di formazione per i docenti di sostegno non specializzati a.s. 2018-2019 Argomenti C T S Centro Territoriale di T R E V Supporto I S O La normativa
C T S Centro Territoriale di Supporto T R E V I S O Piano di formazione per i docenti di sostegno non specializzati a.s. 2018-2019 Argomenti C T S Centro Territoriale di T R E V Supporto I S O La normativa
ESAME TERZA MEDIA 2018
 ESAME TERZA MEDIA 2018 LE NUOVE REGOLE SU PROVE E VALUTAZIONE Il 10 ottobre 2017 il Ministro dell Istruzione Fedeli ha firmato il decreto per ESAMI TERZA MEDIA ANNO SCOLATICO 2017/2018. NOVITA INSIEME
ESAME TERZA MEDIA 2018 LE NUOVE REGOLE SU PROVE E VALUTAZIONE Il 10 ottobre 2017 il Ministro dell Istruzione Fedeli ha firmato il decreto per ESAMI TERZA MEDIA ANNO SCOLATICO 2017/2018. NOVITA INSIEME
Ref. Prof.ri TIC e Informatica e Laboratorio A PRESENTAZIONE. Tecnologia dell informazione e della comunicazione ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
 UNITÀ DI APPRENDIMENTO TECNOLOGIE DELL INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE Ref. Prof.ri TIC e Informatica e Laboratorio A.S. 2015-2016 TITOLO PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI (POWERPOINT) COD 01/02 A PRESENTAZIONE
UNITÀ DI APPRENDIMENTO TECNOLOGIE DELL INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE Ref. Prof.ri TIC e Informatica e Laboratorio A.S. 2015-2016 TITOLO PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI (POWERPOINT) COD 01/02 A PRESENTAZIONE
La valutazione dell'asl
 La valutazione dell'asl Valutazione Nei percorsi di Alternanza è importante verificare : il rispetto del percorso formativo individuale concordato con i tutor esterni il grado di possesso delle competenze
La valutazione dell'asl Valutazione Nei percorsi di Alternanza è importante verificare : il rispetto del percorso formativo individuale concordato con i tutor esterni il grado di possesso delle competenze
PARTE V Monitoraggio. Verifica e valutazione
 PARTE V Monitoraggio Verifica e valutazione Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri
PARTE V Monitoraggio Verifica e valutazione Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri
FORMAT COMPITO DI REALTA. Comprendente: SCHEMA DI PROGETTO CONSEGNA AGLI STUDENTI PIANO DI LAVORO GRIGLIE DI VALUTAZIONE
 FORMAT COMPITO DI REALTA Comprendente: SCHEMA DI PROGETTO CONSEGNA AGLI STUDENTI PIANO DI LAVORO GRIGLIE DI VALUTAZIONE Vademecum per la compilazione La scheda base, così come concordato nei consigli di
FORMAT COMPITO DI REALTA Comprendente: SCHEMA DI PROGETTO CONSEGNA AGLI STUDENTI PIANO DI LAVORO GRIGLIE DI VALUTAZIONE Vademecum per la compilazione La scheda base, così come concordato nei consigli di
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA Anno accademico 2018-2019 Corso di Pedagogia sperimentale Lezione n. 10-8 novembre 2018 Loredana La Vecchia La valutazione* Perché valuto? Come valuto? Che cosa valuto?
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA Anno accademico 2018-2019 Corso di Pedagogia sperimentale Lezione n. 10-8 novembre 2018 Loredana La Vecchia La valutazione* Perché valuto? Come valuto? Che cosa valuto?
P I A N O P E R S O N A L I Z Z A T O D E L L E A T T I V I T A E D U C A T I V E
 I S T I T U T O C O M P R E N S I V O T I V O L I C E N T R O I I S C U O L A D E L L I N F A N Z I A P l e s s i I. G i o r d a n i e S. P o l o d e i C a v a l i e r i a. s. 2 0 1 3-2 0 1 4 P I A N O
I S T I T U T O C O M P R E N S I V O T I V O L I C E N T R O I I S C U O L A D E L L I N F A N Z I A P l e s s i I. G i o r d a n i e S. P o l o d e i C a v a l i e r i a. s. 2 0 1 3-2 0 1 4 P I A N O
M i n i s t e r o d e l l I s t r u z i o n e, d e l l U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a
 M i n i s t e r o d e l l I s t r u z i o n e, d e l l U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell infanzia e del primo ciclo d istruzione
M i n i s t e r o d e l l I s t r u z i o n e, d e l l U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell infanzia e del primo ciclo d istruzione
LA VALUTAZIONE NEL RIORDINO: MODELLI, METODI E PROCESSI. Parma 15 gennaio Prof.ssa Raffaella Brunelli
 LA VALUTAZIONE NEL RIORDINO: MODELLI, METODI E PROCESSI Parma 15 gennaio 2013 Prof.ssa Raffaella Brunelli Decreto 22 agosto 2007 n. 139 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell obbligo
LA VALUTAZIONE NEL RIORDINO: MODELLI, METODI E PROCESSI Parma 15 gennaio 2013 Prof.ssa Raffaella Brunelli Decreto 22 agosto 2007 n. 139 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell obbligo
Lavorare per competenze
 Bruno Losito, Università Roma Tre Lavorare per competenze Cisterna d Asti, 4 ottobre 2016 Terminologia utilizzata in riferimento alle competenze competenze chiave, disciplinari, di base, trasversali, soft
Bruno Losito, Università Roma Tre Lavorare per competenze Cisterna d Asti, 4 ottobre 2016 Terminologia utilizzata in riferimento alle competenze competenze chiave, disciplinari, di base, trasversali, soft
ISTITUTO COMPRENSIVO T.BONATI - BONDENO A.S CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA
 ISTITUTO COMPRENSIVO T.BONATI - BONDENO (FE) Via Gardenghi n 5- BONDENOCAP. 44012- Tel. 0532-898077 Codice meccanografico FEIC802005- C.Fiscale: 93053630385- Codice Univoco Fatturazione elettronica: UFUI4I
ISTITUTO COMPRENSIVO T.BONATI - BONDENO (FE) Via Gardenghi n 5- BONDENOCAP. 44012- Tel. 0532-898077 Codice meccanografico FEIC802005- C.Fiscale: 93053630385- Codice Univoco Fatturazione elettronica: UFUI4I
1. Situazione di partenza. 1d Fasce di livello Strumenti attivati per individuare la situazione di partenza:
 I.C. AUGUSTO CONSOLE - NAPOLI Programmazione Didattica Annuale Anno Scolastico 2012/2013 TECNOLOGIA DOCENTE: Alunni N. CLASSE 3 a SEZIONE di cui N. diversamente abile 1. Situazione di partenza 1a Livello
I.C. AUGUSTO CONSOLE - NAPOLI Programmazione Didattica Annuale Anno Scolastico 2012/2013 TECNOLOGIA DOCENTE: Alunni N. CLASSE 3 a SEZIONE di cui N. diversamente abile 1. Situazione di partenza 1a Livello
MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
 MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ISTITUTO I.I.S S. Ceccato ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INDIRIZZO P.le Collodi, 7 Montecchio Maggiore CLASSE 5 SEZIONE B RIM DISCIPLINA Matematica DOCENTE Conti Eleonora
MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ISTITUTO I.I.S S. Ceccato ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INDIRIZZO P.le Collodi, 7 Montecchio Maggiore CLASSE 5 SEZIONE B RIM DISCIPLINA Matematica DOCENTE Conti Eleonora
I lezione Master Operatore Musicale. Romina Nesti
 I lezione Master Operatore Musicale Romina Nesti Cos è la didattica? Una definizione e una storia complessa che inizia agli albori dell umanità. Da arte a scienza La parola didattica significa arte di
I lezione Master Operatore Musicale Romina Nesti Cos è la didattica? Una definizione e una storia complessa che inizia agli albori dell umanità. Da arte a scienza La parola didattica significa arte di
Come cambia l'esame di III media. Scritto da Administrator Martedì 10 Ottobre :30
 Maggiore attenzione alla valorizzazione del percorso fatto da alunne e alunni durante il triennio di studi. La partecipazione alle prove Invalsi diventa requisito d ammissione all Esame, ma non incide
Maggiore attenzione alla valorizzazione del percorso fatto da alunne e alunni durante il triennio di studi. La partecipazione alle prove Invalsi diventa requisito d ammissione all Esame, ma non incide
SCHEDA PER LA RACCOLTA DI DATI E OSSERVAZIONI A CURA DEI COORDINATORI DI CLASSE
 SCHEDA PER LA RACCOLTA DI DATI E OSSERVAZIONI A CURA DEI COORDINATORI DI CLASSE (Docente: Paola Orenga) AZIONE: MONITORAGGIO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 2017/18 AREA DI PROCESSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE
SCHEDA PER LA RACCOLTA DI DATI E OSSERVAZIONI A CURA DEI COORDINATORI DI CLASSE (Docente: Paola Orenga) AZIONE: MONITORAGGIO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 2017/18 AREA DI PROCESSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE
prestazione autentica
 prestazione autentica E.Fazi UCIIM nazionale 2 DIFFERENZE tra RUBRICHE e PROVE OGGETTIVE DI VERIFICA Prova oggettiva Verifica obiettivi specifici Verifica una prestazione formale,non contestualizzata Rubrica
prestazione autentica E.Fazi UCIIM nazionale 2 DIFFERENZE tra RUBRICHE e PROVE OGGETTIVE DI VERIFICA Prova oggettiva Verifica obiettivi specifici Verifica una prestazione formale,non contestualizzata Rubrica
SCHEDA DISCIPLINARE. Area Disciplinare : Linguistico-Storico-Filosofica
 SCHEDA DISCIPLINARE Area Disciplinare : Linguistico-Storico-Filosofica Disciplina: Scienze Umane (Psicologia e Metodologia della Ricerca) Docente: Antonella Ciappetta Classe : II sez.a I Quadrimestre a.s.
SCHEDA DISCIPLINARE Area Disciplinare : Linguistico-Storico-Filosofica Disciplina: Scienze Umane (Psicologia e Metodologia della Ricerca) Docente: Antonella Ciappetta Classe : II sez.a I Quadrimestre a.s.
Certificazione delle competenze
 Certificazione delle competenze Certificazione delle competenze «L istituzione scolastica certifica l acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l orientamento per
Certificazione delle competenze Certificazione delle competenze «L istituzione scolastica certifica l acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l orientamento per
La valutazione degli alunni
 La valutazione degli alunni Il Collegio Docenti assume come linea guida dell azione valutativa il principio della valutazione formativa. Questa si caratterizza per la sua funzione diagnostica: essa cioè
La valutazione degli alunni Il Collegio Docenti assume come linea guida dell azione valutativa il principio della valutazione formativa. Questa si caratterizza per la sua funzione diagnostica: essa cioè
IL SENSO DELLA PSICOLOGIA
 INSEGNAMENTO DI: PSICOLOGIA GENERALE IL SENSO DELLA PSICOLOGIA PROF.SSA ANNAMARIA SCHIANO Indice 1 IL SENSO DELLA PSICOLOGIA -----------------------------------------------------------------------------------------
INSEGNAMENTO DI: PSICOLOGIA GENERALE IL SENSO DELLA PSICOLOGIA PROF.SSA ANNAMARIA SCHIANO Indice 1 IL SENSO DELLA PSICOLOGIA -----------------------------------------------------------------------------------------
RUBRICHE DI COMPETENZA: SIGNIFICATI E MODALITÀ DI ELABORAZIONE. Maurizio Muraglia S.M. dei Cavoti 4 maggio 2018
 RUBRICHE DI COMPETENZA: SIGNIFICATI E MODALITÀ DI ELABORAZIONE Maurizio Muraglia S.M. dei Cavoti 4 maggio 2018 PRESUPPOSTI NECESSARI METTERE IN MOTO ORCHESTRARE USARE Pellerey 2004 Capacitàdifarfronteauncompito,ouninsiemedicompiti,
RUBRICHE DI COMPETENZA: SIGNIFICATI E MODALITÀ DI ELABORAZIONE Maurizio Muraglia S.M. dei Cavoti 4 maggio 2018 PRESUPPOSTI NECESSARI METTERE IN MOTO ORCHESTRARE USARE Pellerey 2004 Capacitàdifarfronteauncompito,ouninsiemedicompiti,
MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE al termine della scuola primaria e secondaria di 1^ grado. anno scolastico 20 /20
 MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE al termine della scuola primaria e secondaria di 1^ grado anno scolastico 20 /20 La struttura del documento per la certificazione delle competenze in uscita
MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE al termine della scuola primaria e secondaria di 1^ grado anno scolastico 20 /20 La struttura del documento per la certificazione delle competenze in uscita
CURRICOLO TRASVERSALE SCUOLA PRIMARIA a.s. 2015-16
 CURRICOLO TRASVERSALE SCUOLA PRIMARIA a.s. 2015-16 Competenza n 1: Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. Utilizza la lingua italiana per comprendere semplici enunciati e raccontare esperienze
CURRICOLO TRASVERSALE SCUOLA PRIMARIA a.s. 2015-16 Competenza n 1: Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. Utilizza la lingua italiana per comprendere semplici enunciati e raccontare esperienze
Delibera Collegio dei Docenti. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI Verifica dei risultati e valutazione dei processi cognitivi. DPR 8 marzo1999, n.
 Delibera Collegio dei Docenti LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI Verifica dei risultati e valutazione dei processi cognitivi DPR 8 marzo1999, n. 275 Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche
Delibera Collegio dei Docenti LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI Verifica dei risultati e valutazione dei processi cognitivi DPR 8 marzo1999, n. 275 Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche
Scuola primaria di Cisterna d' Asti - a.sc. 2008/09
 Scuola primaria di Cisterna d' Asti - a.sc. 2008/09 Criteri di progettualità educativa fra competenze, didattica laboratoriale e ambienti di apprendimento www.memorbalia.it L ambiente di apprendimento
Scuola primaria di Cisterna d' Asti - a.sc. 2008/09 Criteri di progettualità educativa fra competenze, didattica laboratoriale e ambienti di apprendimento www.memorbalia.it L ambiente di apprendimento
Strategia formativa e Portfolio
 Strategia formativa e Portfolio Azione F3: Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti Verso
Strategia formativa e Portfolio Azione F3: Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti Verso
La valutazione nell organizzazione modulare della didattica. Dott.ssa Anna Maria Ciraci Cosenza 5-6 marzo 2003
 La valutazione nell organizzazione modulare della didattica Dott.ssa Anna Maria Ciraci Cosenza 5-6 marzo 2003 La valutazione nell attuale quadro normativo e operativo Regolamento dell autonomia delle istituzioni
La valutazione nell organizzazione modulare della didattica Dott.ssa Anna Maria Ciraci Cosenza 5-6 marzo 2003 La valutazione nell attuale quadro normativo e operativo Regolamento dell autonomia delle istituzioni
Il PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA (POF) è la CARTA D IDENTITA della scuola.
 SCUOLA PRIMARIA STATALE PRIMO CIRCOLO DI ABBIATEGRASSO Il PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA (POF) è la CARTA D IDENTITA della scuola. Contiene tutte le informazioni utili e necessarie per conoscere le finalità
SCUOLA PRIMARIA STATALE PRIMO CIRCOLO DI ABBIATEGRASSO Il PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA (POF) è la CARTA D IDENTITA della scuola. Contiene tutte le informazioni utili e necessarie per conoscere le finalità
Maurizio Muraglia Marsala 4 dicembre 2014
 Valutare e certificare le competenze Maurizio Muraglia Marsala 4 dicembre 2014 Apriori sulla valutazione scolastica Valutare non è mettere il voto Non si fa media tra atti valutativi Non si può rinunciare
Valutare e certificare le competenze Maurizio Muraglia Marsala 4 dicembre 2014 Apriori sulla valutazione scolastica Valutare non è mettere il voto Non si fa media tra atti valutativi Non si può rinunciare
STRUTTURA UDA U.D.A. 3. Classe IV A PRESENTAZIONE. Alunni della classe quarta (secondo biennio) del settore Manutenzione e Assistenza Tecnica.
 STRUTTURA UDA UNITÀ DIDATTICA di APPRENDIMENTO di TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI U.D.A. 3 Classe IV A.S. 2015/2016 TITOLO: AMPLIFICATORE OPERAZIONALI MICROPROCESSORI COD. TEEA IV 03/05
STRUTTURA UDA UNITÀ DIDATTICA di APPRENDIMENTO di TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI U.D.A. 3 Classe IV A.S. 2015/2016 TITOLO: AMPLIFICATORE OPERAZIONALI MICROPROCESSORI COD. TEEA IV 03/05
Declinare le competenze. Maestra Stefania Torchiani, prof.ssa Elisa Crescini
 Declinare le competenze Maestra Stefania Torchiani, prof.ssa Elisa Crescini Il nostro percorso 1. Il Centro Educativo S.P.E Cerioli 2. Scenario culturale e pedagogico 3. La didattica per competenze 4.
Declinare le competenze Maestra Stefania Torchiani, prof.ssa Elisa Crescini Il nostro percorso 1. Il Centro Educativo S.P.E Cerioli 2. Scenario culturale e pedagogico 3. La didattica per competenze 4.
Scuola Pontificia Paolo VI. Parametri analitici sul livello globale di maturazione degli alunni
 Parametri analitici sul livello globale di maturazione degli alunni 1 Profilo delle competenze Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie
Parametri analitici sul livello globale di maturazione degli alunni 1 Profilo delle competenze Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie
IL PROFILO PROFESSIONALE E LE BUONE PRATICHE DEL DOCENTE NELLA SCUOLA ATTUALE. Dino Cristanini
 IL PROFILO PROFESSIONALE E LE BUONE PRATICHE DEL DOCENTE NELLA SCUOLA ATTUALE Dino Cristanini LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI TRE LETTERE DIECI DIMENSIONI/ASPETTI/AREE DEL MERITO 3. Il comitato
IL PROFILO PROFESSIONALE E LE BUONE PRATICHE DEL DOCENTE NELLA SCUOLA ATTUALE Dino Cristanini LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI TRE LETTERE DIECI DIMENSIONI/ASPETTI/AREE DEL MERITO 3. Il comitato
Dalla valutazione degli apprendimenti al RAV. Maria Carmela Termini
 Dalla valutazione degli apprendimenti al RAV Maria Carmela Termini Verifica e valutazione Differenza concettuale e operativa Verifica ci riferiamo alle operazioni di rilevazione e misurazione dell apprendimento
Dalla valutazione degli apprendimenti al RAV Maria Carmela Termini Verifica e valutazione Differenza concettuale e operativa Verifica ci riferiamo alle operazioni di rilevazione e misurazione dell apprendimento
ISTITUTO COMPRENSIVO DI FALOPPIO Progetto Accoglienza Scuola Secondaria di I Grado
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI FALOPPIO Progetto Accoglienza Scuola Secondaria di I Grado OBIETTIVI 1. Facilitare e rendere serena la ripresa dell attività didattica. 2. Condividere le regole dell Istituto (Patto,
ISTITUTO COMPRENSIVO DI FALOPPIO Progetto Accoglienza Scuola Secondaria di I Grado OBIETTIVI 1. Facilitare e rendere serena la ripresa dell attività didattica. 2. Condividere le regole dell Istituto (Patto,
Scuola e Progetto di vita.! Ripensare continuità educativa! e orientamento.! A CURA DELLA! DOTT.SSA ELENA AGUGGERI
 CORSO DI FORMAZIONE- AREA 6 COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO. Scuola e Progetto di vita.! Ripensare continuità educativa! e orientamento.! A CURA DELLA! DOTT.SSA ELENA AGUGGERI LINEE GUIDA SULL
CORSO DI FORMAZIONE- AREA 6 COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO. Scuola e Progetto di vita.! Ripensare continuità educativa! e orientamento.! A CURA DELLA! DOTT.SSA ELENA AGUGGERI LINEE GUIDA SULL
UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO RIF.3 A.S. 2015/16 A PRESENTAZIONE. Classe V ODONTOTECNICO. Linguistico, Storico-sociale, Matematico
 UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO RIF.3 A.S. 2015/16 TITOLO: IL CONTRATTO DI LAVORO ED I PRINCIPALI CONTRATTI TIPICI E ATIPICI COD. A PRESENTAZIONE Destinatari Classe V ODONTOTECNICO Periodo Gennaio-febbraio-marzo
UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO RIF.3 A.S. 2015/16 TITOLO: IL CONTRATTO DI LAVORO ED I PRINCIPALI CONTRATTI TIPICI E ATIPICI COD. A PRESENTAZIONE Destinatari Classe V ODONTOTECNICO Periodo Gennaio-febbraio-marzo
SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA. Il Dirigente Scolastico
 Istituzione scolastica. SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA Visti gli atti d ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della
Istituzione scolastica. SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA Visti gli atti d ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della
13 SETTEMBRE 2018 Giordani - Beltramini -Sabella
 DIDATTICA PER COMPETENZE 13 SETTEMBRE 2018 Giordani - Beltramini -Sabella SONDAGGIO:Perché la didattica per competenze alla Scuola dell Infanzia? www.menti.com codice 776872 LA SCUOLA DEI PICCOLI È GRANDE
DIDATTICA PER COMPETENZE 13 SETTEMBRE 2018 Giordani - Beltramini -Sabella SONDAGGIO:Perché la didattica per competenze alla Scuola dell Infanzia? www.menti.com codice 776872 LA SCUOLA DEI PICCOLI È GRANDE
PREMESSA ALLA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
 PREMESSA ALLA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE - Disegno e storia dell arte I Docenti del Dipartimento di Disegno e storia dell arte intendono operare per costruire nello studente, elemento centrale di quel
PREMESSA ALLA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE - Disegno e storia dell arte I Docenti del Dipartimento di Disegno e storia dell arte intendono operare per costruire nello studente, elemento centrale di quel
Didattica per competenze e per progetti
 PROGESIS Ancona, 9-10 settembre 2010 Didattica per competenze e per progetti Graziella Pozzo 1 Progettare per competenze: cosa cambia? Il programma Per programma si intende per lo più un elenco di argomenti
PROGESIS Ancona, 9-10 settembre 2010 Didattica per competenze e per progetti Graziella Pozzo 1 Progettare per competenze: cosa cambia? Il programma Per programma si intende per lo più un elenco di argomenti
progetti per l orientamento curricolo orientante PERCORSI FORMATIVI
 Alla luce della normativa il Progetto Orientamento si è basato sul principio che fare orientamento non significa realizzare tanto dei progetti per l orientamento quanto piuttosto adottare un curricolo
Alla luce della normativa il Progetto Orientamento si è basato sul principio che fare orientamento non significa realizzare tanto dei progetti per l orientamento quanto piuttosto adottare un curricolo
SVOLGIMENTO ED ESITO DELL ESAME DI STATO
 SVOLGIMENTO ED ESITO DELL ESAME DI STATO L esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall alunna o dall alunno
SVOLGIMENTO ED ESITO DELL ESAME DI STATO L esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall alunna o dall alunno
Istituto Statale d'istruzione Secondaria Superiore. " U. Foscolo " Teano - Sparanise. Disciplina: Economia Aziendale
 Istituto Statale d'istruzione Secondaria Superiore " U. Foscolo " Teano - Sparanise Disciplina: Economia Aziendale ANNO SCOLASTICO 2017/2018 Classe prima /sez. AFM Prof. Adriano De Monaco 1 COMPOSIZIONE
Istituto Statale d'istruzione Secondaria Superiore " U. Foscolo " Teano - Sparanise Disciplina: Economia Aziendale ANNO SCOLASTICO 2017/2018 Classe prima /sez. AFM Prof. Adriano De Monaco 1 COMPOSIZIONE
