Introduzione. L impresa pubblica. L intervento pubblico in economia avviene anche attraverso: l impresa pubblica;
|
|
|
- Fabiola Venturini
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Introduzione L intervento pubblico in economia avviene anche attraverso: ECONOMIA PUBBLICA (12) Le imprese pubbliche e le privatizzazioni l impresa pubblica; la regolamentazione. In queste pagine vediamo quali sono i problemi di questi strumenti. Economia Pubblica Pagina 1 Economia Pubblica Pagina 2 L impresa pubblica L utilizzo dell impresa pubblica ha avuto una forte accelerazione nel secondo dopoguerra. settori dei servizi (turismo, trasporti, assicurazioni, banche). Ha interessato: i settori di pubblica utilità (elettricità, acqua, gas, poste, ferrovie, telefoni) attraverso la costituzione di monopoli legali pubblici; settori di base (carbone, acciaio, chimica); settori manifatturieri (auto, meccanica, cantieristica, alimentare, armamenti); Economia Pubblica Pagina 3 Economia Pubblica Pagina 4
2 Svantaggi L esperienza dell impresa pubblica ha rivelato i seguenti difetti: elevati costi dei fallimenti di alcune di queste imprese; presenza di corruzione. tariffe elevate e cattiva qualità dei servizi a causa della mancanza di concorrenza; ampie perdite di gestione per la possibilità di coprirle con Trasferimenti; facilità di ottenere fondi; le interferenze politiche nella scelta dei dirigenti e nella gestione; Economia Pubblica Pagina 5 Economia Pubblica Pagina 6 Servizi di pubblica utilità I confronti internazionali dimostrano che nei paesi in cui non ci sono monopoli pubblici le tariffe sono più basse. L introduzione della concorrenza dovrebbe diminuire i divari tra i paesi. Unica eccezione sono le tariffe ferroviarie che sono tariffe politiche che impongono però elevati oneri a carico del bilancio dello stato. Le tariffe ferroviarie Italiane sono tra le più basse in Europa. Oltre a tariffe alte si riscontra spesso una cattiva qualità del servizio. Economia Pubblica Pagina 7 Settori diversi da quelli di pubblica utilità In questi settori le imprese pubbliche hanno accumulato gravi perdite di gestione. Cause: non c è un vero e proprio vincolo di bilancio; manca un sistema di incentivi. I manager: non hanno un controllo da parte degli azionisti e dal mercato Finanziario; non hanno minacce di acquisizione in caso di inefficienze; Economia Pubblica Pagina 8
3 si preoccupano in misura maggiore di soddisfare il referente politico che del denaro pubblico. Il ruolo di indirizzo e di controllo che spetta ai politici e alle amministrazioni pubbliche non è esercitato in modo corretto. Nelle imprese con un elevato numero di dipendenti, l esigenza di garantirsi una base elettorale si fa sentire. Economia Pubblica Pagina 9 Difficoltà nei controlli Il controllo dei costi è spesso reso difficile da una contabilità non trasparente I criteri con cui vengono costruiti i bilanci sembrano tesi a mascherare la dimensione del contributo che l impresa riceveva dallo stato. Le perdite sono spesso state spesso giustificate dalla volontà di fornire il servizio al costo marginale aumentando al massimo la quantità prodotta. Questo atteggiamento era anche accettato dall azionista pubblico perchè gli evitava di fare scelte distributive tra gli agenti. Economia Pubblica Pagina 10 La tariffa marginale non è sempre la regola ottimale. Nei casi di congestione, una tariffa più alta può migliorare l utilizzo e procurare risorse per finanziare gli investimenti. Considerazioni Date queste considerazioni si ritiene che i risultati dell impresa pubblica sono peggiori di quella privata. Si è arrivati a sostenere che gli svantaggi della stessa sarebbero superiori a quelli causati da un monopolio privato. Si spiega in questo modo l avversione all impresa pubblica nei paesi industrializzati che ha spinto a promuovere un imponente processo di privatizzazione. Economia Pubblica Pagina 11 Economia Pubblica Pagina 12
4 La regolamentazione Nel caso delle imprese di pubblica utilità si è talvolta affidato la fornitura a imprese private, ma regolamentandone le condizioni al posto dell impresa pubblica. A volte una sbagliata regolamentazione ha determinato delle distorsioni nella fissazione dei prezzi e ha penalizzato produttori e consumatori. Il maggiore problema della regolamentazione è che essa ha bisogno di un ottima conoscenza del suo oggetto e ha dunque bisogno di un ampio insieme di informazioni. Ad esempio, per regolamentare le tariffe si ha bisogno Economia Pubblica Pagina 13 di conoscere la struttura dei costi delle imprese, ma queste hanno interessi a non rivelare queste informazioni. I principali difetti della regolamentazione sono: creazione di una sorta di protezione dell impresa creando inefficenze X e allocative; può avere inefficienze dinamiche se disincentiva l innovazione; scoraggia i potenziali fornitori e gli investimenti. Il soggetto regolamentato concentra i propri sforzi nell ottenere una regolamentazione favorevole piuttosto Economia Pubblica Pagina 14 che concentrarsi sulla produzione e sul mercato. I problemi che possono presentarsi tra regolato e regolatore possono essere risolti se il privato è costretto a muoversi in un contesto concorrenziale in quanto si ha una molteplicità di regolati. Economia Pubblica Pagina 15 Privatizzazioni Alle disfunzioni dell impresa pubblica si è risposto con un imponente processo di privatizzazioni. Dal 1990 al 1997 si è avuta una crescita costante. Il valore mondiale delle privatizzazioni è passato da 20 miliardi di dollari a 160. Oltre i due terzi delle privatizzazioni hanno interessato i settori delle telecomunicazioni, dell energia, delle banche e delle assicurazioni. I risultati sono stati molto positivi in particolare: di aumento dell efficienza nei vari settori in termini di Economia Pubblica Pagina 16
5 migliore qualità dei beni e prezzi più favorevoli; si sono avute ingenti entrate per lo stato. la necessità del mutamento degli assetti proprietari delle imprese. Nel periodo le privatizzazioni hanno interessato tutti i paesi europei: 165 miliardi di dollari UK, 122 Italia, 71 Francia, 63 Germania, 62 Spagna. Il processo di privatizzazione può trovare ostacoli nell opinione pubblica che ritiene negativo che il controllo di alcune grandi imprese pubbliche venga affidato ai privati sopratutto se si tratta di grandi imprese private. A spingere verso le privatizzazioni saranno le necessità di entrate pubbliche per rispettare il patto di stabilità e Economia Pubblica Pagina 17 Economia Pubblica Pagina 18 Due i modelli: public company; nocciolo duro. Modelli di privatizzazione Nel secondo caso c è un gruppo di azionisti di riferimento mentre nel primo la proprietà è diffusa. Nei casi di aziende ritenute strategiche si è ricorso alla golden share che riserva al governo alcune prerogative importanti per tener conto degli interessi nazionali (gradimento all ingresso di nuovi soci, diritto di veto in Economia Pubblica Pagina 19 alcune delibere, in caso di fusioni, scissioni, trasferimento all estero e nomina di alcuni amministratori). Le dismissioni sono state effettuate attraverso: offerte pubbliche di vendita; trattative private; aste. La trasformazione delle imprese pubbliche in società per azioni ha determinato un notevole aumento del volume di scambi sul mercato dei capitali. Economia Pubblica Pagina 20
6 Sono stati stimolati lo sviluppo di nuovi mercati e di nuovi strumenti finanziari. Questo ha facilitato l impiego del risparmio da parte dei risparmiatori e una migliore struttura finanziaria da parte dell impresa. I mercati finanziari hanno aumentato il loro spessore e la loro efficienza. Servizi di pubblica utilità La dismissione dell impresa pubblica comporta un minor intervento dello stato come produttore di servizi, ma un maggior intervento come regolatore per salvaguardare gli interessi pubblici. La cosa che si deve evitare è che il monopolio legale sia sostituito da quello privato. Condizione necessaria per la privatizzazione è dunque la liberalizzazione. Economia Pubblica Pagina 21 Le misure di liberalizzazione devono offrire a tutti i possibili concorrenti l utilizzo delle infrastrutture e l istituzioni Economia Pubblica Pagina 22 di autorità indipendenti di controllo del settore. Le autorità indipendenti dovrebbero essere introdotte prima della privatizzazione, non devono sostituirsi all esecutivo esistente, ma ne devono essere indipendenti Alcuni esempi: consob, isvap, garante della concorrenza e del mercato, regolamento degli scioperi nei servizi pubblici, per l informatica nella P.A., commissione di vigilanza sui fondi pensione, per l energia e il gas, per le garanzie nelle telecomunicazioni, per gli appalti. Economia Pubblica Pagina 23 Servizi a rete Aumenteranno la loro importanza con la globalizzazione. Il problema fondamentale è quello di decidere se mantenere gli impianti in mano pubblica. L esperienza dimostra che mantenere le strutture pubbliche e un attenta regolazione dell entrata a più concorrenti consentono di aumentare l efficienza e di migliorare le tariffe. Quando anche la manutenzione della rete è affidata ad un terzo, la convenzione che si stipula dovrebbe non avere scadenza troppo breve per non ridurre l orizzonte Economia Pubblica Pagina 24
7 temporale del concessionario che causa disincentivi alla cura della rete, ma non dovrebbe avre una durata troppo lunga per tutelare lo stato da cambiamenti strutturali. In generale il problema principale è un problema di asimmetria informativa (o meglio di agenzia). Nella convenzione occorre specificare una serie di elementi (tariffe, condizioni di accesso ai mercati, standard qualitativi) che riescano a prevedere il più ampio insieme di possibilità future. L aggiudicazione delle concessioni dovrebbe essere fatta attraverso delle aste. Il concessionario non sa infatti quanto i vari partecipanti sono disposti a pagare. Economia Pubblica Pagina 25 Deregolazione Nei settori regolamentati, l introduzione della contendibilità del mercato ha reso obsoleta tale regolamentazione. L aumento della concorrenza ha richiesto quindi una deregolazione. La privatizzazione e la deregolazione hanno avuto ottimi successi nella riduzione delle tariffe e nell aumento della qualità del servizio soprattutto nei settori delle telecomunicazioni, dell elettricità e del gas. In alcuni casi la deregolazione avrebbe avuto effetti negativi: aumento delle tariffe nella fornitura di acqua, riduzione degli standard di sicurezza nel trasporto aereo. Economia Pubblica Pagina 26 Si ritiene tuttavia che la via intrapresa abbia dato effetti molto positivi e che questi aspetti negativi possano essere evitati con l introduzione di una nuova regolamentazione. La fiducia che si ha in questi strumenti è confermata dall atteggiamento della Commissione Europea sia dell organizzazione per il commercio internazionale. La Commissione Europea ha infatti imposto il divieto agli stati membri di aiutare le imprese pubbliche in difficoltà (tranne in casi eccezionali) e ha inoltre emanato delle direttive al fine di eliminare i vincoli alla concorrenza esistenti, imponendo la possibilità di entrata nei settori in cui vigevano monopoli pubblici. Economia Pubblica Pagina 27 Nel 1997 molti paesi aderenti all organizzazione mondiale per il commercio si sono impegnati ad aprire il loro mercato alla competitività e agli investimenti esteri. Da tali accordi si aspettano vantaggi notevoli. Economia Pubblica Pagina 28
8 Conclusioni I limiti al miglioramento della situazione fiscale sono maggiormente di tipo istituzionale. Ma il cambiamento delle istituzioni è lento. Le spinte per realizzare gli obiettivi sono in sostanza due: la globalizzazione; il patto di stabilità che spinge all efficienza del settore Pubblico. a)giustificaz. b) modalità c) spiegazione costi d) costi e) rimedi cap. 1 cap ) spesa 2) imposiz. 3) impresa cap. 2 e 4 cap. 3 e 4 cap. 5 cap. 8 cap. 10 cap. 12 cap. 9 cap. 11 cap. 12 Economia Pubblica Pagina 29 Economia Pubblica Pagina 30
Economia Pubblica. Giuseppe De Feo. Secondo Semestre Università degli Studi di Pavia
 Economia Pubblica Giuseppe De Feo Università degli Studi di Pavia email: giuseppe.defeo@unipv.it Secondo Semestre 2014-15 Outline I Regolamentazione Che cosa è la Regolamentazione? Regolamentazione Economica
Economia Pubblica Giuseppe De Feo Università degli Studi di Pavia email: giuseppe.defeo@unipv.it Secondo Semestre 2014-15 Outline I Regolamentazione Che cosa è la Regolamentazione? Regolamentazione Economica
Economia (Sanna Randaccio) Lezione n 20 Il Monopolio II. Monopolio Naturale
 Economia (Sanna Randaccio) Lezione n 20 Il Monopolio II Monopolio Naturale Una singola impresa è in grado di produrre la quantità che può venire assorbita dal mercato ad un costo totale inferiore rispetto
Economia (Sanna Randaccio) Lezione n 20 Il Monopolio II Monopolio Naturale Una singola impresa è in grado di produrre la quantità che può venire assorbita dal mercato ad un costo totale inferiore rispetto
Aumento della pressione fiscale. Cause. Cause dell aumento della pressione fiscale:
 Aumento della pressione fiscale Cause dell aumento della pressione fiscale: ECONOMIA PUBBLICA (10) Il grande aumento della pressione fiscale e le disfunzioni del fisco Economia Pubblica Pagina 1 aumento
Aumento della pressione fiscale Cause dell aumento della pressione fiscale: ECONOMIA PUBBLICA (10) Il grande aumento della pressione fiscale e le disfunzioni del fisco Economia Pubblica Pagina 1 aumento
Indice. Capitolo Primo. Forme e scopi dell azione pubblica nell economia
 Indice Argomenti delle Lezioni V Capitolo Primo Forme e scopi dell azione pubblica nell economia I. Nozioni introduttive 1. Principi e regole 1 2. Distinzioni: allocazione e gestione 3 3. Distinzioni:
Indice Argomenti delle Lezioni V Capitolo Primo Forme e scopi dell azione pubblica nell economia I. Nozioni introduttive 1. Principi e regole 1 2. Distinzioni: allocazione e gestione 3 3. Distinzioni:
Struttura e potere di mercato nel mercato elettrico italiano
 Università degli Studi di Perugia Facoltà di Scienze Politiche Struttura e potere di mercato nel mercato elettrico italiano Relatore PAOLO POLINORI Candidato JEARTA TROKSI Matricola : 218093 ANNO ACCADEMICO
Università degli Studi di Perugia Facoltà di Scienze Politiche Struttura e potere di mercato nel mercato elettrico italiano Relatore PAOLO POLINORI Candidato JEARTA TROKSI Matricola : 218093 ANNO ACCADEMICO
Fonti del diritto amministrativo
 Titolo I Fonti del diritto amministrativo Capo I Costituzione e leggi costituzionali 1. Costituzione della Repubblica Italiana, approvata dall Assemblea Costituente il 22-12-1947, promulgata dal Capo provvisorio
Titolo I Fonti del diritto amministrativo Capo I Costituzione e leggi costituzionali 1. Costituzione della Repubblica Italiana, approvata dall Assemblea Costituente il 22-12-1947, promulgata dal Capo provvisorio
La regolamentazione: un introduzione
 La regolamentazione: Definizione Regolamentazione: misura di controllo diretto con la quale lo Stato, o altro ente pubblico disciplina il comportamento degli operatori sui mercati 1 La regolamentazione:
La regolamentazione: Definizione Regolamentazione: misura di controllo diretto con la quale lo Stato, o altro ente pubblico disciplina il comportamento degli operatori sui mercati 1 La regolamentazione:
Fallimenti di mercato
 Fallimenti di mercato Dal cap.9 Monopolio naturale I beni pubblici Esternalità Asimmetrie informative, selezione avversa, azzardo morale Monopolio naturale Costi del monopolio Perdita netta di surplus
Fallimenti di mercato Dal cap.9 Monopolio naturale I beni pubblici Esternalità Asimmetrie informative, selezione avversa, azzardo morale Monopolio naturale Costi del monopolio Perdita netta di surplus
ANALISI ECONOMICA DEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI
 Introduzione Privatizzazione e Liberalizzazione Monopolio e Concorrenza Regolamentazione nelle TLC Mercato delle TLC Conclusione ANALISI ECONOMICA DEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI Università degli Studi
Introduzione Privatizzazione e Liberalizzazione Monopolio e Concorrenza Regolamentazione nelle TLC Mercato delle TLC Conclusione ANALISI ECONOMICA DEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI Università degli Studi
18. Completare la seguente frase fornendo esempi e spiegazioni adeguate: In presenza di
 Capitolo 2 Politica economica Paolo Paesani A.A. 2018-2019 DOMANDE DI RIPASSO 1. Illustrare, dove possibile con l ausilio di grafici, tre definizioni diverse del concetto di efficienza. 2. Elencare le
Capitolo 2 Politica economica Paolo Paesani A.A. 2018-2019 DOMANDE DI RIPASSO 1. Illustrare, dove possibile con l ausilio di grafici, tre definizioni diverse del concetto di efficienza. 2. Elencare le
Regolamentazione, vigilanza e politiche di controllo sul sistema finanziario
 Regolamentazione, vigilanza e politiche di controllo sul sistema finanziario Sommario 1. Il sistema dei controlli 2. Le autorità di controllo 3. La regolamentazione e la vigilanza 1. Il sistema dei controlli:
Regolamentazione, vigilanza e politiche di controllo sul sistema finanziario Sommario 1. Il sistema dei controlli 2. Le autorità di controllo 3. La regolamentazione e la vigilanza 1. Il sistema dei controlli:
Alla ricerca della regolazione ottimale
 Alla ricerca della regolazione ottimale Anna Bottasso Claudio Ferrari Maurizio Conti Alessio Tei Università degli Studi di Genova XV Riunione Scientifica SIET Venezia, 18-20 Settembre 2013 Agenda Introduzione
Alla ricerca della regolazione ottimale Anna Bottasso Claudio Ferrari Maurizio Conti Alessio Tei Università degli Studi di Genova XV Riunione Scientifica SIET Venezia, 18-20 Settembre 2013 Agenda Introduzione
Le origini della VIA. il sistema economico neoclassico e il fallimento del mercato
 Le origini della VIA il sistema economico neoclassico e il fallimento del mercato Il modello del flusso circolare domanda di beni e servizi offerta di beni e servizi spese per consumi mercato dei prodotti
Le origini della VIA il sistema economico neoclassico e il fallimento del mercato Il modello del flusso circolare domanda di beni e servizi offerta di beni e servizi spese per consumi mercato dei prodotti
Liberalizzazioni e crescita economica. Mirco Marchiodi Mercoledì, 13 giugno 2012
 Liberalizzazioni e crescita economica Mirco Marchiodi Mercoledì, 13 giugno 2012 Definizione La liberalizzazione amministrativa comprende le misure volte ad eliminare ovvero a ridurre gli ostacoli di natura
Liberalizzazioni e crescita economica Mirco Marchiodi Mercoledì, 13 giugno 2012 Definizione La liberalizzazione amministrativa comprende le misure volte ad eliminare ovvero a ridurre gli ostacoli di natura
Dati sulla Spesa Pubblica (SP)
 Dati sulla Spesa Pubblica (SP) Nei paesi OCSE dal 1870-1990 la spesa pubblica è aumentata 5 volte (8,3%-44,8%). ECONOMIA PUBBLICA (8) Il grande aumento della spesa e del debito pubblico Economia Pubblica
Dati sulla Spesa Pubblica (SP) Nei paesi OCSE dal 1870-1990 la spesa pubblica è aumentata 5 volte (8,3%-44,8%). ECONOMIA PUBBLICA (8) Il grande aumento della spesa e del debito pubblico Economia Pubblica
CICLO DI VITA DELLA TECNOLOGIA
 CICLO DI VITA DELLA TECNOLOGIA VOLUME DI MERCATO LANCIO CRESCITA MATURITA OBSOLESCENZA CICLO DI VITA DELLA TECNOLOGIA VOLUME DI MERCATO LANCIO CRESCITA MATURITA OBSOLESCENZA INNOVAZIONE TECNOLOGICA PROCESSO
CICLO DI VITA DELLA TECNOLOGIA VOLUME DI MERCATO LANCIO CRESCITA MATURITA OBSOLESCENZA CICLO DI VITA DELLA TECNOLOGIA VOLUME DI MERCATO LANCIO CRESCITA MATURITA OBSOLESCENZA INNOVAZIONE TECNOLOGICA PROCESSO
Indice del volume. Presentazione
 Indice del volume Presentazione v I. Introduzione di Sabino Cassese 3 1. I tre significati di «costituzione economica», p. 3 2. I metodi di studio della costituzione economica, p. 5 II. La «vecchia» costituzione
Indice del volume Presentazione v I. Introduzione di Sabino Cassese 3 1. I tre significati di «costituzione economica», p. 3 2. I metodi di studio della costituzione economica, p. 5 II. La «vecchia» costituzione
Conoscere le varie forme di mercato
 Conoscere le varie forme di mercato Diego Medici - Lic. sc. ec. Istituto MecoP - Facoltà di Scienze Economiche Università della Svizzera italiana - Lugano Tenero venerdì 20 ottobre 2006 Contenuti Il settore
Conoscere le varie forme di mercato Diego Medici - Lic. sc. ec. Istituto MecoP - Facoltà di Scienze Economiche Università della Svizzera italiana - Lugano Tenero venerdì 20 ottobre 2006 Contenuti Il settore
8 marzo 2013 Sala Consiglio Palazzo Turati Via Meravigli, 9/B - Milano
 Quale futuro per i servizi pubblici locali: Liberalizzazione, Privatizzazione, Affidamenti Pubblici, Centralità dei bisogni del cittadino, Sviluppo economico 8 marzo 2013 Sala Consiglio Palazzo Turati
Quale futuro per i servizi pubblici locali: Liberalizzazione, Privatizzazione, Affidamenti Pubblici, Centralità dei bisogni del cittadino, Sviluppo economico 8 marzo 2013 Sala Consiglio Palazzo Turati
INTERNATIONAL CONFERENCE ON REMITTANCES G8 GLOBAL REMITTANCES WORKING GROUP PLENARY MEETING
 INTERNATIONAL CONFERENCE ON REMITTANCES G8 GLOBAL REMITTANCES WORKING GROUP PLENARY MEETING Intervento dr Giovanni Carosio Vice Direttore Generale della Banca d Italia Roma, 9 Novembre 2009 Le rimesse
INTERNATIONAL CONFERENCE ON REMITTANCES G8 GLOBAL REMITTANCES WORKING GROUP PLENARY MEETING Intervento dr Giovanni Carosio Vice Direttore Generale della Banca d Italia Roma, 9 Novembre 2009 Le rimesse
Efficienza, carenze dei mercati e implicazioni per l intervento pubblico. (la prospettiva costruttivistica) (parte 1) Manuale 1: cap. 5 (par.
 Efficienza, carenze dei mercati e implicazioni per l intervento pubblico (la prospettiva costruttivistica) (parte 1) Manuale 1: cap. 5 (par. 1, 2, 3) La prospettiva delle carenze dei mercati Cosa intendere
Efficienza, carenze dei mercati e implicazioni per l intervento pubblico (la prospettiva costruttivistica) (parte 1) Manuale 1: cap. 5 (par. 1, 2, 3) La prospettiva delle carenze dei mercati Cosa intendere
Capitolo 6 Fallimenti microeconomici del mercato: il potere di mercato
 Capitolo 6 Fallimenti microeconomici del mercato: il potere di mercato L inefficienza allocativa del monopolio Situazione: mercato nel quale un bene sia servito da una sola impresa (monopolista), che persegue
Capitolo 6 Fallimenti microeconomici del mercato: il potere di mercato L inefficienza allocativa del monopolio Situazione: mercato nel quale un bene sia servito da una sola impresa (monopolista), che persegue
Evoluzione del mercato elettrico italiano. Ancona, 13 maggio 2015
 Evoluzione del mercato elettrico italiano Ancona, 13 maggio 2015 1 Agenda Mercato Elettrico Milestone regolatorie La liberalizzazione e la nuova filiera L organizzazione del sistema elettrico in Italia
Evoluzione del mercato elettrico italiano Ancona, 13 maggio 2015 1 Agenda Mercato Elettrico Milestone regolatorie La liberalizzazione e la nuova filiera L organizzazione del sistema elettrico in Italia
I Centri di Documentazione Europea
 I Centri di Documentazione Europea CDE - OPIB IL CAMMINO DELL EUROPA: DALLA COMUNITA ALL UNIONE RIFLESSIONI E NUOVI SCENARI Intervento del Prof. Umberto Triulzi Sapienza Università di Roma «Mercato interno
I Centri di Documentazione Europea CDE - OPIB IL CAMMINO DELL EUROPA: DALLA COMUNITA ALL UNIONE RIFLESSIONI E NUOVI SCENARI Intervento del Prof. Umberto Triulzi Sapienza Università di Roma «Mercato interno
Audizione X Commissione Senato
 Audizione X Commissione Senato Indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese 10 ottobre 2013 Valorizzazione delle
Audizione X Commissione Senato Indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese 10 ottobre 2013 Valorizzazione delle
Prova scritta del 14 dicembre traccia A -
 Università degli studi di Bari A. Moro Corso di laurea in Economia e commercio SCIENZA DELLE FINANZE Anno accademico 2015/2016 Prova scritta del 14 dicembre 2015 - traccia A - Prima parte (per un totale
Università degli studi di Bari A. Moro Corso di laurea in Economia e commercio SCIENZA DELLE FINANZE Anno accademico 2015/2016 Prova scritta del 14 dicembre 2015 - traccia A - Prima parte (per un totale
MARKETING (Principi e strumenti)
 Corso di Laurea in Economia Aziendale Management internazionalizzazione e qualità A.A. 2017-2018 MARKETING (Principi e strumenti) Prof.ssa Silvia Ranfagni L EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI MARKETING NELL IMPRESA
Corso di Laurea in Economia Aziendale Management internazionalizzazione e qualità A.A. 2017-2018 MARKETING (Principi e strumenti) Prof.ssa Silvia Ranfagni L EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI MARKETING NELL IMPRESA
I MODELLI DI SVILUPPO INFRASTRUTTURALE NEL TERZO PACCHETTO: TRA ESENZIONE E REGOLAZIONE
 I MODELLI DI SVILUPPO INFRASTRUTTURALE NEL TERZO PACCHETTO: TRA ESENZIONE E REGOLAZIONE Clara Poletti, Direttore, Dipartimento per la Regolazione, AEEGSI Giornate di Studio degli Affari Giuridici Il sistema
I MODELLI DI SVILUPPO INFRASTRUTTURALE NEL TERZO PACCHETTO: TRA ESENZIONE E REGOLAZIONE Clara Poletti, Direttore, Dipartimento per la Regolazione, AEEGSI Giornate di Studio degli Affari Giuridici Il sistema
L uso strategico degli appalti pubblici
 L uso strategico degli appalti pubblici Gli appalti pubblici: uno strumento importante per la PA - le condizioni necessarie per la sua efficacia. Cons. Anna Maria Villa responsabile Ufficio Cittadinanza
L uso strategico degli appalti pubblici Gli appalti pubblici: uno strumento importante per la PA - le condizioni necessarie per la sua efficacia. Cons. Anna Maria Villa responsabile Ufficio Cittadinanza
Evoluzione del ruolo del MARKETING nell impresa
 Evoluzione del ruolo del MARKETING nell impresa Orientamento alla vendita Orientamento al cliente Orientamento al Mercato Orientamento al prodotto 1 EVOLUZIONE DEL RUOLO DEL MARKETING NELL IMPRESA (1)
Evoluzione del ruolo del MARKETING nell impresa Orientamento alla vendita Orientamento al cliente Orientamento al Mercato Orientamento al prodotto 1 EVOLUZIONE DEL RUOLO DEL MARKETING NELL IMPRESA (1)
Fallimenti del mercato
 biettivi sociali Equità Efficienza sociale Fallimenti del mercato marginali sociali ( e BM S ) Benessere collettivo dipende dal loro rapporto Incentivare produzione/consumo se BM S > isincentivare produzione/consumo
biettivi sociali Equità Efficienza sociale Fallimenti del mercato marginali sociali ( e BM S ) Benessere collettivo dipende dal loro rapporto Incentivare produzione/consumo se BM S > isincentivare produzione/consumo
Corso di Scelte degli individui, strategie d impresa e strutture di mercato Facoltà di Giurisprudenza LIUC Prof.ssa Donatella Porrini a.a.
 Corso di Scelte degli individui, strategie d impresa e strutture di mercato Facoltà di Giurisprudenza LIUC Prof.ssa Donatella Porrini a.a. 2013-2014 QUINTA LEZIONE 25 OTTOBRE 2013 I FALLIMENTI DI MERCATO
Corso di Scelte degli individui, strategie d impresa e strutture di mercato Facoltà di Giurisprudenza LIUC Prof.ssa Donatella Porrini a.a. 2013-2014 QUINTA LEZIONE 25 OTTOBRE 2013 I FALLIMENTI DI MERCATO
Premessa. Un modello avanzato di regolazione ferroviaria Marco Ponti Roma, 22 Gennaio 2016 RESEARCH CENTER ON TRANSPORT POLICY
 Premessa La presente riflessione costituisce un tentativo di inquadrare la regolazione ferroviaria all interno della disciplina regolatoria. Il modello che qui si propone puo essere valutato come troppo
Premessa La presente riflessione costituisce un tentativo di inquadrare la regolazione ferroviaria all interno della disciplina regolatoria. Il modello che qui si propone puo essere valutato come troppo
Il Decreto Ronchi e la liberalizzazione del servizio idrico
 Il Decreto Ronchi e la liberalizzazione del servizio idrico IL DECRETO RONCHI PRIVATIZZA L ACQUA FALSO DECRETO RONCHI PRIVATIZZA L ACQUA L'ACQUA È E RESTA UN BENE PUBBLICO Questo concetto viene ribadito
Il Decreto Ronchi e la liberalizzazione del servizio idrico IL DECRETO RONCHI PRIVATIZZA L ACQUA FALSO DECRETO RONCHI PRIVATIZZA L ACQUA L'ACQUA È E RESTA UN BENE PUBBLICO Questo concetto viene ribadito
ALL EROGAZIONE DEI SERVIZI. Francesca Lecci
 DIVERSI APPROCCI ALL EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI Francesca Lecci Agenda Il concetto di servizio e di bisogno pubblico I sistemi di offerta dei servizi pubblici Caratteristiche Vantaggi e svantaggi
DIVERSI APPROCCI ALL EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI Francesca Lecci Agenda Il concetto di servizio e di bisogno pubblico I sistemi di offerta dei servizi pubblici Caratteristiche Vantaggi e svantaggi
il beneficiario ed il danneggiato possono essere come detto produttori o consumatori.
 1 U C I I M - Torino Associazione Cattolica Insegnanti Dirigenti Formatori Sezione di Torino Ettore PEYRON Corso di ECONOMIA PUBBLICA 2007 Aggiornamento per docenti di Scienza delle Finanze della scuola
1 U C I I M - Torino Associazione Cattolica Insegnanti Dirigenti Formatori Sezione di Torino Ettore PEYRON Corso di ECONOMIA PUBBLICA 2007 Aggiornamento per docenti di Scienza delle Finanze della scuola
La Consob. Cosa fa la consob
 La Consob Per la tutela dei risparmiatori Cosa fa la consob La Consob ha un compito importantissimo, quello di tutelare il pubblico risparmio. Il risparmio accumulato in una nazione è un bene primario
La Consob Per la tutela dei risparmiatori Cosa fa la consob La Consob ha un compito importantissimo, quello di tutelare il pubblico risparmio. Il risparmio accumulato in una nazione è un bene primario
Lezione 1 - Introduzione
 Lezione 1 - Introduzione Edilio Valentini U.d A. Economia Pubblica Edilio Valentini (U.d A.) Lezione 1 - Introduzione Economia Pubblica 1 / 20 Indice della lezione Cos é lo Stato Economia mista Diverse
Lezione 1 - Introduzione Edilio Valentini U.d A. Economia Pubblica Edilio Valentini (U.d A.) Lezione 1 - Introduzione Economia Pubblica 1 / 20 Indice della lezione Cos é lo Stato Economia mista Diverse
Memoria dell Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in merito alle attività nei settori di competenza
 Memoria dell Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in merito alle attività nei settori di competenza X e VIII Commissione della Camera dei Deputati 10 a e 13 a Commissione del Senato
Memoria dell Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in merito alle attività nei settori di competenza X e VIII Commissione della Camera dei Deputati 10 a e 13 a Commissione del Senato
PREMESSA TERZIETA DELLA RETE NAZIONALE DI TRASPORTO
 (27 gennaio 2005) SEGNALAZIONE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AL PARLAMENTO E AL GOVERNO IN MATERIA DI TERZIETA DELLA RETE NAZIONALE, DEGLI STOCCAGGI E DI SVILUPPO CONCORRENZIALE DEL MERCATO
(27 gennaio 2005) SEGNALAZIONE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AL PARLAMENTO E AL GOVERNO IN MATERIA DI TERZIETA DELLA RETE NAZIONALE, DEGLI STOCCAGGI E DI SVILUPPO CONCORRENZIALE DEL MERCATO
PUBBLICAZIONI REALIZZATE NELLE EDIZIONI DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER GIURISTI D IMPRESA
 PUBBLICAZIONI REALIZZATE NELLE EDIZIONI DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER GIURISTI D IMPRESA 1983-1984 Il finanziamento delle innovazioni tecnologiche nelle imprese industriali Il ritardo nei pagamenti
PUBBLICAZIONI REALIZZATE NELLE EDIZIONI DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER GIURISTI D IMPRESA 1983-1984 Il finanziamento delle innovazioni tecnologiche nelle imprese industriali Il ritardo nei pagamenti
Produttività, Mercato e Stato (azionista o meno) Carlo Scarpa Università di Brescia
 Produttività, Mercato e Stato (azionista o meno) Carlo Scarpa Università di Brescia 1 Un pezzo importante del problema: produttività ai minimi Periodo difficile per tutto il mondo industrializzato La crescita
Produttività, Mercato e Stato (azionista o meno) Carlo Scarpa Università di Brescia 1 Un pezzo importante del problema: produttività ai minimi Periodo difficile per tutto il mondo industrializzato La crescita
Scienza delle finanze
 Scienza delle finanze Emanuela Randon emanuela.randon@unibo.it Corsi di Laurea specialistica: Aera e Economia e politica dei mercati Lezione 1 a.a. 2007-2008 Gennaio 2008 1 PRESENTAZIONE DEL CORSO aspetti
Scienza delle finanze Emanuela Randon emanuela.randon@unibo.it Corsi di Laurea specialistica: Aera e Economia e politica dei mercati Lezione 1 a.a. 2007-2008 Gennaio 2008 1 PRESENTAZIONE DEL CORSO aspetti
Audizione presso la 10ª Commissione Industria del Senato
 Indagine conoscitiva sui prezzi dell energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo o del Paese Audizione presso la 10ª Commissione Industria del Senato Andrea
Indagine conoscitiva sui prezzi dell energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo o del Paese Audizione presso la 10ª Commissione Industria del Senato Andrea
FARE INDUSTRIA A TORINO: opportunità e rischi nella competizione internazionale
 FARE INDUSTRIA A TORINO: opportunità e rischi nella competizione internazionale Torino, 20 Marzo 2006 Presentazione a cura di Luca Pignatelli e Mauro Zangola dell Ufficio Studi Economici dell Unione Industriale
FARE INDUSTRIA A TORINO: opportunità e rischi nella competizione internazionale Torino, 20 Marzo 2006 Presentazione a cura di Luca Pignatelli e Mauro Zangola dell Ufficio Studi Economici dell Unione Industriale
acquisti sostenibili
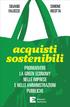 SILVANO FALOCCO SIMONE RICOTTA acquisti sostenibili PROMUOVERE LA GREEN ECONOMY NELLE IMPRESE E NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE prefazione per Acquisti Sostenibili La domanda pubblica di lavori, beni e
SILVANO FALOCCO SIMONE RICOTTA acquisti sostenibili PROMUOVERE LA GREEN ECONOMY NELLE IMPRESE E NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE prefazione per Acquisti Sostenibili La domanda pubblica di lavori, beni e
L Authority dei Trasporti: limiti, posizione e compiti. Massimo Gardina. Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
 L Authority dei Trasporti: limiti, posizione e compiti Massimo Gardina Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche Perché regolare i servizi di pubblica utilità? 1. L efficienza dei monopoli naturali
L Authority dei Trasporti: limiti, posizione e compiti Massimo Gardina Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche Perché regolare i servizi di pubblica utilità? 1. L efficienza dei monopoli naturali
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE I PROTAGONISTI NELLA VITA DELL IMPRESA PROF.SSA MIRELLA MIGLIACCIO
 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE I PROTAGONISTI NELLA VITA DELL IMPRESA PROF.SSA MIRELLA MIGLIACCIO Struttura della lezione - I protagonisti dell impresa e le scelte di governo - Gli organi di governo
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE I PROTAGONISTI NELLA VITA DELL IMPRESA PROF.SSA MIRELLA MIGLIACCIO Struttura della lezione - I protagonisti dell impresa e le scelte di governo - Gli organi di governo
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CAUSI
 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1856 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CAUSI Modifiche all articolo 106 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1856 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CAUSI Modifiche all articolo 106 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
AGENZIE DI RATING E COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLE ASSOCIAZIONI DI
 Studio Legale Losappio Via Ferrucci, 94 www.studiolegalelosappio.it GIUSEPPE LOSAPPIO AGENZIE DI RATING E COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI La disciplina regolamentare delle
Studio Legale Losappio Via Ferrucci, 94 www.studiolegalelosappio.it GIUSEPPE LOSAPPIO AGENZIE DI RATING E COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI La disciplina regolamentare delle
L assetto proprietario degli intermediari
 L assetto proprietario degli intermediari L armonizzazione comunitaria delle regole e dei controlli Giuseppe Boccuzzi Agenda 1. Corporate governance e assetti proprietari 2. Specialità della disciplina
L assetto proprietario degli intermediari L armonizzazione comunitaria delle regole e dei controlli Giuseppe Boccuzzi Agenda 1. Corporate governance e assetti proprietari 2. Specialità della disciplina
Il nuovo pacchetto sugli aiuti di Stato relativi ai SIEG. DG Concorrenza
 Il nuovo pacchetto sugli aiuti di Stato relativi ai SIEG DG Concorrenza Pacchetto adottato il 20.12.2011 Disciplina di qualità per i servizi di interesse generale Proposte della Commissione per la modernizzazione
Il nuovo pacchetto sugli aiuti di Stato relativi ai SIEG DG Concorrenza Pacchetto adottato il 20.12.2011 Disciplina di qualità per i servizi di interesse generale Proposte della Commissione per la modernizzazione
L energia. In futuro solo risorse rinnovabili. In un mercato efficiente il passaggio sarebbe graduale e armonioso
 L energia Il fabbisogno energetico dei paesi industrializzati è attualmente soddisfatto con ricorso al petrolio e al gas naturale (in Italia per l 80% nel 2001). [Fig. 7.1 e 7.2] In futuro solo risorse
L energia Il fabbisogno energetico dei paesi industrializzati è attualmente soddisfatto con ricorso al petrolio e al gas naturale (in Italia per l 80% nel 2001). [Fig. 7.1 e 7.2] In futuro solo risorse
considerando la frontiera delle possibilità produttive ed il prezzo relativo di equilibrio dei due beni.
 2. (8 p.) Per ciascuna delle affermazioni che seguono si dica se essa è vera o falsa e, nel caso in cui si ritenga che essa sia falsa (o vera solo in parte) perché (sinteticamente); nel caso in cui un
2. (8 p.) Per ciascuna delle affermazioni che seguono si dica se essa è vera o falsa e, nel caso in cui si ritenga che essa sia falsa (o vera solo in parte) perché (sinteticamente); nel caso in cui un
Economia e gestione delle imprese
 Anno accademico 2008-2009 Economia e gestione delle imprese Prof. Arturo Capasso 1 Argomenti Rapporto impresa ambiente Analisi dell ambiente di riferimento dell impresa Struttura dei mercati Rapporti impresa-mercato
Anno accademico 2008-2009 Economia e gestione delle imprese Prof. Arturo Capasso 1 Argomenti Rapporto impresa ambiente Analisi dell ambiente di riferimento dell impresa Struttura dei mercati Rapporti impresa-mercato
Economia industriale (6 CFU)
 Economia industriale (6 CFU) Lezione 1 Davide Castellani Università di Perugia Facoltà di Economia Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica davide.castellani@unipg.it Regole Esame scritto 4 domande
Economia industriale (6 CFU) Lezione 1 Davide Castellani Università di Perugia Facoltà di Economia Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica davide.castellani@unipg.it Regole Esame scritto 4 domande
L Economia del settore idrico: problematiche industriali e politiche di regolazione
 L Economia del settore idrico: problematiche industriali e politiche di regolazione L economia del settore idrico: assetti proprietari, profili organizzativi e livelli di efficienza: risultati di una ricerca
L Economia del settore idrico: problematiche industriali e politiche di regolazione L economia del settore idrico: assetti proprietari, profili organizzativi e livelli di efficienza: risultati di una ricerca
Indice delle liberalizzazioni 2013
 Indice delle liberalizzazioni 2013 Più concorrenza, più crescita Il regno Unito è il paese più liberalizzato tra gli UE15, seguito da paesi Bassi e Svezia. I mercati meno aperti si trovano I n Italia,
Indice delle liberalizzazioni 2013 Più concorrenza, più crescita Il regno Unito è il paese più liberalizzato tra gli UE15, seguito da paesi Bassi e Svezia. I mercati meno aperti si trovano I n Italia,
Il sistema elettrico. La produzione: di energia termoelettrica netta per tipo di combustibile
 Il sistema elettrico La produzione: di energia termoelettrica netta per tipo di combustibile Il sistema elettrico La produzione: Fonti Rinnovabili Il sistema elettrico La produzione: La produzione anno
Il sistema elettrico La produzione: di energia termoelettrica netta per tipo di combustibile Il sistema elettrico La produzione: Fonti Rinnovabili Il sistema elettrico La produzione: La produzione anno
DISCRIMINAZIONE DI PREZZO
 DISCRIMINAZIONE DI PREZZO Il monopolista può cercare di utilizzare il potere di mercato di cui dispone per operare la cosiddetta discriminazione di prezzo Con ciò si intende la pratica di fissare prezzi
DISCRIMINAZIONE DI PREZZO Il monopolista può cercare di utilizzare il potere di mercato di cui dispone per operare la cosiddetta discriminazione di prezzo Con ciò si intende la pratica di fissare prezzi
MONOPOLIO. Massimizzazione del profitto per il monopolista. Distorsione di prezzo del monopolio. Effetti: perdita netta di Benessere Sociale (W)
 MONOPOLIO Impresa price maker relazione MR, p, ε Massimizzazione del profitto per il monopolista perché MR
MONOPOLIO Impresa price maker relazione MR, p, ε Massimizzazione del profitto per il monopolista perché MR
ll BIM, quale strumento dell'economia Circolare, per progettare, realizzare e gestire un edificio energeticamente efficiente.
 ll BIM, quale strumento dell'economia Circolare, per progettare, realizzare e gestire un edificio energeticamente efficiente. Anna Moreno Project manager ENEA Presidente IBIMI La PA è il vero propellente
ll BIM, quale strumento dell'economia Circolare, per progettare, realizzare e gestire un edificio energeticamente efficiente. Anna Moreno Project manager ENEA Presidente IBIMI La PA è il vero propellente
Capitolo cinque. La teoria del commercio internazionale. Una visione d insieme sulle teorie del commercio internazionale
 Capitolo cinque La teoria del commercio internazionale Una visione d insieme sulle teorie del commercio internazionale 5-3 Si ha libero scambio quando un governo non cerca di influenzare, con contingentamenti
Capitolo cinque La teoria del commercio internazionale Una visione d insieme sulle teorie del commercio internazionale 5-3 Si ha libero scambio quando un governo non cerca di influenzare, con contingentamenti
MONOPOLIO. Monopolio: mercato nel quale vi è un solo offerente (Monopsonio: mercato nel quale vi è un solo compratore)
 MONOPOLIO Monopolio: mercato nel quale vi è un solo offerente (Monopsonio: mercato nel quale vi è un solo compratore) Monopolio e fallimento del mercato: in realtà ogni volta che in un mercato operano
MONOPOLIO Monopolio: mercato nel quale vi è un solo offerente (Monopsonio: mercato nel quale vi è un solo compratore) Monopolio e fallimento del mercato: in realtà ogni volta che in un mercato operano
PATTO PER IL LAVORO LE CONSIDERAZIONI DI CONFSERVIZI ALLA PROPOSTA DEL 21 MAGGIO 2015
 PATTO PER IL LAVORO LE CONSIDERAZIONI DI CONFSERVIZI ALLA PROPOSTA DEL 21 MAGGIO 2015 15 giugno 2015 1 PREMESSA: CONFSERVIZI condivide lo spirito con cui la Regione Emilia-Romagna sta affrontando il tema
PATTO PER IL LAVORO LE CONSIDERAZIONI DI CONFSERVIZI ALLA PROPOSTA DEL 21 MAGGIO 2015 15 giugno 2015 1 PREMESSA: CONFSERVIZI condivide lo spirito con cui la Regione Emilia-Romagna sta affrontando il tema
Politica economica: Lezione 13
 Politica economica: Lezione 13 II canale: M - Z Crediti: 9 Corsi di laurea: Nuovo Ordinamento (DM. 270) Vecchio ordinamento (DM. 590) 1 Caratteristiche di un monopolio puro Un unico venditore: una sola
Politica economica: Lezione 13 II canale: M - Z Crediti: 9 Corsi di laurea: Nuovo Ordinamento (DM. 270) Vecchio ordinamento (DM. 590) 1 Caratteristiche di un monopolio puro Un unico venditore: una sola
DOMANDA ED OFFERTA DI CREDITO IN PROVINCIA DI MODENA
 DOMANDA ED OFFERTA DI CREDITO IN PROVINCIA DI MODENA 1.1 L assetto finanziario delle aziende Dal punto di vista dell andamento economico le imprese della provincia di registrano una situazione in parte
DOMANDA ED OFFERTA DI CREDITO IN PROVINCIA DI MODENA 1.1 L assetto finanziario delle aziende Dal punto di vista dell andamento economico le imprese della provincia di registrano una situazione in parte
Marcello Messori. Piazza Finanziaria Asset Management. Assogestioni Working Paper 2007/1. Working Paper 2007/1
 Marcello Messori Piazza Finanziaria Asset Management Assogestioni Working Paper 2007/1 Marcello Messori Comitato Tecnico per la Piazza Finanziaria Italiana Gruppo di lavoro sull industria italiana dell
Marcello Messori Piazza Finanziaria Asset Management Assogestioni Working Paper 2007/1 Marcello Messori Comitato Tecnico per la Piazza Finanziaria Italiana Gruppo di lavoro sull industria italiana dell
Analisi di impatto della regolazione sulla concorrenza
 Analisi di impatto della regolazione sulla concorrenza (AIRC) Panel dell LUMSA, 23 giugno 2011 Laura Cavallo MIGLIORE LEGISLAZIONE E AIRC Obiettivo della migliore g legislazione : Migliorare performance
Analisi di impatto della regolazione sulla concorrenza (AIRC) Panel dell LUMSA, 23 giugno 2011 Laura Cavallo MIGLIORE LEGISLAZIONE E AIRC Obiettivo della migliore g legislazione : Migliorare performance
Autorità garante della concorrenza e del mercato
 Camera dei Deputati 16 maggio 2017 Autorità garante della concorrenza e del mercato Relazione sull attività svolta nel 2016 Presentazione del Presidente Giovanni Pitruzzella Sanzioni: 306 milioni di euro
Camera dei Deputati 16 maggio 2017 Autorità garante della concorrenza e del mercato Relazione sull attività svolta nel 2016 Presentazione del Presidente Giovanni Pitruzzella Sanzioni: 306 milioni di euro
Comunicazione via PEC Mittente: AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.
 Comunicazione via PEC pec@pec.autorita-trasporti.it Mittente: AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A. Documento di consultazione sui Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali di cui alla Delibera n. 31/2014.
Comunicazione via PEC pec@pec.autorita-trasporti.it Mittente: AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A. Documento di consultazione sui Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali di cui alla Delibera n. 31/2014.
Fallimenti microeconomici del mercato: Monopolio
 Politica economica (A-D) Sapienza Università di Rome Fallimenti microeconomici del mercato: Monopolio Giovanni Di Bartolomeo Sapienza Università di Roma Fallimenti microeconomici Fallimenti nel ottenere
Politica economica (A-D) Sapienza Università di Rome Fallimenti microeconomici del mercato: Monopolio Giovanni Di Bartolomeo Sapienza Università di Roma Fallimenti microeconomici Fallimenti nel ottenere
ENERGY ON AIR SKY GAS&POWER
 ENERGY ON AIR 2 Sky Gas & Power è un azienda solida che opera nel mercato libero del gas e dell energia elettrica. Si rivolge a tutti i tipi di clientela offrendo non solo prezzi fissi e indicizzati ma
ENERGY ON AIR 2 Sky Gas & Power è un azienda solida che opera nel mercato libero del gas e dell energia elettrica. Si rivolge a tutti i tipi di clientela offrendo non solo prezzi fissi e indicizzati ma
ENERGY ON AIR SKY GAS&POWER
 ENERGY ON AIR 2 Sky Gas & Power è un azienda solida che opera nel mercato libero del gas e dell energia elettrica. Si rivolge a tutti i tipi di clientela offrendo non solo prezzi fissi e indicizzati ma
ENERGY ON AIR 2 Sky Gas & Power è un azienda solida che opera nel mercato libero del gas e dell energia elettrica. Si rivolge a tutti i tipi di clientela offrendo non solo prezzi fissi e indicizzati ma
Indice. 2 La struttura finanziaria dell economia 15. xiii. Presentazione
 Indice Presentazione xiii 1 Le funzioni del sistema finanziario 1 1.1 Che cos è il sistema finanziario 2 1.2 La natura e le caratteristiche degli strumenti finanziari 2 1.3 Quali funzioni svolge il sistema
Indice Presentazione xiii 1 Le funzioni del sistema finanziario 1 1.1 Che cos è il sistema finanziario 2 1.2 La natura e le caratteristiche degli strumenti finanziari 2 1.3 Quali funzioni svolge il sistema
Giustificazione dell intervento pubblico
 Giustificazione dell intervento pubblico Giustificazione dell intervento pubblico Oggetto: Analizzare i contributi della teoria economica per spiegare gli interventi pubblici a livello microeconomico Giustificazione
Giustificazione dell intervento pubblico Giustificazione dell intervento pubblico Oggetto: Analizzare i contributi della teoria economica per spiegare gli interventi pubblici a livello microeconomico Giustificazione
PROTOCOLLO DI INTESA TRA L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI E L AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
 PROTOCOLLO DI INTESA TRA L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI E L AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE L Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: ART o, congiuntamente all Agenzia
PROTOCOLLO DI INTESA TRA L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI E L AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE L Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: ART o, congiuntamente all Agenzia
Analisi dei mercati concorrenziali e valutazione delle politiche pubbliche. G. Pignataro Microeconomia SPOSI
 Analisi dei mercati concorrenziali e valutazione delle politiche pubbliche 1 Efficienza di un mercato concorrenziale Efficienza economica allocativa: Massimizzazione del surplus aggregato del consumatore
Analisi dei mercati concorrenziali e valutazione delle politiche pubbliche 1 Efficienza di un mercato concorrenziale Efficienza economica allocativa: Massimizzazione del surplus aggregato del consumatore
Nuovi strumenti finanziari per lo sviluppo d impresa
 RICerca e Consulenza per le Istituzioni e le Organizzazioni Nuovi strumenti finanziari per lo sviluppo d impresa Prof. Andrea Paci Firenze, Palazzo dei Congressi - 21 dicembre 2006 I vincoli del modello
RICerca e Consulenza per le Istituzioni e le Organizzazioni Nuovi strumenti finanziari per lo sviluppo d impresa Prof. Andrea Paci Firenze, Palazzo dei Congressi - 21 dicembre 2006 I vincoli del modello
La comprensione dell impresa e del contesto in cui opera: Un caso aziendale Soluzione
 La comprensione dell impresa e del contesto in cui opera: Un caso aziendale Soluzione Corso di Audit e Governance Università degli Studi di Bergamo Prof.ssa Stefania Servalli Fattori esterni che influiscono
La comprensione dell impresa e del contesto in cui opera: Un caso aziendale Soluzione Corso di Audit e Governance Università degli Studi di Bergamo Prof.ssa Stefania Servalli Fattori esterni che influiscono
Estratti e conclusioni del documento votato in Commissione Finanze: INDAGINE CONOSCITIVA SUI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
 Estratti e conclusioni del documento votato in Commissione Finanze: INDAGINE CONOSCITIVA SUI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI Le risultanze emerse nel corso dell indagine permettono di circoscrivere
Estratti e conclusioni del documento votato in Commissione Finanze: INDAGINE CONOSCITIVA SUI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI Le risultanze emerse nel corso dell indagine permettono di circoscrivere
DIRITTO delle COMUNICAZIONI -Communication Law & Policy- II. Le Autorità Indipendenti
 DIRITTO delle COMUNICAZIONI -Communication Law & Policy- II 2 2. Diritto delle comunicazioni Autorità di regolazione e controllo. Fonti del diritto delle comunicazioni Il diritto delle comunicazioni è
DIRITTO delle COMUNICAZIONI -Communication Law & Policy- II 2 2. Diritto delle comunicazioni Autorità di regolazione e controllo. Fonti del diritto delle comunicazioni Il diritto delle comunicazioni è
Domande d esame. Prima parte del corso di Economia e Organizzazione Aziendale. di Federico Franceschini 1/15
 Domande d esame Prima parte del corso di Economia e Organizzazione Aziendale di Federico Franceschini 1/15 Cos è il tasso d interesse? E la remunerazione del costo opportunità dell uso del denaro. C è
Domande d esame Prima parte del corso di Economia e Organizzazione Aziendale di Federico Franceschini 1/15 Cos è il tasso d interesse? E la remunerazione del costo opportunità dell uso del denaro. C è
MERCInTRENO. - Forum per il Trasporto Ferroviario delle Merci - Ed. 2017
 MERCInTRENO - Forum per il Trasporto Ferroviario delle Merci - Ed. 2017 CNEL, Viale David Lubin, 2 Roma 26 settembre 2017 1 Nel settore industria: Dal 1945 è l Associazione che rappresenta in modo esclusivo
MERCInTRENO - Forum per il Trasporto Ferroviario delle Merci - Ed. 2017 CNEL, Viale David Lubin, 2 Roma 26 settembre 2017 1 Nel settore industria: Dal 1945 è l Associazione che rappresenta in modo esclusivo
Funzioni e struttura del sistema finanziario, ruolo di quello bancario
 Funzioni e struttura del sistema finanziario, ruolo di quello bancario Obiettivi Analizzare le funzioni, la struttura e le componenti del sistema finanziario e il ruolo del sistema bancario Osservare l
Funzioni e struttura del sistema finanziario, ruolo di quello bancario Obiettivi Analizzare le funzioni, la struttura e le componenti del sistema finanziario e il ruolo del sistema bancario Osservare l
REGOLAMENTAZIONE E POLITICHE PER LA CONCORRENZA POLITICHE PER LA CONCORRENZA. Concorrenza per il mercato: le aste. Le politiche per la concorrenza
 Bosi (a cura di), Corso di scienza delle finanze, il Mulino, 2010 1 Capitolo VI. REGOLAMENTAZIONE E POLITICHE PER LA CONCORRENZA POLITICHE PER LA CONCORRENZA Bosi (a cura di), Corso di scienza delle finanze,
Bosi (a cura di), Corso di scienza delle finanze, il Mulino, 2010 1 Capitolo VI. REGOLAMENTAZIONE E POLITICHE PER LA CONCORRENZA POLITICHE PER LA CONCORRENZA Bosi (a cura di), Corso di scienza delle finanze,
MIGLIORARE LA COMPETITIVITA DELLE PMI NELL ECONOMIA GLOBALE: STRATEGIE E POLITICHE
 MIGLIORARE LA COMPETITIVITA DELLE PMI NELL ECONOMIA GLOBALE: STRATEGIE E POLITICHE La Conferenza di Bologna per i Ministri responsabili delle PMI e i Ministri dell Industria organizzata congiuntamente
MIGLIORARE LA COMPETITIVITA DELLE PMI NELL ECONOMIA GLOBALE: STRATEGIE E POLITICHE La Conferenza di Bologna per i Ministri responsabili delle PMI e i Ministri dell Industria organizzata congiuntamente
Capitolo II LE DEBOLEZZE STRUTTURALI DELL ECONOMIA ITALIANA. II.1 La Performance dell Economia nell ultimo Decennio
 Capitolo II LE DEBOLEZZE STRUTTURALI DELL ECONOMIA ITALIANA II.1 La Performance dell Economia nell ultimo Decennio I recenti dati di contabilità nazionale confermano un passaggio difficile per l economia
Capitolo II LE DEBOLEZZE STRUTTURALI DELL ECONOMIA ITALIANA II.1 La Performance dell Economia nell ultimo Decennio I recenti dati di contabilità nazionale confermano un passaggio difficile per l economia
Regolamentazione del sistema finanziario
 Regolamentazione del sistema finanziario Prof. Domenico Curcio Cattedra di Mercati e investimenti finanziari 2 Perché regolare il sistema finanziario? Tre motivazioni essenziali: Centralità del sistema
Regolamentazione del sistema finanziario Prof. Domenico Curcio Cattedra di Mercati e investimenti finanziari 2 Perché regolare il sistema finanziario? Tre motivazioni essenziali: Centralità del sistema
La chimica in Toscana
 La chimica in Toscana Alcuni numeri Novembre 2018 COSA rappresenta il settore Connubio tra scienza e industria: la chimica intesa come scienza studia le proprietà e le trasformazioni della materia, l industria
La chimica in Toscana Alcuni numeri Novembre 2018 COSA rappresenta il settore Connubio tra scienza e industria: la chimica intesa come scienza studia le proprietà e le trasformazioni della materia, l industria
Cosa sono. Società controllate: quando la quota degli enti pubblici supera la maggioranza assoluta
 SOCIETA PARTECIPATE Cosa sono Cosa sono Società con una parte del capitale sociale che appartiene agli enti pubblici (non solo enti locali) partecipazione totalitaria partecipazione parziale ( società
SOCIETA PARTECIPATE Cosa sono Cosa sono Società con una parte del capitale sociale che appartiene agli enti pubblici (non solo enti locali) partecipazione totalitaria partecipazione parziale ( società
La libera circolazione dei dati all interno della UE
 La libera circolazione dei dati all interno della UE a cura di Patrizia Goffi e Antonella Roletti Dottori Commercialisti Per Comitato Pari Opportunità ODCEC Torino Comitato Pari Opportunità Ordine dei
La libera circolazione dei dati all interno della UE a cura di Patrizia Goffi e Antonella Roletti Dottori Commercialisti Per Comitato Pari Opportunità ODCEC Torino Comitato Pari Opportunità Ordine dei
Capitolo I. 3. La regolamentazione pubblica delle attività economiche: e governo politico dell economia
 INDICE - SOMMARIO Istruzioni per l uso... pag. XI Upgrade per la presente edizione...» XVII Last (minute) prediction...» XIX Capitolo I Regolamentazione pubblica delle attività economiche e governo politico
INDICE - SOMMARIO Istruzioni per l uso... pag. XI Upgrade per la presente edizione...» XVII Last (minute) prediction...» XIX Capitolo I Regolamentazione pubblica delle attività economiche e governo politico
La pianificazione degli investimenti di trade marketing. Beatrice Luceri Facoltà di Economia Anno Accademico 2000/01
 La pianificazione degli investimenti di trade marketing Beatrice Luceri Facoltà di Economia Anno Accademico 2000/01 La gestione della contribuzione Per gestire le condizioni di vendita, occorre definire
La pianificazione degli investimenti di trade marketing Beatrice Luceri Facoltà di Economia Anno Accademico 2000/01 La gestione della contribuzione Per gestire le condizioni di vendita, occorre definire
Sanità. Corso di Scienza delle Finanze Cleam, classe 3 Università Bocconi a.a Dott.ssa Simona Scabrosetti
 Sanità Corso di Cleam, classe 3 Università Bocconi a.a. 2011-2012 Dott.ssa Simona Scabrosetti Aleatorietà del bene salute e avversione al rischio Aleatorietà del bene salute: ogni individuo ha una certa
Sanità Corso di Cleam, classe 3 Università Bocconi a.a. 2011-2012 Dott.ssa Simona Scabrosetti Aleatorietà del bene salute e avversione al rischio Aleatorietà del bene salute: ogni individuo ha una certa
LA POLITICA COMUNE DELLA PESCA
 POLITICHE INTERNE DELL UE: PESCA, TRASPORTI E RETI TRANSEUROPEE PROF.SSA MARIATERESA STILE Indice 1 LA POLITICA COMUNE DELLA PESCA ------------------------------------------------------------------------------
POLITICHE INTERNE DELL UE: PESCA, TRASPORTI E RETI TRANSEUROPEE PROF.SSA MARIATERESA STILE Indice 1 LA POLITICA COMUNE DELLA PESCA ------------------------------------------------------------------------------
Gnl: : opportunità e incentivi
 Seminario IEFE Gnl: : opportunità e incentivi Vincenzo Cioffo Autorità per l energia l elettrica e il gas Direzione Mercati 29 gennaio 2008 Milano 1 Domande a cui rispondere Quali sono i vantaggi del Gnl?
Seminario IEFE Gnl: : opportunità e incentivi Vincenzo Cioffo Autorità per l energia l elettrica e il gas Direzione Mercati 29 gennaio 2008 Milano 1 Domande a cui rispondere Quali sono i vantaggi del Gnl?
IL PROJECT FINANCING Lezione 1
 IL PROJECT FINANCING Lezione 1 Tecnologia dell Architettura Strumenti e Metodi della Produzione Corso D Prof. Arch. Gianni Bardazzi Prof. Arch. Nina Avramidou A.A. 2007 2008 1. Investimenti infrastrutturali
IL PROJECT FINANCING Lezione 1 Tecnologia dell Architettura Strumenti e Metodi della Produzione Corso D Prof. Arch. Gianni Bardazzi Prof. Arch. Nina Avramidou A.A. 2007 2008 1. Investimenti infrastrutturali
IT Unita nella diversità IT B8-0286/23. Emendamento. Julia Reda, Michel Reimon a nome del gruppo Verts/ALE
 25.11.2014 B8-0286/23 23 Considerando I I. considerando che una concorrenza senza ostacoli e condizioni di parità per le imprese, a promozione degli investimenti, sono di vitale importanza per questo settore
25.11.2014 B8-0286/23 23 Considerando I I. considerando che una concorrenza senza ostacoli e condizioni di parità per le imprese, a promozione degli investimenti, sono di vitale importanza per questo settore
