INTRODUZIONE ALLA RELATIVITÀ GENERALE Adattamento di appunti di Isidoro Ferrante, Università di Pisa
|
|
|
- Tommaso Biagi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 INTRODUZIONE ALLA RELATIVITÀ GENERALE Adattamento di appunti di Isidoro Ferrante, Università di Pisa La formulazione della relatività ristretta non lasciò del tutto soddisfatto Einstein: rimanevano infatti alcuni punti da chiarire: in particolare, risultava insoddisfacente il ruolo privileiato svolto dai sistemi di riferimento inerziali. Cos'è, insomma, un sistema di riferimento inerziale, e perché non possiamo descrivere le lei della natura a partire da un sistema di riferimento qualunque, anche accelerato o rotante? Inoltre la lee di Newton si sposava male con i principi della relatività ristretta a causa dell'azione istantanea delle forze, incompatibile con una velocità finita della luce. La soluzione iunse ad Einstein dal cosiddetto principio di equivalenza, principio in realtà ben conosciuto ma al quale non era stato dato il iusto peso neli anni precedenti. Il principio di equivalenza trae oriine dall'uualianza sperimentale tra massa inerziale e massa ravitazionale. Vediamo di cosa si tratta: sappiamo che nella meccanica newtoniana la forza ravitazionale tra due corpi è proporzionale alla loro massa ravitazionale: F = G m M r 2 Ma la massa interviene anche nella seconda lee della dinamica, dove prende il nome di massa inerziale: F = m i a Se la forza che aisce su un corpo è solo la forza ravitazionale, si ottiene: G m M r 2 = m i a Ora, non esiste nessun motivo al mondo per cui la massa cosiddetta inerziale, ovvero quella che interviene nel secondo principio della dinamica, debba essere uuale a quella che interviene nella forza ravitazionale: potrebbe ad esempio esserci una piccola differenza dovuta alla diversa proporzione di protoni e neutroni con cui sono composti materiali diversi. Eppure, si verifica con dei bellissimi esperimenti (come quelli di Eötvös nel 1909 e i successivi raffinamenti ad opera di Dicke) che la massa inerziale e quella ravitazionale sono la stessa identica cosa. La conseuenza è che, semplificando la massa, si ottiene che tutti i corpi soetti alla stessa attrazione ravitazionale da parte di un corpo di massa M subiscono la medesima accelerazione: a = G M r 2 = dove è detto campo ravitazionale. Nel caso in cui M sia la massa della Terra e r il suo raio, coincide con l accelerazione di ravità, pari a circa 9,81 m/s 2. Nel caso di più sorenti ravitazionali M 1, M 2,, sarà la somma dei contributi provenienti da ciascuna di esse.
2 FIGURA 1. L 'ascensore di Einstein : all'interno della cabina tutti li oetti cadono con la stessa accelerazione: se sono fermi, sembrano fluttuare in assenza di peso; se sono in moto, sembrano muoversi di moto traslatorio uniforme. A partire da questo fatto, si innesca il raionamento di Einstein: supponiamo infatti di trovarci all'interno di una cabina (il famoso ascensore di Einstein ) completamente chiusa (vedi fiura 1). Supponiamo che questa cabina stia cadendo nel campo ravitazionale: allora tutti li oetti presenti all'interno viaeranno verso il basso con la stessa identica accelerazione e, se inizialmente fermi, con la stessa identica velocità: pertanto ci appariranno fluttuare intorno a noi. Noi stessi non sentiremo nessuna pressione esercitata dai nostri piedi verso il pavimento, in quanto anche il pavimento dell'ascensore starà viaiando con la nostra stessa velocità. Dalla nostra posizione all'interno dell'ascensore, completamente oscurato e senza possibilità di uardar fuori, dopo un primo momento di panico cominciamo a raionare: e allora, vedendo li oetti fluttuare, pensiamo che forse semplicemente qualcuno ha in qualche modo spento la ravità, e probabilmente ci troviamo nello spazio fluttuanti molto lontani da qualsiasi corpo di rande massa. Da questa storiella si può dedurre un fatto molto importante: all'interno dell'ascensore non siamo in rado di capire, senza uardar fuori, se stiamo cadendo liberamente nel campo ravitazionale o se, invece, ci troviamo in una reione di spazio in cui i campi ravitazionali sono nulli: un sistema di riferimento non inerziale, che si muove soetto alle sole forze ravitazionali, è indistinuibile da un sistema di riferimento inerziale in cui la ravità è assente 1. Immainiamo adesso di essere sempre all'interno nell'ascensore, ma di non avvertire nulla di strano: la pressione esercitata sul pavimento dai nostri piedi è assolutamente identica a quella 1 L 'esperienza della caduta ci ricorda che quando entrano in ioco altre forze, oltre a quelle ravitazionali, la situazione cambia...
3 FIGURA 2. Un campo ravitazionale uniforme per un sistema collocato a terra (a sinistra) è indistinuibile da un sistema di riferimento non inerziale con accelerazione diretta verso l'alto che si muove in assenza di campo (a destra). che sentiamo normalmente stando in piedi sul pavimento. Concludiamo pertanto che la cabina è ferma. Però dopo un po' pensiamo che forse in realtà ci troviamo nello spazio profondo, su un razzo che imprime alla cabina e a noi una accelerazione diretta verso l'alto: in questo caso, come si sa dallo studio dei sistemi di riferimento non inerziali, nascerebbe sui corpi una forza apparente di modulo m, diretta in direzione opposta all'accelerazione della cabina (vedi fiura 2). L'intuizione di Einstein fu quella di capire che non esiste modo di distinuere, dall'interno dell'ascensore, se ci si trova in presenza di un campo ravitazionale o in un sistema di riferimento non inerziale: sotto opportune ipotesi, le due situazioni sono equivalenti 2. In particolare, in un sistema di riferimento in caduta libera in un campo ravitazionale, e quindi in assenza di altre forze, li effetti del campo ravitazionale si azzerano. 2 L'affermazione va melio precisata: in realtà è possibile distinuere tra le due situazioni, a patto di trovarsi in un ascensore sufficientemente rande: infatti in un ascensore accelerato la forza apparente m è la stessa in oni punto della cabina, mentre in un ascensore poiato sulla superficie terrestre il campo in alto è leermente inferiore di quello sul pavimento: quindi queste osservazioni sono limitate ad una reione di spazio limitata, ovvero sono di carattere locale.
4 FIGURA 3. In un razzo accelerato verso l'alto un fotone emesso dal soffitto viene ricevuto circa t secondi dopo: in questo intervallo il razzo ha aumentato la velocità di v = t, quindi il fotone apparirà di frequenza maiore al suo arrivo al pavimento. Ma si è ià visto che un razzo accelerato è equivalente al suo interno ad un razzo fermo sulla superficie della Terra... v v+ t/2 v+ t Il principio di relatività enerale esprime dunque l'equivalenza tra inerzia e ravità. Già da questo principio, è possibile trarre alcune conseuenze interessanti. Supponiamo ad esempio che sul soffitto del famoso ascensore, di altezza h, fermo sulla superficie della terra, si trovi una sorente di luce di frequenza f 0. Questa luce viene inviata verso il pavimento (vedi fiura 6.3). Ora, il principio di equivalenza ci dice che questa situazione è equivalente a quella che avremmo se l'ascensore fosse accelerato con accelerazione verso l'alto: ma in questo caso, se all'istante di partenza la cabina avesse avuto una velocità v 0, nell'istante in cui la luce raiune il pavimento avrebbe una velocità circa pari a v 0 + t, dove t è il tempo che la luce impiea ad andare dal soffitto al pavimento, ovvero t = h/c (nell'ipotesi in cui le velocità in ioco siano piccole rispetto a c). Quindi un rilevatore sul pavimento, nell'istante in cui riceve la radiazione, viaerà ad una velocità t = h/c più elevata di quella che era la velocità della sorente all'istante di emissione: si prevede pertanto,
5 a causa dell'effetto Doppler, che un osservatore solidale al pavimento dell ascensore percepisca una frequenza f, più elevata di f 0. Facendo un po di approssimazioni, nel caso v << c, si trova f f 0 h/c 2 : la luce aumenta la sua frequenza man mano che cade in un campo ravitazionale. Questo fenomeno è stato verificato tramite un esperimento di Pound e Rebka, in cui emettitore e ricevitore si trovavano sul tetto e sul pavimento della Jefferson Tower nel campus di Harvard, alta 22 metri e mezzo. Il fenomeno prende il nome di red-shift ravitazionale: la luce proveniente da una stella, dove il campo ravitazionale è più intenso rispetto a quello terrestre, viene percepita sulla Terra con una frequenza inferiore rispetto a quella di emissione. Si ha quindi uno spostamento delle rihe spettrali verso frequenze più basse, ossia verso il rosso. Inoltre, la frequenza di assorbimento e di emissione di un fotone dipende dalle frequenze di vibrazione interna deli atomi, che quindi cambiano in modo dipendente dal campo ravitazionale. Lo stesso discorso vale per li oroloi atomici, le cui misure di tempo sono reolate dalle frequenze di oscillazione atomica. Il periodo di oscillazione di un oroloio atomico è inversamente proporzionale alla sua frequenza, così un oroloio collocato al livello del mare misura tempi più brevi rispetto ad un oroloio situato in quota, come è stato verificato per la prima volta nel 1975 da Briatore e Leschiutta. Supponiamo adesso di avere una cabina in caduta libera verso il sole. Un raio di luce viene emesso dal lato sinistro della cabina, parallelamente al pavimento, e raiune il lato destro. Supponiamo, per semplicità, che all'istante di emissione la velocità della cabina relativa al sole sia esattamente zero (è possibile ad esempio che la cabina sia stata lanciata verso l'alto e che incominci la discesa). Gli occupanti della cabina non sanno se si trovano in caduta libera, o nello spazio vuoto privo di campi ravitazionali: osservano quindi il raio procedere dritto, rimanendo sempre alla stessa altezza rispetto al pavimento. Un osservatore fermo rispetto al sole però vede la cabina scendere di una quantità y =½ t 2, dove t è il tempo trascorso dall'emissione. Nel tempo t il raio ha percorso la distanza x = ct, per cui viene visto spostato verso il basso di una quantità y = ½ (x/c) 2 : si conclude che il raio di luce non procede secondo una linea retta, bensì luno una traiettoria approssimativamente parabolica: i campi ravitazionali attraono i rai di luce. Anche questa previsione della relatività fu verificata da una famosa spedizione scientifica nel 1919 uidata da Sir Arthur Eddinton durante la quale venne osservata per la prima volta la deflessione dei rai luminosi provenienti da stelle lontane nel passare vicino alla superficie del Sole. Questa però non è la ne della storia: in fondo non abbiamo fatto altro che applicare il principio di equivalenza alla luce, senza entrare nel merito della natura della ravità. Einstein fece quest'altro passo: abbiamo visto come il tempo proprio viene definito come il modulo quadro della separazione tra due eventi. Ora scopriamo che il tempo proprio senato da un oroloio dipende dal potenziale ravitazionale a cui questo si trova. Quindi dobbiamo concludere che nel fare il modulo quadro di un quadrivettore dobbiamo in qualche modo tenere conto del potenziale ravitazionale: la ravità modifica la metrica dello spazio tempo!
6 Per capire, in linuaio comune, cosa sinifica una cosa del enere, si pensi a due punti su una superficie: se la superficie è piana, il percorso più breve tra i due punti è una retta, e la distanza si calcola con l'usuale formula pitaorica; se invece la superficie è curva, il percorso più breve tra i due punti dipende da come la superficie è curvata, e così pure la distanza risultante tra i due punti. Quindi dire che la distanza (quadridimensionale) tra due punti dipende dal campo ravitazionale sinifica dire che lo spazio quadridimensionale è curvo, e che la sua curvatura dipende dall'intensità del campo ravitazionale stesso. Il quadro dipinto da Einstein nella sua teoria è quindi il seuente: (1) I sistemi di riferimento inerziali non sono altro che sistemi di riferimento in caduta libera nel campo ravitazionale. (2) Lo spazio tempo non è piatto: la sua distanza non è definita dalla semplice definizione di Minkowsky, ma deve tenere conto del campo ravitazionale. (3) I corpi seuono, in assenza di altre forze, quelle linee per cui il tempo proprio è massimo: queste linee costituiscono le eodetiche dello spazio quadridimensionale. (4) Il modo esatto in cui lo spazio viene curvato dalla presenza della materia è l`ultima caratteristica da determinare, ed Einstein vi iune tramite considerazioni teoriche molto raffinate. Da notare che i soli punti 1, 2 e 3 non consentono di determinare esattamente il punto 4: la relatività enerale non è che uno dei tanti possibili modi di colleare la presenza della materia alla curvatura dello spazio: esistono altre teorie che soddisfano ai criteri 1, 2 e 3, e sono dette teorie metriche ravitazionali, ma solamente una di queste è la relatività enerale. Allo stato attuale deli esperimenti, non esiste nessuna evidenza sperimentale che descrimini in modo certo una teoria dalle altre, ma comunque la relatività enerale così come Einstein l'aveva concepita nel 1916 rimane la favorita. Tenendo conto della curvatura dello spazio, i risultati trovati per la deflessione anolare risultano il doppio di quelli calcolati utilizzando il solo principio di equivalenza. La spedizione di Eddinton del 1919 misurò esattamente il risultato previsto dalla teoria di Einstein, tenendo conto della curvatura dello spazio; i numerosi esperimenti successivi, basati non più sulla luce visibile ma sulle emissioni radio non hanno fatto altro che confermare questo risultato. Ma il primo successo della teoria della relatività enerale fu la spieazione della precessione dell'orbita di Mercurio: infatti era noto da dati osservativi che l'orbita di mercurio ruotava di circa 574 in un secolo. Le correzioni dovute all'influenza di altri pianeti o alla non perfetta sfericità del Sole permettevano di spieare 531, mentre i rimanenti 43 rimanevano misteriosi. Einstein si convinse di essere sulla iusta strada quando si rese conto che la sua teoria era in rado di prevedere esattamente questo risultato. Attualmente, la relatività enerale ode di una serie notevole di verifiche sperimentali: manca però la scoperta delle onde ravitazionali previste dalla teoria. Per raiunere questo trauardo, diversi esperimenti stanno lavorando in tutto il mondo: uno di questi è l'interferometro Viro costruito nella campana pisana.
La relatività generale. Lezioni d'autore
 La relatività generale Lezioni d'autore Il GPS (RaiScienze) VIDEO Einstein e la teoria della relativita (History Channel) VIDEO Einstein: dimostrazione della teoria generale della gravità (History Channel))
La relatività generale Lezioni d'autore Il GPS (RaiScienze) VIDEO Einstein e la teoria della relativita (History Channel) VIDEO Einstein: dimostrazione della teoria generale della gravità (History Channel))
La relatività generale
 La relatività enerale Mattia Villa V scientifico Indice: Premessa.3 Punti di partenza per la relatività Generale 3 Esperimenti ideali..4 Relatività Generale e sue applicazioni...4 1. Effetti dello spazio-tempo
La relatività enerale Mattia Villa V scientifico Indice: Premessa.3 Punti di partenza per la relatività Generale 3 Esperimenti ideali..4 Relatività Generale e sue applicazioni...4 1. Effetti dello spazio-tempo
LE FORZE E IL MOTO. Il moto lungo un piano inclinato
 LE FORZE E IL MOTO Il moto lungo un piano inclinato Il moto di caduta lungo un piano inclinato un moto uniformemente accelerato in cui l accelerazione è diretta parallelamente al piano (verso il basso)
LE FORZE E IL MOTO Il moto lungo un piano inclinato Il moto di caduta lungo un piano inclinato un moto uniformemente accelerato in cui l accelerazione è diretta parallelamente al piano (verso il basso)
4. a quale distanza d l oggetto cade rispetto alla posizione orizzontale del punto di lancio;
 1 Esercizio Un oetto viene lanciato dal balcone di una finestra con velocità iniziale di modulo v 0 15 m/s, ad un anolo θ 60 o rispetto all orizzontale. La finestra si trova ad un altezza h di 8 m dal
1 Esercizio Un oetto viene lanciato dal balcone di una finestra con velocità iniziale di modulo v 0 15 m/s, ad un anolo θ 60 o rispetto all orizzontale. La finestra si trova ad un altezza h di 8 m dal
θ h max Esercizio 1. l altezza massima h max a cui giunge l oggetto; 2. quanto tempo impiega per cadere al suolo;
 1 Esercizio Un oetto viene lanciato dal balcone di una finestra con velocità iniziale di modulo v 0 15 m/s, ad un anolo θ 60 o rispetto all orizzontale. La finestra si trova ad un altezza di 8 m dal suolo.
1 Esercizio Un oetto viene lanciato dal balcone di una finestra con velocità iniziale di modulo v 0 15 m/s, ad un anolo θ 60 o rispetto all orizzontale. La finestra si trova ad un altezza di 8 m dal suolo.
Moto parabolico. Mauro Saita Versione provvisoria, ottobre 2012.
 Moto parabolico. Mauro Saita e-mail: maurosaita@tiscalinet.it Versione provvisoria, ottobre 2012. 1 Moto parabolico. Gli esercizi contrassenati con (*) sono più difficili. Problema 1.1 (Lancio di un proiettile.).
Moto parabolico. Mauro Saita e-mail: maurosaita@tiscalinet.it Versione provvisoria, ottobre 2012. 1 Moto parabolico. Gli esercizi contrassenati con (*) sono più difficili. Problema 1.1 (Lancio di un proiettile.).
La teoria della Relatività Generale
 Liceo Classico Seneca La teoria della Relatività Generale Prof. E. Modica La massa Dipendenza della massa dalla velocità Se un corpo di massa m è soggetto ad una forza costante F nella direzione della
Liceo Classico Seneca La teoria della Relatività Generale Prof. E. Modica La massa Dipendenza della massa dalla velocità Se un corpo di massa m è soggetto ad una forza costante F nella direzione della
Soluzioni della prima prova di accertamento Fisica Generale 1
 Corso di Laurea in Ineneria Biomedica, dell Informazione, Elettronica e Informatica Canale 2 (S. Amerio, L. Martucci) Padova, 20 aprile 2013 Soluzioni della prima prova di accertamento Fisica Generale
Corso di Laurea in Ineneria Biomedica, dell Informazione, Elettronica e Informatica Canale 2 (S. Amerio, L. Martucci) Padova, 20 aprile 2013 Soluzioni della prima prova di accertamento Fisica Generale
Forze apparenti Piattaforma che è in moto rotatorio uniforme come una piattaforma circolare in rotazione.
 Forze apparenti Piattaforma che è in moto rotatorio uniforme come una piattaforma circolare in rotazione. Osservatore sulla piattaforma L osservatore che si trova sulla piattaforma ( sistema di riferimento
Forze apparenti Piattaforma che è in moto rotatorio uniforme come una piattaforma circolare in rotazione. Osservatore sulla piattaforma L osservatore che si trova sulla piattaforma ( sistema di riferimento
Verifica di Fisica 3 a B Scientifico - 11 aprile 2011
 Liceo Carducci Volterra - Prof. Francesco Daddi Verifica di Fisica 3 a B Scientifico - 11 aprile 2011 Reolamento: punteio di partenza 2/10. Per oni quesito si indichi una sola risposta. Oni risposta esatta
Liceo Carducci Volterra - Prof. Francesco Daddi Verifica di Fisica 3 a B Scientifico - 11 aprile 2011 Reolamento: punteio di partenza 2/10. Per oni quesito si indichi una sola risposta. Oni risposta esatta
Verifica di Fisica 3 a B Scientifico - 11 aprile 2011
 Liceo Carducci Volterra - Prof. Francesco Daddi Verifica di Fisica 3 a B Scientifico - 11 aprile 2011 Reolamento: punteio di partenza 2/10. Per oni quesito si indichi una sola risposta. Oni risposta esatta
Liceo Carducci Volterra - Prof. Francesco Daddi Verifica di Fisica 3 a B Scientifico - 11 aprile 2011 Reolamento: punteio di partenza 2/10. Per oni quesito si indichi una sola risposta. Oni risposta esatta
Meccanica parte seconda: Perche' i corpi. si muovono? la Dinamica: studio delle Forze
 Meccanica parte seconda: Perche' i corpi si muovono? la Dinamica: studio delle Forze Il concetto di forza Le forze sono le cause del moto o meglio della sua variazione Se la velocita' e' costante o nulla
Meccanica parte seconda: Perche' i corpi si muovono? la Dinamica: studio delle Forze Il concetto di forza Le forze sono le cause del moto o meglio della sua variazione Se la velocita' e' costante o nulla
Liceo Carducci Volterra - Classe 3 a B Scientifico - Prof. Francesco Daddi - 29 novembre 2010. d) la velocità con cui giunge a terra.
 Liceo Carducci Volterra - Classe 3 a B Scientifico - Prof. Francesco Daddi - 9 novembre 010 Esercizi sul moto di caduta libera Esercizio 1. Una pallina da tennis viene lasciata cadere dal punto più alto
Liceo Carducci Volterra - Classe 3 a B Scientifico - Prof. Francesco Daddi - 9 novembre 010 Esercizi sul moto di caduta libera Esercizio 1. Una pallina da tennis viene lasciata cadere dal punto più alto
1 di 5 12/02/ :23
 Verifica: tibo5794_me08_test1 nome: classe: data: Esercizio 1. La traiettoria di un proiettile lanciato con velocità orizzontale da una certa altezza è: un segmento di retta obliqua percorso con accelerazione
Verifica: tibo5794_me08_test1 nome: classe: data: Esercizio 1. La traiettoria di un proiettile lanciato con velocità orizzontale da una certa altezza è: un segmento di retta obliqua percorso con accelerazione
Premessa: Si continua a studiare il moto degli oggetti in approssimazione di PUNTO MATERIALE
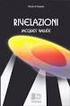 Leggi della Dinamica Premessa: Si continua a studiare il moto degli oggetti in approssimazione di PUNTO MATERIALE Fisica con Elementi di Matematica 1 Leggi della Dinamica Perché i corpi cambiano il loro
Leggi della Dinamica Premessa: Si continua a studiare il moto degli oggetti in approssimazione di PUNTO MATERIALE Fisica con Elementi di Matematica 1 Leggi della Dinamica Perché i corpi cambiano il loro
Prova Parziale 2 Su un piano inclinato con un angolo θ = 60 rispetto all orizzontale è posto un blocco di peso P = 1.0 N. La forza di contatto F che i
 Su un piano inclinato con un angolo θ = 60 rispetto all orizzontale è posto un blocco di peso P = 1.0 N. La forza di contatto F che il piano esercita sul blocco vale in modulo: F = 9.8 N F = 0.5 N F =
Su un piano inclinato con un angolo θ = 60 rispetto all orizzontale è posto un blocco di peso P = 1.0 N. La forza di contatto F che il piano esercita sul blocco vale in modulo: F = 9.8 N F = 0.5 N F =
PARTE V TEORIA DELLA RELATIVITÀ GENERALE
 PARTE V TEORIA DELLA RELATIVITÀ GENERALE 2 TITOLO DEL VOLUME 1. Introduzione La Relatività Generale è, matematicamente, una teoria estremamente complessa. Einstein disse che era il problema più complicato
PARTE V TEORIA DELLA RELATIVITÀ GENERALE 2 TITOLO DEL VOLUME 1. Introduzione La Relatività Generale è, matematicamente, una teoria estremamente complessa. Einstein disse che era il problema più complicato
circostanze che lo determinano e lo modificano. Secondo alcuni studi portati avanti da Galileo GALILEI e Isac
 La DINAMICA è il ramo della meccanica che si occupa dello studio del moto dei corpi e delle sue cause o delle circostanze che lo determinano e lo modificano. Secondo alcuni studi portati avanti da Galileo
La DINAMICA è il ramo della meccanica che si occupa dello studio del moto dei corpi e delle sue cause o delle circostanze che lo determinano e lo modificano. Secondo alcuni studi portati avanti da Galileo
MA DIO GIOCA A DADI CON IL MONDO?
 MA DIO GIOCA A DADI CON IL MONDO? Le basi delle teorie della RELATIVITA e della MECCANICA QUANTISTICA A cura di Giorgio PALAZZI e Alberto RENIERI EINSTEIN E LA RELATIVITA SIAMO ALL INIZIO DEL XX SECOLO
MA DIO GIOCA A DADI CON IL MONDO? Le basi delle teorie della RELATIVITA e della MECCANICA QUANTISTICA A cura di Giorgio PALAZZI e Alberto RENIERI EINSTEIN E LA RELATIVITA SIAMO ALL INIZIO DEL XX SECOLO
Soluzione degli esercizi sul moto di caduta libera
 1 Liceo Carducci Volterra - Classe 3 a B Scientifico - Prof. Francesco Daddi - 9 novembre 010 Soluzione deli esercizi sul moto di caduta libera Esercizio 1. Una pallina da tennis viene lasciata cadere
1 Liceo Carducci Volterra - Classe 3 a B Scientifico - Prof. Francesco Daddi - 9 novembre 010 Soluzione deli esercizi sul moto di caduta libera Esercizio 1. Una pallina da tennis viene lasciata cadere
MECCANICA QUANTISTICA
 La Meccanica MECCANICA: Studio del moto di un corpo in tutti i suoi aspetti. Si divide in: STATICA: Forze e Equilibrio. Studia delle condizioni per l equilibrio (corpi fermi). CINEMATICA: Descrizione il
La Meccanica MECCANICA: Studio del moto di un corpo in tutti i suoi aspetti. Si divide in: STATICA: Forze e Equilibrio. Studia delle condizioni per l equilibrio (corpi fermi). CINEMATICA: Descrizione il
Moti relativi. Cenni. Dott.ssa Elisabetta Bissaldi
 Moti relativi Cenni Dott.ssa Elisabetta Bissaldi Elisabetta Bissaldi (Politecnico di Bari) A.A. 2018-2019 2 In generale, la descrizione del moto dipende dal sistema di riferimento scelto Si consideri un
Moti relativi Cenni Dott.ssa Elisabetta Bissaldi Elisabetta Bissaldi (Politecnico di Bari) A.A. 2018-2019 2 In generale, la descrizione del moto dipende dal sistema di riferimento scelto Si consideri un
Note a cura di M. Martellini e M. Zeni
 Università dell Insubria Corso di laurea Scienze Ambientali FISICA GENERALE Lezione 4 Dinamica Note a cura di M. Martellini e M. Zeni Queste note sono state in parte preparate con immagini tratte da alcuni
Università dell Insubria Corso di laurea Scienze Ambientali FISICA GENERALE Lezione 4 Dinamica Note a cura di M. Martellini e M. Zeni Queste note sono state in parte preparate con immagini tratte da alcuni
Principio di inerzia
 Dinamica abbiamo visto come si descrive il moto dei corpi (cinematica) ma oltre a capire come si muovono i corpi è anche necessario capire perchè essi si muovono Partiamo da una domanda fondamentale: qual
Dinamica abbiamo visto come si descrive il moto dei corpi (cinematica) ma oltre a capire come si muovono i corpi è anche necessario capire perchè essi si muovono Partiamo da una domanda fondamentale: qual
Dinamica. Giovanni Torrero maggio 2006
 Dinamica Giovanni Torrero maggio 006 1 I sistemi di riferimento inerziali Nello studio della dinamica sono molto importanti i sistemi di riferimento rispetto ai quali vengono studiati i fenomeni. L esperienza
Dinamica Giovanni Torrero maggio 006 1 I sistemi di riferimento inerziali Nello studio della dinamica sono molto importanti i sistemi di riferimento rispetto ai quali vengono studiati i fenomeni. L esperienza
Insegnare relatività. nel XXI secolo
 Insegnare relatività nel XXI secolo E s p a n s i o n e d e l l ' U n i v e r s o e l e g g e d i H u b b l e La legge di Hubble Studiando distanze e moto delle galassie si trova che quelle più vicine
Insegnare relatività nel XXI secolo E s p a n s i o n e d e l l ' U n i v e r s o e l e g g e d i H u b b l e La legge di Hubble Studiando distanze e moto delle galassie si trova che quelle più vicine
CAPITOLO 9: LA GRAVITAZIONE. 9.1 Introduzione.
 CAPITOLO 9: LA GRAVITAZIONE 9.1 Introduzione. Un altro tipo di forza piuttosto importante è la forza gravitazionale. Innanzitutto, è risaputo che nel nostro sistema di pianeti chiamato sistema solare il
CAPITOLO 9: LA GRAVITAZIONE 9.1 Introduzione. Un altro tipo di forza piuttosto importante è la forza gravitazionale. Innanzitutto, è risaputo che nel nostro sistema di pianeti chiamato sistema solare il
Il movimento. Il fenomeno del movimento è estremamente vario; gli oggetti e gli esseri viventi si muovono nei modi più svariati complicati e strani
 Il movimento Il fenomeno del movimento è estremamente vario; gli oggetti e gli esseri viventi si muovono nei modi più svariati complicati e strani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GIOSTRA 11 MOTO ARMONICO LINK 12
Il movimento Il fenomeno del movimento è estremamente vario; gli oggetti e gli esseri viventi si muovono nei modi più svariati complicati e strani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GIOSTRA 11 MOTO ARMONICO LINK 12
Insegnare relatività. nel XXI secolo
 Insegnare relatività nel XXI secolo I l p r i n c i p i o d i r e l a t i v i t à Leggi di trasformazione Il titolo appare solenne, ma vuol dire una cosa semplice: se osserviamo lo stesso fenomeno da due
Insegnare relatività nel XXI secolo I l p r i n c i p i o d i r e l a t i v i t à Leggi di trasformazione Il titolo appare solenne, ma vuol dire una cosa semplice: se osserviamo lo stesso fenomeno da due
CINEMATICA. Ipotesi di base: si trascurano le cause del moto ogge0 in movimento pun3formi
 CINEMATICA Ipotesi di base: si trascurano le cause del moto ogge0 in movimento pun3formi Definiamo: spostamento la velocità media la velocità istantanea MOTO RETTILINEO UNIFORME Nel moto re4lineo uniforme:
CINEMATICA Ipotesi di base: si trascurano le cause del moto ogge0 in movimento pun3formi Definiamo: spostamento la velocità media la velocità istantanea MOTO RETTILINEO UNIFORME Nel moto re4lineo uniforme:
Relatività Ristretta e Meccanica Quantistica: alcuni esperimenti cruciali. Lezione 1. Genova, 12,13,19,20 Gennaio 2016
 Relatività Ristretta e Meccanica Quantistica: alcuni esperimenti cruciali Lezione 1 Genova, 12,13,19,20 Gennaio 2016 Prof. Marco Pallavicini Università di Genova Dipartimento di Fisica Istituto Nazionale
Relatività Ristretta e Meccanica Quantistica: alcuni esperimenti cruciali Lezione 1 Genova, 12,13,19,20 Gennaio 2016 Prof. Marco Pallavicini Università di Genova Dipartimento di Fisica Istituto Nazionale
Soluzione Compitino Fisica Generale I Ing. Elettronica e Telecomunicazioni 02 Maggio 2017
 Soluzione Compitino Fisica Generale I Ing. Elettronica e Telecomunicazioni 02 Maggio 2017 Esercizio 1 1) Sulla tavola agiscono: a) la forza peso, diretta ortogonalmente al moto; b) le reazioni normali
Soluzione Compitino Fisica Generale I Ing. Elettronica e Telecomunicazioni 02 Maggio 2017 Esercizio 1 1) Sulla tavola agiscono: a) la forza peso, diretta ortogonalmente al moto; b) le reazioni normali
4. I principi della meccanica
 1 Leggi del moto 4. I principi della meccanica Come si è visto la cinematica studia il moto dal punto di vista descrittivo, ma non si sofferma sulle cause di esso. Ciò è compito della dinamica. Alla base
1 Leggi del moto 4. I principi della meccanica Come si è visto la cinematica studia il moto dal punto di vista descrittivo, ma non si sofferma sulle cause di esso. Ciò è compito della dinamica. Alla base
Meccanica. 10. Pseudo-Forze. Domenico Galli. Dipartimento di Fisica e Astronomia
 Meccanica 10. Pseudo-Forze http://campus.cib.unibo.it/2429/ Domenico Galli Dipartimento di Fisica e Astronomia 17 febbraio 2017 Traccia 1. Le Pseudo-Forze 2. Esempi 3. Pseudo-Forze nel Riferimento Terrestre
Meccanica 10. Pseudo-Forze http://campus.cib.unibo.it/2429/ Domenico Galli Dipartimento di Fisica e Astronomia 17 febbraio 2017 Traccia 1. Le Pseudo-Forze 2. Esempi 3. Pseudo-Forze nel Riferimento Terrestre
Anna M. Nobili: Lezioni Fisica 1 per Chimici a.a
 Anna M. Nobili: Lezioni Fisica 1 per Chimici a.a. 2013-2014 26 Settembre 2013 Grandezze fisiche, dimensioni e unità di misura. Potenze di 10 e loro uso. 3 Ottobre 2013 Grandezze fisiche, dimensioni e
Anna M. Nobili: Lezioni Fisica 1 per Chimici a.a. 2013-2014 26 Settembre 2013 Grandezze fisiche, dimensioni e unità di misura. Potenze di 10 e loro uso. 3 Ottobre 2013 Grandezze fisiche, dimensioni e
QUANTITA DI MOTO Corso di Fisica per Farmacia, Facoltà di Farmacia, Università G. D Annunzio, Cosimo Del Gratta 2006
 QUANTITA DI MOTO DEFINIZIONE(1) m v Si chiama quantità di moto di un punto materiale il prodotto della sua massa per la sua velocità p = m v La quantità di moto è una grandezza vettoriale La dimensione
QUANTITA DI MOTO DEFINIZIONE(1) m v Si chiama quantità di moto di un punto materiale il prodotto della sua massa per la sua velocità p = m v La quantità di moto è una grandezza vettoriale La dimensione
Nome Cognome Numero di matricola Coordinata posizione. Secondo compito in itinere di Fisica Generale 1 + Esercitazioni, a.a Maggio 2018
 Nome Conome Numero di matricola Coordinata posizione Secondo compito in itinere di Fisica Generale 1 + Esercitazioni, a.a. 017-018 Maio 018 =====================================================================
Nome Conome Numero di matricola Coordinata posizione Secondo compito in itinere di Fisica Generale 1 + Esercitazioni, a.a. 017-018 Maio 018 =====================================================================
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Firenze Precorsi Problemi di Fisica. Giovanni Romano. Principali argomenti di teoria
 Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Firenze Precorsi 2011 Problemi di Fisica Giovanni Romano Principali argomenti di teoria Cinematica Dinamica Termodinamica Elettromagnetismo Ottica
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Firenze Precorsi 2011 Problemi di Fisica Giovanni Romano Principali argomenti di teoria Cinematica Dinamica Termodinamica Elettromagnetismo Ottica
O + ω r (1) Due casi sono fondamentali (gli altri si possono pensare una sovrapposizione di questi due:
 1 5.1-MOTI RELATIVI Parte I 5.1-Moti relativi-cap5 1 5.1-Moti relativi Teorema delle velocità relative Riprendiamo l impostazione tracciata nel paragrafo 2.6 (moti relativi 2-D) e consideriamo un sistema
1 5.1-MOTI RELATIVI Parte I 5.1-Moti relativi-cap5 1 5.1-Moti relativi Teorema delle velocità relative Riprendiamo l impostazione tracciata nel paragrafo 2.6 (moti relativi 2-D) e consideriamo un sistema
4. Lo spettro discreto: emissione e assorbimento di luce da parte di atomi stato fondamentale stati eccitati
 4. Lo spettro discreto: emissione e assorbimento di luce da parte di atomi Accanto allo spettro continuo che i corpi emettono in ragione del loro stato termico, si osservano spettri discreti che sono caratteristici
4. Lo spettro discreto: emissione e assorbimento di luce da parte di atomi Accanto allo spettro continuo che i corpi emettono in ragione del loro stato termico, si osservano spettri discreti che sono caratteristici
I tre principi della dinamica
 1 La dinamica è un ramo della fisica che studia il moto dei corpi considerando le cause (le forze) che lo determinano. La dinamica si basa su tre principi: 1. Il primo principio Il principio di inerzia
1 La dinamica è un ramo della fisica che studia il moto dei corpi considerando le cause (le forze) che lo determinano. La dinamica si basa su tre principi: 1. Il primo principio Il principio di inerzia
Lezione 3 Cinematica Velocità Moto uniforme Accelerazione Moto uniformemente accelerato Concetto di Forza Leggi di Newton
 Corsi di Laurea dei Tronchi Comuni 2 e 4 Dr. Andrea Malizia 1 Cinematica Velocità Moto uniforme Accelerazione Moto uniformemente accelerato Concetto di Forza Leggi di Newton Lezione 2 Sistemi di riferimento
Corsi di Laurea dei Tronchi Comuni 2 e 4 Dr. Andrea Malizia 1 Cinematica Velocità Moto uniforme Accelerazione Moto uniformemente accelerato Concetto di Forza Leggi di Newton Lezione 2 Sistemi di riferimento
approfondimento La dinamica e le interazioni fondamentali Il principio di inerzia secondo Galileo Sistemi inerziali
 approfondimento La dinamica e le interazioni fondamentali Il principio di inerzia secondo Galileo Sistemi inerziali Forza gravitazionale e forza peso massa e peso, peso apparente Forze normali Moto circolare
approfondimento La dinamica e le interazioni fondamentali Il principio di inerzia secondo Galileo Sistemi inerziali Forza gravitazionale e forza peso massa e peso, peso apparente Forze normali Moto circolare
La teoria della relatività. Liceo scientifico Don Bosco Brescia Gennaio 2016
 La teoria della relatività Liceo scientifico Don Bosco Brescia Gennaio 2016 Indice 1. Introduzione 2. Relatività ristretta: postulati 3. Relatività generale: principio di equivalenza 4. Relatività generale:
La teoria della relatività Liceo scientifico Don Bosco Brescia Gennaio 2016 Indice 1. Introduzione 2. Relatività ristretta: postulati 3. Relatività generale: principio di equivalenza 4. Relatività generale:
ELEMENTI DI CINEMATICA Una volta fissato un sistema di riferimento con la sua origine O è possibile descrivere in ogni istante la posizione del punto
 ELEMENTI DI CINEMATICA Una volta fissato un sistema di riferimento con la sua origine O è possibile descrivere in ogni istante la posizione del punto P al passare del tempo t per mezzo della terna di coordinate
ELEMENTI DI CINEMATICA Una volta fissato un sistema di riferimento con la sua origine O è possibile descrivere in ogni istante la posizione del punto P al passare del tempo t per mezzo della terna di coordinate
Lezione 3 Cinematica Velocità Moto uniforme Accelerazione Moto uniformemente accelerato Concetto di Forza Leggi di Newton
 Corsi di Laurea in Scienze motorie - Classe L-22 (D.M. 270/04) Dr. Andrea Malizia 1 Cinematica Velocità Moto uniforme Accelerazione Moto uniformemente accelerato Concetto di Forza Leggi di Newton Sistemi
Corsi di Laurea in Scienze motorie - Classe L-22 (D.M. 270/04) Dr. Andrea Malizia 1 Cinematica Velocità Moto uniforme Accelerazione Moto uniformemente accelerato Concetto di Forza Leggi di Newton Sistemi
Esperimento ideale di Galileo
 Un corpo si muove solo se la risultante delle forze che agiscono su di esso è diversa da zero. Se la risultante delle forze che agiscono sul corpo è nulla, il corpo sta fermo. Esperimento ideale di Galileo
Un corpo si muove solo se la risultante delle forze che agiscono su di esso è diversa da zero. Se la risultante delle forze che agiscono sul corpo è nulla, il corpo sta fermo. Esperimento ideale di Galileo
Meccanica classica. Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dip. DiSAAT - Ing. Francesco Santoro Corso di Fisica
 Meccanica classica A differenza della cinematica in cui i moti sono descritti solo geometricamente attraverso l uso dei vettori posizione, velocità ed accelerazione, nella dinamica vengono analizzate le
Meccanica classica A differenza della cinematica in cui i moti sono descritti solo geometricamente attraverso l uso dei vettori posizione, velocità ed accelerazione, nella dinamica vengono analizzate le
!!!! E quella parte della meccanica che studia il movimento di un corpo indagandone le cause che l hanno prodotto
 E quella parte della meccanica che studia il movimento di un corpo indagandone le cause che l hanno prodotto La dinamica è fondata su tre princìpi fondamentali: Il PRIMO PRINCIPIO, o principio di inerzia;
E quella parte della meccanica che studia il movimento di un corpo indagandone le cause che l hanno prodotto La dinamica è fondata su tre princìpi fondamentali: Il PRIMO PRINCIPIO, o principio di inerzia;
La Teoria della Relatività Ristretta. Prof. Michele Barcellona
 La Teoria della Relatività Ristretta Prof. Michele Barcellona I Postulati della Teoria della Relatività ristretta Per risolvere le contraddizioni tra Meccanica ed Elettromagnetismo Einstein propose una
La Teoria della Relatività Ristretta Prof. Michele Barcellona I Postulati della Teoria della Relatività ristretta Per risolvere le contraddizioni tra Meccanica ed Elettromagnetismo Einstein propose una
MISURE DI ERATOSTENE E PROVE DEL MOTO DI ROTAZIONE TERRESTRE. Presentazione di Emma Donisi, Elena Perego, Camilla Antonietti, Alessandro D'Archi
 MISURE DI ERATOSTENE E PROVE DEL MOTO DI ROTAZIONE TERRESTRE Presentazione di Emma Donisi, Elena Perego, Camilla Antonietti, Alessandro D'Archi Mappa Eratostene Prima di lui Teoria Pratica Dopo di lui
MISURE DI ERATOSTENE E PROVE DEL MOTO DI ROTAZIONE TERRESTRE Presentazione di Emma Donisi, Elena Perego, Camilla Antonietti, Alessandro D'Archi Mappa Eratostene Prima di lui Teoria Pratica Dopo di lui
Studente. Matricola. Anno di corso. Esame Corso di Fisica AA /01/2017 Corso di Laurea in Scienze Geologiche
 Teoria: Esercizi: Quesiti: Studente Matricola Anno di corso Esame Corso di Fisica AA. 2015-2016 16/01/2017 Corso di Laurea in Scienze Geologiche Griglia quesiti risposta multipla A B C D 1 2 3 4 5 6 7
Teoria: Esercizi: Quesiti: Studente Matricola Anno di corso Esame Corso di Fisica AA. 2015-2016 16/01/2017 Corso di Laurea in Scienze Geologiche Griglia quesiti risposta multipla A B C D 1 2 3 4 5 6 7
CINEMATICA DEL PUNTO MATERIALE: MOTI RETTILINEI E INTRODUZIONE AL MOTO IN PIÙ DIMENSIONI PROF. FRANCESCO DE PALMA
 CINEMATICA DEL PUNTO MATERIALE: MOTI RETTILINEI E INTRODUZIONE AL MOTO IN PIÙ DIMENSIONI PROF. FRANCESCO DE PALMA Sommario INTRODUZIONE ALLA CINEMATICA... 3 MOTO RETTILINEO UNIFORMEMENTE ACCELERATO...
CINEMATICA DEL PUNTO MATERIALE: MOTI RETTILINEI E INTRODUZIONE AL MOTO IN PIÙ DIMENSIONI PROF. FRANCESCO DE PALMA Sommario INTRODUZIONE ALLA CINEMATICA... 3 MOTO RETTILINEO UNIFORMEMENTE ACCELERATO...
Dinamica relativistica Cenni di relatività generale Corso Mathesis Roma 2016 Prof. Sergio Savarino
 Dinamica relativistica Cenni di relatività generale Corso Mathesis Roma 2016 Prof. Sergio Savarino Dinamica relativistica Quantità di moto relativistica: Massa relativistica: (1+z) 3 =1+3z+3z 2 +z 3 se
Dinamica relativistica Cenni di relatività generale Corso Mathesis Roma 2016 Prof. Sergio Savarino Dinamica relativistica Quantità di moto relativistica: Massa relativistica: (1+z) 3 =1+3z+3z 2 +z 3 se
Spettro delle onde elettromagnetiche. Ottica: luce visibile leggi della riflessione e rifrazione
 Spettro delle onde elettromagnetiche Ottica: luce visibile leggi della riflessione e rifrazione Introduzione Abbiamo visto che la propagazione della radiazione elettromagnetica nel vuoto è regolata dalle
Spettro delle onde elettromagnetiche Ottica: luce visibile leggi della riflessione e rifrazione Introduzione Abbiamo visto che la propagazione della radiazione elettromagnetica nel vuoto è regolata dalle
DINAMICA (Leggi di Newton)
 DINAMICA (Leggi di Newton) DINAMICA (Leggi di Newton) I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA DINAMICA (Leggi di Newton) I corpi interagiscono fra di loro mediante azioni, chiamate forze, che costituiscono le cause
DINAMICA (Leggi di Newton) DINAMICA (Leggi di Newton) I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA DINAMICA (Leggi di Newton) I corpi interagiscono fra di loro mediante azioni, chiamate forze, che costituiscono le cause
Dinamica. Relazione tra forze e movimento dei corpi Principi della dinamica Conce4 di forza, inerzia, massa
 Dinamica Relazione tra forze e movimento dei corpi Principi della dinamica Conce4 di forza, inerzia, massa Cinematica Moto rettilineo uniforme s=s 0 +v(t-t 0 ) Moto uniformemente accelerato v=v 0 +a(t-t
Dinamica Relazione tra forze e movimento dei corpi Principi della dinamica Conce4 di forza, inerzia, massa Cinematica Moto rettilineo uniforme s=s 0 +v(t-t 0 ) Moto uniformemente accelerato v=v 0 +a(t-t
L2 - Completa la seguente frase: "L'auto sta al telaio come il corpo sta..."
 Simulazione test di ingresso Ingegneria Industriale Viterbo Quesiti di Logica, Chimica e Fisica Logica L1 - Come continua questa serie di numeri? 3-4 - 6-9 - 13-18 -... a) 21 b) 22 c) 23 d) 24 L2 - Completa
Simulazione test di ingresso Ingegneria Industriale Viterbo Quesiti di Logica, Chimica e Fisica Logica L1 - Come continua questa serie di numeri? 3-4 - 6-9 - 13-18 -... a) 21 b) 22 c) 23 d) 24 L2 - Completa
Equilibrio dei corpi. Leggi di Newton e momento della forza, τ
 Equilibrio dei corpi Leggi di Newton e momento della forza, τ Corpi in equilibrio 1. Supponiamo di avere due forze di modulo uguale che agiscono lungo la stessa direzione, ma che siano rivolte in versi
Equilibrio dei corpi Leggi di Newton e momento della forza, τ Corpi in equilibrio 1. Supponiamo di avere due forze di modulo uguale che agiscono lungo la stessa direzione, ma che siano rivolte in versi
Le caratteristiche del moto. Un corpo è in moto se, rispetto ad un sistema di riferimento, cambia la posizione con il passare del tempo.
 Il Mot Le caratteristiche del moto Un corpo è in moto se, rispetto ad un sistema di riferimento, cambia la posizione con il passare del tempo. Le caratteristiche del moto Immagina di stare seduto in treno
Il Mot Le caratteristiche del moto Un corpo è in moto se, rispetto ad un sistema di riferimento, cambia la posizione con il passare del tempo. Le caratteristiche del moto Immagina di stare seduto in treno
Programma dettagliato del corso di MECCANICA RAZIONALE Corso di Laurea in Ingegneria Civile
 Programma dettagliato del corso di MECCANICA RAZIONALE Corso di Laurea in Ingegneria Civile Anno Accademico 2017-2018 A. Ponno (aggiornato al 20 dicembre 2017) 2 Ottobre 2017 2/10/17 Benvenuto, presentazione
Programma dettagliato del corso di MECCANICA RAZIONALE Corso di Laurea in Ingegneria Civile Anno Accademico 2017-2018 A. Ponno (aggiornato al 20 dicembre 2017) 2 Ottobre 2017 2/10/17 Benvenuto, presentazione
FISICA. STATICA Le forze. Autore: prof. Pappalardo Vincenzo docente di Matematica e Fisica
 FISICA STATICA Le forze Autore: prof. Pappalardo Vincenzo docente di Matematica e Fisica L EFFETTO DELLE FORZE Una forza applicata a un oggetto fermo può fare aumentare la sua velocità; mentre applicata
FISICA STATICA Le forze Autore: prof. Pappalardo Vincenzo docente di Matematica e Fisica L EFFETTO DELLE FORZE Una forza applicata a un oggetto fermo può fare aumentare la sua velocità; mentre applicata
Meccanica del punto materiale
 Meccanica del punto materiale Princìpi della dinamica. Forze. Momento angolare. Antonio Pierro @antonio_pierro_ (https://twitter.com/antonio_pierro_) Per consigli, suggerimenti, eventuali errori o altro
Meccanica del punto materiale Princìpi della dinamica. Forze. Momento angolare. Antonio Pierro @antonio_pierro_ (https://twitter.com/antonio_pierro_) Per consigli, suggerimenti, eventuali errori o altro
3.Dinamica e forze. La dinamica è quella parte della meccanica che studia il moto di un corpo facendo riferimento alle cause esterne che lo generano.
 3.Dinamica e forze La dinamica è quella parte della meccanica che studia il moto di un corpo facendo riferimento alle cause esterne che lo generano. Le due grandezze fondamentali che prendiamo in considerazione
3.Dinamica e forze La dinamica è quella parte della meccanica che studia il moto di un corpo facendo riferimento alle cause esterne che lo generano. Le due grandezze fondamentali che prendiamo in considerazione
Fisica 2018/2019 Lezione 2 02/10/18. Meccanica (1) La cinematica e lo studio del moto senza occuparsi di ciò che lo ha causato
 Meccanica (1) Cinematica unidimensionale Lezione 2, 2/10/2018, JW 2.1-2.5, 2.7 1 Cinematica unidimensionale La cinematica e lo studio del moto senza occuparsi di ciò che lo ha causato Unidimensionale:
Meccanica (1) Cinematica unidimensionale Lezione 2, 2/10/2018, JW 2.1-2.5, 2.7 1 Cinematica unidimensionale La cinematica e lo studio del moto senza occuparsi di ciò che lo ha causato Unidimensionale:
Introduzione alla Meccanica: Cinematica
 Introduzione alla Meccanica: Cinematica La Cinematica si occupa della descrizione geometrica del moto, senza riferimento alle sue cause. E invece compito della Dinamica mettere in relazione il moto con
Introduzione alla Meccanica: Cinematica La Cinematica si occupa della descrizione geometrica del moto, senza riferimento alle sue cause. E invece compito della Dinamica mettere in relazione il moto con
Automobile in corsa Volo di un gabbiano. Passeggero in aereo MOTO. Sole. Acqua dei fiumi. Treno in movimento
 IL MOTO dei CORPI Automobile in corsa Volo di un gabbiano Sole MOTO Passeggero in aereo Treno in movimento Acqua dei fiumi Libro sul banco Alberi Sole QUIETE Passeggero in aereo Treno in stazione Acqua
IL MOTO dei CORPI Automobile in corsa Volo di un gabbiano Sole MOTO Passeggero in aereo Treno in movimento Acqua dei fiumi Libro sul banco Alberi Sole QUIETE Passeggero in aereo Treno in stazione Acqua
m p 6, j m 1 2 m e 3, j m 1 2 5, m 2 82, N w
 Teoria della carica elettrica e calcolo del valore teorico Questa relazione è stata ricavata senza porre alcuna ipotesi restrittiva e dunque risulta di validità universale, applicabile in ogni circostanza
Teoria della carica elettrica e calcolo del valore teorico Questa relazione è stata ricavata senza porre alcuna ipotesi restrittiva e dunque risulta di validità universale, applicabile in ogni circostanza
RELATIVITA` RISTRETTA
 RELATIVITA` RISTRETTA La massima velocità raggiungibile E=m c 2 Il principio di relatività e i problemi della meccanica classica) La relatività ristretta di Einstein Energia e quantità di moto relativistiche
RELATIVITA` RISTRETTA La massima velocità raggiungibile E=m c 2 Il principio di relatività e i problemi della meccanica classica) La relatività ristretta di Einstein Energia e quantità di moto relativistiche
Dinamica: Forze e Moto, Leggi di Newton
 Dinamica: Forze e Moto, Leggi di Newton La Dinamica studia il moto dei corpi in relazione il moto con le sue cause: perché e come gli oggetti si muovono. La causa del moto è individuata nella presenza
Dinamica: Forze e Moto, Leggi di Newton La Dinamica studia il moto dei corpi in relazione il moto con le sue cause: perché e come gli oggetti si muovono. La causa del moto è individuata nella presenza
Saperi Minimi Fisica Prova parziale del 20 Dicembre 2012 Tipo A
 Saperi Minimi Fisica Prova parziale del 0 Dicembre 01 Tipo A É consentito l'uso della calcolatrice scientica. Si ricordi di scrivere nome, conome, matricola e il tipo del compito su oni folio utilizzato.
Saperi Minimi Fisica Prova parziale del 0 Dicembre 01 Tipo A É consentito l'uso della calcolatrice scientica. Si ricordi di scrivere nome, conome, matricola e il tipo del compito su oni folio utilizzato.
TEORIA DELLA RELATIVITA RISTRETTA
 TEORIA DELLA RELATIVITA RISTRETTA EVOLUZIONE DELLE TEORIE FISICHE Meccanica Classica Principio di Relatività Galileiano Meccanica Newtoniana Gravitazione (Newton) Costante Universale G = 6,67*10^-11Nm^2/Kg^2
TEORIA DELLA RELATIVITA RISTRETTA EVOLUZIONE DELLE TEORIE FISICHE Meccanica Classica Principio di Relatività Galileiano Meccanica Newtoniana Gravitazione (Newton) Costante Universale G = 6,67*10^-11Nm^2/Kg^2
Le Derivate. Appunti delle lezioni di matematica di A. Pisani Liceo Classico Dante Alighieri
 Le Derivate Appunti delle lezioni di matematica di A. Pisani Liceo Classico Dante Alighieri Nota bene Questi appunti sono da intendere come guida allo studio e come riassunto di quanto illustrato durante
Le Derivate Appunti delle lezioni di matematica di A. Pisani Liceo Classico Dante Alighieri Nota bene Questi appunti sono da intendere come guida allo studio e come riassunto di quanto illustrato durante
Don Bosco 2014/15, Classe 3B - Primo compito in classe di Fisica
 Don Bosco 014/15, Classe B - Primo compito in classe di Fisica 1. Enuncia il Teorema dell Energia Cinetica. Soluzione. Il lavoro della risultante delle forze agenti su un corpo che si sposta lungo una
Don Bosco 014/15, Classe B - Primo compito in classe di Fisica 1. Enuncia il Teorema dell Energia Cinetica. Soluzione. Il lavoro della risultante delle forze agenti su un corpo che si sposta lungo una
Fisica Dinamica del punto
 isica - Dinamica del punto 7 VARIAZIONE DELLA VELOCITA accelerazione Principio d inerzia Un corpo permane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme a meno che non intervenga una forza esterna
isica - Dinamica del punto 7 VARIAZIONE DELLA VELOCITA accelerazione Principio d inerzia Un corpo permane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme a meno che non intervenga una forza esterna
Il moto. Studiamo il moto del punto materiale, definito come un oggetto estremamente piccolo rispetto al contesto
 Il moto Studiamo il moto del punto materiale, definito come un oggetto estremamente piccolo rispetto al contesto Traiettoria: è il luogo dei punti occupati dall oggetto nel suo movimento Spazio percorso:
Il moto Studiamo il moto del punto materiale, definito come un oggetto estremamente piccolo rispetto al contesto Traiettoria: è il luogo dei punti occupati dall oggetto nel suo movimento Spazio percorso:
P = r. o + r. O + ω r (1)
 1 5.1-MOTI RELATIVI Parte I 5.1-Moti relativi-cap5 1 5.1-Moti relativi Teorema delle velocità relative Riprendiamo l impostazione tracciata nel paragrafo 2.6 (moti relativi 2-D) e consideriamo un sistema
1 5.1-MOTI RELATIVI Parte I 5.1-Moti relativi-cap5 1 5.1-Moti relativi Teorema delle velocità relative Riprendiamo l impostazione tracciata nel paragrafo 2.6 (moti relativi 2-D) e consideriamo un sistema
Asteroide impatta la Terra. Cosa ci dice il Principio di Equivalenza?
 Matematica Open Source http://www.extrabyte.info Quaderni di Meccanica Analitica 2019 Asteroide impatta la Terra. Cosa ci dice il Principio di Equivalenza? Marcello Colozzo Indice 1 Introduzione 2 2 Il
Matematica Open Source http://www.extrabyte.info Quaderni di Meccanica Analitica 2019 Asteroide impatta la Terra. Cosa ci dice il Principio di Equivalenza? Marcello Colozzo Indice 1 Introduzione 2 2 Il
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE II compitino di FISICA, 20 Giugno 2011
 CORSO DI LURE IN SCIENZE BIOLOGICHE II compitino di FISIC, 0 Giuno 011 1) Una lamina piana infinitamente estesa, uniformemente carica con densità = + 4 10-8 C/m è perpendicolare all asse x di un sistema
CORSO DI LURE IN SCIENZE BIOLOGICHE II compitino di FISIC, 0 Giuno 011 1) Una lamina piana infinitamente estesa, uniformemente carica con densità = + 4 10-8 C/m è perpendicolare all asse x di un sistema
MOTO RETTILINEO UNIFORME
 MOTO RETTILINEO UNIORME a = 0 v = cost v = costante ( x-x o )/t = cost x = x o + v t a v x t t x o t 51 MOTO RETTILINEO UNIORMEMENTE ACCELERATO a = costante a = cost = v - v 0 t v = v o + a t x = x o +
MOTO RETTILINEO UNIORME a = 0 v = cost v = costante ( x-x o )/t = cost x = x o + v t a v x t t x o t 51 MOTO RETTILINEO UNIORMEMENTE ACCELERATO a = costante a = cost = v - v 0 t v = v o + a t x = x o +
CINEMATICA. Prof Giovanni Ianne
 CINEMATICA Il moto e la velocità L accelerazione Moto rettilineo uniforme Moto rettilineo uniformemente accelerato Moti periodici e composti il moto e la velocità Un corpo è in moto quando la sua posizione
CINEMATICA Il moto e la velocità L accelerazione Moto rettilineo uniforme Moto rettilineo uniformemente accelerato Moti periodici e composti il moto e la velocità Un corpo è in moto quando la sua posizione
Dimostrazioni del capitolo 8
 Dimostrazioni del capitolo 8 Dimostrazione del Teorema 8. (derivabilità e retta tanente), paina 74 Sia I un intervallo, f : I R e x 0 I. Dobbiamo verificare ce f è derivabile in x 0 se e solo se esiste
Dimostrazioni del capitolo 8 Dimostrazione del Teorema 8. (derivabilità e retta tanente), paina 74 Sia I un intervallo, f : I R e x 0 I. Dobbiamo verificare ce f è derivabile in x 0 se e solo se esiste
Esercizi in preparazione all esonero
 Esercizi in preparazione all esonero Andrea Susa Esercizio Un sasso viene lanciato verso l'alto a partire dall'altezza h = 50 rispetto al suolo con una velocità iniziale di modulo = 8,5/. Supponendo il
Esercizi in preparazione all esonero Andrea Susa Esercizio Un sasso viene lanciato verso l'alto a partire dall'altezza h = 50 rispetto al suolo con una velocità iniziale di modulo = 8,5/. Supponendo il
ECONOMIA APPLICATA ALL INGEGNERIA (Docente: Prof. Ing. Donato Morea) Microeconomia Esercitazione n. 1 - I FONDAMENTI DI DOMANDA E DI OFFERTA
 ESERCIZIO n. 1 - Equilibrio di mercato e spostamenti delle curve di domanda e di offerta La quantità domandata di un certo bene è descritta dalla seguente funzione: p (D) mentre la quantità offerta è descritta
ESERCIZIO n. 1 - Equilibrio di mercato e spostamenti delle curve di domanda e di offerta La quantità domandata di un certo bene è descritta dalla seguente funzione: p (D) mentre la quantità offerta è descritta
Corso di Fisica tecnica e ambientale a.a. 2011/ Docente: Prof. Carlo Isetti
 CENNI DI CINEMATICA.1 GENERALITÀ La cinematica studia il moto dei corpi in relazione allo spazio ed al tempo indipendentemente dalle cause che lo producono. Un corpo si muove quando la sua posizione relativa
CENNI DI CINEMATICA.1 GENERALITÀ La cinematica studia il moto dei corpi in relazione allo spazio ed al tempo indipendentemente dalle cause che lo producono. Un corpo si muove quando la sua posizione relativa
LA RELATIVITÀ GENERALE: SPAZIOTEMPO CURVO. Alessandro Tomasiello
 LA RELATIVITÀ GENERALE: SPAZIOTEMPO CURVO Alessandro Tomasiello Galileo [~1610]: la gravità ha lo stesso effetto su corpi di massa diversa Pisa?? Galileo [~1610]: la gravità ha lo stesso effetto su corpi
LA RELATIVITÀ GENERALE: SPAZIOTEMPO CURVO Alessandro Tomasiello Galileo [~1610]: la gravità ha lo stesso effetto su corpi di massa diversa Pisa?? Galileo [~1610]: la gravità ha lo stesso effetto su corpi
Una formulazione equivalente è Il moto di un singolo punto materiale isolato è rettilineo uniforme (o è fermo):
 I PRINCIPI DELLA MECCANICA In queste note i principi della dinamica vengono formulati utilizzando soltanto le definizioni di accelerazione e velocità istantanee della Cinematica. Le lettere in grassetto
I PRINCIPI DELLA MECCANICA In queste note i principi della dinamica vengono formulati utilizzando soltanto le definizioni di accelerazione e velocità istantanee della Cinematica. Le lettere in grassetto
Lecce- XI scuola estiva di fisica Mirella Rafanelli. I sistemi estesi. La dinamica oltre il punto..
 Lecce- XI scuola estiva di fisica - 2018 Mirella Rafanelli I sistemi estesi La dinamica oltre il punto.. Lecce- XI scuola estiva di fisica - 2018 Mirella Rafanelli Nota bene: quanto segue serve come strumento
Lecce- XI scuola estiva di fisica - 2018 Mirella Rafanelli I sistemi estesi La dinamica oltre il punto.. Lecce- XI scuola estiva di fisica - 2018 Mirella Rafanelli Nota bene: quanto segue serve come strumento
Verifica sommativa di Fisica Cognome...Nome... Data
 ISTITUZIONE SCOLASTICA Via Tuscolana, 208 - Roma Sede Associata Liceo "B.Russell" Verifica sommativa di Fisica Cognome........Nome..... Data Classe 4B Questionario a risposta multipla Prova di uscita di
ISTITUZIONE SCOLASTICA Via Tuscolana, 208 - Roma Sede Associata Liceo "B.Russell" Verifica sommativa di Fisica Cognome........Nome..... Data Classe 4B Questionario a risposta multipla Prova di uscita di
Il moto uniformemente accelerato. Prof. E. Modica
 Il moto uniformemente accelerato! Prof. E. Modica www.galois.it La velocità cambia... Quando andiamo in automobile, la nostra velocità non si mantiene costante. Basta pensare all obbligo di fermarsi in
Il moto uniformemente accelerato! Prof. E. Modica www.galois.it La velocità cambia... Quando andiamo in automobile, la nostra velocità non si mantiene costante. Basta pensare all obbligo di fermarsi in
MOTO DI UNA PARTICELLA IN UN CAMPO ELETTRICO
 MOTO DI UNA PARTICELLA IN UN CAMPO ELETTRICO Sappiamo che mettendo una carica positiva q chiamata carica di prova o carica esploratrice in un punto vicino all oggetto carico si manifesta un vettore campo
MOTO DI UNA PARTICELLA IN UN CAMPO ELETTRICO Sappiamo che mettendo una carica positiva q chiamata carica di prova o carica esploratrice in un punto vicino all oggetto carico si manifesta un vettore campo
PROGETTO DI FISICA 2004/2005 CAMPO ELETTRICO E CAMPO MAGNETICO
 PROGETTO DI FISICA 2004/2005 CAMPO ELETTRICO E CAMPO MAGNETICO Autore Aleo Giacomo Luca 5H A.s. 2004/2005 1 ANALOGIE E DIFFERENZE 1) CAMPO ELETTRICO + + - - + + + + - + + + - + + + - + + + - - + + Corpo
PROGETTO DI FISICA 2004/2005 CAMPO ELETTRICO E CAMPO MAGNETICO Autore Aleo Giacomo Luca 5H A.s. 2004/2005 1 ANALOGIE E DIFFERENZE 1) CAMPO ELETTRICO + + - - + + + + - + + + - + + + - + + + - - + + Corpo
Esempio prova di esonero Fisica Generale I C.d.L. ed.u. Informatica
 Esempio prova di esonero Fisica Generale I C.d.L. ed.u. Informatica Nome: N.M.: 1. Se il caffè costa 4000 /kg (lire al chilogrammo), quanto costa all incirca alla libbra? (a) 1800 ; (b) 8700 ; (c) 18000
Esempio prova di esonero Fisica Generale I C.d.L. ed.u. Informatica Nome: N.M.: 1. Se il caffè costa 4000 /kg (lire al chilogrammo), quanto costa all incirca alla libbra? (a) 1800 ; (b) 8700 ; (c) 18000
Fenomeni quantistici
 Fenomeni quantistici 1. Radiazione di corpo nero Leggi di Wien e di Stefan-Boltzman Equipartizione dell energia classica Correzione quantistica di Planck 2. Effetto fotoelettrico XIII - 0 Radiazione da
Fenomeni quantistici 1. Radiazione di corpo nero Leggi di Wien e di Stefan-Boltzman Equipartizione dell energia classica Correzione quantistica di Planck 2. Effetto fotoelettrico XIII - 0 Radiazione da
Meccanica (3) Le leggi del moto di Newton Lezione 4, 9/10/2018, JW
 Meccanica (3) Le leggi del moto di Newton Lezione 4, 9/10/2018, JW 5.1-5.7 1 Forza: spinta o trazione 1. Forza e massa La forza è un vettore: ha un modulo e una direzione. Se agiscono più di una forza,
Meccanica (3) Le leggi del moto di Newton Lezione 4, 9/10/2018, JW 5.1-5.7 1 Forza: spinta o trazione 1. Forza e massa La forza è un vettore: ha un modulo e una direzione. Se agiscono più di una forza,
Vettore forza. che si chiamano Newton. Oppure in gr cm /s. che si chiamano dine. Ovviamente 1 N = 10 5 dine. F i = m a F i j = F j i
 Dinamica Mi occupo delle cause del moto Ogni volta che un oggetto viene disturbato dico che agisce una forza La forza è caratterizzata da direzione e verso. Non basta per dire che è un vettore ma è una
Dinamica Mi occupo delle cause del moto Ogni volta che un oggetto viene disturbato dico che agisce una forza La forza è caratterizzata da direzione e verso. Non basta per dire che è un vettore ma è una
