Recuperare il deficit di Denominazione Visiva Rapida nella Dislessia Evolutiva: è possibile?
|
|
|
- Federigo Pandolfi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Recuperare il deficit di Denominazione Visiva Rapida nella Dislessia Evolutiva: è possibile? Pecini Chiara IRCCS Stella Maris - Università di Pisa chiara.pecini@fsm.unipi.it Giornate di Neuropsicologia dell età evolutiva, XI edizione, Bressanone 2016
2 Servizio di teleriabilitazione IRCCS Stella Maris IRCCS Fondazione Santa Lucia, 2005 Materiali IPDA, Tretti et al.2002). Benso, Marinelli, Zanzurino, 2005 Rapid Automatized Namning La Teleriabilitazione può facilitare una Riabilitazione di tipo RESTITUTIVO Esercizio intensivo Livelli autoadattivi Apprendimento procedurale
3 Perché cercare trattamenti Orientati al processo? Motivazioni scientifiche: paradigma riabilitativo : per verificare le ipotesi sulle cause cognitive della DE Motivazioni cliniche (criticità dei trattamenti orientati al compito ): Per intervenire precocemente o prevenire le difficoltà Per favorire un più drastico sradicamento del disturbo (i trattamenti orientati al compito tendono a passare da istruzioni esplicite, consolidando le conoscenze; il processo di apprendimento può rimanere lento e difficoltoso) Per un effetto relise dalle attività riabilitative sul sintomo
4 Quale processo scegliamo per intervenire precocemente? Consapevolezza e memoria Fonologica (es. Tarter) Attenzione visiva (es. Facoetti) Percezione del ritmo (es. Lopez) Memoria procedurale (es. Fawcett) Più processi di base (es. Benso) Multiple Overlapping Risk Factor model Pennington and Bishop, 2009; La DE è il risultato di una costellazione di deficit e di fattori protettivi e di rischio multipli, che possono essere Etiology (es. Shao et al., 2015 ) presenti molto precocemente Neurobiology (es. Pernet et al., 2009) Cognition (es. Cantiani et al 2015)
5 SCARSA COMPLESSITA 2015 the parafoveal Reduced dysfunction parafoveal may preview be consequent to the benefits overload were with observed extracting a phonological naming task, information but not a from silent orthographic letter-finding input task
6 La complessità del compito di lettura RICICLAGGIO NEURALE, (Dehaene, 2009))La lettura è il risultato della capacità del nostro cervello di «FORGIARE» NUOVE CONNESSIONI (per un funzionamento sinergico) fra circuiti designati tanti anni fa per vecchie operazioni visive, uditive, linguistiche e cognitive BLENDING OF PRIMATIVE SKILLS
7 La denominazione e un antecedente filogenetico e ontogenetico della lettura UU H! L associazione fra figure ed azioni è un processo spontaneo e piacevole: Il bambino già a due anni inizia a sfruttare il periodo sensibile (finestra terapeutica) per connettere i sistemi (le aree cerebrali) che utilizzerà per leggere.
8 RAN, il microcosmo della lettura Stimoli ad alta frequenza d uso, precocemente acquisiti, ripetuti La variabile cruciale è il tempo di denominazione Geschwind (1965, 1966) ; Denckla e Rudel (1972, 1976) (Wolf e Bowers, 1999; Lovett et al., 2000; Norton e Wolf, 2012) Il RAN sintetizza L INTEGRAZIONE E L AUTOMATIZZAZIONE dei processi necessari per leggere
9 anni di studi! Analisi visiva dello stimolo Spostamento dell attenzione Identificazione di pattern visivi Integrazione delle caratteristiche visive con le immagini visive (ortografiche) in memoria La natura SERIALE degli stimoli VISIVI E 2013 Integrazione delle immagini visive (ortografiche) con le rappresentazioni fonologiche Il RECUPERO dell etichetta FONOLOGICA Programmazione e output articolatorio Integrazione di tutte le informazioni semantiche e concettuali con gli altri input Recupero dell etichetta fonologica
10 Velocità RAN livello di acquisizione della lingua scritta nei normo lettori e nella DE, in compiti TIME LIMITED (Spring e Davis, 1988; Savage et al., 2005; Norton e Wolf, 2012; Cronin e coll, 2010; Orton et al, 2014, Landerl et al., 2013) La velocità d INTEGRAZIONE VISUO-VERBALE, misurata al RAN in età prescolare, è un PRE- REQUISITO, piuttosto che un «outcome», della lettura in ortografie diverse (Wimmer et al., 2000; Wolf e Katzir-Cohen (2001); Compton, 2003;Tan et al., 2005; Kirby et al., 2010; Norton e Wolf, 2012; No To Hattatsu, 2012; Landerl et al.; 2013)
11 RAN figure se un lettore è fluente quando riesce a traslare in modo sincronizzato ed efficace pattern visivi diversi nelle corrispondenze fonologiche e semantiche, automatizzando un circuito neurofunzionale complesso, allora deve avere la stessa velocità ed efficacia in compiti di denominazione rapida di stimoli visivi non alfanumerici (Misra et al., 2004 Blau et al., 2010)
12 Riabilitare la RAN pochi studi sperimentali (Fugate, 1997; de Jong e Vrielink, 2004; Kirkly et al., 2010 per una rassegna; Conrad e Levy, 2011) materiale cartaceo (no autoadattività) perdita di alcune componenti del compito (solo su lettere, no stress sul tempo, non sempre presentazione seriale) trattamenti brevi «hard to improve QUICKLY» (l apprendimento procedurale è un processo lungo) su campioni DE scarsamente definiti (es. pazienti con deficit fonologico?)
13 VIDEO
14 - DE con deficit prevalente nell automatizzazione della decodifica (rapidità) - bambini a rischio di DE Destinatari - bambini con altri disturbi dello sviluppo, per i quali si riconosca la necessità di migliorare i prerequisiti della letto-scrittura, in particolare le capacità di integrazione visuo-verbale rapida e automatica in compiti da sinistra a destra - età compresa fra 5 e 11 anni circa
15 PARAMETRI AUTO-ADATTIVI AVANZAMENTO AUTOMATICO ON Tempo (esposizione + pausa): msec Complessità linguistica delle parole corrispondenti (frequenza d uso, lunghezza e complessità articolatoria) Complessità visiva (Dimensione e affollamento delle figure: 3,5-1 cm; da 20 a 100)
16 Stimolo singolo Progressivo Anti-progressivo Tutti visibili Cluster
17 Algoritmo AUTO-ADATTIVITA
18 Impostando i parametri è possibile adattare l esercizio d INTEGRAZIONE VISUO-VERBALE RAPIDA in funzione del profilo del bambino LINGUAGGIO SCANSIONE VISIVA TEMPO esposizione + pausa ATTENZIONE e CONTROLLO ESECUTIVO
19
20 Le abilità di RAN possono essere riabilitate con circa 12 ore di esercizio (10 min al giorno per tre mesi) (n=20, 5-10 anni) RAN (z tempi) pre post colori figure numeri IRCCS Fondazione Santa Lucia, ,1-1,2-1,8-1,6-2,9 * -3,4 * * Run the RAN tende a normalizzare la RAN, che rappresenta uno dei due fattori prescolari predittivi delle abilità di letto-scrittura 17/09/14
21 Il miglioramento generalizza alla lettura? E specifico di Run the RAN? Ha effetti diversi in DE con profili diversi?
22 RAN o Lettura: un confronto diretto fra due trattamenti metodologicamente simili Intensività + Auto-adattività Esercizio quotidiano al pc per circa minuti COMPITO: denominare (leggere) ad alta voce e in modo seriale gli stimoli (colori, figure in b/n) contenuti in una serie di matrici (o i brani) 30 DE (16M; 7;6-12;11 anni) n=15, età; classe; QI sill/sec medie pre-tratt Pecini et al, ,9 (0,37) 1,03 (0,31)
23 Differenze pre-post (in punti z) nella velocità e accuratezza di lettura pre post pre post Mean (sd) Mean (sd) Mean (sd) Mean (sd) Reading speed Passage (0.77) (0.49) (0.43) (0.65) Words (0.64) (0.73)* (0.48) (0.64)* Non-words (0.64) (1.17) (0.62) (0.60)* Reading accuracy F(1,27)= 5.45, <.05 Words (1.46) (1.57)* (2.05) (2.32) Non-words -1.2 (1.34) (0.93) (1.72) -1 (1.37) Phonological Processing NW Rep 0.03 (1.07) 0.29 (1.95)* -2.5 (1.57) -1.9 (2.14) Sem. Flu (1.12) (1.01)* (1) (0.67) Phon Flu (0.95) (0.88) (0.84) (0.97)
24 Differenze pre-post dei punteggi z nel test di RAN F(1,27)=7,19, <0,05 F(1,28)=13,1, <0,001 F(1,28)=4,37, <0,05
25 Differenze pre-post ottenute nei DE con e senza pregresso Ritardo del Linguaggio dopo Run the RAN e dopo Reading Trainer Language delay (n=12) no Language delay (n=18) RtR Mean (sd) RT Mean (sd) RtR Mean (sd) RT Mean (sd) Reading speed Passage 0.27 (0.09) 0.22 (0.22) 0.11 (0.3) 0.37 (0.47) Words 0.17 (0.07) 0.30 (0.27) 0.24 (0.13) 0.31 (0.23) Non-words 0.09 (0.1) 0.28 (0.19) 0.09 (0.21) 0.21 (0.14) Reading accuracy Passage 2.86 (7.06) 2.83 (4.19) 0.66 (2.34) 1.38 (4.8) Words 7.33 (9.3) 1.5 (9.7) 1.94 (5.22) 1.12 (4.61) Non-words 2 (5.8) 1.6 (6.8) (6.88) 1.5 (8.23) RAN speed Colors 3.9 (2.45) 0.92 (1.06)* 1.35 (0.9) 0.6 (0.98) Figures 3.92 (2.31) 0.85 (1.13)* 1.73 (1.31) 0.19 (1)* Numbers 2.97 (3.23) 0.35 (0.97) 1.25 (1.46) 0.7 (0.8)
26 Spunti di discussione Si può riabilitare la Denominazione Visiva Rapida > DE ex RL Cause distali Cause prossimali Sintomatologia espressa Circolarità cause-sintomi 0 mesi 5 anni 8 anni > mesi
27 Daniela Brizzolara Anna Chilosi Paola Cipriani Filippo Gasperini Paola Cristofani MariaChiara di Lieto Claudio Vio Francesca Guaran Allice Martinelli Silvia Bonetti.Silvia Spoglianti Alice Martinelli Sara Mazzotti Claudia Casalini Renata Salvadorini PierLuigi Zoccolotti
28 differenza pre-post in sillabe al secondo; in rosso I criteri di soglia (Tressoldi et al., 2011) per il singolo soggetto *
29 Vantaggio di Run the RAN vs Reading Trainer sull accuratezza di lettura (differenza pre-post numero di errori) *
30 30
31
32 RAN-LETTURA Quali componenti della letto-scrittura? RAN = livello di acquisizione della lingua scritta nei normo lettori e nella DE, in compiti TIME LIMITED (Spring e Davis, 1988; Savage et al., 2005; Norton e Wolf, 2012; Orton et al, 2014, Landerl et al., 2013)
33 RAN-LETTURA Differenze con l ortografia? RAN prescolare lettura (across ortografie) (Wimmer et al., 2000; Compton, 2003 Tan et al., 2005; per rassegne Kirby et al., 2010; No To Hattatsu, 2012; Landerl et al., 2013). La velocità d INTEGRAZIONE VISUO- VERBALE come PRE-REQUISITO, piuttosto che «outcome», della lettura (Wolf e Katzir-Cohen (2001) Norton e Wolf, 2012; modello del Doppio Deficit)
34 Studio cross linguistico in 8 lingue europee su 1000 bambini con difficoltà di lettura (8 12 anni) Il RAN è, come la delezione di fonemi, uno dei due predittori concorrente più forti della DE, (Landerl et al, 2013)
35 RAN e lettura sono più correlati nelle ortografie trasparenti (minore il peso della consapevolezza fonologica (Kirby et al., 2010 per una rassegna; Landerl et al., 2013 per evidenze contrarie) In Italiano e nelle ortografie regolari le abilità connesse a RAN sembrano giocare un ruolo di rilievo sia rispetto all acquisizione di una strategia di accesso al lessico ortografico (lettura di parole) che nella lettura sub lessicale e nella conversione grafema-fonema (lettura di nonparole) (Gasperini et al., 2014)
36 RAN-LETTURA Differenze con l età/abilità? La velocità al Ran prescolare non alfanumerico predice la velocità al RAN scolare alfanumerico (Lervag e Hulme, 2009) Puolakanhao et al., il RAN insieme alla denominazione di lettere e alla consapevolezza fonologica predice la lettura già a 3 anni
37 Associazione RAN-LETTURA Differenze con l età/abilità? La maggior parte degli studi supporta una relazione fra RAN e lettura nelle prime fasi di acquisizione della lingua scritta e, nel caso di difficoltà di lettura anche in fasi più tardive Forte relazione fra RAN e lettura quando la lettura non è ancora automatizzata
38 Associazione RAN-LETTURA QUALI CARATTERISTICHE DEL RAN? 42 anni di studi!
39 Analisi visiva dello stimolo Spostamento dell attenzione Programmazione e output articolatorio Identificazione di pattern visivi modificato da Wolf and Denkla, 2005 Integrazione di tutte le informazioni semantiche e concettuali con gli altri input Integrazione delle caratteristiche visive con le immagini visive (ortografiche) in memoria 2013 Integrazione delle immagini visive (ortografiche) con le rappresentazioni fonologiche Recupero dell etichetta fonologica
40 Associazione RAN-LETTURA QUALI CARATTERISTICHE DEL RAN? Quando i deficit di RAN nei DE è pesato (covariato) con la differenza in un compito di barrage con gli stessi stimoli, la differenza DE - controlli nel RAN rimane significativa (Di Filippo et al., 2005; Di Filippo et al, 2006) 17/09/14 Non solo ricerca visiva (Stainthorp et al., 2010; Araujo et al., 2010)
41 Associazione RAN-LETTURA QUALI CARATTERISTICHE DEL RAN? Quando il tempo totale è segregato in tempo di pausa (inter-item processing) e tempo di articolazione, il TEMPO di PAUSA e non il tempo di articolazione predicono la lettura (Geourgeu et al., 2006; Araujo et al., 2011). La velocità di articolazione non correla col deficit di RAN nella DE (Di Filippo et al., 2006) NO fattori articolatori post-lessicali, RAN-lettura sono associati da fattori di elaborazione inter-item 17/09/14
42 Associazione RAN-LETTURA QUALI CARATTERISTICHE DEL RAN? Quando il compito di denominazione è svolto sul singolo stimolo (discrete RAN) la differenza fra DE e controlli diminuisce (Kirby et al., 2009; Zoccolotti et al., 2013; Gasperii et al., 2014) Non solo accesso fonologico/lessicale, RANlettura sono associati da fattori legati all elaborazione di stimoli multipli 17/09/14
43 LINGUAGGIO LIBRERIE DI STIMOLI da cui sono tratte le immagini suddivise per: - tipo - lunghezza - frequenza d uso - struttura fonotattica difficoltà di accesso al lessico/vocabolario espressivo difficoltà fono-articolatorie bloccare/sbloccare solo certe librerie in funzione delle difficoltà di accesso lessicale (tipo, frequenza d uso) bloccare/sbloccare solo certe librerie in funzione della presenza di difficoltà fonologiche (struttura fonotattica, lunghezza)
44 manipolare questi parametri: - diminuire il numero di denominazioni per esercizio e/o la durata netta della sessione, piuttosto facendo più sessioni brevi (se c è una difficoltà di attenzione sostenuta) - pre-segnalazione on - bloccare modalità di presentazione particolarmente interferenti, viceversa attivarle in funzione dei processi che si vogliono sollecitare (disancoraggio, spostamento ) NUMERO DI DENOMINAZIONI ATTENZIONE e CONTROLLO ESECUTIVO PRE- SEGNALAZIONE on/off MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE MATRICI DURATA NETTA SESSIONE difficoltà di attenzione selettiva o di pianificazione
45 DIMENSIONE STIMOLI SCANSIONE VISIVA PRE- SEGNALAZIONE on/off MODALITA DI PRESENTAZIO NE DELLE MATRICI difficoltà di scansione visiva o di crowding manipolare questi parametri: - aumentare la dimensione degli stimoli - privilegiare inizialmente modalità di presentazione antiprogressiva e progressiva - pre-segnalazione on
46 Area di indagine Denominazione rapida seriale Ricerca visiva Ricerca visiva seriale di stimoli Alfanumerici Ricerca visiva seriale di stimoli Non Alfanumerici Dominio del linguaggio Funzione esecutive Protocollo pre e post-trattamento: Prove Prove -RAN (IRCSS Santa Lucia) età scolare (impiegata anche per età prescolare) -Nominazione colori (Benso, 2006) e denominazione rapida di figure (Tretti et al, 2002) età prescolare -Ricerca Visiva (IRCSS Santa Lucia) età scolare (impiegata anche per età prescolare) -Test delle campanelle modificato (TCM) -Prova di ricerca di due lettere (PRCR-2) -Prova di ricerca di sequenza di lettere (PRCR-2) -Prove di Visual Search (Facoetti e Gruppo di Padova) -Ripetizione di Non-parole (VauMelf) -Fluenza Verbale (Nepsy II) -Elaborazione fonologica (Nepsy II) -Attenzione uditiva e set di risposte (Nepsy II) -Inibizione Segue..
47 Area di indagine Apprendimento LETTURA Apprendimento SCRITTURA Protocollo pre e post-trattamento: Prove Prove I elementare PROVE MARTINI Da II elementare -Lettura di parole e non/parole (DDE/2) -Lettura di Brano (Prove MT) I elementare PROVE MARTINI Da II elementare -Scrittura di parole e non-parole (DDE-2)
48 Apprendimenti Pre-trt Intermedia Post-trt Lettura di parole Tempo -2,01 (0,8 sill/sec) -1,42 (0,93 sill/sec) -1,35 (0,94 sill/sec) Lettura di parole Errori -0,14 0,57 0,28 Lettura di non-parole -1,86-1,96 (0,64-1,4 (0,71 Tempo (0,64 sill/sec sill/sec) sill/sec) Lettura di non-parole Errori 0,2 0,6 0,2 Brano MT velocità -1,3 (1,33 sill/sec) -1,16 (1,42 sill/sec) -0,86 (1,70 sill/sec) Brano MT accuratezza 0,08 (Suffic.) 0,42 (Cr. Ragg.) 0,58 (Cr. Ragg.) Scrittura di parole ERRORI -1,25-2,5 Scrittura di non parole -0,33 0,33 Errori
49 Test Punteggi Pre trattamento Punteggi Post trattamento Punteggio medio Punteggio medio RAN Zoccolotti TEMPO TOTALE -0,92-0,47 RAN Zoccolotti ERRORI TOTALE 0,76 0,76 Misure di Barrage Ricerca Visiva Zoccolotti TEMPO 0,18 0,06 Ricerca Visiva Zoccolotti ERRORI 0,45 0,22 Test Campanelle (TCM) Velocità 0,48 1,09 Accuratezza -0,05 0,53 Prova di ricerca visiva seriale (Facoetti) β TEMPO -1,5-0,74 β ERRORI -0,06-0,315 PRCR-2- Ricerca di due lettere (SD 3) Tempo 0,27 0,14 Errori 0,52 0,52 PRCR-2- Ricerca di sequenza di lettere (SD 4) Tempo 0,33 0,007 Errori 0,91 0,91 Misure di FE Attenzione uditiva Nepsy-II perc perc. Set di risposte Neps II perc perc Inibizione Nepsy II Cond A Inibizione Nepsy II Cond B 6 8 Inibizione Nepsy II Cond C 7 13
50 MEMO-RAN Esercizio 1) TUTTI GLI STIMOLI VISIBILI: denominazione e inversione di denominazione Tra i 5 stimoli che appaiono il tutor sceglie due stimoli, di cui si invertirà il nome (per es quando vede lago deve dire ragno e quando vede ragno deve dire lago); compito denominare tutti gli stimoli, ricordandosi di invertire i due prima detti restando al ritmo del cue visivo (quadratino rosso)
51 MEMO-RAN Esercizio 2) ITEM CHE SCOMPAIONO PROGRESSIVAMENTE: denominazione di Stimolo precedente Il tutor dice al bambino che dovrà denominare partendo dal secondo stimolo. Il bambino dovrà denominarlo utilizzando l etichetta verbale dello stimolo precedente e restando al ritmo del cue visivo
52 MEMO-RAN Esercizio 3) Denominazione in Cluster
53 Trattamenti process-oriented Esercizi con video-games (Es. Facoetti e Franceschini) Esercizi di attenzione visiva Esercizi di elaborazione fonologica Fawcett, 2014 visual/auditory memory games Esercizi musicali (es. Luisa Lopez) Trattamenti integrati sull attenzione, la memoria di lavoro e la lettura (Es. benso, 2004)
54 Limite dei trattamenti process oriented esistenti - Lavorano settorialmente su abilità/domini separati Quale processo potenziare in età prescolare? - Talvolta si basano sull apprendimento esplicito delle regole (es. trattamenti metafonologici) piuttosto che sull integrazione (automatizzata e veloce) di informazioni di domini diversi (visuo-verbale)
55 Nella DE APPRENDIMENTO DIFFICOLTOSO e «non AUTOMATICO/IMPLICITO» che viene trattato con: REGOLE ESERCIZIO INTENSIVO ESPLICITE + + ESERCIZIO FACILITATO/a livello costante delle prestazioni del bb. Sistemi informatici di tele- riabilitazione 17/09/14
56 Altre evidenze Cronin e coll (2012) : le prestazioni al RAN possono variare indipendentemente dalla fonologia; sia la velocità al RAN che la consapevolezza fonologica sono abilità necessarie nell apprendimento delle corrispondenze grafema-fonema
57 Effetto di Run the RAN, vs Reading Trainer, sulla velocità di lettura *
58 Vantaggio di Run the RAN vs Reading Trainer sull accuratezza di lettura *
59 MODALITA DI PRESENTAZIONE: ITEM SINGOLO _eliminando i distrattori, facilita lo spostamento dell attenzione sinistra-destra e la focalizzazione sullo stimolo presentato _ sono favoriti i meccanismi attentivi ma è resa impossibile la pianificazione dell item successivo da denominare: molto stressata la rapidità di integrazione visuoverbale e la prontezza di accesso lessicale
60 MODALITA DI PRESENTAZIONE: PROGRESSIVO _oltre a stressare la scansione sinistra-destra, si inserisce un elemento di interferenza (le figure precedenti), che il bambino non deve considerare, ponendo l attenzione sullo stimolo prestabilito _sono facilitati lo spostamento e il ri-ancoraggio dell attenzione
61 MODALITA DI PRESENTAZIONE: ANTIPROGRESSIVO _incalza la denominazione eliminando gli item precedenti _facilita, sopprimendo i distrattori (stimoli già denominati), lo spostamento dell attenzione sinistra-destra (soprattutto il disancoraggio dallo stimolo precedente) e la focalizzazione sullo stimolo da denominare _vantaggio dato dalla possibile anticipazione dell accesso lessicale dello stimolo successivo (pianificazione)
62 MODALITA DI PRESENTAZIONE: TUTTI GLI ITEM _compito che per eccellenza si avvicina di più al compito della lettura _interferenza degli stimoli precedenti e successivi _scansione visiva ancora guidata (facilitata la pianificazione)
63 RAGGRUPPAMENTO DEGLI STIMOLI IN CLUSTER Il bambino denomina un solo stimolo (evidenziato in maniera chiara) tra tutti quelli presenti nel cluster. La dimensione dei cluster è casuale (da 2 a 6). Tutte le modalità di presentazione sono disponibili sia per i singoli stimoli che per i cluster di stimoli. _utile al potenziamento dei processi di attenzione selettiva visiva
64 Studio dei parametri Tempo Affollamento visivo Complessità lessicale e articolatoria Modalità di Scansione sinistra-destra
65 Levels of Causation for Developmental Disorders (Bishop and Snowling 2004) Risk Factor: Delay in oral language milestones etiology gene 1 gene 2 gene.. env. 1 env. 2 env. neurobiology cognition Morphos. Ph Work. Mem. Phon. Awarn. RAN cog. behaviour text comprehension spelling decoding accuracy decoding speed
66 RtR RT Pre Mean (sd) Post Mean (sd) Pre Mean (sd) Post Mean (sd) F (gdl) P < Reading Speed pre-post effect 1.26 (0.56) 1.39 (0.44) 1.25 (0.42) 1.56 (0.46)* (1, 28) Passage RtR-RT effect 0.38 (1, 28) ns interaction 1.22 (1, 28) ns pre-post effect 0.90 (0.35) 1.14 (0.41)* 1.02 (0.30) 1.33 (0.41)* (1, 27) Words RtR-RT effect 2.18 (1, 27) ns interaction 1.72 (1, 27) ns pre-post effect 0.76 (0.24) 0.85 (0.27) 0.78 (0.28) 1.02 (0.25)* (1, 27) Non-words RtR-RT effect 5.45 (1, 27) 0.05 interaction 1.08 (1, 27) ns Reading Accuracy Passage pre-post effect 8.16 (8.4) 6.9 (4.48) 9.79 (5.18) 7.83 (5.90) 4.38 (1, 28) 0.05 RtR-RT effect 0.42 (1, 28) ns
67 RAN pre-post effect (3.38) (1.98)* (1.66) (1.03)* (1, 27) Colors RtR-RT effect 4.26 (1, 27) 0.05 interaction 7.19 (1, 27) 0.05 pre-post effect (3.76) (2.33)* -1.9 (1.71) (1.30) (1, 28) Figures RtR-RT effect 3.92 (1, 28) interaction 13.1 (1, 28) pre-post effect (4.2) (2.87)* (1.78) (1.56)* (1, 28) Numbers RtR-RT effect 1.37 (1, 28) ns interaction 4.37 (1, 28) 0.05
68 Geschwind (1965, 1966) ; Denckla e Rudel (1972, 1976) deficit di RAN deficit di lettura (sindrome da disconnessione) La teoria del Doppio Deficit prevede che il deficit di Denominazione Visiva Rapida (RAN) contribuisca in modo indipendente (rispetto ad eventuali difficoltà fonologiche) alle difficoltà di lettura (Wolf e Bowers, 1999; Lovett et al., 2000; Norton e Wolf, 2012)
69 Benso, Marinelli, Zanzurino, 2005 IRCCS Fondazione Santa Lucia, Materiali IPDA, Tretti et al.2002).
70 Servizio di teleriabilitazione IRCCS Stella Maris Per una riabilitazione orientata al processo l esercizio deve essere: Individualizzato Intensivo Auto-adattivo Friendly/piacevole
L intervento sulle funzioni cognitive di. base nel bambino bilingue a rischio di. difficoltà di letto-scrittura
 DIAGNOSI PRECOCE DEL RITARDO LINGUISTICO NEL BAMBINO BILINGUE E IPOTESI DI TRATTAMENTO L intervento sulle funzioni cognitive di base nel bambino bilingue a rischio di difficoltà di letto-scrittura Chiara
DIAGNOSI PRECOCE DEL RITARDO LINGUISTICO NEL BAMBINO BILINGUE E IPOTESI DI TRATTAMENTO L intervento sulle funzioni cognitive di base nel bambino bilingue a rischio di difficoltà di letto-scrittura Chiara
INDICATORI NEUROCOGNITIVI PRECOCI DELLA DISLESSIA EVOLUTIVA. Andrea Facoetti & Co
 INDICATORI NEUROCOGNITIVI PRECOCI DELLA DISLESSIA EVOLUTIVA Andrea Facoetti & Co Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova, ITALIA Unità di Neuropsicologia Evolutiva, Istituto Scientifico
INDICATORI NEUROCOGNITIVI PRECOCI DELLA DISLESSIA EVOLUTIVA Andrea Facoetti & Co Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova, ITALIA Unità di Neuropsicologia Evolutiva, Istituto Scientifico
Argomenti trattati: Pomeriggio (x chi è sopravvissuto alla mattina ovviamente) Disturbi ortografici e dislessia: è una vera causa? Il sistema visivo;
 Argomenti trattati: Pomeriggio (x chi è sopravvissuto alla mattina ovviamente) Disturbi ortografici e dislessia: è una vera causa? Il sistema visivo; Forma visiva della parola; La segregazione grafemica;
Argomenti trattati: Pomeriggio (x chi è sopravvissuto alla mattina ovviamente) Disturbi ortografici e dislessia: è una vera causa? Il sistema visivo; Forma visiva della parola; La segregazione grafemica;
Prerequisiti linguistici e scrittura
 Prerequisiti linguistici e scrittura Paola Viterbori Polo Bozzo Università di Genova Scrittura come attività complessa Codifica (Alfabetizzazione o Literacy) Attività linguistica di trasformazione del
Prerequisiti linguistici e scrittura Paola Viterbori Polo Bozzo Università di Genova Scrittura come attività complessa Codifica (Alfabetizzazione o Literacy) Attività linguistica di trasformazione del
LABORATORIO Corso di Pedagogia speciale Prof.ssa Zappaterra IV anno GRUPPO 1 23 settembre :00/19:00 Dr.ssa Lucia Donata Nepi
 Scuola di Studi Umanistici e della Formazione CdS in Scienze della Formazione Primaria! LABORATORIO Corso di Pedagogia speciale Prof.ssa Zappaterra IV anno GRUPPO 1 23 settembre 2015 16:00/19:00 Dr.ssa
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione CdS in Scienze della Formazione Primaria! LABORATORIO Corso di Pedagogia speciale Prof.ssa Zappaterra IV anno GRUPPO 1 23 settembre 2015 16:00/19:00 Dr.ssa
Istituzioni di linguistica a.a Federica Da Milano
 Istituzioni di linguistica a.a.2014-2015 Federica Da Milano federica.damilano@unimib.it I processi di lettura, scrittura e calcolo nell età adulta La lettura: la capacità di leggere stringhe di lettere
Istituzioni di linguistica a.a.2014-2015 Federica Da Milano federica.damilano@unimib.it I processi di lettura, scrittura e calcolo nell età adulta La lettura: la capacità di leggere stringhe di lettere
Trattamento diretto e indiretto dei DSA
 Trattamento diretto e indiretto dei DSA Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema Giacomo Stella IRIDE e AID Giacomo.stella@sosdislessia.it APPRENDIMENTO ESPLICITO (o Dichiarativo)
Trattamento diretto e indiretto dei DSA Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema Giacomo Stella IRIDE e AID Giacomo.stella@sosdislessia.it APPRENDIMENTO ESPLICITO (o Dichiarativo)
Lo sviluppo neurale e la plasticità
 Convegno nazionale Musica è apprendimento Parma, 28-29 Ottobre 2016 L effetto della pratica musicale sulle competenze cognitive degli alunni: abilità cognitive di base (attenzione e memoria), letto-scrittura
Convegno nazionale Musica è apprendimento Parma, 28-29 Ottobre 2016 L effetto della pratica musicale sulle competenze cognitive degli alunni: abilità cognitive di base (attenzione e memoria), letto-scrittura
Correlazione tra i disturbi specifici del linguaggio e DSA
 Correlazione tra i disturbi specifici del linguaggio e DSA Dr. B. Rizzo Troina 13 Settembre 2013 U.O.C di ORL & Foniatria - IRCCS OASI MARIA SS. - ONLUS, TROINA Direttore Dr.V.Neri DISTURBI SPECIFICI DEL
Correlazione tra i disturbi specifici del linguaggio e DSA Dr. B. Rizzo Troina 13 Settembre 2013 U.O.C di ORL & Foniatria - IRCCS OASI MARIA SS. - ONLUS, TROINA Direttore Dr.V.Neri DISTURBI SPECIFICI DEL
Prof.ssa Dolores Rollo Psicologia dello Sviluppo e dell Educazione.
 L effetto della pratica musicale sulle competenze cognitive degli alunni: abilità cognitive di base (attenzione e memoria), letto-scrittura e apprendimento musicale Prof.ssa Dolores Rollo Psicologia dello
L effetto della pratica musicale sulle competenze cognitive degli alunni: abilità cognitive di base (attenzione e memoria), letto-scrittura e apprendimento musicale Prof.ssa Dolores Rollo Psicologia dello
PROGETTO DI IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEL RISCHIO DIFFICOLTA DI LETTOSCRITTURA IN ETA PRESCOLARE
 PROGETTO DI IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEL RISCHIO DIFFICOLTA DI LETTOSCRITTURA IN ETA PRESCOLARE Dicembre 2015 C/o Centro Commerciale Azzurro II piano Via M. Moretti, 23 apprendiamorsm@gmail.com Progetto
PROGETTO DI IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEL RISCHIO DIFFICOLTA DI LETTOSCRITTURA IN ETA PRESCOLARE Dicembre 2015 C/o Centro Commerciale Azzurro II piano Via M. Moretti, 23 apprendiamorsm@gmail.com Progetto
Ne esistono diverse e spesso contrastanti
 Ne esistono diverse e spesso contrastanti Una persona che nella quotidianità usa due o più lingue (Grosjean 1989) Chi ha competenze, anche minime, nelle due diverse lingue, in comprensione e/o produzione
Ne esistono diverse e spesso contrastanti Una persona che nella quotidianità usa due o più lingue (Grosjean 1989) Chi ha competenze, anche minime, nelle due diverse lingue, in comprensione e/o produzione
Indice. Introduzione. Il razionale sotteso all evoluzione delle Scale WISC Introduzione 3 Bambini e realtà clinica 5. L evoluzione degli strumenti 15
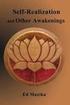 Indice Introduzione XIII Parte prima Il razionale sotteso all evoluzione delle Scale WISC Introduzione 3 Bambini e realtà clinica 5 Quali modelli psicopatologici per i bambini 5 Un modo diverso di considerare
Indice Introduzione XIII Parte prima Il razionale sotteso all evoluzione delle Scale WISC Introduzione 3 Bambini e realtà clinica 5 Quali modelli psicopatologici per i bambini 5 Un modo diverso di considerare
Risultati di un training combinato di lettura e ritmo per la riabilitazione della dislessia
 Convegno La musica nello sviluppo delle abilità linguistiche 22 Ottobre 2016 Bosisio Parini (LC) Risultati di un training combinato di lettura e ritmo per la riabilitazione della dislessia Alice Cancer
Convegno La musica nello sviluppo delle abilità linguistiche 22 Ottobre 2016 Bosisio Parini (LC) Risultati di un training combinato di lettura e ritmo per la riabilitazione della dislessia Alice Cancer
Disturbi specifici di apprendimento Raccomandazioni cliniche
 Disturbi specifici di apprendimento Raccomandazioni cliniche Padova, 11.05.2012 G. Tarter 1 Raccomandazioni per attivare un trattamento riabilitativo Quali i criteri per stabilire se un trattamento ha
Disturbi specifici di apprendimento Raccomandazioni cliniche Padova, 11.05.2012 G. Tarter 1 Raccomandazioni per attivare un trattamento riabilitativo Quali i criteri per stabilire se un trattamento ha
Difficoltà e Disturbo: quale relazione negli apprendimenti scolastici. Marzia L. Bizzaro
 Difficoltà e Disturbo: quale relazione negli apprendimenti scolastici Marzia L. Bizzaro Università Milano-Bicocca, 15 novembre 2010 Disabilità: limitazione o perdita (conseguente a menomazione) delle capacità
Difficoltà e Disturbo: quale relazione negli apprendimenti scolastici Marzia L. Bizzaro Università Milano-Bicocca, 15 novembre 2010 Disabilità: limitazione o perdita (conseguente a menomazione) delle capacità
IPDA. Questionario Osservativo per L IDENTIFICAZIONE. PRECOCE delle DIFFICOLTA di APPRENDIMENTO Terreni et al, 2002
 IPDA Questionario Osservativo per L IDENTIFICAZIONE PRECOCE delle DIFFICOLTA di APPRENDIMENTO Terreni et al, 2002 Cos è L IPDA è la prima fase di un progetto di intervento per ridurre il problema delle
IPDA Questionario Osservativo per L IDENTIFICAZIONE PRECOCE delle DIFFICOLTA di APPRENDIMENTO Terreni et al, 2002 Cos è L IPDA è la prima fase di un progetto di intervento per ridurre il problema delle
L analisi degli errori nei disturbi evolutivi della scrittura
 L analisi degli errori nei disturbi evolutivi della scrittura Dr.ssa Federica Riva U.O. Neurologia dello Sviluppo Servizio per i disordini del linguaggio e dell apprendimento Fondazione IRCCS Istituto
L analisi degli errori nei disturbi evolutivi della scrittura Dr.ssa Federica Riva U.O. Neurologia dello Sviluppo Servizio per i disordini del linguaggio e dell apprendimento Fondazione IRCCS Istituto
Strumenti a supporto della valutazione dell apprendimento. Sara Zaccaria Ordine degli Psicologi della Toscana 26 maggio 2016
 Strumenti a supporto della valutazione dell apprendimento Sara Zaccaria Ordine degli Psicologi della Toscana 26 maggio 2016 Apprendimento e scuola dell infanzia La Legge 170, 8 ottobre 2010 sottolinea
Strumenti a supporto della valutazione dell apprendimento Sara Zaccaria Ordine degli Psicologi della Toscana 26 maggio 2016 Apprendimento e scuola dell infanzia La Legge 170, 8 ottobre 2010 sottolinea
TEST DI DENOMINAZIONE RAPIDA E RICERCA VISIVA DI COLORI, FIGURE E NUMERI MANUALE
 TEST DI DENOMINAZIONE RAPIDA E RICERCA VISIVA DI COLORI, FIGURE E NUMERI MANUALE Maria De Luca, Gloria Di Filippo, Anna Judica, Donatella Spinelli, Pierluigi Zoccolotti Edizione 2005 INTRODUZIONE Negli
TEST DI DENOMINAZIONE RAPIDA E RICERCA VISIVA DI COLORI, FIGURE E NUMERI MANUALE Maria De Luca, Gloria Di Filippo, Anna Judica, Donatella Spinelli, Pierluigi Zoccolotti Edizione 2005 INTRODUZIONE Negli
Studi italiani sul trattamento della dislessia evolutiva
 v.16/9/2010 Studi italiani sul trattamento della dislessia evolutiva Patrizio Tressoldi Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova Obiettivi dello studio: -Riportare i risultati dei trattamenti
v.16/9/2010 Studi italiani sul trattamento della dislessia evolutiva Patrizio Tressoldi Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova Obiettivi dello studio: -Riportare i risultati dei trattamenti
CURRICULUM Gloria Di Filippo
 CURRICULUM Gloria Di Filippo nata a Roma il 15 maggio 1970 TITOLI 2014 Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore Associato per il settore 11-E1 Psicologia generale, psicobiologia e Psicometria
CURRICULUM Gloria Di Filippo nata a Roma il 15 maggio 1970 TITOLI 2014 Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore Associato per il settore 11-E1 Psicologia generale, psicobiologia e Psicometria
Osservazioni e strumenti
 Osservazioni e strumenti Centro di Consulenza Psicologica e Pedagogica L Albero Bianco via Matteo degli Organi, 213 Prato 0574/24684 alberobianco@alicecoop.it Prerequisiti per la lettura Sistema di analisi
Osservazioni e strumenti Centro di Consulenza Psicologica e Pedagogica L Albero Bianco via Matteo degli Organi, 213 Prato 0574/24684 alberobianco@alicecoop.it Prerequisiti per la lettura Sistema di analisi
I^ GIORNATA DI FORMAZIONE
 Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale I^ GIORNATA DI FORMAZIONE Regione MARCHE ASCOLI PICENO San Benedetto del Tronto MARTEDI 20 MARZO 2007 PIANO
Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale I^ GIORNATA DI FORMAZIONE Regione MARCHE ASCOLI PICENO San Benedetto del Tronto MARTEDI 20 MARZO 2007 PIANO
La relazione fra funzioni esecutive, problemi comportamentali e prerequisiti scolastici nell ultimo anno della scuola dell infanzia.
 La relazione fra funzioni esecutive, problemi comportamentali e prerequisiti scolastici nell ultimo anno della scuola dell infanzia. Paola Viterbori, M. Carmen Usai, Laura Traverso Sezione di Psicologia
La relazione fra funzioni esecutive, problemi comportamentali e prerequisiti scolastici nell ultimo anno della scuola dell infanzia. Paola Viterbori, M. Carmen Usai, Laura Traverso Sezione di Psicologia
Lab.D.A. Laboratorio sui Disturbi dell Apprendimento Galleria Berchet, 3 Padova Via Cavour, 24 Rovigo Direttore: Prof.
 Lab.D.A. Laboratorio sui Disturbi dell Apprendimento Galleria Berchet, 3 Padova Via Cavour, 24 Rovigo Direttore: Prof. Cesare Cornoldi I prerequisiti dell apprendimento della lettura e della scrittura
Lab.D.A. Laboratorio sui Disturbi dell Apprendimento Galleria Berchet, 3 Padova Via Cavour, 24 Rovigo Direttore: Prof. Cesare Cornoldi I prerequisiti dell apprendimento della lettura e della scrittura
Diagnosi e ruoli dei vari attori coinvolti nell ottica di un lavoro di rete DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
 Diagnosi e ruoli dei vari attori coinvolti nell ottica di un lavoro di rete DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CONDIZIONI CLINICHE EVOLUTIVE DISLESSIA/LETTURA (intesa come abilità di decodifica del testo)
Diagnosi e ruoli dei vari attori coinvolti nell ottica di un lavoro di rete DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CONDIZIONI CLINICHE EVOLUTIVE DISLESSIA/LETTURA (intesa come abilità di decodifica del testo)
Cosa si intende per produzione del testo?
 1 Cosa si intende per produzione del testo? A partire dagli anni 80 si matura la consapevolezza che la produzione di un testo scritto sia un processo principalmente cognitivo: anche gli aspetti grafo-motori
1 Cosa si intende per produzione del testo? A partire dagli anni 80 si matura la consapevolezza che la produzione di un testo scritto sia un processo principalmente cognitivo: anche gli aspetti grafo-motori
dr.ssa Paola Cavalcaselle psicologa
 Screening delle capacità di lettoscrittura per la rilevazione precoce di alunni a rischio di difficoltà di apprendimento nelle prime due classi della scuola primaria dr.ssa Paola Cavalcaselle psicologa
Screening delle capacità di lettoscrittura per la rilevazione precoce di alunni a rischio di difficoltà di apprendimento nelle prime due classi della scuola primaria dr.ssa Paola Cavalcaselle psicologa
 Livello di lettura di due deviazioni standard inferiore alla media Quoziente intellettivo (QI) nella norma Assenza di cause neurologiche e/o sensoriali Interferenza significativa con l apprendimento scolastico
Livello di lettura di due deviazioni standard inferiore alla media Quoziente intellettivo (QI) nella norma Assenza di cause neurologiche e/o sensoriali Interferenza significativa con l apprendimento scolastico
Progetto IPDA Prevenire le difficoltà d apprendimento a partire dall'ultimo anno della Scuola d Infanzia
 Progetto IPDA Prevenire le difficoltà d apprendimento a partire dall'ultimo anno della Scuola d Infanzia L INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DEI PREREQUISITI Il profilo del bambino ottenuto dall applicazione
Progetto IPDA Prevenire le difficoltà d apprendimento a partire dall'ultimo anno della Scuola d Infanzia L INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DEI PREREQUISITI Il profilo del bambino ottenuto dall applicazione
I sistemi di scrittura. Linguaggio orale e linguaggio scritto. La lettura di parole singole. Ipotesi della profondità ortografica
 Linguaggio orale e linguaggio scritto La percezione, comprensione e produzione del linguaggio parlato si sviluppano molto precocemente e sfruttano meccanismi biologici specializzati e universali La percezione,
Linguaggio orale e linguaggio scritto La percezione, comprensione e produzione del linguaggio parlato si sviluppano molto precocemente e sfruttano meccanismi biologici specializzati e universali La percezione,
APPRENDIMENTO DELLA LETTO-SCRITTURA. 4 settembre 2014 Alessandra Scabia
 APPRENDIMENTO DELLA LETTO-SCRITTURA 4 settembre 2014 Alessandra Scabia L apprendimento della letto-scrittura presuppone l acquisizione di: competenze fonologiche: produzione di tutti i suoni, ripetizioni
APPRENDIMENTO DELLA LETTO-SCRITTURA 4 settembre 2014 Alessandra Scabia L apprendimento della letto-scrittura presuppone l acquisizione di: competenze fonologiche: produzione di tutti i suoni, ripetizioni
Disturbi Specifici di Scrittura
 Disturbi Specifici di Scrittura e disturbi specifici della funzione motoria Il processo di scrittura Condivide con la lettura il nucleo essenziale del processo, Richiede un abilità grafica aggiuntiva Richiede
Disturbi Specifici di Scrittura e disturbi specifici della funzione motoria Il processo di scrittura Condivide con la lettura il nucleo essenziale del processo, Richiede un abilità grafica aggiuntiva Richiede
Lab.D.A. Laboratorio sui Disturbi dell Apprendimento Galleria Berchet, 3 Padova Direttore: Prof. Cesare Cornoldi
 Lab.D.A. Laboratorio sui Disturbi dell Apprendimento Galleria Berchet, 3 Padova Direttore: Prof. Cesare Cornoldi Batteria MT 16-19 BATTERIA PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI DI LETTURA E SCRITTURA E
Lab.D.A. Laboratorio sui Disturbi dell Apprendimento Galleria Berchet, 3 Padova Direttore: Prof. Cesare Cornoldi Batteria MT 16-19 BATTERIA PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI DI LETTURA E SCRITTURA E
COME FUNZIONA IL NOSTRO CERVELLO la memoria
 Referente Dott.ssa Renza Rosiglioni Corso Re Umberto I, n.5 Ivrea (To) Cellulare 347 9662237 COME FUNZIONA IL NOSTRO CERVELLO la memoria a cura di RENZA ROSIGLIONI & LARA MASOERO Ivrea 15 Gennaio 2014
Referente Dott.ssa Renza Rosiglioni Corso Re Umberto I, n.5 Ivrea (To) Cellulare 347 9662237 COME FUNZIONA IL NOSTRO CERVELLO la memoria a cura di RENZA ROSIGLIONI & LARA MASOERO Ivrea 15 Gennaio 2014
La Dislessia Evolutiva
 La Dislessia Evolutiva Dislessia Evolutiva (DE) Disabilità specifica dell apprendimento di origine neurobiologica. Si manifesta quando un bambino non sviluppa, o sviluppa con molta difficoltà, la capacità
La Dislessia Evolutiva Dislessia Evolutiva (DE) Disabilità specifica dell apprendimento di origine neurobiologica. Si manifesta quando un bambino non sviluppa, o sviluppa con molta difficoltà, la capacità
PROTOCOLLO DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE E MONITORAGGIO DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
 PROTOCOLLO DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE E MONITORAGGIO DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA DI SCREENING Istituto Comprensivo Statale Rita Levi-Montalcini SUISIO PREMESSA La legge 8 ottobre, n
PROTOCOLLO DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE E MONITORAGGIO DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA DI SCREENING Istituto Comprensivo Statale Rita Levi-Montalcini SUISIO PREMESSA La legge 8 ottobre, n
Presidio Ospedaliero Villa Rosa
 Presidio Ospedaliero Villa Rosa Salsomaggiore Terme 5-6 novembre 2010 Percorsi riabilitativi Valutazione e trattamento delle menomazioni e disabilità cognitivo comportamentali DISTURBI COMPORTAMENTALI
Presidio Ospedaliero Villa Rosa Salsomaggiore Terme 5-6 novembre 2010 Percorsi riabilitativi Valutazione e trattamento delle menomazioni e disabilità cognitivo comportamentali DISTURBI COMPORTAMENTALI
Obiettivo/i educativi formativi complessivi dell attività formativa
 NEUROPSICOLOGIA DEL DISTURBO DI APPRENDIMENTO DELLA SCRITTURA: LA VALUTAZIONE E LA RIABILITAZIONE Roma 26 e 27 maggio 23 e 24 giugno 2012 Sede Villa Eur Parco dei Pini P.le M. Champagnat, 2 Relatori Dott.ssa
NEUROPSICOLOGIA DEL DISTURBO DI APPRENDIMENTO DELLA SCRITTURA: LA VALUTAZIONE E LA RIABILITAZIONE Roma 26 e 27 maggio 23 e 24 giugno 2012 Sede Villa Eur Parco dei Pini P.le M. Champagnat, 2 Relatori Dott.ssa
Un Software per il potenziamento delle abilità di lettura e scrittura
 OTTOVOLANTE Un Software per il potenziamento delle abilità di lettura e scrittura *G. STELLA *G. CAIAZZO - *G. ZANZURINO * Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia San Marino 19/09/2008 Progetto
OTTOVOLANTE Un Software per il potenziamento delle abilità di lettura e scrittura *G. STELLA *G. CAIAZZO - *G. ZANZURINO * Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia San Marino 19/09/2008 Progetto
Patologia del linguaggio in età evolutiva
 Patologia del linguaggio in età evolutiva U.O. e Cattedra di Neuropsichiatria Infantile Dipartimento di Scienze Neurologiche e della Visione Sezione di Neuroscienze dello Sviluppo IRCCS G. Gaslini Disturbi
Patologia del linguaggio in età evolutiva U.O. e Cattedra di Neuropsichiatria Infantile Dipartimento di Scienze Neurologiche e della Visione Sezione di Neuroscienze dello Sviluppo IRCCS G. Gaslini Disturbi
Cause delle difficolta di lettura. Rachele Fanari
 Cause delle difficolta di lettura Rachele Fanari rfanari@unica.it CAMPANELLI DI ALLARME Elementi da osservare nella Scuola Primaria: Difficoltà a memorizzare sequenze (mesi, giorni, ordine alfabetico,
Cause delle difficolta di lettura Rachele Fanari rfanari@unica.it CAMPANELLI DI ALLARME Elementi da osservare nella Scuola Primaria: Difficoltà a memorizzare sequenze (mesi, giorni, ordine alfabetico,
I PREDITTORI DELLA SCRITTURA
 I PREDITTORI DELLA SCRITTURA - Abilità di base che favoriscono la correttezza ortografica in bambini della scuola primaria Teresa Gloria Scalisi Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione
I PREDITTORI DELLA SCRITTURA - Abilità di base che favoriscono la correttezza ortografica in bambini della scuola primaria Teresa Gloria Scalisi Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione
SEMINARIO DI AVVIO DELLA RETE ADHD
 SEMINARIO DI AVVIO DELLA RETE ADHD Istituto Superiore Sanità 17 Aprile 2007 Riabilitazione neuropsicologica-neurocognitiva neurocognitiva R. Penge, M. Romani D.S.N.P.R.E.E. Università di Roma La Sapienza
SEMINARIO DI AVVIO DELLA RETE ADHD Istituto Superiore Sanità 17 Aprile 2007 Riabilitazione neuropsicologica-neurocognitiva neurocognitiva R. Penge, M. Romani D.S.N.P.R.E.E. Università di Roma La Sapienza
SPM. TEST di ABILITA di SOLUZIONE dei PROBLEMI MATEMATICI
 SPM TEST di ABILITA di SOLUZIONE dei PROBLEMI MATEMATICI CAPACITA di RISOLVERE I PROBLEMI È una delle principali competenze del sistema cognitivo KATONA e WURTHEIMER (Gestaltisti) Una mente strategica
SPM TEST di ABILITA di SOLUZIONE dei PROBLEMI MATEMATICI CAPACITA di RISOLVERE I PROBLEMI È una delle principali competenze del sistema cognitivo KATONA e WURTHEIMER (Gestaltisti) Una mente strategica
I disturbi specifici dell apprendimento: dall identificazione precoce agli interventi di recupero. Autore: Letizia Moretti Editing : Enrica Ciullo
 I disturbi specifici dell apprendimento: dall identificazione precoce agli interventi di recupero Autore: Letizia Moretti Editing : Enrica Ciullo Corso Dsa - I disturbi specifici dell apprendimento: dall
I disturbi specifici dell apprendimento: dall identificazione precoce agli interventi di recupero Autore: Letizia Moretti Editing : Enrica Ciullo Corso Dsa - I disturbi specifici dell apprendimento: dall
Modelli di valutazione e intervento nei disturbi dell espressione scritta
 Modelli di valutazione e intervento nei disturbi dell espressione scritta Barbara Arfé Università degli Studi di Padova In collaborazione con: Eleonora Pizzoccaro Anna Merella Elisa Cona M.R Russo Centro
Modelli di valutazione e intervento nei disturbi dell espressione scritta Barbara Arfé Università degli Studi di Padova In collaborazione con: Eleonora Pizzoccaro Anna Merella Elisa Cona M.R Russo Centro
COME FUNZIONA IL NOSTRO CERVELLO IL LINGUAGGIO
 Referente Dott.ssa Renza Rosiglioni Corso Re Umberto I, n.5 Ivrea (To) renzarosiglioni@libero.it Cellulare 347 9662237 a cura di RENZA ROSIGLIONI & LARA MASOERO COME FUNZIONA IL NOSTRO CERVELLO IL LINGUAGGIO
Referente Dott.ssa Renza Rosiglioni Corso Re Umberto I, n.5 Ivrea (To) renzarosiglioni@libero.it Cellulare 347 9662237 a cura di RENZA ROSIGLIONI & LARA MASOERO COME FUNZIONA IL NOSTRO CERVELLO IL LINGUAGGIO
DIAGNOSI NEUROPSICOLOGICA DELL ADHD
 DIAGNOSI NEUROPSICOLOGICA DELL ADHD Chiarenza GA, Acace M, Lo Torto MG, Pozzi C, Raia R, Tomassini E, Olgiati P¹. Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile, Az. Osp. G. Salvini, Rho, Milano. ¹ Università
DIAGNOSI NEUROPSICOLOGICA DELL ADHD Chiarenza GA, Acace M, Lo Torto MG, Pozzi C, Raia R, Tomassini E, Olgiati P¹. Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile, Az. Osp. G. Salvini, Rho, Milano. ¹ Università
Valutazione e intervento didattico nell apprendimento della lettura e della scrittura. Belluno, ottobre dicembre 2011.
 Valutazione e intervento didattico nell apprendimento della lettura e della scrittura Belluno, ottobre dicembre 2011 Michela Cendron Centro Regionale Specializzato per i Disturbi dell Apprendimento ULSS20
Valutazione e intervento didattico nell apprendimento della lettura e della scrittura Belluno, ottobre dicembre 2011 Michela Cendron Centro Regionale Specializzato per i Disturbi dell Apprendimento ULSS20
Valutazione neuropsicologica delle funzioni cognitive
 Valutazione neuropsicologica delle funzioni cognitive WWW.FISIOKINESITERAPIA.BIZ La Neuropsicologia è quella disciplina scientifica che indaga le relazioni esistenti tra: funzioni cognitive struttura e
Valutazione neuropsicologica delle funzioni cognitive WWW.FISIOKINESITERAPIA.BIZ La Neuropsicologia è quella disciplina scientifica che indaga le relazioni esistenti tra: funzioni cognitive struttura e
DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali) La legge 170/2010 Il DM 12 luglio 2011 e Linee Guida
 DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali) La legge 170/2010 Il DM 12 luglio 2011 e Linee Guida Strumenti di screening e osservazione Alcuni strumenti IPDA Questionario
DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali) La legge 170/2010 Il DM 12 luglio 2011 e Linee Guida Strumenti di screening e osservazione Alcuni strumenti IPDA Questionario
STUDENTI E ISTRUZIONE:
 STUDENTI E ISTRUZIONE: URP - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA 1 Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce
STUDENTI E ISTRUZIONE: URP - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA 1 Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce
Il disordine fonologico: valutazione e trattamento - I e II livello
 Il disordine fonologico: valutazione e trattamento - I e II livello Roma 14 e 15 ottobre 2 e 3 dicembre 2017 Sede Hotel Il Cantico Via del Cottolengo 50 Docente: Vaquer Maria Luisa Patrizia Obiettivi:
Il disordine fonologico: valutazione e trattamento - I e II livello Roma 14 e 15 ottobre 2 e 3 dicembre 2017 Sede Hotel Il Cantico Via del Cottolengo 50 Docente: Vaquer Maria Luisa Patrizia Obiettivi:
AD-DA Online. La VALUTAZIONE. La RESTITUZIONE
 ATTRAVERSO LO SPECCHIO Dai bisogni educativi speciali, alle esigenze educative speciali Workshop: Riabilitazione a distanza e ADDA Strumento on line di supporto professionale alla diagnosi di Disturbo
ATTRAVERSO LO SPECCHIO Dai bisogni educativi speciali, alle esigenze educative speciali Workshop: Riabilitazione a distanza e ADDA Strumento on line di supporto professionale alla diagnosi di Disturbo
Il disordine fonologico: valutazione e trattamento. 1 livello. Docente Vaquer Maria Luisa Patrizia. Obiettivi:
 Il disordine fonologico: valutazione e trattamento. 1 livello. Firenze 7 e 8 maggio 2011 Grand Hotel Cavour Via del Proconsolo 3 Docente Vaquer Maria Luisa Patrizia Obiettivi: Nella pratica clinica relativa
Il disordine fonologico: valutazione e trattamento. 1 livello. Firenze 7 e 8 maggio 2011 Grand Hotel Cavour Via del Proconsolo 3 Docente Vaquer Maria Luisa Patrizia Obiettivi: Nella pratica clinica relativa
Diagnosi precoce ed evoluzione della Dislessia dall età scolare al termine della scolarizzazione
 Diagnosi precoce ed evoluzione della Dislessia dall età scolare al termine della scolarizzazione Marina Silvestrini Logopedista Unità Operativa Disturbi dello Sviluppo Distretto 2 - ASL 3 Sommario - Dislessia
Diagnosi precoce ed evoluzione della Dislessia dall età scolare al termine della scolarizzazione Marina Silvestrini Logopedista Unità Operativa Disturbi dello Sviluppo Distretto 2 - ASL 3 Sommario - Dislessia
Razionale. 3-4 giugno 2010 Alghero Hotel Calabona Loc. Calabona
 Il bambino con disturbi del linguaggio: correlazione tra disturbo della coordinazione motoria e dsl, dsl con dmc e disprassia verbale.diagnosi valutazione e terapia. 3-4 giugno 2010 Alghero Hotel Calabona
Il bambino con disturbi del linguaggio: correlazione tra disturbo della coordinazione motoria e dsl, dsl con dmc e disprassia verbale.diagnosi valutazione e terapia. 3-4 giugno 2010 Alghero Hotel Calabona
3 LEZIONE. I MODELLI DI APPRENDIMENTO DELLA LETTURA E LA DISLESSIA: DALLO SCREENING PRECOCE ALLA DIAGNOSI
 3 LEZIONE. I MODELLI DI APPRENDIMENTO DELLA LETTURA E LA DISLESSIA: DALLO SCREENING PRECOCE ALLA DIAGNOSI Introduzione L obiettivo di questo capitolo e dei prossimi, è quello di comprendere ed analizzare
3 LEZIONE. I MODELLI DI APPRENDIMENTO DELLA LETTURA E LA DISLESSIA: DALLO SCREENING PRECOCE ALLA DIAGNOSI Introduzione L obiettivo di questo capitolo e dei prossimi, è quello di comprendere ed analizzare
La dislessia evolutiva all università Giacomo STELLA. Università di Modena e Reggio Emilia I.RI.D.E.
 La dislessia evolutiva all università Giacomo STELLA Università di Modena e Reggio Emilia I.RI.D.E. La dislessia evolutiva (Lyon, Shaywitz & Shaywitz 2003) La Dislessia è una disabilità specifica dell
La dislessia evolutiva all università Giacomo STELLA Università di Modena e Reggio Emilia I.RI.D.E. La dislessia evolutiva (Lyon, Shaywitz & Shaywitz 2003) La Dislessia è una disabilità specifica dell
Associazione Italiana Disprassia Età Evolutiva
 Associazione Italiana Disprassia Età Evolutiva Correlazioni tra DCD e Disprassia, Disturbi del Linguaggio ( Espressione verbale), Disturbi delle FE (Funzioni esecutive): metodologia di valutazione e terapia
Associazione Italiana Disprassia Età Evolutiva Correlazioni tra DCD e Disprassia, Disturbi del Linguaggio ( Espressione verbale), Disturbi delle FE (Funzioni esecutive): metodologia di valutazione e terapia
Il disordine fonologico: valutazione e trattamento. 1 e 2 livello.
 Il disordine fonologico: valutazione e trattamento. 1 e 2 livello. Lecce 1 livello 24-25 settembre 2 livello 15-16 ottobre 2010 Sede : Grand Hotel Europa Viale Europa Docente Vaquer Maria Luisa Patrizia
Il disordine fonologico: valutazione e trattamento. 1 e 2 livello. Lecce 1 livello 24-25 settembre 2 livello 15-16 ottobre 2010 Sede : Grand Hotel Europa Viale Europa Docente Vaquer Maria Luisa Patrizia
Rovigo Advanced Seminars NEPSY - II SECOND EDITION. Padova: / ; Rovigo:
 Lab.D.A. Sede di Padova: Laboratorio sui Disturbi dell Apprendimento Galleria Berchet, 3 Padova Sede di Rovigo Via Cavour, 24 45100 Rovigo Direttore: Prof. Cesare Cornoldi Rovigo Advanced Seminars SECOND
Lab.D.A. Sede di Padova: Laboratorio sui Disturbi dell Apprendimento Galleria Berchet, 3 Padova Sede di Rovigo Via Cavour, 24 45100 Rovigo Direttore: Prof. Cesare Cornoldi Rovigo Advanced Seminars SECOND
COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO IN BAMBINI POOR COMPREHENDERS
 Università degli Studi di Messina DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO IN BAMBINI POOR COMPREHENDERS COGNIZIONE VS METACOGNIZIONE Prof.ssa Pina FILIPPELLO Abilità fondamentale
Università degli Studi di Messina DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO IN BAMBINI POOR COMPREHENDERS COGNIZIONE VS METACOGNIZIONE Prof.ssa Pina FILIPPELLO Abilità fondamentale
ESPRESSIVITÀ DELLA VELOCITÀ DI LETTURA IN GIOVANI ADULTI: EFFETTI DI ALCUNE VARIABILI PSICOLINGUISTICHE
 ESPRESSIVITÀ DELLA VELOCITÀ DI LETTURA IN GIOVANI ADULTI: EFFETTI DI ALCUNE VARIABILI PSICOLINGUISTICHE Marisa Giorgetti 1, Pier Luigi Baldi 2 1 Servizio Clinico Spaee Università Cattolica del Sacro Cuore
ESPRESSIVITÀ DELLA VELOCITÀ DI LETTURA IN GIOVANI ADULTI: EFFETTI DI ALCUNE VARIABILI PSICOLINGUISTICHE Marisa Giorgetti 1, Pier Luigi Baldi 2 1 Servizio Clinico Spaee Università Cattolica del Sacro Cuore
Percorsi evolutivi e riabilitativi in età evolutiva
 QUANDO I CONTI NON TORNANO: MODELLI NEUROPSICOLOGICI E RIABILITAZIONE DELLA DISCALCULIA Roma, 1 e 2 ottobre 2010 Percorsi evolutivi e riabilitativi in età evolutiva Enrica Mariani Manuela Pieretti Asl
QUANDO I CONTI NON TORNANO: MODELLI NEUROPSICOLOGICI E RIABILITAZIONE DELLA DISCALCULIA Roma, 1 e 2 ottobre 2010 Percorsi evolutivi e riabilitativi in età evolutiva Enrica Mariani Manuela Pieretti Asl
Dislessia Evolutiva. Come si manifesta Le prime fasi (inizio elementare)
 Dislessia Evolutiva Come si manifesta Le prime fasi (inizio elementare) Difficoltà e lentezza nell acquisizione del codice alfabetico e nella applicazione delle mappature Grafema-Fonema e viceversa Controllo
Dislessia Evolutiva Come si manifesta Le prime fasi (inizio elementare) Difficoltà e lentezza nell acquisizione del codice alfabetico e nella applicazione delle mappature Grafema-Fonema e viceversa Controllo
apprendimento: Disturbo della lettura (DISLESSIA):
 Disturbi dell apprendimento apprendimento: Diagnosi differenziale A. normali variazioni nei risultati scolastici B. difficoltà scolastiche dovute a mancanza di opportunità, insegnamento scadente, fattori
Disturbi dell apprendimento apprendimento: Diagnosi differenziale A. normali variazioni nei risultati scolastici B. difficoltà scolastiche dovute a mancanza di opportunità, insegnamento scadente, fattori
Come leggono i bambini dislessici? Rachele Fanari
 Come leggono i bambini dislessici? Rachele Fanari Evidenze dai bambini italiani con sviluppo tipico In uno studio longitudinale abbiamo osservato un gruppo di bambini dalla fine della scuola dell infanzia
Come leggono i bambini dislessici? Rachele Fanari Evidenze dai bambini italiani con sviluppo tipico In uno studio longitudinale abbiamo osservato un gruppo di bambini dalla fine della scuola dell infanzia
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI SCREENING
 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI SCREENING Dott.ssa Isabella Bellagamba Psicologa psicoterapeuta dell età evolutiva isabellabellagamba@libero.it www.psicoterapiainfanziaeadolescenza.it COSA VUOL DIRE SCREENING!
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI SCREENING Dott.ssa Isabella Bellagamba Psicologa psicoterapeuta dell età evolutiva isabellabellagamba@libero.it www.psicoterapiainfanziaeadolescenza.it COSA VUOL DIRE SCREENING!
Sviluppo dei prerequisiti dell apprendimento della letto-scrittura dalla scuola dell infanzia alla scuola primaria
 Convegno nazionale PerCorsi e.qercorsi Dai segni predittivi all identificazione precoce dei Disturbi Specifici dell Apprendimento Sviluppo dei prerequisiti dell apprendimento della letto-scrittura dalla
Convegno nazionale PerCorsi e.qercorsi Dai segni predittivi all identificazione precoce dei Disturbi Specifici dell Apprendimento Sviluppo dei prerequisiti dell apprendimento della letto-scrittura dalla
IDENTIFICAZIONE PRECOCE DI BAMBINI CON RITARDO DI LINGUAGGIO
 Milano, 10 Novembre 2011 Corso di Laurea in Logopedia IDENTIFICAZIONE PRECOCE DI BAMBINI CON RITARDO DI LINGUAGGIO PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DELLO SCREENING DEL LINGUAGGIO NELL ASL DELLA PROVINCIA DI
Milano, 10 Novembre 2011 Corso di Laurea in Logopedia IDENTIFICAZIONE PRECOCE DI BAMBINI CON RITARDO DI LINGUAGGIO PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DELLO SCREENING DEL LINGUAGGIO NELL ASL DELLA PROVINCIA DI
Come leggere una diagnosi
 Come leggere una diagnosi Maristella Scorza Università di Modena e Reggio Emilia maristella.scorza@unimore.it Protocollo Diagnostico La segnalazione La raccolta anamnestica La valutazione clinica L interpretazione
Come leggere una diagnosi Maristella Scorza Università di Modena e Reggio Emilia maristella.scorza@unimore.it Protocollo Diagnostico La segnalazione La raccolta anamnestica La valutazione clinica L interpretazione
Problemi aperti nella clinica e nella riabilitazione dei DSA
 Problemi aperti nella clinica e nella riabilitazione dei DSA Roberta Penge Neuropsichiatra Infantile Università di Roma La Sapienza Direttivo Nazionale AID Patogenesi Modelli teorici Prevenzione DSA Riabilitazione
Problemi aperti nella clinica e nella riabilitazione dei DSA Roberta Penge Neuropsichiatra Infantile Università di Roma La Sapienza Direttivo Nazionale AID Patogenesi Modelli teorici Prevenzione DSA Riabilitazione
Uno sguardo verso il futuro. Conferenza locale salute mentale R.Pioli, G.Rossi Brescia
 Uno sguardo verso il futuro Conferenza locale salute mentale R.Pioli, G.Rossi Brescia 10 12 2012 Innovazione strutturale Irccs FBF oggi e domani 2 strutture residenziali (CPA CPM ) inaugurate il 15 12
Uno sguardo verso il futuro Conferenza locale salute mentale R.Pioli, G.Rossi Brescia 10 12 2012 Innovazione strutturale Irccs FBF oggi e domani 2 strutture residenziali (CPA CPM ) inaugurate il 15 12
14 MAGGIO I giornata
 1 14 MAGGIO 2011 - I giornata NEUROPSICOLOGIA DEL DISTURBO DELL APPRENDIMENTO DELLA LETTURA: definire le competenze cognitive per un adeguato apprendimento della lettura utilizzare gli strumenti necessari
1 14 MAGGIO 2011 - I giornata NEUROPSICOLOGIA DEL DISTURBO DELL APPRENDIMENTO DELLA LETTURA: definire le competenze cognitive per un adeguato apprendimento della lettura utilizzare gli strumenti necessari
I Disturbi Specifici di Linguaggio. Percorsi Evolutivi Dei DSL
 I Disturbi Specifici di Linguaggio Percorsi Evolutivi Dei DSL Il motore dell apprendimento linguistico, come acquisizione di un sistema basato su molte competenze, è il seguente: utilizzare come risolutive
I Disturbi Specifici di Linguaggio Percorsi Evolutivi Dei DSL Il motore dell apprendimento linguistico, come acquisizione di un sistema basato su molte competenze, è il seguente: utilizzare come risolutive
Valutazione Neuropsicologica di Pazienti Adolescenti con Epilessia
 Valutazione Neuropsicologica di Pazienti Adolescenti con Epilessia (13-18 anni) Questo protocollo si propone di identificare gli strumenti neuropsicologici piu idonei per la valutazione di adolescenti
Valutazione Neuropsicologica di Pazienti Adolescenti con Epilessia (13-18 anni) Questo protocollo si propone di identificare gli strumenti neuropsicologici piu idonei per la valutazione di adolescenti
Dott.ssa Silvia Re Psicologa Psicoterapeuta SC NPI Cuneo-Mondovì
 Dott.ssa Silvia Re Psicologa Psicoterapeuta SC NPI Cuneo-Mondovì Molte persone hanno memoria buona per certe cose ma meno buona per altre. Un bambino piccolo ha una memoria visiva migliore di quella
Dott.ssa Silvia Re Psicologa Psicoterapeuta SC NPI Cuneo-Mondovì Molte persone hanno memoria buona per certe cose ma meno buona per altre. Un bambino piccolo ha una memoria visiva migliore di quella
I SISTEMI DI LETTURA E LE DISLESSIE
 I SISTEMI DI LETTURA E LE DISLESSIE L alessia senza agrafia -Disturbo di lettura senza altri disturbi concomitanti -I pazienti scrivono senza essere capaci di leggere quello che hanno scritto Interpretazione
I SISTEMI DI LETTURA E LE DISLESSIE L alessia senza agrafia -Disturbo di lettura senza altri disturbi concomitanti -I pazienti scrivono senza essere capaci di leggere quello che hanno scritto Interpretazione
Anna Maria Antonucci AIRIPA Puglia..aiutamia capire!
 .aiutamia capire! In premessa Stasera siamo qui per Anziché considerare il processo con cui si conquista la conoscenza, come un fenomeno isolato che si produce all interno della testa, bisognerebbe vederla
.aiutamia capire! In premessa Stasera siamo qui per Anziché considerare il processo con cui si conquista la conoscenza, come un fenomeno isolato che si produce all interno della testa, bisognerebbe vederla
Effetto della morfologia sull accuratezza in scrittura: uno studio in bambini normolettori e con dislessia
 Effetto della morfologia sull accuratezza in scrittura: uno studio in bambini normolettori e con dislessia Paola Angelelli*, +Chiara Valeria Marinelli e **Cristina Burani *Università del Salento; +Università
Effetto della morfologia sull accuratezza in scrittura: uno studio in bambini normolettori e con dislessia Paola Angelelli*, +Chiara Valeria Marinelli e **Cristina Burani *Università del Salento; +Università
Si può fare qualcosa per la dislessia e la disortografia?
 Si può fare qualcosa per la dislessia e la disortografia? Ci sono molte posizioni a riguardo, alcune eccessivamente ottimistiche, alcune eccessivamente pessimistiche Occorre comunque sfatare alcune idee:
Si può fare qualcosa per la dislessia e la disortografia? Ci sono molte posizioni a riguardo, alcune eccessivamente ottimistiche, alcune eccessivamente pessimistiche Occorre comunque sfatare alcune idee:
La lettura come processo di decodifica. Di Giacomo Dallari
 La lettura come processo di decodifica. Di Giacomo Dallari Leggere significa attivare dei meccanismi molto complessi che richiedono l intervento di una serie di abilità e di processi articolati e cooperativi.
La lettura come processo di decodifica. Di Giacomo Dallari Leggere significa attivare dei meccanismi molto complessi che richiedono l intervento di una serie di abilità e di processi articolati e cooperativi.
FACOLTA DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA. Classe L24 Insegnamento di Psicobiologia SSD M/PSI-02 CFU 9 A.A.
 FACOLTA DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA Classe L24 Insegnamento di Psicobiologia SSD M/PSI-02 CFU 9 A.A. 2014-2015 Docente Prof.ssa Gloria Di Filippo email. gloria.difilippo@unicusano.it
FACOLTA DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA Classe L24 Insegnamento di Psicobiologia SSD M/PSI-02 CFU 9 A.A. 2014-2015 Docente Prof.ssa Gloria Di Filippo email. gloria.difilippo@unicusano.it
ALLEGATO _A5_ Dgr n. del pag. 1/7
 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATO _A5_ Dgr n. del pag. 1/7 OSSERVAZIONI SISTEMATICHE DI RILEVAZIONE PRECOCE E ATTIVITA DI MIRATO (PRIMARIA)- Allegato A5 Le Osservazioni Sistematiche di Rilevazione
giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATO _A5_ Dgr n. del pag. 1/7 OSSERVAZIONI SISTEMATICHE DI RILEVAZIONE PRECOCE E ATTIVITA DI MIRATO (PRIMARIA)- Allegato A5 Le Osservazioni Sistematiche di Rilevazione
Gli strumenti per la valutazione delle abilità di calcolo
 Gli strumenti per la valutazione delle abilità di calcolo Germana Englaro Servizio Disturbi dell Apprendimento 19 Aprile 2008 Gli strumenti di valutazione per i disturbi specifici dell apprendimento Il
Gli strumenti per la valutazione delle abilità di calcolo Germana Englaro Servizio Disturbi dell Apprendimento 19 Aprile 2008 Gli strumenti di valutazione per i disturbi specifici dell apprendimento Il
Neuropsicologia dei disturbi dell apprendimento della scrittura: la valutazione e la riabilitazione
 Neuropsicologia dei disturbi dell apprendimento della scrittura: la valutazione e la riabilitazione Roma 17 18 e 19 aprile 2015 Sede: Villa Eur Parco dei Pini P.le M. Champagnat, 2 Docenti: Giovanni Masciarelli
Neuropsicologia dei disturbi dell apprendimento della scrittura: la valutazione e la riabilitazione Roma 17 18 e 19 aprile 2015 Sede: Villa Eur Parco dei Pini P.le M. Champagnat, 2 Docenti: Giovanni Masciarelli
DISCALCULIA CON E SENZA DISLESSIA: QUALCHE DIFFERENZA?
 v.19/2/10 DISCALCULIA CON E SENZA DISLESSIA: QUALCHE DIFFERENZA? Patrizio E. Tressoldi Dipartimento di Psicologia Generale Università di Padova -LA DISLESSIA PORTA SEMPRE QUALCHE DIFFICOLTA NELLE ABILITA
v.19/2/10 DISCALCULIA CON E SENZA DISLESSIA: QUALCHE DIFFERENZA? Patrizio E. Tressoldi Dipartimento di Psicologia Generale Università di Padova -LA DISLESSIA PORTA SEMPRE QUALCHE DIFFICOLTA NELLE ABILITA
Scuola e Scrittura: è sempre facile imparare? Lavorare sulla scrittura: presentazione di alcuni percorsi
 Scuola e Scrittura: è sempre facile imparare? Giornata di studio Genova, 30 ottobre 2015 Lavorare sulla scrittura: presentazione di alcuni percorsi Emilia Restani (Pedagogista) iltimone@libero.it PRESENTAZIONE
Scuola e Scrittura: è sempre facile imparare? Giornata di studio Genova, 30 ottobre 2015 Lavorare sulla scrittura: presentazione di alcuni percorsi Emilia Restani (Pedagogista) iltimone@libero.it PRESENTAZIONE
 Il bambino bi va stimolato t sulla letto-scrittura, ma solo in situazioni protette che non espongano la sua difficoltà. Esso va altresì agevolato con strumenti compensativi e dispensativi affinché gli
Il bambino bi va stimolato t sulla letto-scrittura, ma solo in situazioni protette che non espongano la sua difficoltà. Esso va altresì agevolato con strumenti compensativi e dispensativi affinché gli
Parte prima. Modelli teorici per la valutazione e l'intervento
 Indice Presentazione 13 di Margherita Orsolini Parte prima. Modelli teorici per la valutazione e l'intervento 1. Le teorie che orientano la valutazione dei disturbi specifici dell'apprendimento 17 di Margherita
Indice Presentazione 13 di Margherita Orsolini Parte prima. Modelli teorici per la valutazione e l'intervento 1. Le teorie che orientano la valutazione dei disturbi specifici dell'apprendimento 17 di Margherita
STRATEGIE DI INTERVENTO SUI DISTURBI DI APPRENDIMENTO NEL TRATTAMENTO INDIVIDUALE E DI GRUPPO
 STRATEGIE DI INTERVENTO SUI DISTURBI DI APPRENDIMENTO NEL TRATTAMENTO INDIVIDUALE E DI GRUPPO PRESENTAZIONE - Titolo: L INTERVENTO RIABILITATIVO: strumenti e strategie d intervento - Date: 28 settembre
STRATEGIE DI INTERVENTO SUI DISTURBI DI APPRENDIMENTO NEL TRATTAMENTO INDIVIDUALE E DI GRUPPO PRESENTAZIONE - Titolo: L INTERVENTO RIABILITATIVO: strumenti e strategie d intervento - Date: 28 settembre
IL MONDO DELLE PAROLE & INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ DI LETTO-SCRITTURA
 IL MONDO DELLE PAROLE & INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ DI LETTO-SCRITTURA Avvio indagine sulle difficoltà di apprendimento (98/99) Presupposti: Aumento esponenziale delle segnalazioni di bambini
IL MONDO DELLE PAROLE & INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ DI LETTO-SCRITTURA Avvio indagine sulle difficoltà di apprendimento (98/99) Presupposti: Aumento esponenziale delle segnalazioni di bambini
Un modello organizzativo autogestito
 26 Marzo 2012 Progetto sperimentale di individuazione precoce dei DSA nella prima classe della Scuola Primaria Un modello organizzativo autogestito Responsabile della formazione: Dott.ssa Barbara Peroni
26 Marzo 2012 Progetto sperimentale di individuazione precoce dei DSA nella prima classe della Scuola Primaria Un modello organizzativo autogestito Responsabile della formazione: Dott.ssa Barbara Peroni
Modelli di riabilitazione lessicali e sublessicali San Marino 2012 Convegno: «Imparare, questo è il problema»
 Modelli di riabilitazione lessicali e sublessicali San Marino 2012 Convegno: «Imparare, questo è il problema» Francesca Scortichini psicologa Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Riabilitazione
Modelli di riabilitazione lessicali e sublessicali San Marino 2012 Convegno: «Imparare, questo è il problema» Francesca Scortichini psicologa Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Riabilitazione
Dalla valutazione al trattamento della dislessia. Lucina Tretti
 Dalla valutazione al trattamento della dislessia Lucina Tretti scopo della pratica clinica è la ricerca della causa (l identificazione) di un disturbo e dei mezzi per risolverlo La realizzazione di un
Dalla valutazione al trattamento della dislessia Lucina Tretti scopo della pratica clinica è la ricerca della causa (l identificazione) di un disturbo e dei mezzi per risolverlo La realizzazione di un
STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE PER FAVORIRE L APPRENDIMENTO STRUMENTALE DELLA SCRITTURA E LETTURA
 STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE PER FAVORIRE L APPRENDIMENTO STRUMENTALE DELLA SCRITTURA E LETTURA Luciana Ventriglia Specializzata in Pedagogia clinica. Perfezionamento sul lavoro clinico nelle difficoltà
STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE PER FAVORIRE L APPRENDIMENTO STRUMENTALE DELLA SCRITTURA E LETTURA Luciana Ventriglia Specializzata in Pedagogia clinica. Perfezionamento sul lavoro clinico nelle difficoltà
DISTIURBI SPECIFICI DELL APPRENDIMENTO DSA. Dott.sa Pastena Nicolina Università Salerno
 DISTIURBI SPECIFICI DELL APPRENDIMENTO DSA 1 DISTURBI SPECIFICI DELL APPRENDIMENTO (DSA) Sono disturbi funzionali che derivano da una peculiare architettura neuropsicologica del soggetto. Provocano difficoltà
DISTIURBI SPECIFICI DELL APPRENDIMENTO DSA 1 DISTURBI SPECIFICI DELL APPRENDIMENTO (DSA) Sono disturbi funzionali che derivano da una peculiare architettura neuropsicologica del soggetto. Provocano difficoltà
