I verbi deboli. 1. Le classi dei verbi deboli
|
|
|
- Daniele Valente
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 I verbi deboli I verbi deboli rappresentano un innovazione del germ., costituiscono cioè una classe morfologica del tutto nuova rispetto all ie. Si tratta in genere di formazioni secondarie, ovvero derivate da nomi e aggettivi (denominativi) oppure da altri verbi (deverbativi, come germ. *sat-ja-n(an) sedersi, porre derivato da *set-ja-n(an) essere seduto, vb. ft. di V classe). Si rilevano tuttavia alcuni verbi primari, come il germ. *sōk-ja-n(an) cercare. La coniugazione nell intero paradigma dei verbi deboli avviene attraverso suffissazione: si distinguono così, diverse classi, ciascuna caratterizzata da un diverso suffisso, cui si aggiungono poi le desinenze delle varie persone. In base al formante si distinguono nelle lingue germaniche antiche tre classi di verbi deboli; una quarta classe è attestata solo per il gotico. A differenza dei verbi forti, che differenziano i tempi principali tramite il ricorso all apofonia, nei verbi deboli la vocale radicale resta invariata in tutto il paradigma. Per formare il preterito ed il participio passato i verbi deboli aggiungono un suffisso in dentale al tema (= radice+vocale tematica) del presente. Tale suffisso è ancora ben conservato nelle lingue moderne, si vedano ad esempio i verbi deboli del tedesco oppure i verbi regolari dell inglese. 1. Le classi dei verbi deboli I Classe debole - suffisso in *-ja- (< ie. ỊO) Il contrassegno è una /i/ oppure una /j/ (all infinito -*jan, da cui ags. -an, aat. -en, as. -ian) derivato da ie. /EI/, germ. */ij/> /i/, /j/ che segue la vocale tematica (unitiva) al presente. Si tratta di verbi in origine causativi, derivati da verbi forti, oppure di fattitivi derivati da aggettivi; alcuni verbi presentano anche alternanza grammaticale, in quanto in origine l accento cadeva sul suffisso, come nel caso di germ. *naz-ja-n: germ. *naz-ja-n(an) <*nes-an(an) GOT. nasjan <ga-nisan AGS. nerian <nesan AS. nerian <nesan AAT. ner(r)en <gi-nesan I verbi deboli Lezioni prof.ssa C. Sipione
2 Un esempio di causativo è il già citato verbo germ. sat-ja-n, got. satjan, an. setia, ags. settan, aat. sezzen porre, collare derivato dal vb. ft. di V classe germ. *set-ja-n, got. sitan, an. sitia, ags. sittan, aat. sizzen, as. sittian stare seduto. Nei causativi la radice presenta la vocale /a/ che ricorre al pret. sg. del vb. forte. Il suffisso */ja/ del presente/infinito provoca metafonia palatale della vocale radicale in an. e in germ. occ. e geminazione consonantica nel germ. occ. La geminata è soggetta poi alla II mutazione consonantica in aat. germ. *sat-ja-n(an) sedersi, porre <*set-ja-n(an) essere seduto GOT. sat-jan <sitan AN. setia <sitia AGS. settan <sittan AS. settian <sittian AAT. sezzen <sizzen Un esempio di verbo fattitivo è germ. *hail-ja-n(an), got. hailjan, an. heilia, ags. hǣlan, aat. heilen guarire derivato dall agg. germ. *hailaz sano. germ. *hail-ja-n(an) guarire <*hail-az sano GOT. hailjan < hails AN. heila < heill AGS. hǣlan < hāl AS. hēlian < hēl AAT. heilen < heil I verbi deboli Lezioni prof.ssa C. Sipione
3 II Classe debole - suffisso in */ō/ (< ie. Ā); questo suffisso può trovarsi ampliato in germ. */ōja/ <ie. ĀỊO (ad esempio in alcune forme del presente in ags.); si tratta di verbi in origine con significato intensivo o iterativo, derivati da altre radici verbali o nominali. In questa classe potevano trovarsi verbi con coniugazione atematica al presente. Un esempio di verbo denominativo è il germ. salƀōn(an) derivato dal sost. germ. *salƀō- unguento. germ. *salƀōn(an) ungere <*salƀōn unguento GOT. salbōn < salbōns AN. (kalla) AGS. sealfian < sealf(e) (-ōjan> ējan> ijan> ian) AS. salƀōn < salƀa AAT. salbōn < salba Un esempio di deverbativo è il verbo germ. *hwarƀ-ō-n(an) mutare, cambiare derivato dal vb. ft. di III classe germ. *hwerfan(an), got. aírban, an. hverfa, ags. hweorfan, as. hwerƀan, aat. hwerban, werfan girarsi. germ. *hwarƀ-ō-n(an) girare, rotolare <*hwerf-an(an) mutare GOT. aírb-ōn < aírb-an AN. hvarfa <hverfa AGS. hwearfian <hweorfan AS. gi-hwerƀian <hverƀan AAT. (hwerben) <hwerban, werfan girarsi I verbi deboli Lezioni prof.ssa C. Sipione
4 III Classe debole - suffisso in */ē/ (ie. -ĒI-/ -Ē-); si tratta di verbi che avevano significato durativo/stativo. Anche in questo caso i verbi possono essere deverbativi o denominativi. Il suffisso si conserva in aat. e compare sempre come /ē/, mentre in got. appare indebolito ad /ai/, /a/. In ags. e in as. in questa classe sono rimasti pochi verbi poiché si sono verificati passaggi alle altre classi (I e II) e influssi analogici da parte di altri tipi di coniugazioni. Così in ags. la presenza del suffisso /ja/ ha dato luogo a terminazioni analoghe ai verbi di I classe. In ags. questa classe è rappresentata da cinque verbi, e in as. da tre verbi. La varie persone del presente in ags. e in as. vengono formate secondo la I o la II classe oppure presentano forme atematiche. In an. si hanno formazioni analogiche alla II classe, poiché l originario suffisso /ai/> /ē/> /ĕ/ in sillaba finale oppure cade per sincope. germ. *haƀ-ē-(ja)-n GOT. haban AN. hafa AGS. habban AS. hebbian AAT. habēn germ. *þag-ē-n(an) tacere cfr. lat. tac-ē-re GOT. þahan AN. þegja AGS AS. thagian (I cl.) thagōn (II cl.) AAT. dagēn I verbi deboli Lezioni prof.ssa C. Sipione
5 In ags. sono rimasti in questa classe i seguenti verbi: habban, avere libban vivere hycgean pensare secgean dire fēogan odiare In as. si trovano ancora nella III classe: hebbian seggian libbian -huggian IV Classe debole - suffisso germ. *-na- /*-no- (<ie. NƎ- /-NĀ); si tratta di verbi in origine intransitivo-incoativi; tale classe è produttiva solo in got., e presenta alcuni relitti in an.; mentre negli altri dialetti i verbi relativi sono passati alle altre classi. Questi verbi non hanno part. pass. germ. *full-na-n riempirsi < *fullaz pieno GOT. full-na-n full-nō-da AN. fullna AGS. fyllan (I cl.) AS. fullian (I cl.) AAT. fullen (I cl.) Per l an. si vedano le coppie minime an. vak-na svegliarsi (incoativo) - vak-a essere sveglio, an. sof-na addormentarsi - sof-a dormire. Per il got. si confrontino hailn-an guarire (intrans.) e hail-ja-n guarire (trans., causativo). I verbi deboli Lezioni prof.ssa C. Sipione
6 2. Il preterito dei verbi deboli Il preterito dei verbi deboli si forma mediante suffissazione: si tratta di un innovazione del germanico. Il suffisso in dentale utilizzato, il germ. -đē / -đō risale probabilmente alle forme del perfetto del tema ie. DHĒ-/ DHŌ- fare (cfr. gr. t qhmi, scr. dá-dhā-mi pongo, lat. fē-ci). Il medesimo tipo di formazione si riscontra anche nel part. passato, dove ricorre ugualmente un suffisso in dentale (cfr. sotto cap. 3 e schemi di questo cap.). Questo suffisso poteva essere aggiunto alla radice verbale con e senza raddoppiamento; ad esso poi venivano apposte le desinenze personali (ie. -M, -S, -T, -NT). In got. le forme senza raddoppiamento caratterizzano il singolare, mentre al plurale (e al duale) si trovano quelle con raddoppiamento. Negli altri dialetti questa distinzione non esiste più: le forme con raddoppiamento sono scomparse e il plurale viene formato analogamente al singolare, cioè privo di raddoppiamento. Le desinenze per il sg. e il pl. sono le seguenti: LE DESINENZE DEL PRETERITO DEBOLE SINGOLARE PLURALE GERM. *-đō(n); *-đēs; *đē(þ) *-đum(i); -*đuþ(i); -*đun(þ) GOT. -da; -dēs; -da -dēdum; - dēduþ; dēdun AN. -þa (đa); -þer; -þe -þom/-þum; -þoþ; -þo AGS. -de; -des(t); -de -don AAT. -ta; tōs; -ta -tum; -tut; -tun AS. -da; -dos; -da -dun ESEMPI DI FORMAZIONE DEL PRETERITO DEBOLE (I CLASSE) germ. *naz-ja-n(an) < *nes-an(an) germ. tal-ja-n(an) INFINITO PRETERITO SG. PARTICIPIO GOT. nasjan nas-i-da nas-i-þs AN. telia <*tal-ja-n(an) tal-þa tal-(e)-þ-r AGS. nerian ner-e-de gener-e-d AS. nerian ner--ida giner-i-d AAT. ner(r)-en ner-i-ta gi-ner-i-t I verbi deboli Lezioni prof.ssa C. Sipione
7 L origine del suffisso in dentale -đē/-đō è incerta. Sono state avanzate varie ipotesi circa l origine di questo suffisso e di questa formazione. 1. Alcuni studiosi, basandosi soprattutto sulle forme a raddoppiamento del gotico, hanno proposto una teoria perifrastica, secondo cui al tema del verbo principale sarebbe stata aggiunto il preterito del verbo per fare, diventare ; tale verbo mostra infatti raddoppiamento della radice ie. DHĒ/- DHŌ al pret., come in ags. dōn - pret. dyde, dydon aat. tuon - pret. teta, tātum. Si sarebbe trattato in origine di forme analitiche, in cui alla radice del verbo sarebbe stata suffissa, secondo un procedimento di agglutinazione, la base ie. DHĒ - DHŌ; tali forme sarebbero poi diventate sintetiche a seguito di un processo di grammaticalizzazione, analogo a quanto è attestato, per altre lingue ie. in epoca storica; si vedano, ad esempio: lat. amā-bam < rad. -BHŪ essere, scr. dātāsmi donerò < dātā asmi sono un donatore, it. darò, canterò <dare habēo, cantāre habēo, queste forme, in origine analitiche, erano caratterizzate da una coniugazione perifrastica, e sono divenute poi nuovamente sintetiche per un processo di agglutinazione 1. Questa teoria, anche se controversa e non sempre convincente, resta quella più accreditata (Streitberg 2, Fourquet 3, Bammesberger 4, Tops 5 ); studi tipologici ne sembrano confermare la validità (Lahiri 6, Kiparsky 7 ). Secondo P. Ramat, ad esempio, le forme a raddoppiamento del got. sarebbero un innovazione di questo ramo linguistico e non una caratteristica ereditata dall ie. 8 Resta tuttavia il fatto che la radice radice ie. DHĒ - DHŌ non risulta attestata in tutto il germ., essendo sconosciuta sia al got. che all an. 2. Quest ultima circostanza avrebbe indotto alcuni studiosi a formulare una teoria per analogia sulla formazione del preterito in dentale. Il suffisso in dentale deriverebbe così da forme participiali con il formante ie. -TO> germ. *-đa, cui sarebbero state aggiunte desinenze 1 Cfr. P. Ramat, Introduzione alla linguistica germanica, Bologna , p. 208, n Cfr. W. Streitberg; Urgermanische Grammatik, Heidelberg Cfr. J. Fourquet, Ags. eode, dyde et la théorie du préterit faible, in: A Philological Miscellany presented to E, Eckwall, Studia Neophilologica 14 (1941), pp Cfr. A. Bammesberger, Der Aufbau des germanischen Verbalsystems, Heidelberg Cfr. G. A. J. Tops, The Origin of Germanic Dental Preterite. A Critical Research History since 1902, Leiden Cfr. A. Lahiri, Analogy, Levelling, Markedness: Principles of Change in Morphology and Phonology, Berlin Cfr. P. Kiparsky, The Germanic Weak Preterite, 2003; 8 Cfr. Ramat, Introduzione alla linguistica germanica, Bologna , p. 208, n. 38. I verbi deboli Lezioni prof.ssa C. Sipione
8 secondarie di preterito (Rauch 9 ), oppure da originarie forme di aoristo di II sg., estesesi poi a tutto il paradigma (Lehmann 10, Jasanoff 11 ). 3. Altri studiosi infine, dal momento che il suffisso in dentale che entra nella formazione del pret. debole può presentarsi sotto forme diverse (ad es. in got. /d/, /t/, /s/) rinunciano a ricostruire un unica origine e ipotizzano una cronologia ed una provenienza differente a seconda del tipo di verbo. Infatti anche il verbo volere e i preterito-presenti presentano di formazioni analoghe a quelli dei verbi deboli. In particolare, alcune forme di preterito debole con Rückumlaut (del tipo got. brāhta oppure þāhta) 12 e il pret. dei verbi preterito-presenti non possono senz altro essere ricondotti all ipotesi di un origine perifrastica. 4. Così A. Bammerberger cerca di risolvere queste difficoltà, distinguendo diversi casi: il pret. dei preterito-presenti, che rappresenterebbe un tipo arcaico, quello dei verbi con Rückumlaut, e il pret. dei verbi deboli delle quattro classi, che sarebbe un tipo di formazione più recente. Per i verbi preterito-presenti Bammesberger ipotizza l origine in una forma di II pl. del perfetto o dell aoristo: tra la radice e il suffisso di questi verbi non compare infatti mai, sin dalla loro origine, la vocale tematica. Anche per i verbi con Rückumlaut A. Bammesberger ipotizza una provenienza analoga. La formazione del pret. di questi verbi potrebbe essere fatta risalire al perfetto ie. e per essi viene ricostruito un suffisso germ. *-t(o)- che non può essere spiegato a partire da un formante ie. - DHĒ. Infine, secondo lo studioso è sostenibile l origine per i verbi deboli di I e II classe da una formazione perifrastica, mentre i verbi di III classe pongono maggiori difficoltà. Per quest ultima classe, inoltre, il got. e l aat. presentano formazioni diverse rispetto al gruppo ingevone, spiegabili solo sulla base dell alternanza della vocale tematica, che nelle prime due lingue è lunga, rispetto al grado zero delle altre. 9 I. Rauch, The Germanic Dental Preterite, Language Origin and Linguistics Attitude, Indogermanische Forschungen 77 (1972), pp Si tratterebbe secondo Ramat, di nomi verbali suffissati con l ausilio delle desinenze secondarie già viste; cfr. Ramat, nota prec. 10 W. P. Lehmann, The Germanic Weak Preterite Verbs, Language 19 (1943), pp Jay. H. Jasanoff, OS habda and the Gmc. Weak Preterite, in: Indo-European Studies, Cambridge 1972, pp ; id., The Gmc. Third Weak Class, Language 49 (1973), pp ; di recente è apparso: id., Hittite and the Indo-European Verb, Oxford University Press 2005, ISBN X, , 270 pp. 12 Cfr. sotto cap I verbi deboli Lezioni prof.ssa C. Sipione
9 ALTRI ESEMPI DI FORMAZIONE DEL PRETERITO DEBOLE - I CLASSE germ. *hail-ja-n(an) <*hail-az INFINITO PRETERITO SG. PARTICIPIO GOT. hailjan hail-i-da hail-i-þs AN. heila heilþa heilþr AGS. hǣlan hǣl-de gehǣl-e-d AS. hēlian helda (gihēlid) AAT. heilen heil-ta gi-heil-i-t germ. *sat-ja-n(an) sedersi, porre <*set-ja-n(an) essere seduto INFINITO PRETERITO SG. PARTICIPIO GOT. sat-jan sat-i-da sat-i-þs AN. setia setta settr AGS. settan sette ge-sett AS. settian satta/setta AAT. sezzen sazta gisezzit ALTRI ESEMPI DI FORMAZIONE DEL PRETERITO DEBOLE - II CLASSE germ. *salƀōn(an) ungere <*salƀōn unguento INFINITO PRETERITO SG. PARTICIPIO GOT. salbōn salb-ō-da salb-ō-þs AN. kalla kallaþa kallaþr AGS. sealfian sealfode gesealfod AS. salƀōn AAT. salbōn salbōta gisalbōt I verbi deboli Lezioni prof.ssa C. Sipione
10 germ. hwarƀ-ō-n(an) girare, rotolare INFINITO PRETERITO SG. PARTICIPIO GOT. aírb-ōn arb -ō-da arb -ō-þs AN. hvarfa AGS. hwearfian hwearfode hwearfod AS. gi-hwerƀian AAT. (hwerben) ALTRI ESEMPI DI FORMAZIONE DEL PRETERITO DEBOLE - III CLASSE germ. *haƀ-ē-(ja)-n INFINITO PRETERITO SG. PARTICIPIO GOT. haban hab-ai-da hab-ai-þ-s AN. hafa haf-þa haf-a-þ-r AGS. habban hæf-de hæf-d AS. hebbian habda (behabd) AAT. habēn hab-ē-ta gi-hab-ē-t germ. *þag-ē-n(an) tacere cfr. lat. tac-ē-re INFINITO PRETERITO SG. PARTICIPIO GOT. þahan þah-ai-da hab-ai-þ-s AN. þegja þag-þa þag-þr AGS AS. thagian (I cl.) thagōn (II cl.) thagōda AAT. dagēn dag-ē-ta gi-dag-ē-t I verbi deboli Lezioni prof.ssa C. Sipione
11 3. Il participio passato dei verbi deboli Il suffisso del participio preterito dei verbi deboli in germ. risale al suffisso ie. -TÓS > germ. *-đaz: GERM. -đaz GOT. -þs AN. -þr (-đr) AGS. -d AAT. -t AS. -d da cfr. con il lat. ama-tus, nō-tus, gr. dò-toj. Per gli esempi relativi alle varie classi, vedi gli schemi precedenti. I verbi deboli Lezioni prof.ssa C. Sipione
12 4. Formazione del preterito e del participio dei verbi deboli di I classe In base alla formazione del preterito e del participio preterito i verbi deboli di I classe possono essere distinti in due gruppi: 1) verbi con sillaba radicale breve; 2) verbi con sillaba radicale lunga; Mentre in got. non si rileva, al preterito, alcuna differenza tra l uno e l altro gruppo, tale differenza si nota invece negli altri dialetti germanici. Vediamo più da vicino le modalità di formazione del preterito nelle singole lingue. In got. sia l uno che l altro gruppo (che si differenziano al presente) formano preterito e part. pass. tramite la vocale unitiva (tematica) /i/ cui si aggiungono i suffissi -da, ecc. e -þs. In an. la vocale tematica è scomparsa, sia nei verbi a sillaba radicale lunga che in quelli a sillaba radicale breve; tuttavia, mentre in questi ultimi (radicale breve), la vocale radicale non subisce metafonia, in quelli a radicale lunga avviene metafonia ad opera della vocale tematica /i/ (cfr. an. talþa vs. heyrþa). In ags. i verbi con radicale breve mantengono la vocale tematica /e/ (</i/) al pret. e al part. pass.; la vocale della sillaba radicale subisce metafonia (ags. fremman, fremede <*fram-jan, *fram-ideþ). Nei verbi a sillaba radicale lunga la vocale tematica è soggetta a sincope al pret., mentre al part. pass., nelle forme non declinate si conserva; cade invece nelle forme declinate. La vocale radicale subisce comunque metafonia: dēman - dēmde - gedēmed < *dōm-jan. I verbi a sillaba radicale lunga non presentano geminazione al presente e all infinito. In aat., nei verbi a sillaba radicale breve, la vocale tematica si mantiene e provoca metafonia (soltanto in caso di /a/ nel periodo aat.); nei verbi con radicale lunga al pret. cade e la vocale radicale non subisce metafonia; al part. pass. /i/ è soggetta sincope solo nelle forme declinate, e resta, invece, nelle forme non declinate. Anche in aat. i verbi a sillaba radicale originariamente lunga non presentano geminazione al presente e all infinito. In as. il pret. dei verbi a sillaba radicale breve è formato con aggiunta di vocale tematica alla desinenza -da, -d; mentre i verbi a sillaba radicale lunga sono privi al pret. di vocale tematica, che si propone invece al part. pass. Si rilevano numerose nuove formazione analogiche che presentano vocale tematica. I verbi deboli Lezioni prof.ssa C. Sipione
13 ESEMPIO DI CONIUGAZIONE DI PRETERITO (SILLABA RADICALE BREVE) Verbi: got. nasian sanare, salvare, an. telia (germ. *tal-jan) dire, ags. fremman compiere, as. fremmian compiere (germ. *framjan), aat. frummen favorire (germ. *frum-jan). GERM. GOT. AN AGS. AAT. AS. I SG. *-đō(m) nas-i-da tal-þa frem-e-de frum-i-ta frem-i-da II SG. *-đēs nas-i-dēs tal-þer frem-e-des(t) frum-i-tōs frem-i-des III SG. *-đē(þ) nas-i-da tal-þe frem-e-de frum-i-ta frem-i-da I Duale *-đu(n) nas-i-dēdu II Duale *-đuþ(i)z nas-i-dēduts I PL. *-đum(i) nas-i-dēdum tǫl-þom frem-e-don frum-i-tum frem-i-dun II PL. *-đuþ(i) nas-i-duduþ tǫl-þoþ frem-e-don frum-i-tut frem-i-dun III PL. *đun(þ) nas-i-dēdun tǫl-þo frem-e-don frum-i-tun frem-i-dun ESEMPIO DI CONIUGAZIONE DI PRETERITO (SILLABA RADICALE LUNGA) Verbi: got. hausian, an. heyra, as. hōrian ascoltare (germ. *hauz-jan), ags. dǣlan, aat. teilen (germ. *dail-jan) dividere. GERM. GOT. AN AGS. AAT. AS. I SG. *-đō(m) haus-ida heyr-þa dǣl-de teil-ta hōr-da II SG. *-đēs haus-idēs heyr-þer dǣl-des(t) teil-tōs hōr -des III SG. *-đē(þ) haus-i-da heyr-þe dǣl-de teil-ta hōr-da I Duale *-đu(n) haus-i-dēdu II Duale *-đuþ(i)z haus-dēduts I PL. *-đum(i) haus-i-dēdum heyr-þom dǣl-don teil-tum hōr-dun II PL. *-đuþ(i) haus-i-duduþ heyr-þoþ dǣl-don teil-tut hōr-dun III PL. *đun(þ) haus-i-dēdun heyr-þo dǣl-don teil-tun hōr-dun I verbi deboli Lezioni prof.ssa C. Sipione
14 ESEMPIO DI CONIUGAZIONE DI PARTICIPIO GERM. -đaz RADICALE BREVE GOT. -þs nasiþs hausiþs RADICALE LUNGA AN. -þr (-đr) talþr heyrþr AGS. -d ge-frem-ed ge-dǣl-ed AAT. -t ge-frum-it gi-teil-it AS. -d gi-frem-id gi-hōr-id I verbi deboli Lezioni prof.ssa C. Sipione
15 4.1 Particolarità dei verbi deboli di I classe Alcuni verbi deboli di I classe formavano il pret. e il part. pass. già nel protogermanico senza l ausilio della vocale unitiva (tematica). In sostanza, alla radice verbale si univa direttamente il suffisso privo di vocale tematica. Questi verbi presentano metafonia palatale al presente, dovuta al suffisso contenente /j/, ma non al preterito e al part. pass. dove manca sin dall inizio la vocale tematica /i/. Tali verbi vennero definiti da J. Grimm come verbi deboli con Rückumlaut, cioè verbi con Umlaut all indietro. Si tratta di verbi la cui radice terminava in velare, come ad esempio: INFINITO PRETERITO SG. PARTICIPIO GERM. *wurk-ja-n(an) fare *wurk-(i)đō(n)> *wurk-tō> *wurk-taz *wurhtō GOT. wáurkjan wáurhta wáurhts AN. yrkia orkta orktr AGS. wyrcean worhte geworht AAT wurchen /wurken worhta giworht /wirkian AS. wirkian warhta giwarht INFINITO PRETERITO SG. PARTICIPIO GERM. *þank-ja-n(an) *þank-(i)đō(n)> *þank-tō> *þank-taz ecc. pensare *þāh-tō? GOT. þagkjan þāhta -þāhts AN. þekkia þátta þáttr AGS. dencean þōhte geþōht AAT denken dāhta gidāht AS. thenkian thāhta I verbi deboli Lezioni prof.ssa C. Sipione
16 INFINITO PRETERITO SG. PARTICIPIO GERM. *sōk-ja-n(an) cercare *sōk-(i)đō(n)> *sōk-tō> *sōh-tō? *sōk-taz ecc. GOT. sōkjan (sōkita) (sōkiþs) AN. sǿkia sótta sóttr AGS. sêcean sōhte gesōht AAT suohhen suohta gisuohhit AS. sōkian sōhta gisōht IPOTESI SULLA FORMAZIONE DI QUESTO TIPO DI PRETERITO Si è già detto del dibattito intorno alla formazione di questo tipo di verbi. Adesso si esporranno, in maniera schematica, alcune delle teorie più comuni. A) Se si suppone una formazione analoga a quella degli altri verbi deboli di I classe, bisogna ipotizzare che all origine del pret. sia il suffisso germ. *đō(n)/*đē che, già nel germ., si sarebbe unito alla radice verbale senza vocale tematica; in questo modo il pret. di questi verbi avrebbe subito una complessa serie di fenomeni di assimilazione e di trasformazioni, secondo lo schema seguente: 1) þank-(i)-đō(n) > 2) þank-tō > 3) þanh-tō > 4) þāhtō 1) la caduta o la mancanza della vocale unitiva porta a contatto la consonante (/k/) che chiude la radice con la fricativa del suffisso, 2) si verifica assimilazione del tratto sordo alla dentale del suffisso (/đ, d/> /t/) per via dell occlusiva /k/; 3) si ha fricativizzazione di /k/> /h/ [c] per la I mutazione consonantica; 4) si verifica la caduta della nasale dinanzi fricativa velare /h/[c], con allungamento compensatorio della vocale che la precede; in ags. þōhte il timbro velare della vocale è dovuto al fatto che la nasale, prima di cadere ha oscurato l originaria /a/ (isoglossa ingevone). In an. si hanno invece esiti per assimilazione sia al pret. che al part. pass. I verbi deboli Lezioni prof.ssa C. Sipione
17 B) La seconda ipotesi invece prevede un numero minore di fenomeni e di passaggi e fa derivare questi preteriti da forme in cui era presente un suffisso ie. -TOS, tipico dei participi; tale suffisso si sarebbe unito direttamente alla radice uscente in velare, che sarebbe divenuta fricativa secondo la I mutazione germanica; sarebbero poi avvenuti i fenomeni successivi, che conosciamo già, relativi alla caduta della velare e all allungamento della vocale radicale: *þank-tō(s) > *þanh-tō > *þāhtō 4.2 Particolarità dell anglosassone 1) Oltre ai verbi uscenti in velare (/h/, /ǥ/), in ags. anche i verbi uscenti in /l/ (come germ. tal-jan > ags. tellan narrare ) formavano il pret. senza vocale tematica; tali verbi in ags. non presentano metafonia al preterito, ma essendo la vocale radicale seguita da /l+cons./ (d-e) subiscono frattura. Il medesimo fenomeno si verifica al part. pass. GERM. *tal-ja-n(an) narrare *sal-ja-n(an) dare, vendere AGS. tellan tealde geteald AGS. sellan sealde geseald 2) I verbi uscenti in /t/, /d/ presentano sincope della vocale tematica e assimilazione della consonante del suffisso del pret. e del part. pass.: GERM. *sat-ja-n(an) porre, collocare AGS. settan sette (<set-de) gesett (<ge-set-d) I verbi deboli Lezioni prof.ssa C. Sipione
18 5. Formazione del preterito e del participio passato dei verbi deboli di II classe I verbi deboli di II classe formano preterito e participio preterito aggiungendo il solito suffisso in dentale. La vocale tematica (germ. /ō/, got. /ō/, an. /a/, ags. /o/, aat. /ō/, as. /o/) si mantiene durante tutta la coniugazione. ESEMPIO DI CONIUGAZIONE DI PRETERITO got. salbōn ungere, an. kalla chiamare, ags. sealfian, aat. salbōn, as. salƀon ungere GERM. GOT. AN AGS. AAT. AS. I SG. *-đō(m) salb-ō-da kall-a-þa sealf-o-de salb-ō-ta salƀ-o-da II SG. *-đēs salb-ō-dēs kall-a-þer sealf-o-des(t) salb-ō-tōs salƀ-o-dos III SG. *-đē(þ) salb-ō-da kall-a-þe sealf-o-de salb-ō-ta salƀ-o-da I Duale *-đu(n) salb-ō-dēdu II Duale *-đuþ(i)z salb-ō-dēduts I PL. *-đum(i) salb-ō-dēdum kǫll-u-þom sealf-o-don salb-ō-tum salƀ-o-dun II PL. *-đuþ(i) salb-ō-duduþ kǫll-u-þoþ sealf-o-don salb-ō-tut salƀ-o-dun III PL. *đun(þ) salb-ō-dēdun kǫll-u-þo sealf-o-don salb-ō-tun salƀ-o-dun ESEMPIO DI CONIUGAZIONE DI PARTICIPIO GERM. -đaz GOT. -þs salb-ō-þs AN. -þr (-đr) kall-a-þr AGS. -d sealf-o-d AAT. -t gi-salb-ō-t AS. -d gi- salƀ-od I verbi deboli Lezioni prof.ssa C. Sipione
19 6. Formazione del preterito e del participio passato dei verbi deboli di III classe Nella formazione del preterito e del part. passato dei verbi deboli di III classe i vari dialetti germanici si differenziano notevolmente. In got. si ha la solita formazione mediante vocale tematica /ai/ e suffisso (-da, -þs). In an. si ha il suffisso -þa, -þr, ma la vocale tematica /a/ (proto nord. /ē/ < germ. /ai/) al pret. è soggetta a sincope, mentre al part. pass. di solito resta; alcuni verbi però presentano anche in questo caso sincope come al pret. In ags. i pochi resti di questa classe formano il pret. e il part. pass. senza vocale tematica, aggiungendo direttamente il suffisso -de, -d alla radice verbale. In aat. si ha sempre la vocale tematica /ē/ che si aggiunge al suffisso -ta, -t. In as. le poche forme attestate sono sempre prive di vocale tematica. In ags. appartengono a questa classe i seguenti verbi: habban - hæfde - gehæfd avere libban - lifde - gelifd vivere hycgean - hogde - gehogod pensare secgean sægde - gesægd fēogan odiare dire In as. si trovano ancora nella III classe: hebbian - habda - (behabd) seggian - sagda - gisagd libbian - libdun - gilibd -huggian - -hogda- I verbi deboli Lezioni prof.ssa C. Sipione
20 ESEMPIO DI CONIUGAZIONE DI PRETERITO got. haban avere, an. hafa, ags. habban, aat. habēn, as. hebbian GERM. GOT. AN AGS. AAT. AS. I SG. *-đō(m) hab-ai-da haf-þa hæf-de hab-ē-ta haƀ-da /habda II SG. *-đēs hab-ai-dēs haf-þer hæf-des(t) hab-ē-tōs haƀ-dos III SG. *-đē(þ) hab-ai-da haf-þe hæf-de hab-ē-ta haƀ-da /habda I Duale *-đu(n) hab-ai-dēdu II Duale *-đuþ(i)z hab-ai-dēduts I PL. *-đum(i) hab-aidēdum hǫf-þom hæf-don hab-ē-tum haƀ-dun II PL. *-đuþ(i) hab-ai-duduþ hǫf-þoþ hæf-don hab-ē-tut haƀ-dun III PL. *đun(þ) hab-ai-dēdun hǫf-þo hæf-don hab-ē-tun haƀ-dun ESEMPIO DI CONIUGAZIONE DI PARTICIPIO GERM. -đaz GOT. -þs habai-þs AN. -þr (-đr) haf-þr /hafat AGS. -d ge-hæf-d AAT. -t gi-hab-ē-t AS. -d gi- hafd I verbi deboli Lezioni prof.ssa C. Sipione
21 TABELLA SINOTTICA DI CONIUGAZIONE DEL PRETERITO DI I CLASSE GERM. GOT. AN AGS. (RADICE AGS. AAT. AAT. AS. BREVE) (RADICE LUNGA) (RADICE BREVE) (RADICE LUNGA) I SG. *-đō(m) nas-i-da tal-þa ner-e-de dēm-de ner-i-ta hōr-ta ner-i-da II SG. *-đēs nas-i-dēs tal-þer ner-e-des(t) dēm-des(t) ner-i-tōs hōr-tōs ner-i-des III SG. *-đē(þ) nas-i-da tal-þe ner-e-de dēm-de ner-i-ta hōr-ta ner-i-da I Duale *-đu(n) nas-i-dēdu II Duale *-đuþ(i)z nas-i-dēduts I PL. *-đum(i) nas-i-dēdum tǫl-þom ner-e-don dēm-don ner-i-tum hōr-tum ner-i-dun II PL. *-đuþ(i) nas-i-duduþ tǫl-þoþ ner-e-don dēm-don ner-i-tut hōr-tut ner-i-dun III PL. *đun(þ) nas-i-dēdun tǫl-þo ner-e-don dēm-don ner-i-tun hōr-tun ner-i-dun I verbi deboli Lezioni prof.ssa C. Sipione
INTRODUZIONE: IL GERMANICO E LE LINGUE GERMANICHE
 INDICE Premessa... XIII Abbreviazioni... XV INTRODUZIONE: IL GERMANICO E LE LINGUE GERMANICHE 1. Le lingue germaniche... 3 1.1 Le lingue germaniche moderne... 3 1.2 Le lingue germaniche antiche e la loro
INDICE Premessa... XIII Abbreviazioni... XV INTRODUZIONE: IL GERMANICO E LE LINGUE GERMANICHE 1. Le lingue germaniche... 3 1.1 Le lingue germaniche moderne... 3 1.2 Le lingue germaniche antiche e la loro
Lingua tedesca I 2016/2017: AUSILIARI E PRESENTE INDICATIVO. Laura A. Colaci
 Lingua tedesca I 2016/2017: IL VERBO: AUSILIARI E PRESENTE INDICATIVO Laura A. Colaci La classe del verbo è unaclasse morfologica aperta, nella quale vengono inserite sempre nuove parole. Basti pensare
Lingua tedesca I 2016/2017: IL VERBO: AUSILIARI E PRESENTE INDICATIVO Laura A. Colaci La classe del verbo è unaclasse morfologica aperta, nella quale vengono inserite sempre nuove parole. Basti pensare
PARTE PRIMA - FONETICA
 Sommario PARTE PRIMA - FONETICA 1. Scrittura e pronuncia 3 1.1. Introduzione 3 1.2. L alfabeto: i segni grafici 6 1.2.1. La pronuncia del greco e la fonetica 7 1.2.2. Spiriti 10 1.2.3. Segni d interpunzione
Sommario PARTE PRIMA - FONETICA 1. Scrittura e pronuncia 3 1.1. Introduzione 3 1.2. L alfabeto: i segni grafici 6 1.2.1. La pronuncia del greco e la fonetica 7 1.2.2. Spiriti 10 1.2.3. Segni d interpunzione
STORIA DELLA LINGUA TEDESCA
 STORIA DELLA LINGUA TEDESCA PROF. LUCA PANIERI A.A. 2012-2013 Libera Università di Lingue e comunicazione IULM Introduzione Il corso viene tenuto dal professor Luca Panieri e si occupa di tracciare la
STORIA DELLA LINGUA TEDESCA PROF. LUCA PANIERI A.A. 2012-2013 Libera Università di Lingue e comunicazione IULM Introduzione Il corso viene tenuto dal professor Luca Panieri e si occupa di tracciare la
Caratteri principali della fonologia del tedesco antico. Fenomeni di fonetica combinatoria nel vocalismo in sillaba tonica
 Caratteri principali della fonologia del tedesco antico Fenomeni di fonetica combinatoria nel vocalismo in sillaba tonica Si tratta di una serie di sviluppi del vocalismo in sillaba tonica, dovuti sostanzialmente
Caratteri principali della fonologia del tedesco antico Fenomeni di fonetica combinatoria nel vocalismo in sillaba tonica Si tratta di una serie di sviluppi del vocalismo in sillaba tonica, dovuti sostanzialmente
APPUNTI DI LINGUISTICA GERMANICA a.a
 APPUNTI DI LINGUISTICA GERMANICA a.a. 2016-17 VOCALISMO IN SILLABA TONICA Triangolo vocalico indoeuropeo: vocali brevi vocali lunghe i u ī ū e o ē ō a ā Triangolo vocalico germanico (II-I sec. a.c.): vocali
APPUNTI DI LINGUISTICA GERMANICA a.a. 2016-17 VOCALISMO IN SILLABA TONICA Triangolo vocalico indoeuropeo: vocali brevi vocali lunghe i u ī ū e o ē ō a ā Triangolo vocalico germanico (II-I sec. a.c.): vocali
Il verbo che cos'è. Il verbo è la parte del discorso più importante.
 IL VERBO Il verbo che cos'è Il verbo è la parte del discorso più importante. Esso è il centro di ogni frase. Il verbo "dice" qualcosa sul soggetto e lo fa servendosi anche di altre parti del discorso che
IL VERBO Il verbo che cos'è Il verbo è la parte del discorso più importante. Esso è il centro di ogni frase. Il verbo "dice" qualcosa sul soggetto e lo fa servendosi anche di altre parti del discorso che
AGGETTIVI DI SECONDA CLASSE A DUE E A UNA SOLA USCITA. AGGETTIVI IRREGOLARI AGGETTIVI A DUE USCITE
 ETTII I SECO CLSSE UE E U SOL USCIT. ETTII IRREOLRI ETTII UE USCITE 1 Hanno il tema in preceduta da (Quelli in preceduta da e in preceduta da sono, sempre di seconda classe, ma a 3 uscite; vedi nero e
ETTII I SECO CLSSE UE E U SOL USCIT. ETTII IRREOLRI ETTII UE USCITE 1 Hanno il tema in preceduta da (Quelli in preceduta da e in preceduta da sono, sempre di seconda classe, ma a 3 uscite; vedi nero e
Domande relative a Glottologia a.a
 Prof.ssa Paola Cotticelli Domande relative a Glottologia a.a. 2005-2006 CONCETTI INTRODUTTIVI Che cosa si intende per indoeuropeo? Quali sono le concezioni interpretative relative ad esso? Quando e dove
Prof.ssa Paola Cotticelli Domande relative a Glottologia a.a. 2005-2006 CONCETTI INTRODUTTIVI Che cosa si intende per indoeuropeo? Quali sono le concezioni interpretative relative ad esso? Quando e dove
LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II
 LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II Classe VA scolastico 2015/2016 Anno Docente: L. Salvadori PROGRAMMA DI GRECO -FONETICA E MORFOLOGIA LA DECLINAZIONE ATEMATICA (TERZA DECLINAZIONE) TEMI IN CONSONANTE
LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II Classe VA scolastico 2015/2016 Anno Docente: L. Salvadori PROGRAMMA DI GRECO -FONETICA E MORFOLOGIA LA DECLINAZIONE ATEMATICA (TERZA DECLINAZIONE) TEMI IN CONSONANTE
2 PAGINA. 1 Il greco lingua flessiva. Radice, tema, desinenza 44 2 La flessione dei nomi. Le declinazioni. I casi e le loro funzioni 47 1 PAGINA
 I AVVERTENZA PAGINA III 0 PAGINA 1 1 PAGINA 15 1 L alfabeto greco 17 2 Spiriti, accenti e altri segni diacritici. I segni d interpunzione 21 3 Le vocali e i dittonghi 25 4 Le consonanti 27 5 L accento
I AVVERTENZA PAGINA III 0 PAGINA 1 1 PAGINA 15 1 L alfabeto greco 17 2 Spiriti, accenti e altri segni diacritici. I segni d interpunzione 21 3 Le vocali e i dittonghi 25 4 Le consonanti 27 5 L accento
LATINO A COLORI MATERIALI PER IL DOCENTE
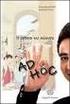 Gian Biagio Conte LATINO A COLORI MATERIALI PER IL DOCENTE a cura di Laura Perrotta 2009 by Mondadori Education S.p.A., Milano Tutti i diritti riservati Progettazione e redazione Impaginazione Rilettura
Gian Biagio Conte LATINO A COLORI MATERIALI PER IL DOCENTE a cura di Laura Perrotta 2009 by Mondadori Education S.p.A., Milano Tutti i diritti riservati Progettazione e redazione Impaginazione Rilettura
Materia: LATINO. Classe I sez. A. Liceo Scientifico. Docente: Prof.ssa Carla Bonfitto
 Materia: LATINO Classe I sez. A Liceo Scientifico Docente: Prof.ssa Carla Bonfitto a.s. 2015/2016 UNITÀ 1 L alfabeto latino e la pronuncia Vocali e dittonghi Consonanti Divisione in sillabe Quantità delle
Materia: LATINO Classe I sez. A Liceo Scientifico Docente: Prof.ssa Carla Bonfitto a.s. 2015/2016 UNITÀ 1 L alfabeto latino e la pronuncia Vocali e dittonghi Consonanti Divisione in sillabe Quantità delle
PROGRAMMA DI GRECO. ANNO SCOLASTICO
 GRAMMATICA INTRODUZIONE Il greco lingua indoeuropea La prima fase della lingua greca: il miceneo FONETICA E MORFOLOGIA Leggere e scrivere il greco L alfabeto La pronuncia I segni diacritici La classificazione
GRAMMATICA INTRODUZIONE Il greco lingua indoeuropea La prima fase della lingua greca: il miceneo FONETICA E MORFOLOGIA Leggere e scrivere il greco L alfabeto La pronuncia I segni diacritici La classificazione
4) La geminazione consonantica del germ. occidentale
 4) La geminazione consonantica del germ. occidentale La geminazione consonantica è un fenomeno che riguarda solo il germ. occidentale ad esclusione del gotico e dell antico nordico (germ. settentrionale).
4) La geminazione consonantica del germ. occidentale La geminazione consonantica è un fenomeno che riguarda solo il germ. occidentale ad esclusione del gotico e dell antico nordico (germ. settentrionale).
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE ANNO SCOLASTICO 2013/2014
 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: GRECO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO 1 2 Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Fonetica L alfabeto greco; Campanini
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: GRECO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO 1 2 Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Fonetica L alfabeto greco; Campanini
OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME. Competenze specifiche Abilità Conoscenze ABILITÀ MORFO-SINTATTICHE
 OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME Fonetica sue strutture morfosintattiche di base. 3. Arricchire il proprio bagaglio lessicale, imparando a usarlo consapevolmente. 4. Comprendere lo stretto rapporto
OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME Fonetica sue strutture morfosintattiche di base. 3. Arricchire il proprio bagaglio lessicale, imparando a usarlo consapevolmente. 4. Comprendere lo stretto rapporto
13- Metafonia e Mutazione Vocalica Pretonica nella prima coniugazione dei verbi
 A Lenga Turrese La Grammatica 13- Metafonia e Mutazione Vocalica Pretonica nella prima coniugazione dei verbi Salvatore Argenziano METAFONIA 1 e MUTAZIONE VOCALICA, nella coniugazione dei verbi Nel dialetto
A Lenga Turrese La Grammatica 13- Metafonia e Mutazione Vocalica Pretonica nella prima coniugazione dei verbi Salvatore Argenziano METAFONIA 1 e MUTAZIONE VOCALICA, nella coniugazione dei verbi Nel dialetto
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Federico II di Svevia
 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Federico II di Svevia PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA CLASSE I SEZ. A CLASSICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 Prof.ssa Carmen Santarsiero SEZIONE 1 - UNITA 1 1.1 Vocali
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Federico II di Svevia PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA CLASSE I SEZ. A CLASSICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 Prof.ssa Carmen Santarsiero SEZIONE 1 - UNITA 1 1.1 Vocali
DOCENTE: ERRICO INES DISCIPLINA: GRECO CLASSE 1 N. Morfologia del nome e del verbo. Elementi di sintassi come da programma allegato.
 DOCENTE: ERRICO INES DISCIPLINA: GRECO CLASSE 1 N Contenuti da recuperare Tipologia della prova Modalità di recupero Morfologia del nome e del verbo. Elementi di sintassi come da programma allegato. -
DOCENTE: ERRICO INES DISCIPLINA: GRECO CLASSE 1 N Contenuti da recuperare Tipologia della prova Modalità di recupero Morfologia del nome e del verbo. Elementi di sintassi come da programma allegato. -
Categorie grammaticali = tratti morfosintattici + tratti morfosemantici + tratti morfologici
 1) Il verbo Le categorie morfologiche del verbo (categorie grammaticali, paradigmi, coniugazioni, classi regolari, sottoregolari, irregolari, allomorfie ecc.) Il verbo = la parte del discorso (estremamente)
1) Il verbo Le categorie morfologiche del verbo (categorie grammaticali, paradigmi, coniugazioni, classi regolari, sottoregolari, irregolari, allomorfie ecc.) Il verbo = la parte del discorso (estremamente)
Presentazione di: Condes Angel Grace Colella Ludovica Conte Flaminia
 Presentazione di: Condes Angel Grace Colella Ludovica Conte Flaminia Il verbo Che cos'è il verbo? Il verbo è la parte variabile del discorso con la quale si esprimono, collocandoli nel tempo, un'azione,
Presentazione di: Condes Angel Grace Colella Ludovica Conte Flaminia Il verbo Che cos'è il verbo? Il verbo è la parte variabile del discorso con la quale si esprimono, collocandoli nel tempo, un'azione,
IIS Via Silvestri Liceo Scientifico Anno scolastico Classe I sez. D Prof. ssa Francesca Ferrari. Programma di Latino
 IIS Via Silvestri Liceo Scientifico Anno scolastico 2014-2015 Classe I sez. D Prof. ssa Francesca Ferrari Programma di Latino Introduzione allo studio del Latino Riflessioni sulle motivazioni allo studio.
IIS Via Silvestri Liceo Scientifico Anno scolastico 2014-2015 Classe I sez. D Prof. ssa Francesca Ferrari Programma di Latino Introduzione allo studio del Latino Riflessioni sulle motivazioni allo studio.
Facoltà di Studi Umanistici Cagliari Riallineamento Greco
 Il sistema verbale greco Le coniugazioni sono due: -tematica o dei verbi in w in cui la desinenza si unisce al tema tramite vocale tematica; -atematica o dei verbi in mi in cui la desinenza si unisce al
Il sistema verbale greco Le coniugazioni sono due: -tematica o dei verbi in w in cui la desinenza si unisce al tema tramite vocale tematica; -atematica o dei verbi in mi in cui la desinenza si unisce al
5 L evoluzione delle lingue: livelli del mutamento linguistico
 Sonia Cristofaro - Glottologia A - a.a 2014-15 1 5 L evoluzione delle lingue: livelli del mutamento linguistico [Materiali di riferimento per questa parte (solo in riferimento agli arrgomenti trattati):
Sonia Cristofaro - Glottologia A - a.a 2014-15 1 5 L evoluzione delle lingue: livelli del mutamento linguistico [Materiali di riferimento per questa parte (solo in riferimento agli arrgomenti trattati):
Indice. Premessa. Abbreviazioni
 Indice Premessa IV Abbreviazioni VI 1. Antroponimia germanica 1 1.1. Classificazione tipologica 1 1.1.1. Antroponimi composti 1 1.1.2. Antroponimi monotematici 2 1.1.3. Antroponimi derivazionali 3 1.2.
Indice Premessa IV Abbreviazioni VI 1. Antroponimia germanica 1 1.1. Classificazione tipologica 1 1.1.1. Antroponimi composti 1 1.1.2. Antroponimi monotematici 2 1.1.3. Antroponimi derivazionali 3 1.2.
La flessione Particolarità : I casi Il numero UNITA 4 LA II DECLINAZIONE
 LICEO SCIENTIFICO FEDERICO II di SVEVIA MELFI PROGRAMMA DI LATINO Svolto dalla classe I sez. AS Anno scolastico 2015 2016 Prof. Giovanna Paternoster GRAMMATICA UNITA 1 FONETICA, PRONUNCIA e ACCENTO La
LICEO SCIENTIFICO FEDERICO II di SVEVIA MELFI PROGRAMMA DI LATINO Svolto dalla classe I sez. AS Anno scolastico 2015 2016 Prof. Giovanna Paternoster GRAMMATICA UNITA 1 FONETICA, PRONUNCIA e ACCENTO La
2 LE PARTI DEL DISCORSO Le nove parti del discorso Caratteristiche delle parti del discorso 48 ESERCIZI 50 INDICE
 1 FONOLOGIA E ORTOGRAFIA SUONI, LETTERE E ORTOGRAFIA 2 A COLPO D OCCHIO - PERCORSO DI STUDIO 2 QUIZ PER COMINCIARE 4 1. I suoni e le lettere 5 1. L alfabeto italiano 5 2. Le sette vocali 6 3. Dittonghi,
1 FONOLOGIA E ORTOGRAFIA SUONI, LETTERE E ORTOGRAFIA 2 A COLPO D OCCHIO - PERCORSO DI STUDIO 2 QUIZ PER COMINCIARE 4 1. I suoni e le lettere 5 1. L alfabeto italiano 5 2. Le sette vocali 6 3. Dittonghi,
INDICE PREFAZIONE. Capitolo 1 INFORMAZIONI DI BASE. Capitolo 2 STATO DETERMINATO E INDETERMINATO. Capitolo 3 I GENERI MASCHILE E FEMMINILE
 INDICE PREFAZIONE XIII Capitolo 1 INFORMAZIONI DI BASE 1.1 Le lettere dell alfabeto e la loro traslitterazione 1 1.2 Le vocali 2 1.3 I segni ortografici 3 1.4 Il sostegno della hamza 4 1.5 Le caratteristiche
INDICE PREFAZIONE XIII Capitolo 1 INFORMAZIONI DI BASE 1.1 Le lettere dell alfabeto e la loro traslitterazione 1 1.2 Le vocali 2 1.3 I segni ortografici 3 1.4 Il sostegno della hamza 4 1.5 Le caratteristiche
IL SISTEMA VERBALE DEL PERFETTO
 IL SISTEMA VERBALE DEL PERFETTO INDICATIVO PERFETTO ATTIVO Il tempo perfetto del modo indicativo latino può primere tre tempi italiani: il passato prossimo, il passato remoto e il trapassato remoto. L
IL SISTEMA VERBALE DEL PERFETTO INDICATIVO PERFETTO ATTIVO Il tempo perfetto del modo indicativo latino può primere tre tempi italiani: il passato prossimo, il passato remoto e il trapassato remoto. L
Domande di preparazione di Glottologia. Prof.ssa Paola Cotticelli - aa
 Domande di preparazione di Glottologia Prof.ssa Paola Cotticelli - aa. 2011-2012 STORIA E METODO Che cosa si intende per indoeuropeo? Quali sono le concezioni interpretative relative ad esso? Quando e
Domande di preparazione di Glottologia Prof.ssa Paola Cotticelli - aa. 2011-2012 STORIA E METODO Che cosa si intende per indoeuropeo? Quali sono le concezioni interpretative relative ad esso? Quando e
La tipologia e gli universali
 La tipologia e gli universali La tipologia studia la variazione interlinguistica; la ricerca sugli universali si occupa di ciò che è comune a tutte le lingue, cioè delle proprietà rispetto alle quali non
La tipologia e gli universali La tipologia studia la variazione interlinguistica; la ricerca sugli universali si occupa di ciò che è comune a tutte le lingue, cioè delle proprietà rispetto alle quali non
La tipologia e gli universali
 La tipologia e gli universali La tipologia studia la variazione interlinguistica; la ricerca sugli universali si occupa di ciò che è comune a tutte le lingue, cioè delle proprietà rispetto alle quali non
La tipologia e gli universali La tipologia studia la variazione interlinguistica; la ricerca sugli universali si occupa di ciò che è comune a tutte le lingue, cioè delle proprietà rispetto alle quali non
PROGRAMMA DI GRECO ANNO 2009/10 CLASSE IV E
 LIBRO DI GRAMMATICA DESCRITTIVA CAPITOLO 1 1. L alfabeto 2. La pronuncia 3. Segni diacritici 3.1 Gli accenti 3.2 Gli spiriti 3.3 La punteggiatura 3.4 L apostrofo 3.5 La coronide CAPITOLO 2 1. Le vocali
LIBRO DI GRAMMATICA DESCRITTIVA CAPITOLO 1 1. L alfabeto 2. La pronuncia 3. Segni diacritici 3.1 Gli accenti 3.2 Gli spiriti 3.3 La punteggiatura 3.4 L apostrofo 3.5 La coronide CAPITOLO 2 1. Le vocali
1. Parole e frasi (E. Slomp) Giocare con le frasi 2. Frasi da fiaba (R. Cressotti) Giocare con le frasi
 INDICE SCUOLA PRIMARIA Classe prima 1. Parole e frasi (E. Slomp) Giocare con le frasi 2. Frasi da fiaba (R. Cressotti) Giocare con le frasi IL NOME 3. Nomi propri e nomi comuni (E. Slomp) Tutto ha un nome
INDICE SCUOLA PRIMARIA Classe prima 1. Parole e frasi (E. Slomp) Giocare con le frasi 2. Frasi da fiaba (R. Cressotti) Giocare con le frasi IL NOME 3. Nomi propri e nomi comuni (E. Slomp) Tutto ha un nome
22 PAGINA 23 PAGINA. Laboratorio PAGINA
 V AVVERTENZA PAGINA I 22 PAGINA 1 1 Il tema del presente e il tema verbale 3 2 Il lessico 12 3 Il futuro. Il futuro sigmatico dei temi in vocale e in dittongo 14 4 Il futuro sigmatico dei temi in consonante
V AVVERTENZA PAGINA I 22 PAGINA 1 1 Il tema del presente e il tema verbale 3 2 Il lessico 12 3 Il futuro. Il futuro sigmatico dei temi in vocale e in dittongo 14 4 Il futuro sigmatico dei temi in consonante
BFLR A Alfonso D'Agostino LO SPAGNOLO ANTICO SINTESI STORICO-DESCRITTIVA. edizioni U.niuz'iiitaxU di J-ttizit economia J->iiitto
 BFLR A 351667 Alfonso D'Agostino LO SPAGNOLO ANTICO SINTESI STORICO-DESCRITTIVA edizioni U.niuz'iiitaxU di J-ttizit economia J->iiitto INDICE ABBREVIATURE 1. Principali abbreviature usate, p. 11 n INTRODUZIONE
BFLR A 351667 Alfonso D'Agostino LO SPAGNOLO ANTICO SINTESI STORICO-DESCRITTIVA edizioni U.niuz'iiitaxU di J-ttizit economia J->iiitto INDICE ABBREVIATURE 1. Principali abbreviature usate, p. 11 n INTRODUZIONE
Nome. Articolo. Aggettivo. Variabili. Pronome. Parti del discorso. Verbo. Avverbio. Preposizione. Invariabili. Congiunzione.
 Nome Articolo Variabili Aggettivo Pronome Parti del discorso Verbo Avverbio Invariabili Preposizione Congiunzione Interiezione IL VERBO (dal latino verbum = parola) Parte variabile del discorso Esprime
Nome Articolo Variabili Aggettivo Pronome Parti del discorso Verbo Avverbio Invariabili Preposizione Congiunzione Interiezione IL VERBO (dal latino verbum = parola) Parte variabile del discorso Esprime
VIII. Indice. Unità 2 La semantica 20
 Presentazione Metodo e menti Struttura dell 0pera Percorso A Il lessico: parole, suoni, segni e significati Unità 1 Il lessico 2 2 1. Che cos è il lessico 3 2. La forma delle parole: il significante 3
Presentazione Metodo e menti Struttura dell 0pera Percorso A Il lessico: parole, suoni, segni e significati Unità 1 Il lessico 2 2 1. Che cos è il lessico 3 2. La forma delle parole: il significante 3
Sistema vocalico del latino: ă vs. ā, ŏ vs. ō, ĕ vs. ē, ĭ vs. ī, ŭ vs. ū (es. mălum il male vs. mālum mela o pŏpulus popolo vs.
 Sistema vocalico del latino: ă vs. ā, ŏ vs. ō, ĕ vs. ē, ĭ vs. ī, ŭ vs. ū (es. mălum il male vs. mālum mela o pŏpulus popolo vs. pōpulus pioppo ) Passaggio dal latino alle lingue romanze: distinzioni di
Sistema vocalico del latino: ă vs. ā, ŏ vs. ō, ĕ vs. ē, ĭ vs. ī, ŭ vs. ū (es. mălum il male vs. mālum mela o pŏpulus popolo vs. pōpulus pioppo ) Passaggio dal latino alle lingue romanze: distinzioni di
Indice. Premessa. Segni grafici e caratteri utilizzati
 Indice XI XII Premessa Segni grafici e caratteri utilizzati 1 Capitolo 1 I suoni della lingua ebraica 1 1. Le consonanti (le lettere) 4 2. I segni vocalici 5 a) Le vocali 6 i) Le vocali vere 6 ii) Lo scevà
Indice XI XII Premessa Segni grafici e caratteri utilizzati 1 Capitolo 1 I suoni della lingua ebraica 1 1. Le consonanti (le lettere) 4 2. I segni vocalici 5 a) Le vocali 6 i) Le vocali vere 6 ii) Lo scevà
INDICE. Ringraziamenti 11 CAPITOLOI INTRODUZIONE 12. 1.1. Oggetto di studio 12. 1.2. II sangiovannese nella classificazione dei dialetti calabresi 13
 INDICE Ringraziamenti 11 CAPITOLOI INTRODUZIONE 12 1.1. Oggetto di studio 12 1.2. II sangiovannese nella classificazione dei dialetti calabresi 13 1.3. San Giovanni in Fiore 14 1.4. Raccolta e presentazione
INDICE Ringraziamenti 11 CAPITOLOI INTRODUZIONE 12 1.1. Oggetto di studio 12 1.2. II sangiovannese nella classificazione dei dialetti calabresi 13 1.3. San Giovanni in Fiore 14 1.4. Raccolta e presentazione
L apprendimento dell italiano L2. Insegnare l italiano. Giuseppe Faso
 L apprendimento dell italiano L2 Insegnare l italiano Giuseppe Faso premessa La scuola italiana si è già trovata di fronte a difficoltà di inserimento attribuite alla diversità culturale Educazione linguistica:
L apprendimento dell italiano L2 Insegnare l italiano Giuseppe Faso premessa La scuola italiana si è già trovata di fronte a difficoltà di inserimento attribuite alla diversità culturale Educazione linguistica:
Domande su Gianni Rodari
 Domande su Gianni Rodari 1. Come si chiama la figlia di Gianni Rodari? E quale libro le ha dedicato? 2. Che lavoro faceva Gianni? 3. Gianni era un fascista? 4. Cosa accadde à sua fratello Cesare? 5. In
Domande su Gianni Rodari 1. Come si chiama la figlia di Gianni Rodari? E quale libro le ha dedicato? 2. Che lavoro faceva Gianni? 3. Gianni era un fascista? 4. Cosa accadde à sua fratello Cesare? 5. In
INDICE GENERALE Capitolo 1 - preliminari... 3 Capitolo 2 - Morfologia: preliminari... 12
 INDICE GENERALE Capitolo 1 - Preliminari... 3 1. L alfabeto latino...3 2. La pronunzia del latino...4 3. Vocali e semivocali...5 4. Dittonghi...6 5. La dieresi...7 6. L apofonia...7 7. Consonanti...7 8.
INDICE GENERALE Capitolo 1 - Preliminari... 3 1. L alfabeto latino...3 2. La pronunzia del latino...4 3. Vocali e semivocali...5 4. Dittonghi...6 5. La dieresi...7 6. L apofonia...7 7. Consonanti...7 8.
Fonologia e ortografia
 Programma di lingua e letteratura italiana (grammatica) 2014/2015 Prof.ssa Maria Rosaria Aliberti Classe 1BT Fonologia e ortografia I suoni e i segni Come si scrivono e come si pronunciano le lettere Uso
Programma di lingua e letteratura italiana (grammatica) 2014/2015 Prof.ssa Maria Rosaria Aliberti Classe 1BT Fonologia e ortografia I suoni e i segni Come si scrivono e come si pronunciano le lettere Uso
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE ANNO SCOLASTICO 2013/2014
 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 2LC (V Ginnasio) Disciplina: GRECO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Periodo 1 Ripasso del programma svolto
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 2LC (V Ginnasio) Disciplina: GRECO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Periodo 1 Ripasso del programma svolto
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE ANNO SCOLASTICO 2013/2014
 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: LATINO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Nozioni di fonetica Flocchini-Guidotti
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: LATINO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Nozioni di fonetica Flocchini-Guidotti
5 Motivazioni funzionali
 Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2009-10 1 5 Motivazioni funzionali [Materiale di riferimento per questa parte: Croft 1990: capp. 3 (traduzione italiana in Cristofaro and Ramat 1999: cap.1) e 4; Cristofaro
Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2009-10 1 5 Motivazioni funzionali [Materiale di riferimento per questa parte: Croft 1990: capp. 3 (traduzione italiana in Cristofaro and Ramat 1999: cap.1) e 4; Cristofaro
4) Con la fine dell Impero romano (476 d.c.) il latino fu sostituito dalle lingue romanze negli atti ufficiali e nel parlato.
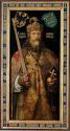 1) La differenza tra documento e monumento sta nel fatto che: a) i documenti sono cartacei, i monumenti lapidei b) il documento è una scrittura non fatta per durare, il monumento sì c) il documento è personale,
1) La differenza tra documento e monumento sta nel fatto che: a) i documenti sono cartacei, i monumenti lapidei b) il documento è una scrittura non fatta per durare, il monumento sì c) il documento è personale,
ScuolaSi di Cip.Sa s.a.s. Sede Legale: Salerno Via Carmine, 127 P.IVA C.F Fax Programma del Corso di lingua Araba:
 Programma del Corso di lingua Araba: Parte preliminare Alfabeto arabo أا أ Presentazione delle lettere arabe Alif, bâ,tâ,thâ Dâl, dhâl, râ, zây, sīn, šīn Kâf, lâm, mīm, nūn Gīm, hâ, hâ, fâ,qâf Sâd, dâd,
Programma del Corso di lingua Araba: Parte preliminare Alfabeto arabo أا أ Presentazione delle lettere arabe Alif, bâ,tâ,thâ Dâl, dhâl, râ, zây, sīn, šīn Kâf, lâm, mīm, nūn Gīm, hâ, hâ, fâ,qâf Sâd, dâd,
a. s CLASSE I B Insegnante A. Pruneddu Disciplina Latino
 a. s. 2015-2016 CLASSE I B Insegnante A. Pruneddu Disciplina Latino PROGRAMMA SVOLTO Segni e suoni L alfabeto: confronto italiano - latino Vocali e dittonghi Come si legge il latino La quantità della penultima
a. s. 2015-2016 CLASSE I B Insegnante A. Pruneddu Disciplina Latino PROGRAMMA SVOLTO Segni e suoni L alfabeto: confronto italiano - latino Vocali e dittonghi Come si legge il latino La quantità della penultima
Alda Baldaccini Patrizia Pugliese Maria Cristina Zanti IL MIO LIBRO DI ITALIANO
 Alda Baldaccini Patrizia Pugliese Maria Cristina Zanti IL MIO LIBRO DI ITALIANO 1998 by G. B. Palumbo & C. Editore S.p.A. progetto grafico e coordinamento tecnico Federica Giovannini videoimpaginazione
Alda Baldaccini Patrizia Pugliese Maria Cristina Zanti IL MIO LIBRO DI ITALIANO 1998 by G. B. Palumbo & C. Editore S.p.A. progetto grafico e coordinamento tecnico Federica Giovannini videoimpaginazione
La terza declinazione
 La terza declinazione La terza declinazione è la più complessa del sistema nominale latino. A differenza della prima e della seconda, essa è atematica, cioè non presenta una vocale tematica di raccordo
La terza declinazione La terza declinazione è la più complessa del sistema nominale latino. A differenza della prima e della seconda, essa è atematica, cioè non presenta una vocale tematica di raccordo
Prof.ssa Paola Cotticelli Linguistica Storica (s)
 Prof.ssa Paola Cotticelli Linguistica Storica (s) Il mutamento linguistico (Modulo I: 18 ore) Mutamento morfologico: aspetti della grammaticalizzazione (Modulo II: 36 ore) Programma 2010/2011 I. All interno
Prof.ssa Paola Cotticelli Linguistica Storica (s) Il mutamento linguistico (Modulo I: 18 ore) Mutamento morfologico: aspetti della grammaticalizzazione (Modulo II: 36 ore) Programma 2010/2011 I. All interno
Indice. Introduzione. Unità I. Unità 2. Unità Unità Unità Simboli impiegati nelle nozioni di grammatica storica
 Indice Introduzione Simboli impiegati nelle nozioni di grammatica storica Unità I 1.1. I1 latino lingua indoeuropea / 1.2. Le fasi della lingua latina / 11.1. L alfabeto latino / 11.2. La pronuncia del
Indice Introduzione Simboli impiegati nelle nozioni di grammatica storica Unità I 1.1. I1 latino lingua indoeuropea / 1.2. Le fasi della lingua latina / 11.1. L alfabeto latino / 11.2. La pronuncia del
Indice del volume MORFOLOGIA. unità 1 Alfabeto e fonetica. unità 2 Nozioni preliminari di morfologia
 Indice del volume Notizia storica MORFOLOGIA unità 1 Alfabeto e fonetica XV 1 I fonemi 2 2 L alfabeto 2 3 I fonemi del latino 3 Vocali 3 Dittonghi 4 Consonanti 4 Semivocali (o semiconsonanti) 5 4 La pronuncia
Indice del volume Notizia storica MORFOLOGIA unità 1 Alfabeto e fonetica XV 1 I fonemi 2 2 L alfabeto 2 3 I fonemi del latino 3 Vocali 3 Dittonghi 4 Consonanti 4 Semivocali (o semiconsonanti) 5 4 La pronuncia
Fai attenzione ai colori
 L imperativo Fai attenzione ai colori In questo PowerPoint, sono utilizzati colori diversi: Marrone= modo del verbo Rosso = persona del verbo Viola = tempo del verbo Verde = numero del verbo Verbo, modo,
L imperativo Fai attenzione ai colori In questo PowerPoint, sono utilizzati colori diversi: Marrone= modo del verbo Rosso = persona del verbo Viola = tempo del verbo Verde = numero del verbo Verbo, modo,
PIANO DI LAVORO ANNUALE
 ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE MAJORANA Via Ada Negri, 14 10024 MONCALIERI (TO) Codice fiscale 84511990016 Sezione Liceale E.Majorana Sezione Tecnico Economica Scientifico - Linguistico A.Marro Via Ada
ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE MAJORANA Via Ada Negri, 14 10024 MONCALIERI (TO) Codice fiscale 84511990016 Sezione Liceale E.Majorana Sezione Tecnico Economica Scientifico - Linguistico A.Marro Via Ada
La Morfologia. L aggettivo
 La Morfologia L aggettivo L aggettivo - Definizione L aggettivo è la parte variabile del discorso che si aggiunge al nome per indicarne qualità e caratteristiche. Esso concorda in genere e numero con il
La Morfologia L aggettivo L aggettivo - Definizione L aggettivo è la parte variabile del discorso che si aggiunge al nome per indicarne qualità e caratteristiche. Esso concorda in genere e numero con il
CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE PRIMA
 CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE PRIMA Conoscere l ordine alfabetico; Riconoscere le vocali dal punto di vista grafico e fonico; Riconoscere e isolare le vocali nelle parole che le contengono; Riconoscere
CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE PRIMA Conoscere l ordine alfabetico; Riconoscere le vocali dal punto di vista grafico e fonico; Riconoscere e isolare le vocali nelle parole che le contengono; Riconoscere
PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE
 PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo : LICEO SCIENTIFICO? LICEO TECNICO? ISTITUTO TECNICO AMM INISTRAZI FINANZA E MARKETING M ATERIA: LATINO Prof.ssa Luisella Ronda ANNO SCOLASTICO 2011/2012 Classe
PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo : LICEO SCIENTIFICO? LICEO TECNICO? ISTITUTO TECNICO AMM INISTRAZI FINANZA E MARKETING M ATERIA: LATINO Prof.ssa Luisella Ronda ANNO SCOLASTICO 2011/2012 Classe
Introduzione, di Anna Giacalone Ramat e Paolo Ramat. I. Antichità indoeuropee, di Enrico Campanile. 11. I1 proto-indoeuropeo, di Culvert Watkins
 Introduzione, di Anna Giacalone Ramat e Paolo Ramat I. Antichità indoeuropee, di Enrico Campanile i. La ricostruzione della cultura degli Indoeuropei i. i. I1 metodo lessicalistico 1.2. I1 metodo testuale
Introduzione, di Anna Giacalone Ramat e Paolo Ramat I. Antichità indoeuropee, di Enrico Campanile i. La ricostruzione della cultura degli Indoeuropei i. i. I1 metodo lessicalistico 1.2. I1 metodo testuale
modulo magistrale di Storia della filosofia del linguaggio
 Prof. Stefano Gensini modulo magistrale di Storia della filosofia del linguaggio SSD M-FIL/05 2015-2016 Dispensa 4_2015-2016 (a cura della dott. Valentina Vitali) N.B. La lettura e lo studio di questa
Prof. Stefano Gensini modulo magistrale di Storia della filosofia del linguaggio SSD M-FIL/05 2015-2016 Dispensa 4_2015-2016 (a cura della dott. Valentina Vitali) N.B. La lettura e lo studio di questa
5 L evoluzione delle lingue: tipi di mutamento linguistico
 Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2010-11 1 5 L evoluzione delle lingue: tipi di mutamento linguistico [Materiali di riferimento per questa parte: Per il mutamento linguistico in generale: Lazzeroni
Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2010-11 1 5 L evoluzione delle lingue: tipi di mutamento linguistico [Materiali di riferimento per questa parte: Per il mutamento linguistico in generale: Lazzeroni
LATINE DISCO ET LUDO CORSO di AVVIAMENTO ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA E DELLA CULTURA LATINA PROGRAMMA
 LATINE DISCO ET LUDO CORSO di AVVIAMENTO ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA E DELLA CULTURA LATINA PROGRAMMA 1^ Argomenti il latino che parliamo : - parole latine di uso quotidiano e modi di dire; -parole italiane
LATINE DISCO ET LUDO CORSO di AVVIAMENTO ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA E DELLA CULTURA LATINA PROGRAMMA 1^ Argomenti il latino che parliamo : - parole latine di uso quotidiano e modi di dire; -parole italiane
PROGRAMMA DI GRECO CLASSE V F A.S. 2015/16 PROF. LIVIA MARRONE
 1 PROGRAMMA DI GRECO CLASSE V F A.S. 2015/16 PROF. LIVIA MARRONE MORFOLOGIA Recupero argomenti programmati e non svolti nel precedente anno scolastico: III declinazione: temi in vocale dolce; temi in dittogo;
1 PROGRAMMA DI GRECO CLASSE V F A.S. 2015/16 PROF. LIVIA MARRONE MORFOLOGIA Recupero argomenti programmati e non svolti nel precedente anno scolastico: III declinazione: temi in vocale dolce; temi in dittogo;
6 Approcci esplicativi al mutamento linguistico
 Sonia Cristofaro - Glottologia B - a.a 2016-17 1 6 Approcci esplicativi al mutamento linguistico Manuali di riferimento per questa parte:le parti citate di McMahon 1994; Croft 2000: capp. 3 e 7 [solo per
Sonia Cristofaro - Glottologia B - a.a 2016-17 1 6 Approcci esplicativi al mutamento linguistico Manuali di riferimento per questa parte:le parti citate di McMahon 1994; Croft 2000: capp. 3 e 7 [solo per
che cosa sai fare Prova a misurare la tua consapevolezza sulla lingua parlata 4 Prova a misurare la tua consapevolezza sulla lingua scritta 5
 Percorso 1 La fonortografia mappa del percorso 2 Prova a misurare la tua consapevolezza sulla lingua parlata 4 Prova a misurare la tua consapevolezza sulla lingua scritta 5 Come si parla e come si scrive
Percorso 1 La fonortografia mappa del percorso 2 Prova a misurare la tua consapevolezza sulla lingua parlata 4 Prova a misurare la tua consapevolezza sulla lingua scritta 5 Come si parla e come si scrive
DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE LM. Elena Nuzzo
 DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE LM Elena Nuzzo Limiti delle sequenze acquisizionali Due problemi fondamentali per l insegnante: 1. Le sequenze riguardano pochi fenomeni. 2. Le esigenze didattiche possono
DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE LM Elena Nuzzo Limiti delle sequenze acquisizionali Due problemi fondamentali per l insegnante: 1. Le sequenze riguardano pochi fenomeni. 2. Le esigenze didattiche possono
ENTRA. questo è il sistema! il verbo è l'inizio di tutto, il punto di partenza, dal
 ESSERE O NON ESSERE questo è il sistema! il verbo è l'inizio di tutto, il punto di partenza, dal verbo dobbiamo cominciare, il verbo è quello c he rende un insieme di parole una frase, cioè un messaggio,
ESSERE O NON ESSERE questo è il sistema! il verbo è l'inizio di tutto, il punto di partenza, dal verbo dobbiamo cominciare, il verbo è quello c he rende un insieme di parole una frase, cioè un messaggio,
PROGRAMMA SVOLTO ITALIANO ANNO SCOLASTICO CLASSE: ID INSEGNANTE: Gemma Marras
 ITALIANO INSEGNANTE: GRAMMATICA Fonologia L alfabeto italiano: scrivere ordinatamente nella pagina in stampatello maiuscolo e minuscolo, in corsivo maiuscolo e minuscolo; esercitazioni pratiche. Vocali,
ITALIANO INSEGNANTE: GRAMMATICA Fonologia L alfabeto italiano: scrivere ordinatamente nella pagina in stampatello maiuscolo e minuscolo, in corsivo maiuscolo e minuscolo; esercitazioni pratiche. Vocali,
La nascita delle forme verbali perifrastiche nelle lingue romanze
 La nascita delle forme verbali perifrastiche nelle lingue romanze Premesse generali: Tempo: collocazione temporale del discorso (in genere rispetto al momento dell'enunciazione) Es. presente passato futuro
La nascita delle forme verbali perifrastiche nelle lingue romanze Premesse generali: Tempo: collocazione temporale del discorso (in genere rispetto al momento dell'enunciazione) Es. presente passato futuro
3) Quale di questi nomi propri non contiene un dittongo? a) Paolo b) Pietro c) Mauro d) Chiara
 1) La fonologia: a) studia i suoni in quanto entità concrete fisico-acustiche b) è sinonimo di fonetica c) ha per unità minime i fonemi d) prescinde dalle relazioni tra i suoni in una determinata lingua
1) La fonologia: a) studia i suoni in quanto entità concrete fisico-acustiche b) è sinonimo di fonetica c) ha per unità minime i fonemi d) prescinde dalle relazioni tra i suoni in una determinata lingua
Russian Conjugation: Acquisition and Evolutive Change
 Russian Conjugation: Acquisition and Evolutive Change Henning Andersen University of Copenhagen Linguistica Storica 2010/2011 Sabrina Piccinin Premessa Grammatica interna del parlante intesa come sistema
Russian Conjugation: Acquisition and Evolutive Change Henning Andersen University of Copenhagen Linguistica Storica 2010/2011 Sabrina Piccinin Premessa Grammatica interna del parlante intesa come sistema
a. s CLASSE: 1A Insegnante: Daniela Saracco Disciplina: Latino
 a. s. 2015-2016 CLASSE: 1A Insegnante: Daniela Saracco Disciplina: Latino PROGRAMMA SVOLTO Testi adottati: Nicola Flocchini, Piera Guidotti Bacci, Marco Moscio Testi consigliati Nicola Flocchini, Piera
a. s. 2015-2016 CLASSE: 1A Insegnante: Daniela Saracco Disciplina: Latino PROGRAMMA SVOLTO Testi adottati: Nicola Flocchini, Piera Guidotti Bacci, Marco Moscio Testi consigliati Nicola Flocchini, Piera
La Morfologia. L aggettivo. Pag. 164 CLASSE II C
 La Morfologia L aggettivo Pag. 164 CLASSE II C 2016-2017 L aggettivo - Definizione L aggettivo è la parte variabile del discorso che si aggiunge al nome per indicarne qualità e caratteristiche. Gli aggettivi
La Morfologia L aggettivo Pag. 164 CLASSE II C 2016-2017 L aggettivo - Definizione L aggettivo è la parte variabile del discorso che si aggiunge al nome per indicarne qualità e caratteristiche. Gli aggettivi
Corso di elettrotecnica Materiale didattico: i grafi
 Corso di elettrotecnica Materiale didattico: i grafi A. Laudani 12 ottobre 2005 I grafi costituiscono uno strumento matematico che permette di descrivere e schematizzare una grande varietà di problemi
Corso di elettrotecnica Materiale didattico: i grafi A. Laudani 12 ottobre 2005 I grafi costituiscono uno strumento matematico che permette di descrivere e schematizzare una grande varietà di problemi
A R R I V O I N I T A L I A
 CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI DI LIVELLO A1-A2 3 MariaTeresa Frattegiani Rosella Baldelli SOMMAR I O PREMESSA 07 INTRODUZIONE 08 L ALFABETO ITALIANO 08-09 LE SILLABE 10-11 I NUMERI 11
CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI DI LIVELLO A1-A2 3 MariaTeresa Frattegiani Rosella Baldelli SOMMAR I O PREMESSA 07 INTRODUZIONE 08 L ALFABETO ITALIANO 08-09 LE SILLABE 10-11 I NUMERI 11
http://digital.casalini.it/8884535131 ISBN-10: 88-8453-513-1 (online) ISBN-13: 978-88-8453-513-9 (online)
 IV PRIMA UNITÀ Nuovi itinerari alla scoperta del greco antico : le strutture fondamentali della lingua greca : fonetica, morfologia, sintassi, semantica, pragmatica / Francesco Michelazzo. Firenze : Firenze
IV PRIMA UNITÀ Nuovi itinerari alla scoperta del greco antico : le strutture fondamentali della lingua greca : fonetica, morfologia, sintassi, semantica, pragmatica / Francesco Michelazzo. Firenze : Firenze
T R I BU N A L E D I T R E V IS O A Z I E N D A LE. Pr e me s so
 1 T R I BU N A L E D I T R E V IS O BA N D O P E R L A C E S S IO N E C O M P E TI TI V A D EL C O M P E N D I O A Z I E N D A LE D E L C O N C O R D A T O PR EV E N T I V O F 5 Sr l i n l i q u i da z
1 T R I BU N A L E D I T R E V IS O BA N D O P E R L A C E S S IO N E C O M P E TI TI V A D EL C O M P E N D I O A Z I E N D A LE D E L C O N C O R D A T O PR EV E N T I V O F 5 Sr l i n l i q u i da z
LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II di Napoli
 LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II di Napoli PROGRAMMA DI LATINO Anno scolastico: 2015/2016 Docente: Prof.ssa Leombruno Classe: V G Materia: Latino MORFOLOGIA NOMINALE Gli aggettivi pronominali (ripetizione)
LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II di Napoli PROGRAMMA DI LATINO Anno scolastico: 2015/2016 Docente: Prof.ssa Leombruno Classe: V G Materia: Latino MORFOLOGIA NOMINALE Gli aggettivi pronominali (ripetizione)
Scritture sillabiche scritture alfabetiche
 LA SCRITTURA I 1. Sistema di segni grafici (grafemi) che trasmette attraverso il canale visivo dei significati convenzionali. 2. La scrittura nasce molto dopo la comparsa del linguaggio verbale ( che ha
LA SCRITTURA I 1. Sistema di segni grafici (grafemi) che trasmette attraverso il canale visivo dei significati convenzionali. 2. La scrittura nasce molto dopo la comparsa del linguaggio verbale ( che ha
Istituto Comprensivo di Gaggio Montano. Scuola Primaria di Castel d Aiano PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO. Classe quarta. Anno scolastico 2015/2016
 Istituto Comprensivo di Gaggio Montano. Scuola Primaria di Castel d Aiano PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO Classe quarta Anno scolastico 2015/2016 Insegnante: Ropa Lina La presente Programmazione annuale
Istituto Comprensivo di Gaggio Montano. Scuola Primaria di Castel d Aiano PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO Classe quarta Anno scolastico 2015/2016 Insegnante: Ropa Lina La presente Programmazione annuale
184 Il dialetto arzaghese
 INDICE PREFAZIONE...3 Prefazione alla seconda edizione...8 FONOLOGIA E ORTOGRAFIA...9 Fonemi...9 Alfabeto IPA...10 Alfabeto arzaghese e sua corrispondenza col sistema fonologico...17 Ortografia...18 Scrittura
INDICE PREFAZIONE...3 Prefazione alla seconda edizione...8 FONOLOGIA E ORTOGRAFIA...9 Fonemi...9 Alfabeto IPA...10 Alfabeto arzaghese e sua corrispondenza col sistema fonologico...17 Ortografia...18 Scrittura
GLI UNIVERSALI LINGUISTICI
 GLI UNIVERSALI LINGUISTICI Universali assoluti: sanciscono la presenza (o l assenza) di una particolare proprietà in ogni lingua storico-naturale, senza fare riferimento ad alcun altro parametro e senza
GLI UNIVERSALI LINGUISTICI Universali assoluti: sanciscono la presenza (o l assenza) di una particolare proprietà in ogni lingua storico-naturale, senza fare riferimento ad alcun altro parametro e senza
INDICE. Introduzione 9. Funzioni comunicative 52 Come comunicare la frequenza delle azioni Posso Voglio Devo
 INDICE Introduzione 9 1 Essere e Avere 11 Funzioni comunicative 12 Presentarsi 2 I nomi 17 3 Gli articoli determinativi 23 4 Gli articoli indeterminativi 27 5 Gli aggettivi 31 Aggettivi della I classe:
INDICE Introduzione 9 1 Essere e Avere 11 Funzioni comunicative 12 Presentarsi 2 I nomi 17 3 Gli articoli determinativi 23 4 Gli articoli indeterminativi 27 5 Gli aggettivi 31 Aggettivi della I classe:
Esercizi VALICO per lusofoni : punteggi e commenti
 Esercizi VALICO per lusofoni : punteggi e commenti Per il livello A2 Esercizio 1 A) Stavo pensando su un viaggio 3 B) Stavo pensando ad un viaggio 4 C) Stavo pensando in un viaggio 2 D) Ero pensando ad
Esercizi VALICO per lusofoni : punteggi e commenti Per il livello A2 Esercizio 1 A) Stavo pensando su un viaggio 3 B) Stavo pensando ad un viaggio 4 C) Stavo pensando in un viaggio 2 D) Ero pensando ad
La morfologia (dal greco, morphé "forma" e lògos "studio") è la sezione della grammatica o della linguistica che ha per oggetto lo studio della
 La morfologia (dal greco, morphé "forma" e lògos "studio") è la sezione della grammatica o della linguistica che ha per oggetto lo studio della struttura grammaticale delle parole e che ne stabilisce la
La morfologia (dal greco, morphé "forma" e lògos "studio") è la sezione della grammatica o della linguistica che ha per oggetto lo studio della struttura grammaticale delle parole e che ne stabilisce la
DOCENTE : TIZIANA COMINOTTO ANNO SCOLASTICO 2012/ 2013
 ISIS VINCENZO MANZINI PIANO DI LAVORO ANNUALE CLASSE : 1 A LL DISCIPLINA : LATINO DOCENTE : TIZIANA COMINOTTO ANNO SCOLASTICO 2012/ 2013 Situazione della classe. La classe 1^ALL è formata da 22 allievi,
ISIS VINCENZO MANZINI PIANO DI LAVORO ANNUALE CLASSE : 1 A LL DISCIPLINA : LATINO DOCENTE : TIZIANA COMINOTTO ANNO SCOLASTICO 2012/ 2013 Situazione della classe. La classe 1^ALL è formata da 22 allievi,
ANALISI DELLE PAROLE COMPLESSE Q U E S T I O N I D I M E T O D O P A R T E 1. Francesca Forza - Linguistica Generale 2
 ANALISI DELLE PAROLE COMPLESSE 1 Q U E S T I O N I D I M E T O D O P A R T E 1 Perché? Parole complesse: struttura interna. rappresentare tale struttura in modi espliciti e non ambigui. La struttura che
ANALISI DELLE PAROLE COMPLESSE 1 Q U E S T I O N I D I M E T O D O P A R T E 1 Perché? Parole complesse: struttura interna. rappresentare tale struttura in modi espliciti e non ambigui. La struttura che
La metafonia napoletana: evoluzione e funzionamento sincronico
 La metafonia napoletana: evoluzione e funzionamento sincronico Presentazioni di Max Pfister e Patrick Sauzet von Michela Russo 1. Auflage La metafonia napoletana: evoluzione e funzionamento sincronico
La metafonia napoletana: evoluzione e funzionamento sincronico Presentazioni di Max Pfister e Patrick Sauzet von Michela Russo 1. Auflage La metafonia napoletana: evoluzione e funzionamento sincronico
Liceo Ginnasio L. Galvani a.s. 2016/2017. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI LATINO CLASSE 1^ M Prof.ssa Barbara Temperini
 Liceo Ginnasio L. Galvani a.s. 2016/2017 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI LATINO CLASSE 1^ M Prof.ssa Barbara Temperini ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE La classe 1^ M, composta da 25 alunni,
Liceo Ginnasio L. Galvani a.s. 2016/2017 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI LATINO CLASSE 1^ M Prof.ssa Barbara Temperini ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE La classe 1^ M, composta da 25 alunni,
1 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: ascoltare. 2 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: parlare
 1 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: ascoltare 2 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: parlare 3 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: leggere 4 Modulo operativo: Le abilità linguistiche:
1 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: ascoltare 2 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: parlare 3 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: leggere 4 Modulo operativo: Le abilità linguistiche:
Le declinazioni. I liceo A.S
 Le declinazioni I liceo A.S. 2010-2011 2011 LE CINQUE DECLINAZIONI DEFINIZIONE La declinazione del nome/sostantivo è la flessione/cambiamento della parte finale della parola DEL NOME STRUTTURA Il nome
Le declinazioni I liceo A.S. 2010-2011 2011 LE CINQUE DECLINAZIONI DEFINIZIONE La declinazione del nome/sostantivo è la flessione/cambiamento della parte finale della parola DEL NOME STRUTTURA Il nome
C U R R I C O L O D I I T A L I A N O SCUOLA PRIMARIA CLASSE 5ª
 C U R R I C O L O D I I T A L I A N O SCUOLA PRIMARIA CLASSE 5ª COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura. Leggere, analizzare e comprendere testi.
C U R R I C O L O D I I T A L I A N O SCUOLA PRIMARIA CLASSE 5ª COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura. Leggere, analizzare e comprendere testi.
Arrivederci! 1 Unità 9 Una giornata in famiglia
 Con la mia famiglia Indicazioni per l insegnante Obiettivi didattici parlare della famiglia utilizzo degli aggettivi possessivi con i nomi di parentela al singolare e al plurale Svolgimento Dividete la
Con la mia famiglia Indicazioni per l insegnante Obiettivi didattici parlare della famiglia utilizzo degli aggettivi possessivi con i nomi di parentela al singolare e al plurale Svolgimento Dividete la
aringa), der Jünglich (il giovane), der Busen (il petto), der Himmel (il cielo), der Bohrer (il trapano).
 TAVOLA GRAMMATICALE: Caratteristiche principali Esistono sostantivi concreti (oggetti animati e inanimati) e astratti (concetti, qualità). In tedesco i sostantivi sono sempre scritti con l' iniziale maiuscola.
TAVOLA GRAMMATICALE: Caratteristiche principali Esistono sostantivi concreti (oggetti animati e inanimati) e astratti (concetti, qualità). In tedesco i sostantivi sono sempre scritti con l' iniziale maiuscola.
informatica di base per le discipline umanistiche
 informatica di base per le discipline umanistiche vito pirrelli Istituto di Linguistica Computazionale CNR Pisa Dipartimento di linguistica Università di Pavia ottava lezione: la dinamica del testo vito
informatica di base per le discipline umanistiche vito pirrelli Istituto di Linguistica Computazionale CNR Pisa Dipartimento di linguistica Università di Pavia ottava lezione: la dinamica del testo vito
