BIBLIOGRAFIA RAGIONATA. "LESSICO E ORTOGRAFIA NELLA LETTURA AD ALTA VOCE DI ADULTI E BAMBINI DI LINGUE DIVERSE" Laura Barca
|
|
|
- Cornelia Bossi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 BIBLIOGRAFIA RAGIONATA "LESSICO E ORTOGRAFIA NELLA LETTURA AD ALTA VOCE DI ADULTI E BAMBINI DI LINGUE DIVERSE" Laura Barca Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Università "La Sapienza" di Roma. Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, CNR di Roma. ETA' EVOLUTIVA (2002) ISSN: Introduzione Questa bibliografia ragionata affronta il tema del ruolo di diversi fattori (variabili lessicali e caratteristiche ortografiche) nella lettura ad alta voce (di singole parole) di adulti e bambini di diverse lingue. In una prima parte introduttiva saranno sinteticamente descritti alcuni modelli di lettura di riferimento. In particolare descriveremo il modello di lettura "a due vie" (Coltheart, Curtis, Atkins e Haller, 1993), così chiamato perché prevede la possibilità di elaborare l'input scritto tramite due processi distinti che si attivano in parallelo (un processo di analisi dell'intero stimolo, o "via lessicale", ed un processo di scomposizione analitica dello stimolo, o "via sublessicale"); ed il modello di acquisizione delle abilità di lettura proposto da Frith (1985), che prevede l acquisizione della lettura in quattro fasi successive (procedendo da una fase iniziale di analisi delle caratteristiche percettive degli stimoli, ad una fase finale in cui i bambini sarebbero capaci di riconoscere le parole facilmente e di accedere al significato delle stesse attraverso l'accesso diretto al lessico). Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., Haller, M. (1993). Models of reading aloud: Dual-route and parallel-distributed-processing approaches. Psychological Review, 100, Frith U. (1985). "Beneath the surface of developmental dyslexia". In K.E. Patterson, J.C. Marshall & M.Coltheart (a cura di), Surface Dyslexia. Neuropsychological and Cognitive Studies of the Phonological Reading. Erlbaum. London, pp
2 Seguirà una seconda parte dedicata agli studi che si sono occupati degli effetti lessicali nella lettura di adulti e di bambini senza disturbi acquisiti di linguaggio. Il modello di lettura "a due vie" Un modello di lettura particolarmente influente è il modello "a due vie" (Coltheart e coll., 1993). La versione più recente di questo modello, chiamato DRC (Dual Route Cascaded Model), è quella computazionale descritta in Coltheart, Rastle, Perry, Landgon e Ziegler (2001). Coltheart V., Rastle K., Perry C., Langdon R., Ziegler J. (2001). DRC: A dual route cascaded model of visual word recognition and reading aloud. Psychological Review, 108, In questo modello, varie componenti si attivano in modo seriale "a cascata" (l'attivazione viene trasmessa in modo sequenziale e continuo da un livello di analisi all'altro). Ad una fase iniziale di analisi delle caratteristiche visive dello stimolo e di riconoscimento delle lettere che compongono una parola, seguono due possibili processi di elaborazione: una via lessicale ed una via non lessicale (o sublessicale). La via lessicale prevede un accesso al lessico mediante elaborazione della parola intera, e il recupero in successione della rappresentazione ortografica e poi di quella fonologica della parola. Il risultato di questo processo consiste nell'attivazione di rappresentazioni nel lessico mentale. Queste rappresentazioni hanno una soglia di attivazione per cui le parole incontrate frequentemente in forma scritta necessitano di una minore attivazione rispetto alle parole incontrate meno frequentemente. Durante la messa in corrispondenza (mapping) della forma ortografica con quella fonologica, è previsto l'accesso ad un magazzino di memoria che contiene le informazioni semantiche sulle parole. Una volta attivata la rappresentazione fonologica, questa viene trasmessa al sistema fonemico coinvolto nella produzione e, dopo una fase di programmazione articolatoria, si ha la produzione della risposta, ossia la lettura ad alta voce. Questa via è detta "diretta" in quanto prevede un accesso diretto alle informazioni lessicali immagazzinate in memoria. Nella via sublessicale, invece, non avviene accesso al lessico ed è utilizzato un processo tramite il quale le parole vengono scomposte in lettere e grafemi. Queste unità vengono associate alla rappresentazione fonologica della parola tramite un sistema di regole, chiamato "procedura di conversione grafema-fonema" (d'ora in avanti g-f). Questa via è detta "indiretta" in quanto non prevede un'elaborazione della parola intera e quindi un accesso lessicale diretto. La via lessicale viene utilizzata nella lettura di parole conosciute (per le quali sono state precedentemente immagazzinate informazioni lessicali), in particolare parole irregolari (per l'inglese, ad esempio, la parola yacht), per le quali non c'è corrispondenza diretta tra forma ortografica e fonologica, e in cui l'applicazione della via sublessicale porterebbe a commettere degli errori. L'utilizzo di questa via comporta tempi di lettura più veloci in quanto si ha elaborazione simultanea dell'intero stimolo. 2
3 La via sublessicale viene utilizzata invece principalmente nella lettura di parole nuove regolari (con corrispondenza diretta tra ortografia e fonologia) e di non parole (per le quali non si hanno informazioni immagazzinate in memoria). L'applicazione di questa procedura determina tempi di lettura più lunghi in quanto si ha un'elaborazione analitica dello stimolo, mediante scomposizione nei grafemi che lo compongono, la conversione di questi nei fonemi corrispondenti, e il successivo riassemblaggio dei fonemi per la produzione verbale. Il fatto che questo modello preveda due distinte vie di elaborazione degli stimoli scritti non vuol dire che l'utilizzo prevalente di una modalità di lettura escluda la possibilità di utilizzare anche l'altra. Entrambe le vie di lettura vengono infatti attivate in parallelo. A seconda del tipo di stimoli, e/o del tipo di contesto sperimentale, potrebbe prevalere l'una o l'altra strategia di lettura. Per le parole poco conosciute, ad esempio, si può ipotizzare un maggiore utilizzo in parallelo delle due vie. Inoltre, evolutivamente, la lettura sublessicale potrebbe essere caratteristica delle prime fasi di apprendimento, mentre la via lessicale sarebbe propria di fasi più avanzate in cui il processo di lettura è più automatizzato (Temple, 1998). Temple C. (1998). Developmental Cognitive Neuropsychology. Psychology Press Ltd., Hove, UK. Un modello di acquisizione delle abilità di lettura I modelli dello sviluppo delle abilità di lettura fanno l'assunzione implicita che le fasi di apprendimento della lettura siano più o meno uniformi tra le diverse lingue alfabetiche. Tra i vari modelli che sono stati proposti, il modello della Frith (1985) è forse il più influente, e prevede che l acquisizione della lettura si articoli in quattro fasi: logografica, alfabetica, ortografica e lessicale. Secondo questo modello, il riconoscimento di parole nelle prime fasi di apprendimento si baserebbe principalmente sulle caratteristiche percettive parziali degli stimoli (fase logografica o prealfabetica in cui avviene la costruzione di un limitato vocabolario visivo). Questo stadio è seguito da una fase più sofisticata, o fase alfabetica, caratterizzata da un'analisi delle singole componenti delle parole tramite una procedura di conversione g-f, in cui il bambino diventa consapevole della relazione sistematica esistente tra le lettere ed i suoni corrispondenti. La fase ortografica sarebbe caratterizzata dall'analisi della parola in unità ortografiche (che coincidono con i morfemi) senza una conversione fonologica. Alla fine di questo processo i bambini sarebbero capaci di riconoscere le parole facilmente e di accedere al significato delle stesse attraverso l'accesso diretto al lessico, recuperando così le informazioni relative a unità più grandi del singolo grafema o del morfema (fase lessicale). In Brizzolara (2001), così come in Temple (1998), vengono descritti e messi a confronto i vari modelli di acquisizione dei processi di lettura. Brizzolara D. (2001)."Imparare la lingua scritta". In L. Camaioni (a cura di), Psicologia dello sviluppo e del linguaggio. Il Mulino, Bologna, pp
4 Ciò che in questi modelli non viene considerato è il ruolo delle differenze ortografiche tra le diverse lingue alfabetiche. Le caratteristiche ortografiche delle lingue (ossia la maggiore o minore trasparenza-regolarità dell'ortografia) potrebbero, infatti, influenzare lo sviluppo delle abilità di lettura. Se un'ortografia è trasparente, come l italiano, con un mapping coerente e regolare tra la forma ortografica e quella fonologica delle parole, la procedura di conversione g-f dovrebbe risultare più facile da imparare e da utilizzare. In lingue ad ortografia profonda (come l inglese, in cui sono presenti numerose parole con pronuncia irregolare ed eccezioni), l'utilizzo sistematico della procedura di conversione risulta più complicato e può portare a commettere numerosi errori. In questo tipo di ortografie potrebbe risultare più adattivo ed economico apprendere la forma fonologica (la pronuncia) di singole parole scritte, utilizzando poi varie strategie (quali la lettura per analogia) per cercare di leggere le parole nuove, e questo fin dalle prime fasi di apprendimento. Questo potrebbe anche avere un'influenza indiretta sulle tecniche di insegnamento del processo di lettura. Il compito di lettura ad alta voce Il compito generalmente utilizzato per analizzare i processi di lettura è quello di lettura ad alta voce di parole singole. In tale compito si presentano delle parole al centro dello schermo di un computer, e ai partecipanti viene chiesto di leggerle il più velocemente ed accuratamente possibile. Un microfono collegato ad un timer e al computer registra l'onset della risposta, ossia il tempo che intercorre tra la presentazione dello stimolo e l'inizio della risposta. Lo sperimentatore, inoltre, prende nota degli errori commessi. Gli errori nella lettura ad alta voce degli adulti sono generalmente limitati di numero, il che spesso non ne consente l'analisi. Invece nella lettura dei bambini gli errori sono più numerosi e l'accuratezza è spesso utilizzata come variabile dipendente al posto della velocità di lettura. Ortografie diverse (ortografie trasparenti vs. ortografie profonde) Diversi lavori si sono occupati della possibilità di utilizzare differenti strategie di lettura in lingue alfabetiche con differenti caratteristiche ortografiche. Wimmer e Goswami (1994) mettono a confronto le prestazioni di bambini di lingua inglese (lingua ad ortografia profonda) e di bambini di lingua tedesca (lingua ad ortografia trasparente) in un compito di lettura ad alta voce di parole e non parole, con lo scopo di evidenziare se i bambini delle due lingue differiscono fin dalle prime fasi di apprendimento della lettura nell'utilizzo di una via diretta o di una via di conversione g-f. Wimmer H., Goswami U. (1994). The influence of orthographic consistency on reading development: Word recognition in English and German children. Cognition, 51, Mentre nella lettura delle parole non emergono differenze significative, i bambini di lingua tedesca sono più veloci nella lettura delle non parole. I bambini di lingua tedesca, oltre ad utilizzare la procedura sublessicale di conversione g-f per le non parole, utilizzano anche la via di lettura diretta 4
5 per le parole, come evidenziato da tempi di lettura più veloci per le parole di alta frequenza rispetto a quelle di bassa frequenza. I bambini di lingua inglese, invece, tendono ad utilizzare unicamente la via diretta, il che porta a tempi più lenti per la lettura delle non parole. Secondo gli autori, inoltre, l'utilizzo di strategie diverse di lettura sarebbe più marcato nelle prime fasi di apprendimento, mentre nelle fasi successive, in cui l'obiettivo non è tanto quello di una corretta transcodifica dell'ortografia nella fonologia corrispondente, ma è quello di leggere per capire (e quindi accedere al significato delle parole), tale differenza dovrebbe diminuire. Per attivare il significato delle parole, infatti, i bambini devono sviluppare una strategia di riconoscimento diretto delle parole, utilizzando in modo molto minore la procedura di conversione. Ulteriore evidenza dell'utilizzo di differenti strategie di lettura in relazione ad ortografie diverse, in questo caso tra l'inglese e l'italiano, è presentata in Paulesu e coll. (2000). Paulesu E., McCrory E., Fazio F., Menoncello L., Brunswick N., Cappa S.F., Cotelli M., Cossu G., Corte F., Lorusso M., Pesenti S., Gallagher A., Perani D., Price C., Frith C.D., Frith U. (2000). A cultural effect on brain function. Nature Neuroscience, 3, Paulesu e coll. (2000) hanno studiato i processi di lettura di parole e non parole in studenti italiani ed inglesi. Gli studenti italiani risultano più veloci sia nella lettura delle parole che delle non parole. Entrambi i gruppi risultano più lenti nella lettura di non parole che nella lettura di parole, e questa differenza è significativamente maggiore per gli studenti inglesi. L'utilizzo della PET (tomografia ad emissione di positroni), inoltre, evidenzia l'esistenza di un sistema di lettura comune per diverse ortografie alfabetiche. Tuttavia, alcune aree cerebrali risultano essere maggiormente attivate da un'ortografia piuttosto che da un'altra. Gli studenti italiani, infatti, mostrano una maggiore attivazione di regioni associate con l'elaborazione dei fonemi, mentre gli studenti inglesi mostrano una maggiore attivazione di aree associate con il recupero della parola intera. L'utilizzo di differenti strategie di lettura sembra essere legato, per una stessa lingua, anche alle differenti abilità di lettura: Waters G.S., Seidenberg M.S., Bruck, M. (1984). Children's and adults' use of spelling-sound information in three reading tasks. Memory & Cognition, Waters e coll. (1984) confrontano le prestazioni di adulti e bambini (con abilità di lettura diverse, ossia "buoni lettori" e "cattivi lettori") di lingua inglese in diversi compiti lessicali. Oltre alla regolarità di corrispondenza g-f, le differenti prestazioni sono messe in relazione anche alla frequenza scritta delle parole. Mentre per gli adulti l'effetto della regolarità è limitato alle parole poco frequenti, i bambini più piccoli ed i cattivi lettori sono influenzati dalla regolarità anche con le parole di alta frequenza. Gli adulti ed i buoni lettori sarebbero in grado di sfruttare l'accesso al lessico per recuperare la corretta pronuncia delle parole di alta frequenza, mentre i bambini più piccoli o quelli 5
6 con difficoltà utilizzerebbero prevalentemente la procedura sublessicale che permetterebbe il manifestarsi di effetti di regolarità sia per le parole poco frequenti che per quelle molto frequenti. Effetti lessicali nella lettura Effetti lessicali nella lettura di adulti Effetti lessicali nella lettura ad alta voce di adulti di lingua italiana sono stati studiati da Barca, Burani e Arduino (2002) e da Bates, Burani, D'Amico e Barca (2001). Barca L., Burani C., Arduino L.S. (2002). Word naming times and psycholinguistic norms for Italian nouns. Behaviour Research Methods, Instruments, & Computers, 34, Bates E., Burani C., D'Amico S., Barca L. (2001). Word reading and picture naming in Italian. Memory & Cognition, 29, 7, Questi due lavori, condotti su adulti senza disturbi acquisiti di linguaggio, considerano un numero elevato di variabili lessicali e sublessicali (tra le quali la lunghezza in lettere, la frequenza nello scritto, l'immaginabilità e l'età di acquisizione delle parole). La velocità di lettura ad alta voce, in italiano, risulta influenzata principalmente dalle caratteristiche ortografiche delle parole (quali la lunghezza) e da caratteristiche più propriamente lessicali quali la frequenza scritta, mentre le caratteristiche semantiche (quali l'immaginabilità e l'età di acquisizione) degli stimoli non risultano essere dei predittori significativi. In base a questi risultati, le autrici propendono per l'ipotesi che, per leggere velocemente parole presentate isolatamente, sia possibile utilizzare una strategia di lettura lessicale non necessariamente semantica. Diversamente dall'italiano, in inglese emerge invece soprattutto un interessamento di variabili lessicali e semantico-lessicali mentre la lunghezza sembra avere, in confronto alle altre variabili, un ruolo più limitato. Per l'inglese il ruolo della frequenza e dell'età di acquisizione delle parole sono alquanto discussi, e si possono delineare due principali filoni di risultati. Alcuni studi (Morrison e Ellis, 1995), hanno trovato effetti di età di acquisizione (le parole acquisite prima vengono lette più velocemente e accuratamente di quelle acquisite più tardi) indipendenti dalla frequenza, ma non è emerso un effetto della frequenza quando le parole erano controllate per età di acquisizione. Morrison C.M., Ellis A.W. (1995). The role of word frequency and age of acquisition in word naming and lexical decision. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 21, Altri studi hanno evidenziato effetti separati (Morrison e Ellis, 2000) o indipendenti (Gerhand e Barry, 1998) sia di frequenza che di età di acquisizione. Morrison C.M., Ellis A.W. (2000). Real age of acquisition effects in word naming and lexical 6
7 decision. British Journal of Psychology, 91, Gerhand S., Barry C. (1998). Word frequency effects in oral reading are not merely age-ofacquisition effects in disguise. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 24, In nessun lavoro è stata documentata una mancanza dell'effetto dell'età di acquisizione sulla lettura di parole inglesi quando la frequenza viene controllata. Per l'italiano pare avvenga un maggiore utilizzo in parallelo delle due vie di lettura, come manifestato dal ruolo sia della frequenza (che riflette l'accesso alle informazioni immagazzinate in memoria, ossia l'utilizzo della via diretta) che della lunghezza (che riflette una procedura di scomposizione delle parole in costituenti ortografici e fonologici, per cui le parole più lunghe determinerebbero tempi di lettura maggiori rispetto alle parole corte, ossia l'utilizzo della via sublessicale). Il ruolo della frequenza nello scritto nel predire la velocità di lettura in italiano è emerso in Colombo (1992), ed in altri lavori che hanno investigato la lettura di pseudo-parole morfologicamente complesse (Burani e Laudanna, 2002). Colombo L. (1992). Lexical stress effect and its interaction with frequency in word pronunciation. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 18, , Burani C., Laudanna A. (2002). Morpheme-based lexical reading: Evidence from pseudoword naming. In E. Assink & D. Sandra (Eds.), Reading complex words. Dordrecht, Kluwer. Le uniche parole per le quali l'applicazione del processo di conversione g-f non determina necessariamente una corretta forma fonologica (sempre per l'italiano), sono le parole di tre o quattro sillabe aventi un accento sdrucciolo (ad es., bibita). Per recuperare la corretta forma fonologica delle parole sdrucciole è, infatti, necessario un accesso al lessico in quanto queste parole rappresentano una piccola percentuale della lingua (sono infatti solo il 14% circa, come riportato da Thornton, Iacobini e Burani, 1994; 1997), e possono essere considerate l'unica irregolarità (o meglio non predicibilità per regola) dell'italiano. Thornton A.M., Iacobini C., Burani C. (1994). BDVDB. Una base di dati sul vocabolario di base della lingua italiana (I edizione). Roma: Istituto di Psicologia del CNR. Thornton A.M., Iacobini C., Burani C. (1997). BDVDB. Una base di dati sul vocabolario di base della lingua italiana (II edizione, riveduta ed ampliata). Roma: Bulzoni. Per le lingue ad ortografia regolare o trasparente (non solo l'italiano, ma anche il tedesco, il turco ed il serbo-croato) è virtualmente possibile leggere tutte le parole utilizzando una procedura di conversione g-f. Per l'inglese l'utilizzo della via di lettura diretta risulta invece essere più efficace. Per il recupero dell'esatta forma fonologica delle parole irregolari inglesi (molto numerose) è necessario 7
8 accedere alle informazioni immagazzinate nel lessico, il che permetterebbe il manifestarsi di effetti non solo di variabili lessicali (quali la frequenza) ma anche di variabili semantico-lessicali (quali l'età di acquisizione delle parole). Effetti lessicali nella lettura di bambini I lavori che si sono occupati delle prestazioni di bambini (e soprattutto di bambini senza disturbi di linguaggio) nella lettura ad alta voce sono scarsi. Uno dei primi lavori che ha affrontato questo tema è quello di Jorm (1977). Jorm A.F.(1977). Effect of word imageability on reading performance as a function of reader ability. Journal of Educational Psychology, 69, In questo lavoro si studia il ruolo di una variabile semantica, l immaginabilità delle parole, confrontando le prestazioni di bambini con differenti abilità di lettura (buoni lettori e cattivi lettori). Le parole utilizzate, ricavate da testi letti frequentemente dai bambini, erano fatte variare ortogonalmente per immaginabilità, lunghezza e frequenza. In generale i buoni lettori commettevano meno errori rispetto ai cattivi lettori. Nello specifico, mentre i buoni lettori erano influenzati solo dalla frequenza delle parole, per i cattivi lettori c era un effetto significativo anche dell immaginabilità. La lunghezza non era significativa per nessuno dei due gruppi. Il differente effetto dell immaginabilità per i buoni ed i cattivi lettori potrebbe essere dovuto, secondo l autore, all utilizzo di differenti strategie di lettura da parte dei due gruppi. I bambini con problemi di lettura, avendo difficoltà nell applicare la procedura di conversione g-f, farebbero un maggiore riferimento ad una procedura di elaborazione della parola intera, con la quale imparano ad associare direttamente la forma scritta di una parola con la sua corrispondente forma fonologica. Quando i bambini vengono indotti ad utilizzare una procedura di lettura visiva l immaginabilità risulta significativa per entrambi i gruppi. L'autore sostiene quindi che l'immaginabilità è un buon predittore della lettura in bambini con un disturbo specifico della lettura e che, per questa ragione, è una variabile che deve essere controllata nella fase di costruzione di test volti alla riabilitazione delle abilità di lettura dei bambini. Più recentemente, il ruolo dell immaginabilità viene studiato nel contesto di un'altra variabile ad essa molto correlata, l età di acquisizione delle parole: Coltheart V., Laxon V., Keating C. (1988). Effects of word imageability and age of acquisition on children s reading. British Journal of Experimental Psychology, 79, Coltheart e coll. (1988) confrontano le prestazioni di bambini (suddivisi in buoni lettori vs. cattivi lettori) e adulti, utilizzando come materiale due gruppi di parole, un gruppo di parole variate per età di acquisizione (parole acquisite presto vs. parole acquisite tardi, bilanciate per lunghezza in lettere, frequenza ed immaginabilità) ed un gruppo di parole variate per immaginabilità (parole molto 8
9 immaginabili vs. parole poco immaginabili, bilanciate per lunghezza in lettere, frequenza ed età di acquisizione). Mentre l'età di acquisizione è significativa per entrambi i gruppi di bambini (le parole acquisite prima vengono lette più facilmente, ossia con meno errori, anche se tale effetto è maggiore per i cattivi lettori), l immaginabilità è significativa solo per il gruppo dei cattivi lettori. Anche per gli adulti le parole acquisite prima sono lette più velocemente rispetto alle parole acquisite dopo, mentre non c è un effetto significativo dell immaginabilità. Le autrici confermano dunque i dati emersi in Jorm (1977), secondo cui l immaginabilità ha effetto solo sulle prestazioni dei cattivi lettori. Le stesse autrici mostrano invece che l età di acquisizione influenza sia le prestazioni dei bambini che quelle degli adulti. L'ordine di acquisizione delle parole risulta essere un buon predittore della lettura non solo per la lingua inglese ma anche per altre lingue, quali l'olandese: Brysbaert M. (1996). Word frequency affects naming latency in Dutch when age of acquisition is controlled. European Journal of Cognitive Psychology, 8, In Brysbaert (1996) viene utilizzata una particolare misura di età di acquisizione, ottenuta chiedendo a delle maestre di scuola elementare di indicare quali parole, all'interno di una lista presentata loro, pensano siano comprese ("conoscenza passiva") da bambini di 6 anni. Il valore di età di acquisizione di una parola è dato dalla percentuale di insegnanti che hanno indicato la stessa parola come conosciuta. Il ruolo di questa misura di età di acquisizione è studiato nel contesto di altre variabili quali la lunghezza in lettere e la frequenza, in un compito di lettura ad alta voce svolto da bambini olandesi di 8-9 anni. Tutte e tre le variabili apportano un contributo significativo alla velocità di lettura. Inoltre età di acquisizione e frequenza risultano avere effetti indipendenti, in quanto l'età di acquisizione risulta significativa anche quando viene controllata la porzione di varianza spiegata dalla frequenza e viceversa. Brysbaert (1996) quindi replica i risultati ottenuti da Morrison e Ellis (1995) mostrando che l'età di acquisizione ha un effetto significativo sulla velocità di lettura, anche in una lingua diversa (olandese vs. inglese) e con una popolazione diversa (bambini vs. adulti). Tuttavia questo lavoro, a differenza di Morrison e Ellis (1995), mostra anche un effetto indipendente della frequenza. Tra le diverse ipotesi esplicative fornite dall'autore, una considera la differenza tra le misure di età di acquisizione utilizzate nei due lavori. Brysbaert sostiene infatti che le stime retrospettive fornite da studenti universitari ed utilizzate in Morrison e Ellis (1995) potrebbero essere influenzate da una componente di frequenza di occorrenza delle parole o di familiarità. L'immaginabilità risulta correlata alle prestazioni di cattivi lettori anche quando si considerano le prestazioni di adulti con differenti abilità di lettura: Strain E., Herdman C.M. (1999). Imageability effects in word naming: An individual differences analysis. Canadian Journal of Experimental Psychology, 53,
10 Il ruolo dell'immaginabilità sulla lettura risulta notevolmente ridimensionato quando è considerata un'altra variabile semantica, la "disponibilità del contesto". Questa misura si riferisce a quanto è facile, data una parola, pensare ad un suo possibile contesto di riferimento. Come l'immaginabilità e l'età di acquisizione, anche la disponibilità del contesto viene ricavata attraverso stime empiriche fornite da partecipanti ai quali è richiesto di indicare quanto, per una data parola, è facile pensare ad una circostanza o avvenimento in cui la stessa viene utilizzata. Schwanenflugel e Noyes (1996) indagano il ruolo dell'immaginabilità e della disponibilità del contesto sulle prestazioni di bambini di scuola elementare con abilità di lettura nella norma e di cattivi lettori, in compiti di riconoscimento di parole (lettura ad alta voce e decisione lessicale - compito in cui viene chiesto di indicare, premendo uno di due tasti, se una stringa di lettere è una parola o una non parola). Schwanenflugel P.J., Noyes C.R. (1996). Context availability and the development of word reading skill. Journal of Literacy Research, 28, I risultati mostrano che la disponibilità del contesto è un fattore ancora più importante dell'immaginabilità nel determinare la velocità di lettura e di decisione lessicale sia per bambini con adeguate abilità di lettura che per bambini con difficoltà. L'immaginabilità sembra essere un po' più coinvolta della disponibilità del contesto nella decisione lessicale per i bambini più piccoli e per i meno abili. Questi risultati mostrano che una variabile semantica, ed in particolare la disponibilità del contesto, è un fattore importante nell analisi lessicale dei bambini. Il ruolo della frequenza nello scritto è stato investigato nello studio di Hermelin e O'Connor (1982), in cui sono confrontate le prestazioni di bambini con un elevato quoziente di intelligenza (QI) e bambini con QI nella norma, in diversi tipi di compito (denominazione e classificazione di parole e di figure, e di riconoscimento e ricordo di parole). Hermelin B., O'Connor N. (1982). Naming and classifying: Intelligence and frequency effects. British Journal of Psychology, 73, Per quanto riguarda la lettura, i bambini con elevato QI hanno tempi di risposta minori rispetto ai bambini con QI nella norma, e mostrano di non essere influenzati dalla frequenza della parola. Il fatto che non ci sia un effetto della frequenza sulla lettura dei bambini con elevato QI contrasta con i lavori precedentemente citati sulla lettura degli adulti. Gli autori cercano di darne spiegazione distinguendo tra una frequenza delle parole "assoluta" e una frequenza delle parole "relativa". Mentre le parole poco comuni possono essere state incontrate meno spesso dai bambini rispetto a quelle più comuni, i bambini con elevato QI potrebbero averle incontrate più spesso rispetto agli altri. Quindi le parole "assolutamente" poco frequenti per i bambini con abilità nella norma potrebbero essere "relativamente" poco frequenti per i bambini con elevate capacità intellettive. 10
11 Più recentemente Nation e Snowling (1998) si sono occupate del ruolo della frequenza, in relazione alla regolarità della corrispondenza g-f, nella lettura di bambini con difficoltà di comprensione e di bambini con abilità di lettura nella norma. Nation K., Snowling M.J. (1998). Semantic processing and the development of word-recognition skills: Evidence from children with reading comprehension difficulties. Journal of Memory and Language, 39, I due gruppi di bambini hanno prestazioni simili in compiti che richiedono principalmente l'utilizzo di abilità fonologiche (ad esempio nel compito in cui viene richiesto di giudicare se due parole "rimano"), mentre il gruppo dei bambini con difficoltà di comprensione ha prestazioni deficitarie in compiti che richiedono l'utilizzo di abilità semantiche (ad esempio nel compito in cui si richiede di giudicare se due parole sono sinonimi). Come materiale nel compito di lettura si sono utilizzate parole variate per frequenza scritta (adulta) e per regolarità, bilanciate per lunghezza e fonema iniziale. Nella lettura di parole regolari di alta frequenza non c'è differenza tra i controlli e i bambini con difficoltà di comprensione né sui tempi né sugli errori. Tuttavia, i bambini con difficoltà di comprensione hanno maggiore difficoltà nella lettura delle parole-eccezione di bassa frequenza. Questo dato concorda con l'ipotesi delle autrici, secondo cui queste parole sarebbero lette correttamente attivando anche le informazioni semantiche. Poiché i bambini con difficoltà di comprensione hanno un deficit al livello semantico, le parole-eccezione di bassa frequenza risultano per loro particolarmente difficili da trattare. Questi risultati sono messi in relazione al modello connessionista di Plaut, McClelland, Seidenberg e Patterson (1996), in cui l'elaborazione fonologica e quella semantica interagiscono tra loro. Plaut D., McClelland J.L., Seidenberg M.S., Patterson K.E. (1996). Understanding normal and impaired language: Computational principles in quasi regular domains. Psychological Review, 103, Plaut e coll. (1996) ipotizzano che l'interazione tra la fonologia a la semantica possa essere caratterizzata come una "suddivisione del lavoro" tra un processo fonologico, che si occupa principalmente del mapping tra le rappresentazioni ortografiche e fonologiche delle parole, ed un processo semantico, che si occupa del mapping tra le rappresentazioni semantiche, fonologiche e ortografiche delle parole. Inizialmente il sistema fonologico sarebbe quello maggiormente implicato nella lettura, ma in fasi successive dello sviluppo, quando aumenta notevolmente il numero delle parole immagazzinate in memoria, parte del lavoro sarebbe svolto anche dal sistema semantico che permetterebbe una più rapida elaborazione delle parole già rappresentate nel lessico. Questo modello, quindi, suggerisce che il sistema semantico e quello fonologico interagiscano tra loro e che questa interazione possa modificarsi in funzione dell'apprendimento e dell'esperienza nella lettura. 11
12 Il lavoro di Laxon, Coltheart e Keating (1988) è uno dei pochi che si è occupato dell'effetto del numero di vicini ortografici (cioè del numero di parole ortograficamente simili ad una parola data ottenuto sostituendo una lettera per volta nella parola) sulla lettura dei bambini. Laxon V., Coltheart V., Keating C. (1988). Children find friendly words friendly too: Words with many orthographic neighbours are easier to read and spell. British Journal of Educational Psychology, 58, In questo lavoro vengono utilizzati tre compiti diversi: la lettura ad alta voce, la decisione lessicale ed un compito di scrittura (in cui lo sperimentatore legge una parola ed il bambino la deve scrivere), cui hanno partecipato bambini di due differenti classi, con età media rispettivamente di 8,4 e 10,4 anni. Come materiali sono state utilizzate parole e non parole con un differente numero di vicini ortografici, bilanciate per frequenza e lunghezza, e come variabile dipendente è stata considerata l'accuratezza delle risposte. Per la lettura ed il compito di scrittura sia le parole che le non parole con molti vicini vengono lette e scritte più facilmente, ossia commettendo meno errori. Da un'analisi effettuata sugli items e considerando anche altre variabili quali la frequenza tratta da testi letti da bambini, la regolarità, la lunghezza e l'età di acquisizione, emerge che il miglior predittore dell'accuratezza della lettura è l'età di acquisizione delle parole (come mostrato anche da Coltheart e coll., 1988), mentre il numero di vicini ortografici è il miglior predittore dell'accuratezza della scrittura. Tuttavia, le stesse autrici raccomandano di considerare con cautela questi risultati data l'elevata correlazione interna tra le variabili. I risultati di questo lavoro, comunque, mostrano che la struttura ortografica delle parole è una variabile importante nella lettura dei bambini, in quanto le parole con pochi vicini ortografici risultano essere più difficili rispetto a quelle con molti vicini in decisione lessicale e lettura di parole e non parole. Un'utile, anche se stringata, rassegna dei lavori che si sono occupati dei meccanismi cognitivi coinvolti nell'apprendimento della lettura e delle basi cognitive dei disturbi di lettura nei bambini è presentata in Snowling, Hulme e Nation (1997), Snowling M., Hulme C., Nation K. (1997). A connectionist perspective on the development of reading skills in children. Trends in Cognitive Science, 1, Da questa revisione degli studi sulla dislessia o sulla lettura di bambini con difficoltà di comprensione emerge, per la lingua inglese, un ruolo importante di variabili lessicali e semanticolessicali. In particolare, il ruolo dell'immaginabilità è stato ampiamente studiato, ma il suo effetto sembra limitato alle prestazioni di bambini con difficoltà di lettura, e viene notevolmente ridimensionato nel momento in cui vengono considerate altre variabili semantiche ad essa molto correlate, come l'età di acquisizione delle parole o la disponibilità del contesto. Queste due variabili risultano essere buoni predittori sia dell'accuratezza che della velocità di lettura di bambini di lingua 12
13 inglese, anche se in letteratura non ci sono lavori che le hanno messe a confronto. La rassegna di Snowling e coll. (1977) conferma che il ruolo di variabili quali il numero di vicini ortografici e la frequenza non è stato molto studiato, anche se dai pochi lavori disponibili emerge un effetto significativo di entrambe. Effetti lessicali nella lettura di bambini di lingua italiana? I dati forniti dalla letteratura sull acquisizione del processo di lettura della lingua italiana indicano l esistenza di effetti di lessicalità fin dalla 2^ elementare, dimostrati dalla differenza in velocità e correttezza tra lettura di parole e di non parole, e dalla diminuzione degli errori nella distinzione di omofoni non omografi (quali lago e l'ago; quest'ultimo aspetto è trattato in Scalisi e Berardi, 1992): Brizzolara D., Chilosi A.M., Cipriani P., De Pasquale L. (1994). L'apprendimento del linguaggio scritto in bambini con difficoltà di linguaggio orale: continuità o discontinuità? In G. Masi & A. Martini (a cura di), Apprendimento e patologia neuropsichica nei primi anni di scuola. Borla, Roma, pp Tressoldi P.E. (1996). L'evoluzione della lettura e della scrittura dalla II elementare alla III media. Età Evolutiva, 37, Maschietto D., Vio C. (1998). Acquisizione delle competenze alfabetiche ad ortografiche di lettura e di scrittura: proposte per un modello evolutivo. Psicologia e Clinica dello Sviluppo, Martini A., Brizzolara D., Pecini C., Dinetti D., Negrin E. (in stampa). Aspetti diagnostici e riabilitativi nei bambini dislessici italiani. In Disturbi di apprendimento della lettura e della scrittura. Angeli, Milano; Scalisi G., Berardi C. (1992). Effetti di omofonia nel riconoscimento di parole e frasi: confronto tra bambini italiani di età diversa. Archivio di Psicologia, Neurologia e Psichiatria, 53, Una ricerca che si occupa specificamente degli effetti di variabili lessicali nella lettura ad alta voce di bambini di lingua italiana è quella di Burani, Marcolini e Stella (2002) (si veda anche Marcolini e Burani, in stampa), in cui viene indagato l'utilizzo di strategie di lettura lessicali e morfo-lessicali da parte di bambini italiani del secondo ciclo di scuola elementare, valutando aspetti di frequenza e di struttura morfologica delle parole: Burani C., Marcolini S., Stella G. (2002). How early does morpho-lexical reading develop in readers of a shallow orthography? Brain and Language, 81, Marcolini S., Burani C. (in stampa). Sviluppo della lettura morfo-lessicale in una lingua a ortografia regolare. In Bambini in difficoltà nell'apprendimento della lingua scritta, a cura di G.T. Scalisi, M.Orsolini e C. Maronato. Roma: Edizioni Kappa. 13
14 Nel lavoro di Burani e coll. (2002), sono state analizzate le prestazione di bambini italiani di III, IV e V elementare, e si sono considerate la frequenza nello scritto infantile e la lunghezza. Ciò che emerge è un precoce utilizzo della lettura lessicale, che si manifesterebbe fin dalle prime fasi di apprendimento (è già presente in III elementare), con le parole di alta frequenza lette più velocemente rispetto a quelle di bassa frequenza. Anche la lunghezza delle parole influenza significativamente la prestazione, con le parole corte lette più velocemente rispetto alle parole lunghe. Inoltre si nota un progressivo aumento della velocità di lettura nelle tre classi, accompagnato da una significativa diminuzione del numero di errori. Ciò che emerge da questo lavoro non è solo il precoce utilizzo di una strategia di lettura lessicale, ma anche l'utilizzo della morfologia (la scomposizione in radice e suffisso) nella lettura di parole nuove. Conclusioni Con questa bibliografia ragionata abbiamo affrontato il tema del ruolo di variabili lessicali e non lessicali (caratteristiche ortografiche) nella lettura ad alta voce di adulti e bambini. In Burani e coll. (2002), uno dei pochi lavori condotto sull'italiano, sono emersi chiari effetti di frequenza e lunghezza nella lettura ad alta voce di bambini (confermando gli effetti lessicali emersi nella lettura di adulti); tuttavia rimane aperta la questione del ruolo di altre variabili lessicali e semantico-lessicali in tale compito. Sulla base dei lavori condotti con partecipanti adulti, possiamo ipotizzare un ruolo importante di altri fattori, quali il numero di vicini ortografici, mentre variabili semantico-lessicali (quali immaginabilità ed età di acquisizione) dovrebbero essere poco rilevanti. Si sente quindi l'esigenza di uno studio più approfondito delle variabili lessicali coinvolte nella lettura di bambini di lingua italiana. Inoltre sarebbe auspicabile l'utilizzo di un disegno sperimentale che permetta di differenziare il più possibile le variabili, generalmente molto correlate tra loro. Ruolo di variabili lessicali nella lettura di parole: uno strumento Uno strumento per questo campo d'indagine per la lingua italiana è la base di dati di Burani, Barca e Arduino (2001). Burani C., Barca L., Arduino, L.S. (2001). Una base di dati sui valori di età di acquisizione, frequenza, familiarità, immaginabilità, concretezza, e altre variabili lessicali e sublessicali per 626 nomi semplici dell'italiano. Giornale Italiano di Psicologia, 4, In questa base di dati, disponibile presso il sito è raccolto un elevato numero di indici lessicali e semantico-lessicali relativi a 626 parole dell'italiano, omogenee per categoria grammaticale e morfologica (nomi non morfologicamente complessi). Per ciascuno dei 626 nomi sono riportati i valori di: età di acquisizione, familiarità, immaginabilità, concretezza, frequenza nello scritto adulto, frequenza nello scritto infantile, frequenza nel parlato adulto, numero di vicini ortografici, frequenza media in bigrammi, lunghezza in lettere ed in sillabe, 14
15 tipo di fonema iniziale (classificato in base a sonorità vs. sordità, e al modo di articolazione). La classificazione di quest'ultima variabile risulta utile soprattutto per la selezione del materiale da utilizzare in compiti di lettura, in quanto è stato ampiamente mostrato (si vedano ad esempio i due lavori citati di seguito) che il fonema iniziale delle parole influenza la velocità e l'accuratezza della rilevazione della pronuncia in condizioni sperimentali: Treiman R., Mullennix J., Bijeljac-Babic R., Richmond-Welty E.D. (1995). The special role of rimes in the description, use, and acquisition of English orthography. Journal of Experimental Psychology: General, 124, Spieler D.H., Balota D.A. (1997). Bringing computational models of word naming down to the item level. Psychological Science, 8, La base di dati presentata da Burani e coll. (2001), oltre a fornire una descrizione dei diversi indici e delle procedure di rilevazione utilizzate, presenta un'analisi descrittiva delle relazioni tra le diverse variabili e colma una lacuna esistente negli strumenti per la lingua italiana. Questa base di dati potrebbe costituire uno strumento utile non solo per la ricerca sul lessico, ma anche per lo studio dei processi di lettura nei bambini. Se ne può dunque prevedere un'utilizzazione per indagare gli effetti delle diverse variabili sulla lettura dei bambini, e per approntare materiali utili per la riabilitazione della lettura. 15
APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA
 APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA COSA SONO LA LETTURA E LA SCRITTURA? I sistemi di comunicazione distinzione tra sistemi comunicativi verbali e non - verbali; i sistemi di scrittura sono strettamente
APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA COSA SONO LA LETTURA E LA SCRITTURA? I sistemi di comunicazione distinzione tra sistemi comunicativi verbali e non - verbali; i sistemi di scrittura sono strettamente
19/05/2017. Elena Farruggia
 Elena Farruggia Verificare se il deficit fonologico e il deficit nella denominazione rapida automatizzata (RAN) sono presenti e associati in bambini italiani con dislessia e se influenzano in modo differenziato
Elena Farruggia Verificare se il deficit fonologico e il deficit nella denominazione rapida automatizzata (RAN) sono presenti e associati in bambini italiani con dislessia e se influenzano in modo differenziato
Psicofisiologia della Lettura. Lettura: 2 processi. Lettura vs. Linguaggio. Lettura = processo di decodifica. - comprensione del messaggio
 Psicofisiologia della Lettura Il propagandarsi o l essere il protagonista comunque sulla base quotidiana dei mezzi di comunicazione è un esigenza che molti hanno ma che è altamente inflazionistica. Andrea
Psicofisiologia della Lettura Il propagandarsi o l essere il protagonista comunque sulla base quotidiana dei mezzi di comunicazione è un esigenza che molti hanno ma che è altamente inflazionistica. Andrea
Lo sviluppo della lettura. Margherita Orsolini Università La Sapienza
 Lo sviluppo della lettura Margherita Orsolini Università La Sapienza Ma come legge un lettore esperto? Un po di secoli fa si leggeva così. Siamo più veloci o più lenti se leggiamo così.? Gliuominihannocominciatoafilosofare,
Lo sviluppo della lettura Margherita Orsolini Università La Sapienza Ma come legge un lettore esperto? Un po di secoli fa si leggeva così. Siamo più veloci o più lenti se leggiamo così.? Gliuominihannocominciatoafilosofare,
Valutazione, Potenziamento e Studio nella Dislessia: un approccio clinico integrato
 Valutazione, Potenziamento e Studio nella Dislessia: un approccio clinico integrato METODO DI LAVORO Metodo valutare/potenziare la lettura nella Dislessia Frith, U. (1985). Beneath the surface of developmental
Valutazione, Potenziamento e Studio nella Dislessia: un approccio clinico integrato METODO DI LAVORO Metodo valutare/potenziare la lettura nella Dislessia Frith, U. (1985). Beneath the surface of developmental
Istituzioni di linguistica a.a Federica Da Milano
 Istituzioni di linguistica a.a.2014-2015 Federica Da Milano federica.damilano@unimib.it I processi di lettura, scrittura e calcolo nell età adulta La lettura: la capacità di leggere stringhe di lettere
Istituzioni di linguistica a.a.2014-2015 Federica Da Milano federica.damilano@unimib.it I processi di lettura, scrittura e calcolo nell età adulta La lettura: la capacità di leggere stringhe di lettere
La lettura come processo di decodifica. Di Giacomo Dallari
 La lettura come processo di decodifica. Di Giacomo Dallari Leggere significa attivare dei meccanismi molto complessi che richiedono l intervento di una serie di abilità e di processi articolati e cooperativi.
La lettura come processo di decodifica. Di Giacomo Dallari Leggere significa attivare dei meccanismi molto complessi che richiedono l intervento di una serie di abilità e di processi articolati e cooperativi.
DISORTOGRAFIA. La disortografia è la difficoltà a tradurre correttamente i suoni che compongono le parole in simboli grafici. Dott.
 DISORTOGRAFIA La disortografia è la difficoltà a tradurre correttamente i suoni che compongono le parole in simboli grafici Dott.ssa Mirella Carosi Aspetti linguistici Disordine di codifica del testo scritto
DISORTOGRAFIA La disortografia è la difficoltà a tradurre correttamente i suoni che compongono le parole in simboli grafici Dott.ssa Mirella Carosi Aspetti linguistici Disordine di codifica del testo scritto
PROVA DI LETTURA DI PAROLE E NON-PAROLE MANUALE. Pierluigi Zoccolotti, Maria De Luca, Gloria Di Filippo, Anna Judica, Donatella Spinelli
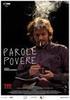 PROVA DI LETTURA DI PAROLE E NON-PAROLE MANUALE Pierluigi Zoccolotti, Maria De Luca, Gloria Di Filippo, Anna Judica, Donatella Spinelli Edizione 2005 INTRODUZIONE È noto che il riconoscimento delle parole
PROVA DI LETTURA DI PAROLE E NON-PAROLE MANUALE Pierluigi Zoccolotti, Maria De Luca, Gloria Di Filippo, Anna Judica, Donatella Spinelli Edizione 2005 INTRODUZIONE È noto che il riconoscimento delle parole
I disturbi specifici dell apprendimento: dall identificazione precoce agli interventi di recupero. Autore: Letizia Moretti Editing : Enrica Ciullo
 I disturbi specifici dell apprendimento: dall identificazione precoce agli interventi di recupero Autore: Letizia Moretti Editing : Enrica Ciullo Corso Dsa - I disturbi specifici dell apprendimento: dall
I disturbi specifici dell apprendimento: dall identificazione precoce agli interventi di recupero Autore: Letizia Moretti Editing : Enrica Ciullo Corso Dsa - I disturbi specifici dell apprendimento: dall
Prova di lettura di parole. e non parole
 2005 Prova di lettura di parole e non parole Pierluigi Zoccolotti, Maria De Luca, Gloria Di Filippo, Anna Judica e Donatella Spinelli - MANUALE D'USO - INTRODUZIONE E noto che il riconoscimento delle parole
2005 Prova di lettura di parole e non parole Pierluigi Zoccolotti, Maria De Luca, Gloria Di Filippo, Anna Judica e Donatella Spinelli - MANUALE D'USO - INTRODUZIONE E noto che il riconoscimento delle parole
Le difficoltà di apprendimento e l intervento di aiuto APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA
 Le difficoltà di apprendimento e l intervento di aiuto APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA COSA SONO LA LETTURA E LA SCRITTURA? Come si colloca la funzione della scrittura all interno dei sistemi di comunicazione?
Le difficoltà di apprendimento e l intervento di aiuto APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA COSA SONO LA LETTURA E LA SCRITTURA? Come si colloca la funzione della scrittura all interno dei sistemi di comunicazione?
(1) Le ortografie differiscono nel grado di trasparenza lettera-suono
 Linguaggio: disturbi evolutivi e trattamento 5 Apprendimento della lettura Cristina Burani Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, CNR, Roma Università degli studi di Trieste, anno accademico
Linguaggio: disturbi evolutivi e trattamento 5 Apprendimento della lettura Cristina Burani Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, CNR, Roma Università degli studi di Trieste, anno accademico
Progetto IPDA Prevenire le difficoltà d apprendimento a partire dall'ultimo anno della Scuola d Infanzia LA BATTERIA DI APPROFONDIMENTO
 Progetto IPDA Prevenire le difficoltà d apprendimento a partire dall'ultimo anno della Scuola d Infanzia LA BATTERIA DI APPROFONDIMENTO Perché una batteria di approfondimento? verificare se i casi risultati
Progetto IPDA Prevenire le difficoltà d apprendimento a partire dall'ultimo anno della Scuola d Infanzia LA BATTERIA DI APPROFONDIMENTO Perché una batteria di approfondimento? verificare se i casi risultati
Un Software per il potenziamento delle abilità di lettura e scrittura
 OTTOVOLANTE Un Software per il potenziamento delle abilità di lettura e scrittura *G. STELLA *G. CAIAZZO - *G. ZANZURINO * Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia San Marino 19/09/2008 Progetto
OTTOVOLANTE Un Software per il potenziamento delle abilità di lettura e scrittura *G. STELLA *G. CAIAZZO - *G. ZANZURINO * Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia San Marino 19/09/2008 Progetto
LE COMPETENZE FONOLOGICHE NEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA LETTO-SCRITTURA
 LE COMPETENZE FONOLOGICHE NEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA LETTO-SCRITTURA LUCIANA DI NATALE - -OGOPEDISTA LORETTA MASON - LOGOPEDISTA RAFFAELA ZANON - LOGOPEDISTA Anno scolastico 2018-2019 Dislessia
LE COMPETENZE FONOLOGICHE NEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA LETTO-SCRITTURA LUCIANA DI NATALE - -OGOPEDISTA LORETTA MASON - LOGOPEDISTA RAFFAELA ZANON - LOGOPEDISTA Anno scolastico 2018-2019 Dislessia
FREQUENZA, IMMAGINABILITÀ ED ETÀ DI ACQUISIZIONE DELLE PAROLE: IN CHE MISURA INFLUENZANO LA LETTURA DEI BAMBINI ITALIANI?
 FREQUENZA, IMMAGINABILITÀ ED ETÀ DI ACQUISIZIONE DELLE PAROLE: IN CHE MISURA INFLUENZANO LA LETTURA DEI BAMBINI ITALIANI? Simone Mazzotta*, Laura Barca #^, Stefania Marcolini #, Giacomo Stella + e Cristina
FREQUENZA, IMMAGINABILITÀ ED ETÀ DI ACQUISIZIONE DELLE PAROLE: IN CHE MISURA INFLUENZANO LA LETTURA DEI BAMBINI ITALIANI? Simone Mazzotta*, Laura Barca #^, Stefania Marcolini #, Giacomo Stella + e Cristina
Cristina Burani*, Laura Barca* e Lisa S. Arduino*^ * Istituto di Psicologia del CNR, Roma ^ Università di Roma La Sapienza
 Una base di dati sui valori di età di acquisizione, frequenza, familiarità, immaginabilità, concretezza, e altre variabili lessicali e sublessicali per 626 nomi dell'italiano. Cristina Burani*, Laura Barca*
Una base di dati sui valori di età di acquisizione, frequenza, familiarità, immaginabilità, concretezza, e altre variabili lessicali e sublessicali per 626 nomi dell'italiano. Cristina Burani*, Laura Barca*
Prerequisiti linguistici e scrittura
 Prerequisiti linguistici e scrittura Paola Viterbori Polo Bozzo Università di Genova Scrittura come attività complessa Codifica (Alfabetizzazione o Literacy) Attività linguistica di trasformazione del
Prerequisiti linguistici e scrittura Paola Viterbori Polo Bozzo Università di Genova Scrittura come attività complessa Codifica (Alfabetizzazione o Literacy) Attività linguistica di trasformazione del
DISCALCULIA CON E SENZA DISLESSIA: QUALCHE DIFFERENZA?
 v.19/2/10 DISCALCULIA CON E SENZA DISLESSIA: QUALCHE DIFFERENZA? Patrizio E. Tressoldi Dipartimento di Psicologia Generale Università di Padova -LA DISLESSIA PORTA SEMPRE QUALCHE DIFFICOLTA NELLE ABILITA
v.19/2/10 DISCALCULIA CON E SENZA DISLESSIA: QUALCHE DIFFERENZA? Patrizio E. Tressoldi Dipartimento di Psicologia Generale Università di Padova -LA DISLESSIA PORTA SEMPRE QUALCHE DIFFICOLTA NELLE ABILITA
I SISTEMI DI LETTURA E LE DISLESSIE
 I SISTEMI DI LETTURA E LE DISLESSIE L alessia senza agrafia -Disturbo di lettura senza altri disturbi concomitanti -I pazienti scrivono senza essere capaci di leggere quello che hanno scritto Interpretazione
I SISTEMI DI LETTURA E LE DISLESSIE L alessia senza agrafia -Disturbo di lettura senza altri disturbi concomitanti -I pazienti scrivono senza essere capaci di leggere quello che hanno scritto Interpretazione
COSTRUIRE APPRENDIMENTI SIGNIFICATIVI NELLA SCUOLA DELL INFANZIA. dott.ssa Damian Elisa, logopedista
 COSTRUIRE APPRENDIMENTI SIGNIFICATIVI NELLA SCUOLA DELL INFANZIA dott.ssa Damian Elisa, logopedista APPRENDIMENTO (Stella) ESPLICITO IMPLICITO appr scolastici locomozione, linguaggio esplicito: istruzione
COSTRUIRE APPRENDIMENTI SIGNIFICATIVI NELLA SCUOLA DELL INFANZIA dott.ssa Damian Elisa, logopedista APPRENDIMENTO (Stella) ESPLICITO IMPLICITO appr scolastici locomozione, linguaggio esplicito: istruzione
CURRICULUM Gloria Di Filippo
 CURRICULUM Gloria Di Filippo nata a Roma il 15 maggio 1970 TITOLI 2014 Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore Associato per il settore 11-E1 Psicologia generale, psicobiologia e Psicometria
CURRICULUM Gloria Di Filippo nata a Roma il 15 maggio 1970 TITOLI 2014 Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore Associato per il settore 11-E1 Psicologia generale, psicobiologia e Psicometria
Corso di Psicologia dello sviluppo tipico e atipico dei processi cognitivi 2014/2015 (Prof. Margherita Orsolini ) Su elearning:
 Corso di Psicologia dello sviluppo tipico e atipico dei processi cognitivi 2014/2015 (Prof. Margherita Orsolini ) Su elearning: Programma, calendario delle lezioni, letture per le tesine dei non frequentanti,
Corso di Psicologia dello sviluppo tipico e atipico dei processi cognitivi 2014/2015 (Prof. Margherita Orsolini ) Su elearning: Programma, calendario delle lezioni, letture per le tesine dei non frequentanti,
Il peso epidemiologico
 Le disabilità dell apprendimento Umberto Balottin, Cristiano Termine Cattedra di Neuropsichiatria Infantile Università degli Studi dell Insubria Unità Operativa di Neuropsichiatria dell Infanzia e Adolescenza
Le disabilità dell apprendimento Umberto Balottin, Cristiano Termine Cattedra di Neuropsichiatria Infantile Università degli Studi dell Insubria Unità Operativa di Neuropsichiatria dell Infanzia e Adolescenza
Le difficoltà di apprendimento e l intervento di aiuto APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA
 Le difficoltà di apprendimento e l intervento di aiuto APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA I meccanismi che servono per la scrittura sono gli stessi che servono anche per la lettura? Ambedue i sistemi (lettura
Le difficoltà di apprendimento e l intervento di aiuto APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA I meccanismi che servono per la scrittura sono gli stessi che servono anche per la lettura? Ambedue i sistemi (lettura
Memoria dichiarativa e memoria procedurale. Memoria semantica e memoria episodica
 ORGANIZZAZIONE DELLA CONOSCENZA Come è organizzata la conoscenza? l organizzazione della conoscenza si riferisce in parte ai sistemi di memoria: Ø Memoria sensoriale, a breve, a lungo termine Memoria dichiarativa
ORGANIZZAZIONE DELLA CONOSCENZA Come è organizzata la conoscenza? l organizzazione della conoscenza si riferisce in parte ai sistemi di memoria: Ø Memoria sensoriale, a breve, a lungo termine Memoria dichiarativa
I sistemi di scrittura. Linguaggio orale e linguaggio scritto. La lettura di parole singole. Ipotesi della profondità ortografica
 Linguaggio orale e linguaggio scritto La percezione, comprensione e produzione del linguaggio parlato si sviluppano molto precocemente e sfruttano meccanismi biologici specializzati e universali La percezione,
Linguaggio orale e linguaggio scritto La percezione, comprensione e produzione del linguaggio parlato si sviluppano molto precocemente e sfruttano meccanismi biologici specializzati e universali La percezione,
Effetto della morfologia sull accuratezza in scrittura: uno studio in bambini normolettori e con dislessia
 Effetto della morfologia sull accuratezza in scrittura: uno studio in bambini normolettori e con dislessia Paola Angelelli*, +Chiara Valeria Marinelli e **Cristina Burani *Università del Salento; +Università
Effetto della morfologia sull accuratezza in scrittura: uno studio in bambini normolettori e con dislessia Paola Angelelli*, +Chiara Valeria Marinelli e **Cristina Burani *Università del Salento; +Università
Studi italiani sul trattamento della dislessia evolutiva
 v.16/9/2010 Studi italiani sul trattamento della dislessia evolutiva Patrizio Tressoldi Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova Obiettivi dello studio: -Riportare i risultati dei trattamenti
v.16/9/2010 Studi italiani sul trattamento della dislessia evolutiva Patrizio Tressoldi Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova Obiettivi dello studio: -Riportare i risultati dei trattamenti
TUTTI A BORDO! PROGETTO IRIDE DI INTERCETTAZIONE PRECOCE IN RETE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA
 TUTTI A BORDO! PROGETTO IRIDE DI INTERCETTAZIONE PRECOCE IN RETE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2013-14 ISTITUTO COMPRENSIVO BADIA POLESINE - ROVIGO Badia Polesine 3 dicembre 2013 Francesca
TUTTI A BORDO! PROGETTO IRIDE DI INTERCETTAZIONE PRECOCE IN RETE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2013-14 ISTITUTO COMPRENSIVO BADIA POLESINE - ROVIGO Badia Polesine 3 dicembre 2013 Francesca
L analisi degli errori nei disturbi evolutivi della scrittura
 L analisi degli errori nei disturbi evolutivi della scrittura Dr.ssa Federica Riva U.O. Neurologia dello Sviluppo Servizio per i disordini del linguaggio e dell apprendimento Fondazione IRCCS Istituto
L analisi degli errori nei disturbi evolutivi della scrittura Dr.ssa Federica Riva U.O. Neurologia dello Sviluppo Servizio per i disordini del linguaggio e dell apprendimento Fondazione IRCCS Istituto
I DISTURBI E LE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO IN ADOLESCENZA. Barbara Carretti
 I DISTURBI E LE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO IN ADOLESCENZA Barbara Carretti Disturbi specifici dell apprendimento Base biologica Disturbi evolutivi Specifici Persistenti Evoluzione dei DSA Il DSA persiste,
I DISTURBI E LE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO IN ADOLESCENZA Barbara Carretti Disturbi specifici dell apprendimento Base biologica Disturbi evolutivi Specifici Persistenti Evoluzione dei DSA Il DSA persiste,
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO INSEGNAMENTO STRUMENTALE DELLA LETTURA. Interventi di miglioramento evidence-based - SApIE LUCIANA VENTRIGLIA MIUR
 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO INSEGNAMENTO STRUMENTALE DELLA LETTURA Interventi di miglioramento evidence-based - SApIE LUCIANA VENTRIGLIA MIUR OBIETTIVI Sensibilizzare gli insegnanti ad attivare modalità
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO INSEGNAMENTO STRUMENTALE DELLA LETTURA Interventi di miglioramento evidence-based - SApIE LUCIANA VENTRIGLIA MIUR OBIETTIVI Sensibilizzare gli insegnanti ad attivare modalità
FONOLOGIA DEL LINGUAGGIO E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA SCRITTA R.A. 2011/2012
 1 FONOLOGIA DEL LINGUAGGIO E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA SCRITTA R.A. 2011/2012 Badia Polesine 25 ottobre 2011 Francesca Zanella, Logopedista, Formatore A.I.D., Referente tecnico del progetto 2 ARGOMENTI
1 FONOLOGIA DEL LINGUAGGIO E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA SCRITTA R.A. 2011/2012 Badia Polesine 25 ottobre 2011 Francesca Zanella, Logopedista, Formatore A.I.D., Referente tecnico del progetto 2 ARGOMENTI
Marco Piccinno Introduzione generale ai Disturbi specifici dell apprendimento e alla Dislessia
 Marco Piccinno Introduzione generale ai Disturbi specifici dell apprendimento e alla Dislessia Il Disturbi specifici dell apprendimento (DSA) rappresentano dei deficit che insistono a carico delle funzioni
Marco Piccinno Introduzione generale ai Disturbi specifici dell apprendimento e alla Dislessia Il Disturbi specifici dell apprendimento (DSA) rappresentano dei deficit che insistono a carico delle funzioni
Ne esistono diverse e spesso contrastanti
 Ne esistono diverse e spesso contrastanti Una persona che nella quotidianità usa due o più lingue (Grosjean 1989) Chi ha competenze, anche minime, nelle due diverse lingue, in comprensione e/o produzione
Ne esistono diverse e spesso contrastanti Una persona che nella quotidianità usa due o più lingue (Grosjean 1989) Chi ha competenze, anche minime, nelle due diverse lingue, in comprensione e/o produzione
L acquisizione della scrittura e lettura
 Formazione insegnanti L acquisizione della scrittura e lettura Camponogara 2016 Logopedista Tagliapietra Dorotea Servizio di Età Evolutiva ULSS 13 Specializzata nei dsa e dsl PREMESSA I bambini, che hanno
Formazione insegnanti L acquisizione della scrittura e lettura Camponogara 2016 Logopedista Tagliapietra Dorotea Servizio di Età Evolutiva ULSS 13 Specializzata nei dsa e dsl PREMESSA I bambini, che hanno
Gli effetti di ampiezza e di frequenza del vicinato sul riconoscimento di parole scritte. dell italiano
 Gli effetti di ampiezza e di frequenza del vicinato sul riconoscimento di parole scritte dell italiano Introduzione Lo scopo di questo lavoro è analizzare gli effetti di ampiezza e di frequenza del vicinato
Gli effetti di ampiezza e di frequenza del vicinato sul riconoscimento di parole scritte dell italiano Introduzione Lo scopo di questo lavoro è analizzare gli effetti di ampiezza e di frequenza del vicinato
I^ GIORNATA DI FORMAZIONE
 Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale I^ GIORNATA DI FORMAZIONE Regione MARCHE ASCOLI PICENO San Benedetto del Tronto MARTEDI 20 MARZO 2007 PIANO
Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale I^ GIORNATA DI FORMAZIONE Regione MARCHE ASCOLI PICENO San Benedetto del Tronto MARTEDI 20 MARZO 2007 PIANO
I disturbi del linguaggio:
 I disturbi del linguaggio: Il linguaggio è... la capacità di utilizzare un codice per ESPRIMERE, COMPRENDERE COMUNICARE RAPPRESENTARE IDEE attraverso un SISTEMA CONVENZIONALE Di SEGNI LINGUAGGIO NELLE
I disturbi del linguaggio: Il linguaggio è... la capacità di utilizzare un codice per ESPRIMERE, COMPRENDERE COMUNICARE RAPPRESENTARE IDEE attraverso un SISTEMA CONVENZIONALE Di SEGNI LINGUAGGIO NELLE
Le competenze metafonologiche: attività, giochi metalinguistici e fonologici per favorire il loro sviluppo. Relatrice: Maria Angela Berton
 Le competenze metafonologiche: attività, giochi metalinguistici e fonologici per favorire il loro sviluppo Relatrice: Maria Angela Berton IL LINGUAGGIO VERBALE E UNO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE COME SI
Le competenze metafonologiche: attività, giochi metalinguistici e fonologici per favorire il loro sviluppo Relatrice: Maria Angela Berton IL LINGUAGGIO VERBALE E UNO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE COME SI
Come leggono i bambini dislessici? Rachele Fanari
 Come leggono i bambini dislessici? Rachele Fanari Evidenze dai bambini italiani con sviluppo tipico In uno studio longitudinale abbiamo osservato un gruppo di bambini dalla fine della scuola dell infanzia
Come leggono i bambini dislessici? Rachele Fanari Evidenze dai bambini italiani con sviluppo tipico In uno studio longitudinale abbiamo osservato un gruppo di bambini dalla fine della scuola dell infanzia
L espressione scritta e i disturbi del neurosviluppo. Anna Maria Re
 L espressione scritta e i disturbi del neurosviluppo Anna Maria Re Argomenti di ricerca ü ADHD ed espressione scritta ü Disturbo di comprensione del testo ed espressione scritta ü Training per bambini
L espressione scritta e i disturbi del neurosviluppo Anna Maria Re Argomenti di ricerca ü ADHD ed espressione scritta ü Disturbo di comprensione del testo ed espressione scritta ü Training per bambini
LABORATORIO Corso di Pedagogia speciale Prof.ssa Zappaterra IV anno GRUPPO 1 23 settembre :00/19:00 Dr.ssa Lucia Donata Nepi
 Scuola di Studi Umanistici e della Formazione CdS in Scienze della Formazione Primaria! LABORATORIO Corso di Pedagogia speciale Prof.ssa Zappaterra IV anno GRUPPO 1 23 settembre 2015 16:00/19:00 Dr.ssa
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione CdS in Scienze della Formazione Primaria! LABORATORIO Corso di Pedagogia speciale Prof.ssa Zappaterra IV anno GRUPPO 1 23 settembre 2015 16:00/19:00 Dr.ssa
RISULTATI DI ALCUNI STUDI SPERIMENTALI SULLA RIABILITAZIONE DELLA DISLESSIA:
 RISULTATI DI ALCUNI STUDI SPERIMENTALI SULLA RIABILITAZIONE DELLA DISLESSIA: FATTORI NEUROPSICOLOGICI IMPLICATI E MODELLI DI RIFERIMENTO Maria Luisa Lorusso IRCCS E. Medea Bosisio Parini (LC) E NOTO CHE.
RISULTATI DI ALCUNI STUDI SPERIMENTALI SULLA RIABILITAZIONE DELLA DISLESSIA: FATTORI NEUROPSICOLOGICI IMPLICATI E MODELLI DI RIFERIMENTO Maria Luisa Lorusso IRCCS E. Medea Bosisio Parini (LC) E NOTO CHE.
Osservazioni e strumenti
 Osservazioni e strumenti Centro di Consulenza Psicologica e Pedagogica L Albero Bianco via Matteo degli Organi, 213 Prato 0574/24684 alberobianco@alicecoop.it Prerequisiti per la lettura Sistema di analisi
Osservazioni e strumenti Centro di Consulenza Psicologica e Pedagogica L Albero Bianco via Matteo degli Organi, 213 Prato 0574/24684 alberobianco@alicecoop.it Prerequisiti per la lettura Sistema di analisi
Interpretazione della prova di scrittura spontanea. Consigli metodologici per favorire l apprendimento
 Interpretazione della prova di scrittura spontanea. Consigli metodologici per favorire l apprendimento Monteforte 19 ottobre 2012 Ivana Tacchella Tiziana Turco Formatrici AID Tre livelli descrittivi dei
Interpretazione della prova di scrittura spontanea. Consigli metodologici per favorire l apprendimento Monteforte 19 ottobre 2012 Ivana Tacchella Tiziana Turco Formatrici AID Tre livelli descrittivi dei
ACCESSO LESSICALE E LETTURA AD ALTA VOCE: IL RUOLO DELLE COMPONENTI MORFOLOGICHE DELLE PAROLE
 ACCESSO LESSICALE E LETTURA AD ALTA VOCE: IL RUOLO DELLE COMPONENTI MORFOLOGICHE DELLE PAROLE DANIELA TRAFICANTE, LAURA BARCA E CRISTINA BURANI Università Cattolica di Milano, Università di Roma «La Sapienza»
ACCESSO LESSICALE E LETTURA AD ALTA VOCE: IL RUOLO DELLE COMPONENTI MORFOLOGICHE DELLE PAROLE DANIELA TRAFICANTE, LAURA BARCA E CRISTINA BURANI Università Cattolica di Milano, Università di Roma «La Sapienza»
Ciclo di incontri con operatori scolastici: struttura
 Ciclo di incontri con operatori scolastici: struttura 1. Incontri teorico/pratici: tutti gli insegnanti 2. Incontri pratici: gruppo tecnico Ciclo di incontri con operatori scolastici: gli argomenti 1.
Ciclo di incontri con operatori scolastici: struttura 1. Incontri teorico/pratici: tutti gli insegnanti 2. Incontri pratici: gruppo tecnico Ciclo di incontri con operatori scolastici: gli argomenti 1.
Un Software per il potenziamento delle abilità di lettura e scrittura
 OTTOVOLANTE Un Software per il potenziamento delle abilità di lettura e scrittura HANDIMATICA 2008 Progetto A.P.RI.CO. Tecniche di Apprendimento Assistito A CHI È RIVOLTO? A bambini che frequentano la
OTTOVOLANTE Un Software per il potenziamento delle abilità di lettura e scrittura HANDIMATICA 2008 Progetto A.P.RI.CO. Tecniche di Apprendimento Assistito A CHI È RIVOLTO? A bambini che frequentano la
INDICATORI NEUROCOGNITIVI PRECOCI DELLA DISLESSIA EVOLUTIVA. Andrea Facoetti & Co
 INDICATORI NEUROCOGNITIVI PRECOCI DELLA DISLESSIA EVOLUTIVA Andrea Facoetti & Co Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova, ITALIA Unità di Neuropsicologia Evolutiva, Istituto Scientifico
INDICATORI NEUROCOGNITIVI PRECOCI DELLA DISLESSIA EVOLUTIVA Andrea Facoetti & Co Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova, ITALIA Unità di Neuropsicologia Evolutiva, Istituto Scientifico
I disturbi specifici dell apprendimento: dall identificazione precoce agli interventi di recupero. Autore: Letizia Moretti Editing : Enrica Ciullo
 I disturbi specifici dell apprendimento: dall identificazione precoce agli interventi di recupero Autore: Letizia Moretti Editing : Enrica Ciullo Corso Dsa - I disturbi specifici dell apprendimento: dall
I disturbi specifici dell apprendimento: dall identificazione precoce agli interventi di recupero Autore: Letizia Moretti Editing : Enrica Ciullo Corso Dsa - I disturbi specifici dell apprendimento: dall
I processi di lettura e scrittura in classe seconda
 Cristina Fabbri, Catia Gardini, Raffaella Mistura, Maddalena Vitali I processi di lettura e scrittura in classe seconda A.s. 2017-18 Articolazione degli incontri L analisi dell errore e le prove di monitoraggio
Cristina Fabbri, Catia Gardini, Raffaella Mistura, Maddalena Vitali I processi di lettura e scrittura in classe seconda A.s. 2017-18 Articolazione degli incontri L analisi dell errore e le prove di monitoraggio
Calendario degli incontri. Le lezioni avranno luogo presso l aula X (secondo piano) del Dipartimento di psicologia, Via dei Marsi 78.
 Calendario degli incontri Le lezioni avranno luogo presso l aula X (secondo piano) del Dipartimento di psicologia, Via dei Marsi 78. Orario : mattina: 9-13; pomeriggio: 14-18. 1a 2 Prerequisiti della lettura
Calendario degli incontri Le lezioni avranno luogo presso l aula X (secondo piano) del Dipartimento di psicologia, Via dei Marsi 78. Orario : mattina: 9-13; pomeriggio: 14-18. 1a 2 Prerequisiti della lettura
Brescia, 12 gennaio Logopedista DANIELA PALA
 Brescia, 12 gennaio 2018 Logopedista DANIELA PALA C'è relazione fra Linguaggio orale e Linguaggio scritto? Perché? Quali aspetti del Linguaggio orale incidono maggiormente sull'apprendimento della Letto-scrittura
Brescia, 12 gennaio 2018 Logopedista DANIELA PALA C'è relazione fra Linguaggio orale e Linguaggio scritto? Perché? Quali aspetti del Linguaggio orale incidono maggiormente sull'apprendimento della Letto-scrittura
ESPRESSIVITÀ DELLA VELOCITÀ DI LETTURA IN GIOVANI ADULTI: EFFETTI DI ALCUNE VARIABILI PSICOLINGUISTICHE
 ESPRESSIVITÀ DELLA VELOCITÀ DI LETTURA IN GIOVANI ADULTI: EFFETTI DI ALCUNE VARIABILI PSICOLINGUISTICHE Marisa Giorgetti 1, Pier Luigi Baldi 2 1 Servizio Clinico Spaee Università Cattolica del Sacro Cuore
ESPRESSIVITÀ DELLA VELOCITÀ DI LETTURA IN GIOVANI ADULTI: EFFETTI DI ALCUNE VARIABILI PSICOLINGUISTICHE Marisa Giorgetti 1, Pier Luigi Baldi 2 1 Servizio Clinico Spaee Università Cattolica del Sacro Cuore
Indicatori di rischio dei disturbi specifici di apprendimento M. Carmen Usai
 Indicatori di rischio dei disturbi specifici di apprendimento M. Carmen Usai DiSA - Polo M.T. Bozzo Ricerca e intervento sui disturbi del linguaggio e dell apprendimento Università di Genova I disturbi
Indicatori di rischio dei disturbi specifici di apprendimento M. Carmen Usai DiSA - Polo M.T. Bozzo Ricerca e intervento sui disturbi del linguaggio e dell apprendimento Università di Genova I disturbi
La dislessia disturbo specifico capacità di leggere decodifica criteri per l identificazione Ogni soggetto dislessico
 La dislessia La dislessia è un disturbo specifico di apprendimento (diffuso nel 2-2,5% circa della popolazione italiana) che riguarda fondamentalmente la capacità di leggere in modo corretto e fluente.
La dislessia La dislessia è un disturbo specifico di apprendimento (diffuso nel 2-2,5% circa della popolazione italiana) che riguarda fondamentalmente la capacità di leggere in modo corretto e fluente.
Un modello organizzativo autogestito
 26 Marzo 2012 Progetto sperimentale di individuazione precoce dei DSA nella prima classe della Scuola Primaria Un modello organizzativo autogestito Responsabile della formazione: Dott.ssa Barbara Peroni
26 Marzo 2012 Progetto sperimentale di individuazione precoce dei DSA nella prima classe della Scuola Primaria Un modello organizzativo autogestito Responsabile della formazione: Dott.ssa Barbara Peroni
APPRENDIMENTO E NEUROSCIENZE
 APPRENDIMENTO E NEUROSCIENZE Modello interattivo e multicomponenziale della compresione Eleonora Aliano Apprendimento e neuroscienze Apprendere: variare la struttura e l attività dei neuroni Ultime notizie
APPRENDIMENTO E NEUROSCIENZE Modello interattivo e multicomponenziale della compresione Eleonora Aliano Apprendimento e neuroscienze Apprendere: variare la struttura e l attività dei neuroni Ultime notizie
PROGETTO DI IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEL RISCHIO DIFFICOLTA DI LETTOSCRITTURA IN ETA PRESCOLARE
 PROGETTO DI IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEL RISCHIO DIFFICOLTA DI LETTOSCRITTURA IN ETA PRESCOLARE Dicembre 2015 C/o Centro Commerciale Azzurro II piano Via M. Moretti, 23 apprendiamorsm@gmail.com Progetto
PROGETTO DI IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEL RISCHIO DIFFICOLTA DI LETTOSCRITTURA IN ETA PRESCOLARE Dicembre 2015 C/o Centro Commerciale Azzurro II piano Via M. Moretti, 23 apprendiamorsm@gmail.com Progetto
Disturbi Specifici di Scrittura
 Disturbi Specifici di Scrittura e disturbi specifici della funzione motoria Il processo di scrittura Condivide con la lettura il nucleo essenziale del processo, Richiede un abilità grafica aggiuntiva Richiede
Disturbi Specifici di Scrittura e disturbi specifici della funzione motoria Il processo di scrittura Condivide con la lettura il nucleo essenziale del processo, Richiede un abilità grafica aggiuntiva Richiede
NORMAL AND PATHOLOGICAL PERFORMANCE IN A SERIAL LEARNING TEST. Salmaso, D., Scaglioni, A., Chiusa, M., Malvezzi, L., Caffarra, P.
 NORMAL AND PATHOLOGICAL PERFORMANCE IN A SERIAL LEARNING TEST. Salmaso, D., Scaglioni, A., Chiusa, M., Malvezzi, L., Caffarra, P. CNR-Istituto di Psicologia, Roma; Clinica Neurologica, Universita' di Parma;
NORMAL AND PATHOLOGICAL PERFORMANCE IN A SERIAL LEARNING TEST. Salmaso, D., Scaglioni, A., Chiusa, M., Malvezzi, L., Caffarra, P. CNR-Istituto di Psicologia, Roma; Clinica Neurologica, Universita' di Parma;
ETA DI ACQUISIZIONE DELLE PAROLE E DISTURBI ACQUISITI DEL LINGUAGGIO: UNA RASSEGNA WORD AGE-OF-ACQUISITION AND ACQUIRED LANGUAGE IMPAIRMENTS: A REVIEW
 ETA DI ACQUISIZIONE DELLE PAROLE E DISTURBI ACQUISITI DEL LINGUAGGIO: UNA RASSEGNA WORD AGE-OF-ACQUISITION AND ACQUIRED LANGUAGE IMPAIRMENTS: A REVIEW Laura Barca*^ e Cristina Burani* * Istituto di Psicologia,
ETA DI ACQUISIZIONE DELLE PAROLE E DISTURBI ACQUISITI DEL LINGUAGGIO: UNA RASSEGNA WORD AGE-OF-ACQUISITION AND ACQUIRED LANGUAGE IMPAIRMENTS: A REVIEW Laura Barca*^ e Cristina Burani* * Istituto di Psicologia,
PROGETTO CLIL 2017/2019 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Programma Operativo Fondo sociale europeo della Provincia autonoma di Trento
 PROGETTO 2017/2019 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Programma Operativo Fondo sociale europeo della Provincia autonoma di Trento 2014-2020 CRITERI DI VALUTAZIONE: I materiali prodotti saranno esaminati secondo
PROGETTO 2017/2019 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Programma Operativo Fondo sociale europeo della Provincia autonoma di Trento 2014-2020 CRITERI DI VALUTAZIONE: I materiali prodotti saranno esaminati secondo
OLTRE LA DIAGNOSI: VERSO UNA VALUTAZIONE CHE PERMETTA DI COMPRENDERE LA NATURA DELLE DIFFICOLTÀ E DI INDIVIDUARE LE PRIORITA PER UN INTERVENTO
 OLTRE LA DIAGNOSI: VERSO UNA VALUTAZIONE CHE PERMETTA DI COMPRENDERE LA NATURA DELLE DIFFICOLTÀ E DI INDIVIDUARE LE PRIORITA PER UN INTERVENTO LA VALUTAZIONE PER CERCARE UNA SPIEGAZIONE Per Vygotskij un
OLTRE LA DIAGNOSI: VERSO UNA VALUTAZIONE CHE PERMETTA DI COMPRENDERE LA NATURA DELLE DIFFICOLTÀ E DI INDIVIDUARE LE PRIORITA PER UN INTERVENTO LA VALUTAZIONE PER CERCARE UNA SPIEGAZIONE Per Vygotskij un
Introduzione. (Levi e Giardini, 1990)
 Introduzione Il disturbo specifico di apprendimento, pur non essendo considerato un disordine evolutivo particolarmente grave, essendo il suo nucleo centrale circoscritto alla sola abilità del leggere
Introduzione Il disturbo specifico di apprendimento, pur non essendo considerato un disordine evolutivo particolarmente grave, essendo il suo nucleo centrale circoscritto alla sola abilità del leggere
Consistenza ortografico-semantica:
 Consistenza ortografico-semantica: EFFETTI DI TRASPARENZA SEMANTICA IN PAROLE MORFOLOGICAMENTE SEMPLICI? Marco Marelli, Simona Amenta, Davide Crepaldi Masked-priming in morfologia TARGET Condizione trasparente
Consistenza ortografico-semantica: EFFETTI DI TRASPARENZA SEMANTICA IN PAROLE MORFOLOGICAMENTE SEMPLICI? Marco Marelli, Simona Amenta, Davide Crepaldi Masked-priming in morfologia TARGET Condizione trasparente
CURRICOLO VERTICALE ITALIANO
 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo R. Franceschi Via Concordia, 2/4-20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Tel. 02 48 40 20 46 - Fax 02 48 49 01 97 E-mail: segreteria@icfranceschi.gov.it
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo R. Franceschi Via Concordia, 2/4-20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Tel. 02 48 40 20 46 - Fax 02 48 49 01 97 E-mail: segreteria@icfranceschi.gov.it
3 LEZIONE. I MODELLI DI APPRENDIMENTO DELLA LETTURA E LA DISLESSIA: DALLO SCREENING PRECOCE ALLA DIAGNOSI
 3 LEZIONE. I MODELLI DI APPRENDIMENTO DELLA LETTURA E LA DISLESSIA: DALLO SCREENING PRECOCE ALLA DIAGNOSI Introduzione L obiettivo di questo capitolo e dei prossimi, è quello di comprendere ed analizzare
3 LEZIONE. I MODELLI DI APPRENDIMENTO DELLA LETTURA E LA DISLESSIA: DALLO SCREENING PRECOCE ALLA DIAGNOSI Introduzione L obiettivo di questo capitolo e dei prossimi, è quello di comprendere ed analizzare
CURRICOLO VERTICALE ITALIANO
 ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO GALLIATE Scuola Primaria CURRICOLO VERTICALE ITALIANO CLASSE PRIMA ASCOLTO E PARLATO L allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o
ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO GALLIATE Scuola Primaria CURRICOLO VERTICALE ITALIANO CLASSE PRIMA ASCOLTO E PARLATO L allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o
Atti del congresso SIPF05. XIII Congresso Nazionale S. I. P. F. (Società Italiana di Psicofisiologia), 2-4 Dicembre 2005, Marina di Carrara (Italia).
 Atti del congresso SIPF05 XIII Congresso Nazionale S. I. P. F. (Società Italiana di Psicofisiologia), 2-4 Dicembre 2005, Marina di Carrara (Italia). Test Diretto Di Lettura e Scrittura (TDLS): IDENTIFICAZIONE
Atti del congresso SIPF05 XIII Congresso Nazionale S. I. P. F. (Società Italiana di Psicofisiologia), 2-4 Dicembre 2005, Marina di Carrara (Italia). Test Diretto Di Lettura e Scrittura (TDLS): IDENTIFICAZIONE
DSA in adulti (quesiti B) Es. B1 quali e quanti i parametri per la diagnosi negli adolescenti e adulti (tempo, velocità, accuratezza...)?
 PARCC Panel di Aggiornamento e Revisione della Consensus Conference DSA febbraio 2011 Raccomandazioni cliniche sui DSA Risposte ai quesiti Documento d'intesa DSA adulti Trattazioni inerenti genetica, visione,
PARCC Panel di Aggiornamento e Revisione della Consensus Conference DSA febbraio 2011 Raccomandazioni cliniche sui DSA Risposte ai quesiti Documento d'intesa DSA adulti Trattazioni inerenti genetica, visione,
Pratiche didattiche nell insegnamento dell inglese ad alunni con DSA
 Pratiche didattiche nell insegnamento dell inglese ad alunni con DSA BIENNIO DELLA SCUOLA SUPERIORE 1 Premessa L efficacia dell insegnamento dipende da tre aspetti: La conoscenza delle caratteristiche
Pratiche didattiche nell insegnamento dell inglese ad alunni con DSA BIENNIO DELLA SCUOLA SUPERIORE 1 Premessa L efficacia dell insegnamento dipende da tre aspetti: La conoscenza delle caratteristiche
Lo screening precoce nella scuola elementare
 G. STELLA E A. APOLITO Lo screening precoce nella scuola elementare Lo screening precoce nella scuola elementare Può una prova di 16 parole prevedere i disturbi specifici di apprendimento? Giacomo Stella
G. STELLA E A. APOLITO Lo screening precoce nella scuola elementare Lo screening precoce nella scuola elementare Può una prova di 16 parole prevedere i disturbi specifici di apprendimento? Giacomo Stella
Profili di lettura in bambini italiani con DSA
 Imparare: questo è il problema Sistemi ortografici e dislessia S. Marino, 15-16 settembre 2006 Profili di lettura in bambini italiani con DSA Roberta Penge Università di Roma La Sapienza Dipartimento Scienze
Imparare: questo è il problema Sistemi ortografici e dislessia S. Marino, 15-16 settembre 2006 Profili di lettura in bambini italiani con DSA Roberta Penge Università di Roma La Sapienza Dipartimento Scienze
Susi Cazzaniga, Rosanna Ferrara. Dalla valutazione alla riabilitazione: percorsi virtuosi nei disturbi di scrittura
 Susi Cazzaniga, Rosanna Ferrara Dalla valutazione alla riabilitazione: percorsi virtuosi nei disturbi di scrittura Step per la valutazione Step per il percorso riabilitativo Valutazione: strumenti di diagnosi
Susi Cazzaniga, Rosanna Ferrara Dalla valutazione alla riabilitazione: percorsi virtuosi nei disturbi di scrittura Step per la valutazione Step per il percorso riabilitativo Valutazione: strumenti di diagnosi
ARIEE. Associazione Ricerca ed Intervento in Età Evolutiva SOFTWARE READER MANUALE DI ISTRUZIONI
 ARIEE Associazione Ricerca ed Intervento in Età Evolutiva SOFTWARE READER MANUALE DI ISTRUZIONI 1 Reader è un software che serve per la riabilitazione della velocità e correttezza di lettura (lozzino e
ARIEE Associazione Ricerca ed Intervento in Età Evolutiva SOFTWARE READER MANUALE DI ISTRUZIONI 1 Reader è un software che serve per la riabilitazione della velocità e correttezza di lettura (lozzino e
Modelli di valutazione e intervento nei disturbi dell espressione scritta
 Modelli di valutazione e intervento nei disturbi dell espressione scritta Barbara Arfé Università degli Studi di Padova In collaborazione con: Eleonora Pizzoccaro Anna Merella Elisa Cona M.R Russo Centro
Modelli di valutazione e intervento nei disturbi dell espressione scritta Barbara Arfé Università degli Studi di Padova In collaborazione con: Eleonora Pizzoccaro Anna Merella Elisa Cona M.R Russo Centro
MODELLI NEUROPSICOLOGICI DELLA LETTURA
 MODELLI NEUROPSICOLOGICI DELLA LETTURA La neuropsicologia cognitiva, nell ambito di un approccio modulare all organizzazione delle funzioni cognitive, consente di isolare le funzione che compongono un
MODELLI NEUROPSICOLOGICI DELLA LETTURA La neuropsicologia cognitiva, nell ambito di un approccio modulare all organizzazione delle funzioni cognitive, consente di isolare le funzione che compongono un
Modello di lettura a due vie - Sartori 1984
 Che cos è la lettura? Per lettura si intende un processo che consente di comprendere un testo scritto. E il risultato di una serie di processi complessi, che comprendono: un attività di decodifica o transcodifica;
Che cos è la lettura? Per lettura si intende un processo che consente di comprendere un testo scritto. E il risultato di una serie di processi complessi, che comprendono: un attività di decodifica o transcodifica;
Pratica pedagogica: trattamento del. disturbo specifico dell apprendimento
 La dislessia da ogni punto di vista Genova 19 novembre 2011 dott.ssa Emilia Restani- Pratica pedagogica: trattamento del disturbo specifico dell apprendimento Consensus Conference (genn. 2007) DSA Nonostante
La dislessia da ogni punto di vista Genova 19 novembre 2011 dott.ssa Emilia Restani- Pratica pedagogica: trattamento del disturbo specifico dell apprendimento Consensus Conference (genn. 2007) DSA Nonostante
DALLA PAROLA E DAL GESTO GRAFICO ALLA LETTO-SCRITTURA
 Centro Territoriale per l Inclusione TREVISO SUD PROGETTO SCUOLA DELL INFANZIA DALLA PAROLA E DAL GESTO GRAFICO ALLA LETTO-SCRITTURA Logopedista L. Di Natale Az. ULSS 2 Marca Trevigiana 29 maggio 1017
Centro Territoriale per l Inclusione TREVISO SUD PROGETTO SCUOLA DELL INFANZIA DALLA PAROLA E DAL GESTO GRAFICO ALLA LETTO-SCRITTURA Logopedista L. Di Natale Az. ULSS 2 Marca Trevigiana 29 maggio 1017
L apprendimento disturbato: i disturbi di apprendimento specifici nella scuola secondaria di I grado
 L apprendimento disturbato: i disturbi di apprendimento specifici nella scuola secondaria di I grado Giacomo Stella Università di Modena e Reggio Emilia Associazione Italiana Dislessia La dislessia è una
L apprendimento disturbato: i disturbi di apprendimento specifici nella scuola secondaria di I grado Giacomo Stella Università di Modena e Reggio Emilia Associazione Italiana Dislessia La dislessia è una
PROGETTAZIONE DISCIPLINARE
 PROGETTAZIONE DISCIPLINARE ITALIANO classe 2^ PER ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE 1 bim. 2 bim. 3 bim. 4 bim. 1a) Attenzione entro i tempi richiesti. 1b) Ascolto e intervento nelle conversazioni
PROGETTAZIONE DISCIPLINARE ITALIANO classe 2^ PER ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE 1 bim. 2 bim. 3 bim. 4 bim. 1a) Attenzione entro i tempi richiesti. 1b) Ascolto e intervento nelle conversazioni
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI SCREENING
 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI SCREENING Dott.ssa Isabella Bellagamba Psicologa psicoterapeuta dell età evolutiva isabellabellagamba@libero.it www.psicoterapiainfanziaeadolescenza.it COSA VUOL DIRE SCREENING!
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI SCREENING Dott.ssa Isabella Bellagamba Psicologa psicoterapeuta dell età evolutiva isabellabellagamba@libero.it www.psicoterapiainfanziaeadolescenza.it COSA VUOL DIRE SCREENING!
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO e la motivazione dell intervento precoce
 TUTTI A BORDO! PROGETTO IRIDE DI INTERCETTAZIONE PRECOCE IN RETE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO e la motivazione dell intervento precoce Dr.ssa Campioni Annamaria
TUTTI A BORDO! PROGETTO IRIDE DI INTERCETTAZIONE PRECOCE IN RETE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO e la motivazione dell intervento precoce Dr.ssa Campioni Annamaria
Lettura, dislessia e difficoltà di comprensione del testo. Il progetto MT Scuola
 Associazione Italiana per la Ricerca e l Intervento nella Psicopatologia Lettura, dislessia e difficoltà di comprensione del testo. Il progetto MT Scuola Barbara Carretti Università degli Studi di Padova
Associazione Italiana per la Ricerca e l Intervento nella Psicopatologia Lettura, dislessia e difficoltà di comprensione del testo. Il progetto MT Scuola Barbara Carretti Università degli Studi di Padova
Difficoltà e disturbo di espressione scritta
 Barbara Arfé DPSS, Università di Padova Difficoltà e disturbo di espressione scritta Difficoltà e disturbi dell'apprendimento: aspetti educativi scolastici e abilitativi Disturbi dell espressione scritta?
Barbara Arfé DPSS, Università di Padova Difficoltà e disturbo di espressione scritta Difficoltà e disturbi dell'apprendimento: aspetti educativi scolastici e abilitativi Disturbi dell espressione scritta?
Cornice teorica di riferimento:
 RELAZIONE SECONDO ANNO SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE UMANE INDIRIZZO: Psicologia, antropologia e storia del mondo moderno e contemporaneo Titolo della Ricerca: Dall analisi visiva all attribuzione del
RELAZIONE SECONDO ANNO SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE UMANE INDIRIZZO: Psicologia, antropologia e storia del mondo moderno e contemporaneo Titolo della Ricerca: Dall analisi visiva all attribuzione del
SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA ITALIANO CLASSE PRIMA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO. Micro- obiettivi
 SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA ITALIANO CLASSE PRIMA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Nuclei Macro- obiettivi al termine della classe terza Ascolto e parlato Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA ITALIANO CLASSE PRIMA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Nuclei Macro- obiettivi al termine della classe terza Ascolto e parlato Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
I precursori della lettura e della scrittura
 I precursori della lettura e della scrittura Scuola dell infanzia e primaria: una rilevazione comune Anno scolastico 2015/16 Lo strumento di rilevazione Il portfolio della prima alfabetizzazione Il portfolio
I precursori della lettura e della scrittura Scuola dell infanzia e primaria: una rilevazione comune Anno scolastico 2015/16 Lo strumento di rilevazione Il portfolio della prima alfabetizzazione Il portfolio
LA DIDATTICA EFFICACE PER L INSEGNAMENTO DELLA LETTURA
 LA DIDATTICA EFFICACE PER L INSEGNAMENTO DELLA LETTURA Luciana Ventriglia Docente con perfezionamento sul lavoro clinico nelle difficoltà di apprendimento Aspettative alunni Da una indagine durata dieci
LA DIDATTICA EFFICACE PER L INSEGNAMENTO DELLA LETTURA Luciana Ventriglia Docente con perfezionamento sul lavoro clinico nelle difficoltà di apprendimento Aspettative alunni Da una indagine durata dieci
Lab.D.A. Laboratorio sui Disturbi dell Apprendimento Galleria Berchet, 3 Padova Direttore: Prof. Cesare Cornoldi
 Lab.D.A. Laboratorio sui Disturbi dell Apprendimento Galleria Berchet, 3 Padova Direttore: Prof. Cesare Cornoldi Batteria MT 16-19 BATTERIA PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI DI LETTURA E SCRITTURA E
Lab.D.A. Laboratorio sui Disturbi dell Apprendimento Galleria Berchet, 3 Padova Direttore: Prof. Cesare Cornoldi Batteria MT 16-19 BATTERIA PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI DI LETTURA E SCRITTURA E
Istituto comprensivo di Villongo. 24 ottobre 2011
 Istituto comprensivo di Villongo 24 ottobre 2011 È una difficoltà selettiva nella lettura in presenza di capacità cognitive adeguate e di adeguate opportunità sociali e relazionali, in assenza di deficit
Istituto comprensivo di Villongo 24 ottobre 2011 È una difficoltà selettiva nella lettura in presenza di capacità cognitive adeguate e di adeguate opportunità sociali e relazionali, in assenza di deficit
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO
 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO CLASSE PRIMA OBIETTIVI 1. PRODUZIONE E COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE: ASCOLTARE, COMPRENDERE, PARLARE 1.1 Ascoltare e comprendere semplici messaggi 1.2 Ascoltare
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO CLASSE PRIMA OBIETTIVI 1. PRODUZIONE E COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE: ASCOLTARE, COMPRENDERE, PARLARE 1.1 Ascoltare e comprendere semplici messaggi 1.2 Ascoltare
Bambini sordi e udenti a scuola La LIS come strumento di inclusione e di apprendimento
 Bambini sordi e udenti a scuola La LIS come strumento di inclusione e di apprendimento MARIA CRISTINA CASELLI ISTC-CNR Quanti bambini nascono sordi? 1/1000 nascono sordi Solo il 5-10% di bambini sordi
Bambini sordi e udenti a scuola La LIS come strumento di inclusione e di apprendimento MARIA CRISTINA CASELLI ISTC-CNR Quanti bambini nascono sordi? 1/1000 nascono sordi Solo il 5-10% di bambini sordi
