ACCESSO LESSICALE E LETTURA AD ALTA VOCE: IL RUOLO DELLE COMPONENTI MORFOLOGICHE DELLE PAROLE
|
|
|
- Lucio Riccardi
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 ACCESSO LESSICALE E LETTURA AD ALTA VOCE: IL RUOLO DELLE COMPONENTI MORFOLOGICHE DELLE PAROLE DANIELA TRAFICANTE, LAURA BARCA E CRISTINA BURANI Università Cattolica di Milano, Università di Roma «La Sapienza» e Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR, Roma Riassunto. In questo lavoro viene esaminato il ruolo della numerosità del paradigma flessivo nel determinare l accesso lessicale visivo e la lettura di verbi e aggettivi italiani, in condizioni di lista mista e bloccata. Sono stati predisposti due esperimenti: un compito di decisione lessicale (Esperimento 1) e un compito di lettura ad alta voce veloce (Esperimento 2). In entrambi i verbi hanno fatto registrare tempi di reazione più lenti degli aggettivi, sebbene gli stimoli fossero pareggiati per le più rilevanti variabili psicolinguistiche. Le analisi correlazionali condotte post-hoc hanno manifestato effetti significativi della frequenza della radice solo per i verbi, ed effetti più rilevanti della frequenza della parola intera per gli aggettivi rispetto ai verbi. Non è stato rilevato alcun effetto di lista. Questi risultati sono prova del fatto che un alto numero di forme flesse favorisce l accesso tramite rappresentazioni morfemiche, mentre un paradigma flessivo numericamente limitato induce preferenzialmente una modalità di accesso tramite parola intera. INTRODUZIONE Un numero consistente di dati sperimentali avvalora l ipotesi che un lettore esperto utilizzi i costituenti morfologici delle parole per accedere al loro significato e per organizzarne la rappresentazione nel lessico mentale (cfr. Feldman, 1995). D altra parte, esistono riscontri circa l importanza della frequenza d uso della parola intera, per cui se due parole condividono la stessa radice, è probabile che venga riconosciuta più velocemente quella la cui forma intera presenta un maggior numero di occorrenze e ciò deporrebbe a favore dell utilizzo di rappresentazioni globali delle parole nel processo di riconoscimento delle stesse (Burani, Salmaso e Caramazza, 1984; Katz, Rexer e Lukatela, 1991; Sereno e Jongman, 1997). Sulla base di simili dati sperimentali, sono stati elaborati modelli di riconoscimento di parole singole che prevedono due modalità di elaborazione degli stimoli percepiti visivamente: una che si basa sulla parola intera, più rapida e diretta, e una che utilizza la rappresentazione della radice e degli affissi separatamente, più lenta perché implicherebbe fasi di scomposizione e di verifica della plausibilità della combinazione radice + affisso (ad esempio, «parle», pur essendo costituito GIORNALE ITALIANO DI PSICOLOGIA / a. XXXI, n. 4, dicembre
2 da una radice (parl-) e da un suffisso (-e) reali, non è una parola). Tra i modelli che prevedono entrambe le modalità di accesso al lessico mentale, particolare rilevanza hanno assunto l AAM (Augmented Addressed Morphology) (Burani e Caramazza, 1987; Caramazza, Laudanna e Romani, 1988; Chialant e Caramazza, 1995) e il Race model di Schreuder e Baayen (Schreuder e Baayen, 1995; Baayen e Schreuder, 1999; Baayen, Schreuder e Sproat, 2000). Nell AAM la decomposizione morfemica è considerata una procedura «ausiliaria» che viene attivata soltanto per parole rare, neologismi e pseudoparole, cioè per stimoli che, non avendo una propria rappresentazione d accesso di tipo globale, possono essere decodificati a partire dalle rappresentazioni dei morfemi in essi contenuti. Il Race model prevede, invece, l attivazione automatica sia di componenti morfemiche sia di parole intere di fronte a qualsiasi tipo di stimolo: a partire dall attivazione di tali rappresentazioni si innescherebbero sia la procedura d accesso diretta (direct-route) sia quella basata su regole di decomposizione-ricomposizione (parsing-route). Questo modello, quindi, non prevede, in modo deterministico, l utilizzo di una particolare procedura in funzione di uno specifico tipo di stimolo. Esso si configura piuttosto come un modello stocastico, per cui la probabilità di successo di una via a scapito dell altra dipenderebbe dai costi e dai benefici ad essa associati. I benefici si riferiscono essenzialmente alla velocità di attivazione delle rappresentazioni utilizzate, dovuta alla frequenza d uso di queste (siano esse la parola intera o i costituenti morfologici). I costi invece si riferiscono esclusivamente all utilizzo della via morfo-lessicale; essi riflettono il tempo necessario per attuare le procedure di controllo della legalità della combinazione radice + affissi attivati e di combinazione del significato della parola intera a partire da quello delle singole componenti. Sulla base del Race model, ad esempio, si può prevedere che parole usate poco frequentemente che contengono però radici molto frequenti (es. «chiamaste») saranno con maggiore probabilità riconosciute su base morfemica (attraverso la parsing route), dato che il vantaggio derivante dall utilizzo di rappresentazioni morfemiche molto frequenti (es. «chiam-») sarà tale da compensare i costi di elaborazione derivanti dal controllo della liceità della combinazione di radice + affisso. Nel caso in cui, invece, la radice non sia sufficientemente frequente da indurre tale vantaggio, è probabile che il riconoscimento derivi dalla via diretta (direct route), basata sull utilizzo della parola intera (per ipotesi simili, si vedano Burani e Laudanna, 1992; Burani e Thornton, 2003; Chialant e Caramazza, 1995). Per verificare l adeguatezza di questa classe di modelli risultano particolarmente interessanti i risultati di ricerche condotte su lingue con una morfologia che prevede paradigmi flessivi costituiti da nume- 872
3 rose forme contenenti la stessa radice. In questi casi è più facile trovare parole in cui il divario tra frequenza della parola e frequenza della radice sia rilevante. I dati sperimentali ottenuti in lingue morfologicamente ricche, quali l ebraico, il serbo-croato e lo stesso italiano, indicano che, a parità di una serie di altre proprietà, quanto più ampio è il paradigma flessivo di una determinata categoria grammaticale, tanto maggiore è la probabilità di elaborazione morfologica (Deutsch, Frost e Forster, 1998; Kostic e Katz, 1987; Laudanna, Voghera e Gazzellini, 2002). I dati ottenuti con la lingua finlandese, che presenta un sistema flessivo con centinaia di forme flesse, hanno dimostrato che l utilizzo della scomposizione morfemica comporta generalmente un rallentamento nel processo di riconoscimento di parole flesse rispetto a parole monomorfemiche pareggiate alle prime per le principali variabili psicolinguistiche (cfr. Laine, Vainio e Hyönä, 1999). Tali risultati comprovano l esistenza di costi di elaborazione nel caso in cui sia utilizzata una procedura di parsing morfemico e avvalorano il modello proposto da Niemi, Laine e Tuominen (1994), il SAID (Stem Allomorph/Inflectional Decomposition), che prevede una procedura di scomposizione automatica per tutte le parole flesse polimorfemiche. Tale modello si differenzia, pertanto, sia dall AAM, che, come si è detto sopra, considera la scomposizione una procedura ausiliaria, sia dal Race model, che assume una prospettiva probabilistica. Per quanto riguarda l italiano, sulla base del SAID ci si potrebbe attendere che i nomi, gli aggettivi e i verbi italiani vengano riconosciuti attraverso scomposizione in radice e suffisso flessivo e che, di conseguenza, i tempi di risposta siano determinati prevalentemente dalla frequenza della radice in essi contenuta. I dati ottenuti da Baayen, Burani e Schreuder (1997) su nomi singolari e plurali non sembrano però confermare completamente questa previsione: i plurali di nomi semplici con plurale «dominante» (plural dominant; ad es. «baffi», «reni», «stivali», ecc.) manifestano principalmente effetti della frequenza della parola intera, avvalorando l ipotesi dell utilizzo di rappresentazioni globali anche per parole polimorfemiche. In un recente lavoro Traficante e Burani (2003) hanno rilevato che gli aggettivi vengono riconosciuti più rapidamente dei verbi (pareggiati ai primi per le più rilevanti variabili psicolinguistiche) e le analisi correlazionali post-hoc hanno fatto ipotizzare che mentre il riconoscimento di aggettivi avverrebbe essenzialmente tramite rappresentazioni corrispondenti alla parola intera, per i verbi potrebbero giocare un ruolo più rilevante le rappresentazioni di tipo morfemico, in particolare la radice. È interessante notare che la differenza tra verbi e aggettivi si riscontra non solo in un compito come la decisione lessicale, che induce l attivazione di informazioni semantiche, ma anche nel compito di identificazione della parola tramite «smascheramento progressi- 873
4 vo» (progressive demasking), che dovrebbe cogliere fasi più periferiche del processo di riconoscimento ed essere quindi più influenzato da aspetti ortografici e percettivi, senza implicare necessariamente un accesso al significato (Schreuder e Baayen, 1997). Secondo Traficante e Burani questi dati sperimentali riflettono l influenza di una variabile morfologica specifica, cioè la diversa numerosità delle forme flesse presenti nel paradigma di aggettivi e verbi. Tale variabile inciderebbe sull individuazione della radice come rappresentazione isolabile dagli affissi: a parità di una serie di altre proprietà, quanto più ampio è il paradigma flessivo, tanto maggiore è la probabilità che la parola venga elaborata in costituenti morfologici. In italiano, aggettivi e verbi hanno paradigmi flessivi di ampiezza diversa. Mentre gli aggettivi prendono da due a quattro flessioni diverse (indicanti genere e numero), i verbi hanno un paradigma flessivo molto più ampio, caratterizzato da circa 50 flessioni in media. In compiti di riconoscimento di parole, questa diversa ampiezza del paradigma flessivo comporterebbe una maggiore probabilità, per i verbi, di venire elaborati mediante attivazione della radice: la radice verbale costituirebbe una unità di processing più saliente e disponibile, occorrendo in un numero più alto di combinazioni flessive. La probabilità di elaborazione morfologica sarebbe invece minore per gli aggettivi, riconosciuti prevalentemente come parole intere. Il ruolo dell ampiezza del paradigma flessivo è stato confermato da Colombo e Burani (2002) confrontando i verbi con i nomi, che hanno un paradigma flessivo di ampiezza analoga a quello degli aggettivi: anche l accesso lessicale ai nomi sembra maggiormente influenzato dalla frequenza della forma intera, mentre i verbi sono più sensibili alla frequenza della radice. Colombo e Burani (2002) hanno esteso l indagine al compito di lettura veloce ad alta voce, trovando risultati analoghi a quelli della decisione lessicale: anche la prestazione in lettura è influenzata per i nomi dalle caratteristiche della parola intera, per i verbi maggiormente dalla frequenza della radice. La procedura di lettura sembra dunque implicare un ricorso alla segmentazione morfologica nel caso dei verbi, ma non dei nomi. In un modello della lettura ad alta voce a due vie (cfr. Coltheart, Rastle, Perry, Langdon e Ziegler, 2001) si potrebbe quindi ipotizzare, in parallelo con la lettura non-lessicale per regola, l attivazione di una via di lettura lessicale basata non solo sulla parola intera, ma anche sull attivazione dei morfemi costituenti. Nel compito di lettura, nel quale non c è necessità di verificare la legittimità della combinazione radice-suffisso, dato che non si tratta di decidere ma solo di pronunciare ad alta voce il più velocemente possibile recuperando i costituenti morfologici dal lessico, i costi derivanti dal parsing potrebbero ridursi. Se invece la procedura di parsing comporta costi in fasi di elaborazione quali la segmentazione o la ri- 874
5 combinazione dei due elementi costituenti lo stimolo, potrebbe aversi di nuovo un rallentamento dei verbi rispetto agli aggettivi. Tutti questi dati fanno ipotizzare che le procedure di scomposizione si inneschino con maggiori probabilità nel caso di parole che fanno parte di paradigmi flessivi molto articolati, ipotesi avvalorata anche dai dati sul finlandese. L effetto di rallentamento dovuto alla scomposizione morfemica sembra essere influenzato però dal contesto in cui le parole sono presentate. Hyönä, Vainio e Laine (2002) fanno notare che nel primo esperimento di Laine et al. (1999), in cui le parole con suffisso flessivo costituivano il 46% della lista di stimoli, il rallentamento per le parole flesse rispetto a quelle monomorfemiche era di 106 ms. Nel secondo esperimento dello stesso lavoro, in cui la percentuale di parole flesse o pseudoflesse era del 92%, la penalizzazione per le parole flesse scendeva a 47 ms. Un contesto di lista che favorisca l utilizzazione di una procedura morfologica omogenea potrebbe dunque limitare i costi associati al parsing. Nel presente lavoro intendiamo considerare nuovamente il confronto tra verbi e aggettivi per valutare se gli effetti presenti in decisione lessicale siano generalizzabili al compito di lettura e per indagare eventuali effetti del contesto di lista. ESPERIMENTO 1 Partecipanti METODO Hanno partecipato all esperimento 46 studenti dell Università Cattolica di Milano. Ciascun partecipante ha visto tutti gli item una volta sola, metà in condizione di lista bloccata (solo verbi o solo aggettivi) e metà in condizione di lista mista (metà verbi e metà aggettivi). Stimoli Sono stati selezionati 20 verbi e 20 aggettivi costituiti da radice + suffisso flessivo monovocalico (es. «corr-o»; «bell-o»). I due gruppi di stimoli sono stati pareggiati per le variabili psicolinguistiche più rilevanti 1, i cui valori sono riportati nella tabella 1. 1 Per ciascuna variabile è stato effettuato un test t per confrontare le due medie e nessuno di essi è risultato significativo. 875
6 TAB. 1. Statistiche descrittive delle principali variabili psicolinguistiche considerate nella selezione degli stimoli sperimentali (N = 20) Aggettivi Verbi Variabile min max media dev.st. min max media dev. st. Frequenza della parola a Frequenza della radice b Frequenza cumulata c Concretezza d Immaginabilità d Lunghezza in lettere Lunghezza in sillabe Frequenza dei bigrammi e Note a Tutti i valori di frequenza sono ricavati dal formario dell Istituto di Linguistica Computazionale del CNR di Pisa (1989), su un totale di 1,5 milioni di occorrenze. b La frequenza della radice è stata ottenuta sommando la frequenza delle diverse forme flesse dello stesso lemma. c La frequenza cumulata è stata ottenuta sommando la frequenza di tutte le parole flesse e derivate che condividono la stessa radice. d I valori di concretezza e di immaginabilità sono stati ottenuti tramite rating scales a 7 punti sottoposte a due gruppi distinti di 25 persone, pareggiati per età e livello d istruzione ai partecipanti ai due esperimenti. e Frequenza media dei bigrammi che compongono la parola, trasformata sulla base del logaritmo naturale. Sono state selezionate anche 80 parole-filler, metà verbi e metà aggettivi, con suffisso flessivo monovocalico e di frequenza simile agli stimoli sperimentali, e 120 pseudoparole, ricavate da parole di lunghezza e frequenza simile agli stimoli sperimentali, cambiando una lettera o nella parte iniziale o nella parte finale della parola e mantenendo le caratteristiche fonotattiche della lingua italiana. Tutte le pseudoparole terminavano con vocali uguali ai suffissi flessivi delle parole e nel 20% dei casi contenevano una radice reale. Procedura È stato utilizzato un compito di decisione lessicale, gestito dal programma MEL 2.1 su PC IBM 486. Ciascuna lista di stimoli (fillers, aggettivi e verbi sperimentali, pseudoparole) è stata suddivisa in 2 parti e combinata in modo da ottenere 2 elenchi di stimoli in condizione mista e 2 elenchi in condizione bloccata. L ordine di presentazione degli elenchi di stimoli è stato variato sistematicamente, in modo che ciascun partecipante vedesse metà degli aggettivi in condizione mista e metà in condizione bloccata e altrettanto avvenisse per i 876
7 verbi, mentre l ordine degli stimoli era completamente randomizzato. I fillers precedevano sempre gli stimoli sperimentali, per creare l effetto di lista. La sequenza sperimentale prevedeva la presentazione di un punto di fissazione (+) al centro del video per 150 ms, seguito dopo 300 ms dallo stimolo su cui il partecipante doveva produrre la risposta (PAROLA o NON PAROLA), premendo uno dei due tasti collegati al computer. RISULTATI E DISCUSSIONE Dall analisi dei tempi di reazione e degli errori, «per soggetti» e «per parole», è stato eliminato il verbo «mormora», associato a un tempo di reazione superiore a 2.5 d.s. rispetto alla media generale. La lista di verbi è risultata comunque ancora bilanciata rispetto a quella degli aggettivi per le variabili considerate. I tempi di riconoscimento dei verbi sono significativamente più lunghi rispetto agli aggettivi (tabella 2), sia «per soggetti» che «per parole» 2 [F1(1,45) = 29.07, p <.001, MSe = ; F2(1,37) = 6.19, p <.02, MSe = ]. La composizione della lista, invece, non manifesta effetti significativi sui tempi di reazione, né risulta significativa l interazione tra categoria grammaticale e composizione della lista. Per quanto riguarda gli errori, non solo si nota che gli aggettivi sono associati a un maggiore livello di correttezza rispetto ai verbi, sia «per soggetti» sia «per parole» [F1(1,45) = 37.15, p <.001, MSe = 0.87; F2(1,37) = 5.31, p <.05, MSe = 9.85], ma anche che la condizione di lista bloccata determina livelli di correttezza maggiore rispetto a quella di lista mista [F1(1,45) = 12.04, p <.001, MSe = 0.62; F2(1,37) = 5.09, p <.05, MSe = 2.01]. L interazione non è però significativa. I risultati mostrano dunque che, a parità dei diversi fattori che potrebbero influire sul processo di riconoscimento, quest ultimo è più lento e difficile per i verbi rispetto agli aggettivi in entrambe le condizioni di lista. La composizione della lista incide solo sulla correttezza delle risposte. 2 In entrambi gli esperimenti, le ANOVA «per soggetti» sono su misure ripetute 2 (categoria) 2 (condizione di lista). Inoltre, poiché ogni soggetto vedeva soltanto metà degli stimoli, si avevano due gruppi di soggetti: quelli che vedevano la prima parte della lista di stimoli in condizione mista e l altra in condizione bloccata e quelli che vedevano gli stessi stimoli, ma in condizione opposta. Per questa caratteristica dell esperimento, si è introdotto il fattore «gruppo» come covariata. Per le ANOVA «per parole», si è condotta un analisi di tipo misto, con un fattore ripetuto (condizione di lista) e uno indipendente (categoria). Anche in questo caso la composizione dell elenco di stimoli è stata controllata introducendo la covariata «elenco». 877
8 TAB. 2. Esperimento 1. Compito di decisione lessicale: media («per parole») dei tempi di reazione, deviazioni standard e percentuale d errore in risposta a verbi e aggettivi, in condizione di lista mista e bloccata Lista mista Lista bloccata Verbi Aggettivi Diff. Verbi Aggettivi Diff. T.R. media (ms) d.s Errori % Sono state condotte delle analisi correlazionali separate fra ciascuna delle variabili caratterizzanti gli stimoli sperimentali e le due variabili dipendenti, tempi di reazione ed errori. Dall analisi correlazionale emerge che mentre per gli aggettivi l unica correlazione significativa è quella fra tempo di reazione nella condizione mista e frequenza della parola intera 3 (r = 0.51, p <.05), per i verbi, in entrambe le condizioni, il tempo di reazione correla sia con la frequenza della parola (lista mista: r =.40, p <.05; lista bloccata: r =.55, p < 01) sia con la frequenza cumulata della radice (lista mista: r =.40, p <.05; lista bloccata: r =.38, p <.05). Infine, per i verbi, la frequenza cumulata della radice è correlata significativamente con il numero di errori nella condizione di lista mista (r =.53, p <.05). I dati ottenuti confermano quelli rilevati precedentemente da Traficante e Burani (2003) e da Colombo e Burani (2002), e avvalorano l ipotesi che i verbi vengano riconosciuti tramite una procedura di scomposizione con maggiore probabilità rispetto agli aggettivi. Questi effetti corrispondono solo parzialmente a quelli riscontrati con una lingua morfologicamente ricca come il finlandese. Prima di tutto, la differenza tra verbi e aggettivi non è spiegabile sulla base del SAID (Niemi et al., 1994), secondo il quale tutte le forme flesse dovrebbero essere sottoposte automaticamente alla stessa procedura di scomposizione-ricomposizione morfemica. Dai tempi di reazione rilevati con gli aggettivi rispetto ai verbi sia in questo esperimento che nel precedente di Traficante e Burani (2003), si può invece ipotizzare che per gli aggettivi, così come per i nomi (Colombo e Burani, 2002) e in particolare per determinate forme plurali (Baayen et al., 1997), nonostante la complessità morfologica il lettore esperto utilizzi prevalentemente una via diretta, basata sulla parola intera. Inoltre, a differenza dei dati sul finlandese, l entità del divario tra 3 Frequenza della parola con trasformazione logaritmica. 878
9 verbi e aggettivi non cambia al mutare della composizione della lista: si passa da una differenza di 38 ms in condizione mista a una differenza di 31 ms in condizione bloccata. Occorre comunque notare che queste differenze sono molto inferiori rispetto a quelle riportate dagli studi finlandesi e questo indica che le diversità tra parole monomorfemiche e parole flesse finlandesi sono molto più marcate rispetto alle diversità tra verbi e aggettivi italiani, entrambi polimorfemici. Per spiegare i nostri dati sembra dunque più plausibile un modello in cui entrambe le procedure, sia quella diretta sia quella di scomposizionericomposizione, intervengano parallelamente per entrambi i tipi di parole. Dal lavoro precedente di Traficante e Burani (2003) emergeva che la differenza di elaborazione tra verbi e aggettivi non era specificamente imputabile a fasi del processo di decisione, quali il controllo della liceità della combinazione tra radice e suffisso o la computazione del significato. I costi del parsing erano infatti riscontrabili già in fasi precoci di identificazione dello stimolo, quali quelle evidenziate dal progressive demasking (si veda anche Laine et al., 1999, Esperimento 7). Il prossimo esperimento propone un confronto tra i due tipi di stimolo (aggettivi e verbi) in un altro compito, la lettura ad alta voce, che può essere condotto senza ricorrere a componenti semantiche e non è influenzato da processi di natura decisionale. Nonostante che l ortografia regolare e trasparente della lingua italiana consenta di leggere «per regola», cioè applicando corrispondenze grafema/fonema senza necessità di consultare il lessico mentale, anche nella lettura ad alta voce veloce dell italiano si riscontrano effetti di frequenza della parola (cfr. Arduino, Burani e Vallar, 2002; Barca, Burani e Arduino, 2002; Bates, Burani, D Amico e Barca, 2001; Burani, Marcolini e Stella, 2002; Colombo, 1992). Ciò testimonia l attivazione di unità lessicali anche in questo compito. Rimane però da verificare se per parole morfologicamente complesse la procedura di lettura lessicale implichi il ricorso alla segmentazione morfologica. I dati di Colombo e Burani (2002) indicano un ruolo della composizione morfologica nella lettura ad alta voce di parole flesse. Resta però da accertare se la segmentazione morfologica comporti costi di elaborazione in lettura analogamente a quanto ottenuto in decisione lessicale e se gli eventuali costi associati a forme con paradigma flessivo ampio come i verbi si riducano in contesti di lista bloccata in cui ci sia omogeneità nel processo di elaborazione. 879
10 ESPERIMENTO 2 METODO Partecipanti Hanno partecipato all esperimento 44 studenti e giovani collaboratori dell ISTC-CNR, nessuno dei quali aveva partecipato al primo esperimento. Ciascun partecipante ha visto tutti gli item una volta sola, metà in condizione di lista bloccata (solo verbi o solo aggettivi) e metà in condizione di lista mista (metà verbi e metà aggettivi). Stimoli Sono stati utilizzati gli stessi verbi e gli stessi aggettivi selezionati per l esperimento precedente, suddivisi in 40 stimoli sperimentali e 80 fillers. Nei due gruppi sperimentali è stato bilanciato anche il fonema iniziale delle parole, una caratteristica che incide sul tempo di rilevazione dell onset della lettura. Le liste sono dunque quelle utilizzate nel compito di decisione lessicale, tranne che, in questo caso, non sono incluse pseudoparole. Procedura Dopo la comparsa di un punto di fissazione per 500 ms, veniva presentata una parola, che rimaneva sullo schermo finché il partecipante non iniziava a pronunciarla ad alta voce e, comunque, per non più di 1000 ms. Lo sperimentatore annotava manualmente eventuali letture errate; i tempi di reazione si riferiscono al tempo intercorrente tra la comparsa dello stimolo e l inizio della pronuncia, per le sole parole pronunciate correttamente. 880 RISULTATI E DISCUSSIONE Sono state condotte le stesse analisi adottate per l esperimento 1 (v. nota 2). Anche in questo caso, come nell esperimento precedente, i verbi sono associati a latenze maggiori rispetto agli aggettivi (tabella 3), sia «per soggetti» sia «per parole» [F1(1,43) = 34.02, p <.001, MSe = ; F2(1,37) = 7.32, p <.01, MSe = ]. Non risultano significativi né il contesto di lista né l interazione tra categoria grammaticale e composizione della lista. Stessa situazione si riscontra
11 TAB. 3. Esperimento 2. Compito di lettura veloce: media dei tempi di reazione («per parole»), deviazioni standard e percentuale d errore in risposta a verbi e aggettivi, in condizione di lista mista e bloccata Lista mista Lista bloccata Verbi Aggettivi Diff. Verbi Aggettivi Diff. T.R. media (ms) d.s Errori % per gli errori, in cui si nota che i verbi sono suscettibili di un maggiore numero di errori rispetto agli aggettivi, sia «per soggetti» sia «per parole» [F1(1,43) = 10.59, p <.01, MSe = 0.21; F2(1,37) = 7.01, p <.01, MSe = 0.71]. Le correlazioni post-hoc presentano un quadro molto simile a quello della decisione lessicale: per gli aggettivi si coglie una correlazione significativa tra tempi di reazione e frequenza della parola sia nella condizione mista (r =.52, p <.05) sia in quella bloccata (r =.48, p <.05), mentre per i verbi l unica correlazione significativa è tra tempi di reazione in condizione bloccata e frequenza della radice (r =.46, p <.05). Questo risultato evidenzia che nel compito di lettura, come in quello di decisione lessicale, possono venire attivate rappresentazioni di tipo morfologico. Infatti, analogamente a quanto rilevato nel precedente esperimento, la lettura degli aggettivi risulta influenzata prevalentemente dall utilizzo della parola intera, mentre nel caso dei verbi il ruolo maggiore è svolto dalla rappresentazione della radice (si veda anche il risultato simile di Colombo e Burani, 2002 per i verbi vs. i nomi). I tempi di lettura più veloci e la maggiore accuratezza confermano per gli aggettivi una modalità di lettura più «diretta». Analogamente, i tempi di lettura più lunghi e la minore accuratezza per i verbi indicano che il maggior ricorso alla lettura per parsing morfologico comporta tempi aggiuntivi di segmentazione e ricomposizione dello stimolo. DISCUSSIONE GENERALE Per rendere conto dell insieme dei risultati ottenuti con verbi, aggettivi e nomi italiani in questa e nelle precedenti ricerche (Baayen et al., 1997; Colombo e Burani, 2002; Traficante e Burani, 2003) è necessario un modello che permetta di interpretare i processi di elabora- 881
12 zione che intervengono sia nel compito di decisione lessicale sia in quello di lettura e che renda conto degli effetti di natura morfologica riscontrati. Una prospettiva integrata potrebbe prendere spunto da un modello di lettura «a due vie» (cfr. Coltheart e Rastle, 1994; Coltheart et al., 2001), in cui si assume l attivazione parallela di una procedura di lettura lessicale e di una procedura non lessicale basata su singole lettere o grafemi. Per rendere conto degli effetti morfologici, la «via lessicale» dovrebbe, a sua volta, prevedere due modalità distinte di accesso al lessico, come proposto dall AAM e dal Race model per spiegare il compito di decisione lessicale: una via diretta, basata su rappresentazioni intere e una via morfologica, in cui vengono utilizzate rappresentazioni morfemiche in forma scomposta. In un nuovo modello, a «tre vie», i diversi tipi di codici (parola intera, morfemi e grafemi) si attiverebbero in parallelo. Quale delle procedure (lessicale «per parola intera», «morfolessicale» e non-lessicale) riesca a determinare per prima la risposta dovrebbe dipendere da quanto risulti disponibile e facilmente attivabile una rappresentazione d accesso e dai costi associati alle procedure che in ciascuna via si applicano. Quando uno stimolo morfologicamente complesso è formato da una combinazione radice-suffisso mai vista prima, tanto da essere considerato una parola nuova, la possibilità di leggerlo attivando i due morfemi costituenti dovrebbe comportare tempi di lettura più veloci ed accurati, rispetto a una lettura non lessicale che lo scomponga più analiticamente nei numerosi grafemi che lo compongono. Evidenze di una lettura che utilizza costituenti morfologici sono state in effetti più volte ottenute nel caso di pseudoparole morfologicamente complesse, cioè costituite da combinazioni nuove di radici ed affissi (Arduino et al., 2002; Burani, Dovetto, Spuntarelli e Thornton, 1999; Burani, Dovetto, Thornton e Laudanna, 1997; Burani et al., 2002; Burani e Laudanna, 2003; Laudanna, Cermele e Caramazza, 1997). In questi casi la lettura basata su morfemi è dunque risultata vantaggiosa rispetto alla lettura non lessicale. Nella presente ricerca invece, in cui abbiamo considerato parole flesse conosciute, la lettura morfologica non è risultata vantaggiosa rispetto a quella basata sulla parola intera. La modalità di lettura morfo-lessicale basata su morfemi comporta in effetti una lettura più analitica, quindi più lenta, rispetto alla lettura per parola intera, mentre comporta una lettura meno analitica, quindi più veloce ad efficiente, rispetto alla lettura non lessicale basata su grafemi singoli. Le differenze riscontrate nei nostri esperimenti mettono in luce che esistono delle caratteristiche delle parole che rendono più probabile l attivazione di una procedura rispetto alle altre. Verbi e aggettivi, ad 882
13 esempio, sembrano differenziarsi per qualche proprietà che rende i primi più soggetti ad essere riconosciuti/letti tramite la «via morfolessicale» e i secondi più facilmente elaborabili tramite la «via lessicale diretta». Se si escludono caratteristiche di tipo grammaticale, sintattico e/o semantico, che non dovrebbero influenzare le prestazioni in compiti di natura «superficiale» come lo smascheramento progressivo (cfr. Traficante e Burani, 2003; Laine et al., 1999, Esperimento 7; Schreuder e Baayen, 1997) e la lettura, rimane da considerare il ruolo del numero di forme appartenenti ai rispettivi paradigmi flessivi. Nel caso dei verbi l utilizzo della forma scomposta e il processo di ri-composizione dei morfemi potrebbe essere più comune, essendo il lettore più abituato a cogliere la parte invariante anche in parole ortograficamente molto diverse (es. «ama» e «amerebbero»). Questa modalità di elaborazione sarebbe particolarmente utile nel caso di forme verbali poco frequenti, che potrebbero non avere neppure una rappresentazione in forma intera 4. L individuazione della radice e dell affisso e la loro ricombinazione potrebbero essere invece meno abituali per gli aggettivi, dato che le forme aggettivali flesse che condividono la stessa radice sono poche e sono in genere tutte abbastanza frequenti da poter avere una propria rappresentazione in forma intera. L interdipendenza tra frequenza delle parola (in termini di occorrenze tokens) e numerosità delle parole morfologicamente relate in modo semanticamente trasparente (in termini di parole che condividono la stessa radice types) è un fattore la cui importanza è riconosciuta anche da autori che interpretano i processi di riconoscimento del linguaggio secondo una prospettiva connessionista. In particolare, Plaut e Gonnerman (2000) affermano che nella misura in cui una particolare configurazione ortografica e/o fonologica è presente in molte parole e si riferisce in modo sistematico a specifici contenuti semantici (come avverrebbe per il morfema-radice), potrebbero crearsi rappresentazioni interne specifiche per questo tipo di schema, che indurrebbero un elaborazione relativamente indipendente dello stesso dalle altre parti della parola (Plaut e Gonnerman, 2000, p. 448). Questa previsione, formulata da Plaut e Gonnerman (2000) per la lingua ebraica, risulterebbe adeguata a spiegare il ruolo della radice per i verbi regolari italiani, dato che il paradigma flessivo verbale contiene molte parole che sono relate tra loro ortograficamente, foneticamente e semanticamente. La prospettiva connessionista, però, non spiega la penalizzazione che si riscontra nel caso dell elaborazione «componen- 4 Riguardo alla frequenza di parola minima necessaria affinché una parola possa avere una rappresentazione in forma intera nel lessico mentale, Alegre e Gordon (1999) propongono la soglia di 6 occorrenze su un milione. 883
14 ziale» delle parole. In un modello unitario come quello proposto da Plaut e Gonnerman (2000) l attivazione di pattern di riconoscimento molto familiari, perché condivisi da molte parole, dovrebbe comportare una maggiore rapidità e correttezza nella risposta e non un rallentamento e un maggior numero di errori come riscontrato nei nostri lavori e nelle ricerche in lingua finlandese. I modelli «a una via» attualmente conosciuti non sembrano quindi fornire una spiegazione adeguata dei risultati da noi ottenuti, mentre modelli che prevedano più modalità di elaborazione permettono una più agevole interpretazione dei dati. BIBLIOGRAFIA ALEGRE M., GORDON P. (1999). Frequency effects and the representational status of regular inflections. Journal of Memory and Language, 40, ARDUINO L.S., BURANI C., VALLAR G. (2002). Lexical effects in left neglect dyslexia: A study in Italian patients. Cognitive Neuropsychology, 19, BAAYEN R.H., BURANI C., SCHREUDER R. (1997). Effects of semantic markedness in the processing of regular nominal singulars and plurals in Italian. In G.E. Booij, J. van Marle (eds.), Yearbook of morphology. Dordrecht: Kluwer, pp BAAYEN R.H., SCHREUDER R. (1999). War and peace: Morphemes and full forms in a noninteractive activation parallel dual-route model. Brain and Language, 68, BAAYEN R.H., SCHREUDER R., SPROAT R. (2000). Morphology in the mental lexicon: A computational model for visual word recognition. In F. van Eynde, D. Gibbon (eds.), Lexicon development for speech and language processing. Dordrecht: Kluwer, pp BARCA L., BURANI C., ARDUINO L.S. (2002). Word naming times and psycholinguistic norms for Italian nouns. Behavior Research Methods, Instruments & Computers, 34, BATES E., BURANI, C., D AMICO S., BARCA L. (2001). Word reading and picture naming in Italian. Memory & Cognition, 29, BURANI C., CARAMAZZA A. (1987). Representation and processing of derived words. Language and Cognitive Processes, 2, BURANI C., DOVETTO F.M., SPUNTARELLI A., THORNTON A.M. (1999). Morpho-lexical access and naming: The semantic interpretability of new rootsuffix combinations. Brain and Language, 68, BURANI C., DOVETTO F. M., THORNTON A.M., LAUDANNA A. (1997). Accessing and naming suffixed pseudo-words. In G.E. Booij, J. van Marle (eds.), Yearbook of morphology. Dordrecht: Kluwer, pp BURANI C., LAUDANNA A. (1992). Units of representation for derived words in the lexicon. In R. Frost, L. Katz (eds.), Orthography, phonology, morphology, and meaning. Amsterdam: North-Holland, pp BURANI C., LAUDANNA A. (2003). Morpheme-based lexical reading: Evidence from pseudo-word naming. In E. Assink, D. Sandra (eds.), Reading complex words: Cross-language studies. Dordrecht: Kluwer, pp BURANI C., MARCOLINI S., STELLA G. (2002). How early does morpho-lexical 884
15 reading develop in readers of a shallow orthography? Brain and Language, 81, BURANI C., SALMASO D., CARAMAZZA A. (1984). Morphological structure and lexical access. Visible Language, 18, BURANI C., THORNTON A.M. (2003). The interplay of root, suffix and wholeword frequency in processing derived words. In R.H. Baayen, R. Schreuder (eds.), Morphological structure in language processing. Berlin: Mouton de Gruyter, pp CARAMAZZA A., LAUDANNA A., ROMANI C. (1988). Lexical access and inflectional morphology. Cognition, 28, CHIALANT D., CARAMAZZA A. (1995). Where is morphology and how is it processed? The case of written word recognition. In L.B. Feldman (ed.), Morphological aspects of language processing. Hove: Erlbaum), pp COLOMBO L. (1992). Lexical stress effect and its interaction with frequency in word pronunciation. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 18, COLOMBO L., BURANI C. (2002). The influence of age of acquisition, root frequency and context availability in processing nouns and verbs. Brain and Language, 81, COLTHEART M., RASTLE K. (1994). Serial processing in reading aloud: Evidence for dual-route models of reading. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 20, COLTHEART M., RASTLE K., PERRY C., LANGDON R., ZIEGLER J. (2001). DRC: A dual route cascaded model of visual word recognition and reading aloud. Psychological Review, 108, DEUTSCH A., FROST R., FORSTER K.I. (1998). Verbs and nouns are organized and accessed differently in the mental lexicon: Evidence from Hebrew. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 24, FELDMAN L.B. (1995). Morphological aspects of language processing. Hove: Erlbaum. HYÖNÄ J., VAINIO S., LAINE M. (2002). A morphological effect obtains for isolated words but not for words in sentence context. European Journal of Cognitive Psychology, 14, ISTITUTO DI LINGUISTICA COMPUTAZIONALE CNR (1989). Corpus di Italiano contemporaneo. Manoscritto non pubblicato. Pisa. KATZ L., REXER K., LUKATELA G. (1991). The processing of inflected words. Psychological Research, 53, KOSTI? A., KATZ L. (1987). Processing differences between nouns, adjectives, and verbs. Psychological Research, 49, LAINE M., VAINIO S., HYÖNÄ J. (1999). Lexical access routes to nouns in a morphologically rich language. Journal of Memory and Language, 40, LAUDANNA A., CERMELE A., CARAMAZZA A. (1997). Morpho-lexical representations in naming. Language and Cognitive Processes, 12, LAUDANNA A., VOGHERA M., GAZZELLINI S. (2002). Lexical representations of written nouns and verbs in Italian. Brain and Language, 81, NIEMI J., LAINE M., TUOMINEN J. (1994). Cognitive morphology in Finnish: Foundations of a new model. Language and Cognitive Processes, 9, PLAUT D.C., GONNERMAN L.M. (2000). Are non-semantic morphological effects incompatible with a distributed connectionist approach to lexical processing? Language and Cognitive Processes, 15,
16 SCHREUDER R., BAAYEN R.H. (1995). Modeling morphological processing. In L.B. Feldman (ed.), Morphological aspects of language processing. Hove: Erlbaum, pp SCHREUDER R., BAAYEN R.H. (1997). How complex simple words can be. Journal of Memory and Language, 36, SERENO J.A., JONGMAN A. (1997). Processing of English inflectional morphology. Memory and Cognition, 25, TRAFICANTE D., BURANI C. (2003). Visual processing of Italian verbs and adjectives: The role of inflectional family size. In R.H. Baayen, R. Schreuder (eds.), Morphological structure in language processing. Berlin: Mouton de Gruyter, pp [Ricevuto il 26 maggio 2003] [Accettato il 25 ottobre 2003] Summary. Two experiments investigated the role of the size of the inflectional paradigm in processing Italian inflected verbs and adjectives, in mixed and blocked list conditions. In both lexical decision (Experiment 1) and naming (Experiment 2), verbs showed slower RTs than adjectives, although stimuli were matched for several psycholinguistic variables. Post-hoc correlational analyses showed different effects on reaction times and accuracy of variables related to frequency, with effects of root frequency for verbs only, and greater effects of whole-word frequency for adjectives relative to verbs. No list effects were found. These results are interpreted as evidence that a high number of inflected forms favours morphemic access, while a small inflectional family size leads to prevalent full-form processing. La corrispondenza va inviata a Daniela Traficante, Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli 1, Milano, daniela.traficante@unicatt.it 886
Prova di lettura di parole. e non parole
 2005 Prova di lettura di parole e non parole Pierluigi Zoccolotti, Maria De Luca, Gloria Di Filippo, Anna Judica e Donatella Spinelli - MANUALE D'USO - INTRODUZIONE E noto che il riconoscimento delle parole
2005 Prova di lettura di parole e non parole Pierluigi Zoccolotti, Maria De Luca, Gloria Di Filippo, Anna Judica e Donatella Spinelli - MANUALE D'USO - INTRODUZIONE E noto che il riconoscimento delle parole
PROVA DI LETTURA DI PAROLE E NON-PAROLE MANUALE. Pierluigi Zoccolotti, Maria De Luca, Gloria Di Filippo, Anna Judica, Donatella Spinelli
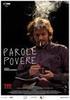 PROVA DI LETTURA DI PAROLE E NON-PAROLE MANUALE Pierluigi Zoccolotti, Maria De Luca, Gloria Di Filippo, Anna Judica, Donatella Spinelli Edizione 2005 INTRODUZIONE È noto che il riconoscimento delle parole
PROVA DI LETTURA DI PAROLE E NON-PAROLE MANUALE Pierluigi Zoccolotti, Maria De Luca, Gloria Di Filippo, Anna Judica, Donatella Spinelli Edizione 2005 INTRODUZIONE È noto che il riconoscimento delle parole
Il ruolo del contesto sintattico nell assegnazione dell accento di parola in italiano
 XX Congresso Nazionale AIP Sezione Psicologia Sperimentale Il ruolo del contesto sintattico nell assegnazione dell accento di parola in italiano Giacomo Spinelli a,b, Simone Sulpizio c, Silvia Primativo
XX Congresso Nazionale AIP Sezione Psicologia Sperimentale Il ruolo del contesto sintattico nell assegnazione dell accento di parola in italiano Giacomo Spinelli a,b, Simone Sulpizio c, Silvia Primativo
Effetto della morfologia sull accuratezza in scrittura: uno studio in bambini normolettori e con dislessia
 Effetto della morfologia sull accuratezza in scrittura: uno studio in bambini normolettori e con dislessia Paola Angelelli*, +Chiara Valeria Marinelli e **Cristina Burani *Università del Salento; +Università
Effetto della morfologia sull accuratezza in scrittura: uno studio in bambini normolettori e con dislessia Paola Angelelli*, +Chiara Valeria Marinelli e **Cristina Burani *Università del Salento; +Università
Consistenza ortografico-semantica:
 Consistenza ortografico-semantica: EFFETTI DI TRASPARENZA SEMANTICA IN PAROLE MORFOLOGICAMENTE SEMPLICI? Marco Marelli, Simona Amenta, Davide Crepaldi Masked-priming in morfologia TARGET Condizione trasparente
Consistenza ortografico-semantica: EFFETTI DI TRASPARENZA SEMANTICA IN PAROLE MORFOLOGICAMENTE SEMPLICI? Marco Marelli, Simona Amenta, Davide Crepaldi Masked-priming in morfologia TARGET Condizione trasparente
I sistemi di scrittura. Linguaggio orale e linguaggio scritto. La lettura di parole singole. Ipotesi della profondità ortografica
 Linguaggio orale e linguaggio scritto La percezione, comprensione e produzione del linguaggio parlato si sviluppano molto precocemente e sfruttano meccanismi biologici specializzati e universali La percezione,
Linguaggio orale e linguaggio scritto La percezione, comprensione e produzione del linguaggio parlato si sviluppano molto precocemente e sfruttano meccanismi biologici specializzati e universali La percezione,
METODOLOGIA DELLA RICERCA IN PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO A.A APPUNTI DEL CORSO TENUTO DALLA Prof.Laura D Odorico N.3
 METODOLOGIA DELLA RICERCA IN PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO A.A. 2005-2006 APPUNTI DEL CORSO TENUTO DALLA Prof.Laura D Odorico N.3 Ricerche correlazionali In alcuni disegni di ricerca non c è una variabile
METODOLOGIA DELLA RICERCA IN PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO A.A. 2005-2006 APPUNTI DEL CORSO TENUTO DALLA Prof.Laura D Odorico N.3 Ricerche correlazionali In alcuni disegni di ricerca non c è una variabile
Prerequisiti linguistici e scrittura
 Prerequisiti linguistici e scrittura Paola Viterbori Polo Bozzo Università di Genova Scrittura come attività complessa Codifica (Alfabetizzazione o Literacy) Attività linguistica di trasformazione del
Prerequisiti linguistici e scrittura Paola Viterbori Polo Bozzo Università di Genova Scrittura come attività complessa Codifica (Alfabetizzazione o Literacy) Attività linguistica di trasformazione del
DISCALCULIA CON E SENZA DISLESSIA: QUALCHE DIFFERENZA?
 v.19/2/10 DISCALCULIA CON E SENZA DISLESSIA: QUALCHE DIFFERENZA? Patrizio E. Tressoldi Dipartimento di Psicologia Generale Università di Padova -LA DISLESSIA PORTA SEMPRE QUALCHE DIFFICOLTA NELLE ABILITA
v.19/2/10 DISCALCULIA CON E SENZA DISLESSIA: QUALCHE DIFFERENZA? Patrizio E. Tressoldi Dipartimento di Psicologia Generale Università di Padova -LA DISLESSIA PORTA SEMPRE QUALCHE DIFFICOLTA NELLE ABILITA
Un Software per il potenziamento delle abilità di lettura e scrittura
 OTTOVOLANTE Un Software per il potenziamento delle abilità di lettura e scrittura *G. STELLA *G. CAIAZZO - *G. ZANZURINO * Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia San Marino 19/09/2008 Progetto
OTTOVOLANTE Un Software per il potenziamento delle abilità di lettura e scrittura *G. STELLA *G. CAIAZZO - *G. ZANZURINO * Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia San Marino 19/09/2008 Progetto
BIBLIOGRAFIA RAGIONATA. "LESSICO E ORTOGRAFIA NELLA LETTURA AD ALTA VOCE DI ADULTI E BAMBINI DI LINGUE DIVERSE" Laura Barca
 BIBLIOGRAFIA RAGIONATA "LESSICO E ORTOGRAFIA NELLA LETTURA AD ALTA VOCE DI ADULTI E BAMBINI DI LINGUE DIVERSE" Laura Barca Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Università
BIBLIOGRAFIA RAGIONATA "LESSICO E ORTOGRAFIA NELLA LETTURA AD ALTA VOCE DI ADULTI E BAMBINI DI LINGUE DIVERSE" Laura Barca Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Università
Istituzioni di linguistica a.a Federica Da Milano
 Istituzioni di linguistica a.a.2014-2015 Federica Da Milano federica.damilano@unimib.it I processi di lettura, scrittura e calcolo nell età adulta La lettura: la capacità di leggere stringhe di lettere
Istituzioni di linguistica a.a.2014-2015 Federica Da Milano federica.damilano@unimib.it I processi di lettura, scrittura e calcolo nell età adulta La lettura: la capacità di leggere stringhe di lettere
informatica di base per le discipline umanistiche
 informatica di base per le discipline umanistiche vito pirrelli Istituto di Linguistica Computazionale CNR Pisa Dipartimento di linguistica Università di Pavia sesta lezione: la dinamica del testo vito
informatica di base per le discipline umanistiche vito pirrelli Istituto di Linguistica Computazionale CNR Pisa Dipartimento di linguistica Università di Pavia sesta lezione: la dinamica del testo vito
ESPRESSIVITÀ DELLA VELOCITÀ DI LETTURA IN GIOVANI ADULTI: EFFETTI DI ALCUNE VARIABILI PSICOLINGUISTICHE
 ESPRESSIVITÀ DELLA VELOCITÀ DI LETTURA IN GIOVANI ADULTI: EFFETTI DI ALCUNE VARIABILI PSICOLINGUISTICHE Marisa Giorgetti 1, Pier Luigi Baldi 2 1 Servizio Clinico Spaee Università Cattolica del Sacro Cuore
ESPRESSIVITÀ DELLA VELOCITÀ DI LETTURA IN GIOVANI ADULTI: EFFETTI DI ALCUNE VARIABILI PSICOLINGUISTICHE Marisa Giorgetti 1, Pier Luigi Baldi 2 1 Servizio Clinico Spaee Università Cattolica del Sacro Cuore
Tecniche statistiche di analisi del cambiamento
 Tecniche statistiche di analisi del cambiamento 07-Anova con covariata (vers. 1.0, 3 dicembre 2015) Germano Rossi 1 germano.rossi@unimib.it 1 Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca 2015-16
Tecniche statistiche di analisi del cambiamento 07-Anova con covariata (vers. 1.0, 3 dicembre 2015) Germano Rossi 1 germano.rossi@unimib.it 1 Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca 2015-16
I SISTEMI DI LETTURA E LE DISLESSIE
 I SISTEMI DI LETTURA E LE DISLESSIE L alessia senza agrafia -Disturbo di lettura senza altri disturbi concomitanti -I pazienti scrivono senza essere capaci di leggere quello che hanno scritto Interpretazione
I SISTEMI DI LETTURA E LE DISLESSIE L alessia senza agrafia -Disturbo di lettura senza altri disturbi concomitanti -I pazienti scrivono senza essere capaci di leggere quello che hanno scritto Interpretazione
Disturbi Specifici di Scrittura
 Disturbi Specifici di Scrittura e disturbi specifici della funzione motoria Il processo di scrittura Condivide con la lettura il nucleo essenziale del processo, Richiede un abilità grafica aggiuntiva Richiede
Disturbi Specifici di Scrittura e disturbi specifici della funzione motoria Il processo di scrittura Condivide con la lettura il nucleo essenziale del processo, Richiede un abilità grafica aggiuntiva Richiede
Categorie grammaticali = tratti morfosintattici + tratti morfosemantici + tratti morfologici
 1) Il verbo Le categorie morfologiche del verbo (categorie grammaticali, paradigmi, coniugazioni, classi regolari, sottoregolari, irregolari, allomorfie ecc.) Il verbo = la parte del discorso (estremamente)
1) Il verbo Le categorie morfologiche del verbo (categorie grammaticali, paradigmi, coniugazioni, classi regolari, sottoregolari, irregolari, allomorfie ecc.) Il verbo = la parte del discorso (estremamente)
APPRENDIMENTO E NEUROSCIENZE
 APPRENDIMENTO E NEUROSCIENZE Modello interattivo e multicomponenziale della compresione Eleonora Aliano Apprendimento e neuroscienze Apprendere: variare la struttura e l attività dei neuroni Ultime notizie
APPRENDIMENTO E NEUROSCIENZE Modello interattivo e multicomponenziale della compresione Eleonora Aliano Apprendimento e neuroscienze Apprendere: variare la struttura e l attività dei neuroni Ultime notizie
Elementi di Psicologia dello Sviluppo (II modulo) Mirco Fasolo
 Elementi di Psicologia dello Sviluppo (II modulo) Mirco Fasolo mirco.fasolo@unimib.it Bibliografia Testi obbligatori - D amico, Devescovi (2003). Comunicazione e linguaggio nei bambini. Carocci: Roma.
Elementi di Psicologia dello Sviluppo (II modulo) Mirco Fasolo mirco.fasolo@unimib.it Bibliografia Testi obbligatori - D amico, Devescovi (2003). Comunicazione e linguaggio nei bambini. Carocci: Roma.
Come leggono i bambini dislessici? Rachele Fanari
 Come leggono i bambini dislessici? Rachele Fanari Evidenze dai bambini italiani con sviluppo tipico In uno studio longitudinale abbiamo osservato un gruppo di bambini dalla fine della scuola dell infanzia
Come leggono i bambini dislessici? Rachele Fanari Evidenze dai bambini italiani con sviluppo tipico In uno studio longitudinale abbiamo osservato un gruppo di bambini dalla fine della scuola dell infanzia
NORMA UNI EN 689/97 ESPOSIZIONE
 Assessorato politiche per la salute Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Servizio Sanità Pubblica CORSO DI FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO in materia di Gestione del Rischio derivante da Materiali Contenenti
Assessorato politiche per la salute Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Servizio Sanità Pubblica CORSO DI FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO in materia di Gestione del Rischio derivante da Materiali Contenenti
Funzioni fondamentali della frase (soggetto, oggetto diretto, ecc.) Ruoli tematici: agente, paziente, beneficiario, strumento, ecc.
 Both English and Dyirbal have different syntactic means of encoding the same semantic roles (p. 114) Funzioni fondamentali della frase (soggetto, oggetto diretto, ecc.) Ruoli tematici: agente, paziente,
Both English and Dyirbal have different syntactic means of encoding the same semantic roles (p. 114) Funzioni fondamentali della frase (soggetto, oggetto diretto, ecc.) Ruoli tematici: agente, paziente,
Studi italiani sul trattamento della dislessia evolutiva
 v.16/9/2010 Studi italiani sul trattamento della dislessia evolutiva Patrizio Tressoldi Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova Obiettivi dello studio: -Riportare i risultati dei trattamenti
v.16/9/2010 Studi italiani sul trattamento della dislessia evolutiva Patrizio Tressoldi Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova Obiettivi dello studio: -Riportare i risultati dei trattamenti
IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE
 IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE Per
IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE Per
A proposito di valutazione scolastica
 A proposito di valutazione scolastica Livello scolare: 2 biennio Abilità interessate Identificare situazioni che richiedono di rilevare lo stesso carattere su una unità statistica formata da 2 elementi,
A proposito di valutazione scolastica Livello scolare: 2 biennio Abilità interessate Identificare situazioni che richiedono di rilevare lo stesso carattere su una unità statistica formata da 2 elementi,
EFFETTI DI TRAINING DI BREVE DURATA SULLE CONOSCENZE RIGUARDO LA MEMORIA E SULLE PRESTAZIONI DI MEMORIA DI RAGAZZI CON SINDROME DI DOWN
 EFFETTI DI TRAINING DI BREVE DURATA SULLE CONOSCENZE RIGUARDO LA MEMORIA E SULLE PRESTAZIONI DI MEMORIA DI RAGAZZI CON SINDROME DI DOWN Corso di Disabilità Cognitive prof. Renzo Vianello Università di
EFFETTI DI TRAINING DI BREVE DURATA SULLE CONOSCENZE RIGUARDO LA MEMORIA E SULLE PRESTAZIONI DI MEMORIA DI RAGAZZI CON SINDROME DI DOWN Corso di Disabilità Cognitive prof. Renzo Vianello Università di
LABORATORIO Corso di Pedagogia speciale Prof.ssa Zappaterra IV anno GRUPPO 1 23 settembre :00/19:00 Dr.ssa Lucia Donata Nepi
 Scuola di Studi Umanistici e della Formazione CdS in Scienze della Formazione Primaria! LABORATORIO Corso di Pedagogia speciale Prof.ssa Zappaterra IV anno GRUPPO 1 23 settembre 2015 16:00/19:00 Dr.ssa
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione CdS in Scienze della Formazione Primaria! LABORATORIO Corso di Pedagogia speciale Prof.ssa Zappaterra IV anno GRUPPO 1 23 settembre 2015 16:00/19:00 Dr.ssa
dr.ssa Paola Cavalcaselle psicologa
 Screening delle capacità di lettoscrittura per la rilevazione precoce di alunni a rischio di difficoltà di apprendimento nelle prime due classi della scuola primaria dr.ssa Paola Cavalcaselle psicologa
Screening delle capacità di lettoscrittura per la rilevazione precoce di alunni a rischio di difficoltà di apprendimento nelle prime due classi della scuola primaria dr.ssa Paola Cavalcaselle psicologa
Agency in una comunità di apprendimento online: dall Agency Individuale all Agency Collettiva
 Agency in una comunità di apprendimento online: dall Agency Individuale all Agency Collettiva Maria Antonietta Impedovo Aix-Marseille University, Francia Maria Beatrice Ligorio Università degli Studi di
Agency in una comunità di apprendimento online: dall Agency Individuale all Agency Collettiva Maria Antonietta Impedovo Aix-Marseille University, Francia Maria Beatrice Ligorio Università degli Studi di
Lo sviluppo linguistico nei primi anni di vita
 Università di Genova Polo M.T. Bozzo Lo sviluppo linguistico nei primi anni di vita Paola Viterbori Il ritardo di linguaggio il ritardo di linguaggio è un rallentamento nell acquisizione delle normali
Università di Genova Polo M.T. Bozzo Lo sviluppo linguistico nei primi anni di vita Paola Viterbori Il ritardo di linguaggio il ritardo di linguaggio è un rallentamento nell acquisizione delle normali
La lettura come processo di decodifica. Di Giacomo Dallari
 La lettura come processo di decodifica. Di Giacomo Dallari Leggere significa attivare dei meccanismi molto complessi che richiedono l intervento di una serie di abilità e di processi articolati e cooperativi.
La lettura come processo di decodifica. Di Giacomo Dallari Leggere significa attivare dei meccanismi molto complessi che richiedono l intervento di una serie di abilità e di processi articolati e cooperativi.
informatica di base per le discipline umanistiche
 informatica di base per le discipline umanistiche vito pirrelli Istituto di Linguistica Computazionale CNR Pisa Dipartimento di linguistica Università di Pavia ottava lezione: la dinamica del testo vito
informatica di base per le discipline umanistiche vito pirrelli Istituto di Linguistica Computazionale CNR Pisa Dipartimento di linguistica Università di Pavia ottava lezione: la dinamica del testo vito
FREQUENZA, IMMAGINABILITÀ ED ETÀ DI ACQUISIZIONE DELLE PAROLE: IN CHE MISURA INFLUENZANO LA LETTURA DEI BAMBINI ITALIANI?
 FREQUENZA, IMMAGINABILITÀ ED ETÀ DI ACQUISIZIONE DELLE PAROLE: IN CHE MISURA INFLUENZANO LA LETTURA DEI BAMBINI ITALIANI? Simone Mazzotta*, Laura Barca #^, Stefania Marcolini #, Giacomo Stella + e Cristina
FREQUENZA, IMMAGINABILITÀ ED ETÀ DI ACQUISIZIONE DELLE PAROLE: IN CHE MISURA INFLUENZANO LA LETTURA DEI BAMBINI ITALIANI? Simone Mazzotta*, Laura Barca #^, Stefania Marcolini #, Giacomo Stella + e Cristina
Educazione linguistica. SILSIS Scienze Naturali e FIM a.a
 Educazione linguistica SILSIS Scienze Naturali e FIM a.a. 2007-08 Linguaggio scientifico Il tema del linguaggio scientifico offre ampia materia di lavoro non solo al linguista, ma anche allo studioso di
Educazione linguistica SILSIS Scienze Naturali e FIM a.a. 2007-08 Linguaggio scientifico Il tema del linguaggio scientifico offre ampia materia di lavoro non solo al linguista, ma anche allo studioso di
Indice. Prefazione all edizione italiana. Gli Autori e i Curatori dell edizione italiana PARTE PRIMA ASPETTI GENERALI
 Indice Prefazione all edizione italiana Gli Autori e i Curatori dell edizione italiana XI XII PARTE PRIMA ASPETTI GENERALI Capitolo 1. Introduzione 1 1.1 La psicologia scientifica 1 1.2 I contesti della
Indice Prefazione all edizione italiana Gli Autori e i Curatori dell edizione italiana XI XII PARTE PRIMA ASPETTI GENERALI Capitolo 1. Introduzione 1 1.1 La psicologia scientifica 1 1.2 I contesti della
Invecchiamento e autoinganni: quando le illusioni percettive generano falsi ricordi M. Vannucci Dip. Psicologia, Università degli Studi di Firenze
 Invecchiamento e autoinganni: quando le illusioni percettive generano falsi ricordi M. Vannucci Dip. Psicologia, Università degli Studi di Firenze Introduzione e obiettivi La memoria durante l arco della
Invecchiamento e autoinganni: quando le illusioni percettive generano falsi ricordi M. Vannucci Dip. Psicologia, Università degli Studi di Firenze Introduzione e obiettivi La memoria durante l arco della
2001/ Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia dell Università degli Studi Milano- Bicocca.
 LISA S. ARDUINO CURRICULUM VITAE LUOGO E DATA DI NASCITA Albenga (SV)da 1 ottobre 1968 Università LUMSA Dipartimento di Scienze Umane P.zza delle Vaschette, 101 00193 Roma l.arduino@lumsa.it POSIZIONE
LISA S. ARDUINO CURRICULUM VITAE LUOGO E DATA DI NASCITA Albenga (SV)da 1 ottobre 1968 Università LUMSA Dipartimento di Scienze Umane P.zza delle Vaschette, 101 00193 Roma l.arduino@lumsa.it POSIZIONE
DA GIOVE E GIUNONE A BARBIE E KEN (LE CHIAVI DELLA CITTÀ): VALUTAZIONE DAVIDE DÈTTORE
 DA GIOVE E GIUNONE A BARBIE E KEN (LE CHIAVI DELLA CITTÀ): VALUTAZIONE DAVIDE DÈTTORE Università degli Studi di Firenze Istituto Miller, Genova/Firenze Da Giove e Giunone a Barbie e Ken: un intervento
DA GIOVE E GIUNONE A BARBIE E KEN (LE CHIAVI DELLA CITTÀ): VALUTAZIONE DAVIDE DÈTTORE Università degli Studi di Firenze Istituto Miller, Genova/Firenze Da Giove e Giunone a Barbie e Ken: un intervento
Sviluppo di Risorse Linguistiche per l Ambiente di Scrittura Assistita (ASA)
 Università degli Studi di Pisa Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali Corso di Laurea Triennale in Informatica Informatica e Linguistica Linguistica Sviluppo di Risorse Linguistiche per l Ambiente
Università degli Studi di Pisa Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali Corso di Laurea Triennale in Informatica Informatica e Linguistica Linguistica Sviluppo di Risorse Linguistiche per l Ambiente
Linguistica Generale. Docente: Paola Monachesi. Contents First Last Prev Next
 Linguistica Generale Docente: Paola Monachesi Contents 1 La linguistica e i suoi settori............................... 3 2 La grammatica come mezzo per rappresentare la competenza linguistica...............................................
Linguistica Generale Docente: Paola Monachesi Contents 1 La linguistica e i suoi settori............................... 3 2 La grammatica come mezzo per rappresentare la competenza linguistica...............................................
Marco Piccinno Introduzione generale ai Disturbi specifici dell apprendimento e alla Dislessia
 Marco Piccinno Introduzione generale ai Disturbi specifici dell apprendimento e alla Dislessia Il Disturbi specifici dell apprendimento (DSA) rappresentano dei deficit che insistono a carico delle funzioni
Marco Piccinno Introduzione generale ai Disturbi specifici dell apprendimento e alla Dislessia Il Disturbi specifici dell apprendimento (DSA) rappresentano dei deficit che insistono a carico delle funzioni
QUADRO DI RIFERIMENTO DI ITALIANO PROVE INVALSI 2009
 QUADRO DI RIFERIMENTO DI ITALIANO PROVE INVALSI 2009 RIFERIMENTI NORMATIVI INDICAZIONI NAZIONALI 2003 (OSA) L. n 53/2003 e D. Lgs 59/2004 INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICULO 2007 QUADRO DI RIFERIMENTO
QUADRO DI RIFERIMENTO DI ITALIANO PROVE INVALSI 2009 RIFERIMENTI NORMATIVI INDICAZIONI NAZIONALI 2003 (OSA) L. n 53/2003 e D. Lgs 59/2004 INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICULO 2007 QUADRO DI RIFERIMENTO
INDICATORI NEUROCOGNITIVI PRECOCI DELLA DISLESSIA EVOLUTIVA. Andrea Facoetti & Co
 INDICATORI NEUROCOGNITIVI PRECOCI DELLA DISLESSIA EVOLUTIVA Andrea Facoetti & Co Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova, ITALIA Unità di Neuropsicologia Evolutiva, Istituto Scientifico
INDICATORI NEUROCOGNITIVI PRECOCI DELLA DISLESSIA EVOLUTIVA Andrea Facoetti & Co Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova, ITALIA Unità di Neuropsicologia Evolutiva, Istituto Scientifico
AppuntiBicoccaAppuntiBicoccaAppu ntibicoccaappuntibicoccaappuntibic occaappuntibicoccaappuntibicoccaa ppuntibicoccaappuntibicoccaappunt
 AppuntiBicoccaAppuntiBicoccaAppu ntibicoccaappuntibicoccaappuntibic occaappuntibicoccaappuntibicoccaa ppuntibicoccaappuntibicoccaappunt Struttura delle parole ibicoccaappuntibicoccaappuntibicoc Riassunto
AppuntiBicoccaAppuntiBicoccaAppu ntibicoccaappuntibicoccaappuntibic occaappuntibicoccaappuntibicoccaa ppuntibicoccaappuntibicoccaappunt Struttura delle parole ibicoccaappuntibicoccaappuntibicoc Riassunto
Presentazione dell edizione italiana Prefazione xix Ringraziamenti xxii Glossario dei simboli xxiii
 Sommario Presentazione dell edizione italiana Prefazione xix Ringraziamenti xxii Glossario dei simboli xxiii xv Parte I Statistica descrittiva 1 Capitolo 1 Introduzione 3 Perché studiare statistica? 4
Sommario Presentazione dell edizione italiana Prefazione xix Ringraziamenti xxii Glossario dei simboli xxiii xv Parte I Statistica descrittiva 1 Capitolo 1 Introduzione 3 Perché studiare statistica? 4
TUTTI A BORDO! PROGETTO IRIDE DI INTERCETTAZIONE PRECOCE IN RETE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA
 TUTTI A BORDO! PROGETTO IRIDE DI INTERCETTAZIONE PRECOCE IN RETE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2013-14 ISTITUTO COMPRENSIVO BADIA POLESINE - ROVIGO Badia Polesine 3 dicembre 2013 Francesca
TUTTI A BORDO! PROGETTO IRIDE DI INTERCETTAZIONE PRECOCE IN RETE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2013-14 ISTITUTO COMPRENSIVO BADIA POLESINE - ROVIGO Badia Polesine 3 dicembre 2013 Francesca
Istituto Comprensivo Nord 1 Brescia. Progetto D.S.A.
 Istituto Comprensivo Nord 1 Brescia Progetto D.S.A. Test CMF Valutazione delle abilità di scrittura Giovanardi Rossi e Malaguti BVSCO Velocità scrittura CMF di Marotta, Ronchetti, Trasciani, Vicari EDIZIONI
Istituto Comprensivo Nord 1 Brescia Progetto D.S.A. Test CMF Valutazione delle abilità di scrittura Giovanardi Rossi e Malaguti BVSCO Velocità scrittura CMF di Marotta, Ronchetti, Trasciani, Vicari EDIZIONI
Grant, L'analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino, 2011 Capitolo IV. L analisi dei concorrenti L ANALISI DEI CONCORRENTI
 L ANALISI DEI CONCORRENTI 1 Saper eseguire una corretta analisi dei concorrenti comporta saper: 1. valutare l impatto e i profitti potenziali di prodotti e fornitori complementari; 2. valutare le implicazioni
L ANALISI DEI CONCORRENTI 1 Saper eseguire una corretta analisi dei concorrenti comporta saper: 1. valutare l impatto e i profitti potenziali di prodotti e fornitori complementari; 2. valutare le implicazioni
COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO IN BAMBINI POOR COMPREHENDERS
 Università degli Studi di Messina DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO IN BAMBINI POOR COMPREHENDERS COGNIZIONE VS METACOGNIZIONE Prof.ssa Pina FILIPPELLO Abilità fondamentale
Università degli Studi di Messina DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO IN BAMBINI POOR COMPREHENDERS COGNIZIONE VS METACOGNIZIONE Prof.ssa Pina FILIPPELLO Abilità fondamentale
Le votazioni. 1 Per il calcolo delle medie il voto di 110 e lode è stato posto uguale a 113. Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA 101
 7. Le votazioni I principali fattori che incidono sulla probabilità di ottenere buoni voti alla laurea sono il background scolastico (percorso liceale e buoni voti di diploma), essersi iscritti spinti
7. Le votazioni I principali fattori che incidono sulla probabilità di ottenere buoni voti alla laurea sono il background scolastico (percorso liceale e buoni voti di diploma), essersi iscritti spinti
Monitorare gli apprendimenti in matematica PROVE PER LA SCUOLA PRIMARIA. Beatrice Caponi. CTI Valmont Montebelluna, 3 settembre 2015
 Monitorare gli apprendimenti in matematica PROVE PER LA SCUOLA PRIMARIA Beatrice Caponi CTI Valmont Montebelluna, 3 settembre 2015 ANTICIPAZIONI Modelli di riferimento per la costruzione delle Prove di
Monitorare gli apprendimenti in matematica PROVE PER LA SCUOLA PRIMARIA Beatrice Caponi CTI Valmont Montebelluna, 3 settembre 2015 ANTICIPAZIONI Modelli di riferimento per la costruzione delle Prove di
Modelli e Metodi per la Simulazione (MMS)
 Modelli e Metodi per la Simulazione (MMS) adacher@dia.uniroma3.it Programma La simulazione ad eventi discreti, è una metodologia fondamentale per la valutazione delle prestazioni di sistemi complessi (di
Modelli e Metodi per la Simulazione (MMS) adacher@dia.uniroma3.it Programma La simulazione ad eventi discreti, è una metodologia fondamentale per la valutazione delle prestazioni di sistemi complessi (di
Una proposta di costruzione di un indice sintetico di qualità dell aria
 Una proposta di costruzione di un indice sintetico di qualità dell aria Daniela Cocchi, Francesca Bruno Università di Bologna SEMINARIO SU "INDICE DI QUALITÀ DELL'ARIA" Assessorato Politiche per la Salute
Una proposta di costruzione di un indice sintetico di qualità dell aria Daniela Cocchi, Francesca Bruno Università di Bologna SEMINARIO SU "INDICE DI QUALITÀ DELL'ARIA" Assessorato Politiche per la Salute
Atti del congresso SIPF05. XIII Congresso Nazionale S. I. P. F. (Società Italiana di Psicofisiologia), 2-4 Dicembre 2005, Marina di Carrara (Italia).
 Atti del congresso SIPF05 XIII Congresso Nazionale S. I. P. F. (Società Italiana di Psicofisiologia), 2-4 Dicembre 2005, Marina di Carrara (Italia). Test Diretto Di Lettura e Scrittura (TDLS): IDENTIFICAZIONE
Atti del congresso SIPF05 XIII Congresso Nazionale S. I. P. F. (Società Italiana di Psicofisiologia), 2-4 Dicembre 2005, Marina di Carrara (Italia). Test Diretto Di Lettura e Scrittura (TDLS): IDENTIFICAZIONE
Conoscenza e simulazione mentale
 Conoscenza e simulazione mentale Aspetti storici: cognitivismo, mente computazionale, mente modulare Mente simulativa, mente situata e radicata nel corpo (grounding cognition) Mappe cerebrali e mappe mentali
Conoscenza e simulazione mentale Aspetti storici: cognitivismo, mente computazionale, mente modulare Mente simulativa, mente situata e radicata nel corpo (grounding cognition) Mappe cerebrali e mappe mentali
PROTOCOLLO DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE E MONITORAGGIO DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
 PROTOCOLLO DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE E MONITORAGGIO DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA DI SCREENING Istituto Comprensivo Statale Rita Levi-Montalcini SUISIO PREMESSA La legge 8 ottobre, n
PROTOCOLLO DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE E MONITORAGGIO DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA DI SCREENING Istituto Comprensivo Statale Rita Levi-Montalcini SUISIO PREMESSA La legge 8 ottobre, n
Elementi di Psicometria
 Elementi di Psicometria 7-Punti z e punti T vers. 1.0a (21 marzo 2011) Germano Rossi 1 germano.rossi@unimib.it 1 Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca 2010-2011 G. Rossi (Dip. Psicologia)
Elementi di Psicometria 7-Punti z e punti T vers. 1.0a (21 marzo 2011) Germano Rossi 1 germano.rossi@unimib.it 1 Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca 2010-2011 G. Rossi (Dip. Psicologia)
ISTRUZIONI PROGETTO FASE 4
 ISTRUZIONI PROGETTO FASE 4 Data consegna: tre giorni (72 ore) prima della verbalizzazione Questo documento contiene le istruzione per l esecuzione della fase 4 del progetto. Per informazioni o domande
ISTRUZIONI PROGETTO FASE 4 Data consegna: tre giorni (72 ore) prima della verbalizzazione Questo documento contiene le istruzione per l esecuzione della fase 4 del progetto. Per informazioni o domande
«L'INDAGINE STATISTICA»
 Formazione personale docente su Didattica per competenze e Prove Invalsi MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO A. M.
Formazione personale docente su Didattica per competenze e Prove Invalsi MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO A. M.
Situazione meteorologica
 Situazione meteorologica Ad integrazione della presentazione dei dati rilevati nella rete di monitoraggio della qualità dell aria, si riportano in maniera sintetica i dati relativi ai parametri meteorologici
Situazione meteorologica Ad integrazione della presentazione dei dati rilevati nella rete di monitoraggio della qualità dell aria, si riportano in maniera sintetica i dati relativi ai parametri meteorologici
Il peso epidemiologico
 Le disabilità dell apprendimento Umberto Balottin, Cristiano Termine Cattedra di Neuropsichiatria Infantile Università degli Studi dell Insubria Unità Operativa di Neuropsichiatria dell Infanzia e Adolescenza
Le disabilità dell apprendimento Umberto Balottin, Cristiano Termine Cattedra di Neuropsichiatria Infantile Università degli Studi dell Insubria Unità Operativa di Neuropsichiatria dell Infanzia e Adolescenza
Capitolo 3.2. La valutazione economica dei Nuovi Anticoagulanti Orali (NOACs) nella prevenzione di ictus in pazienti con fibrillazione atriale (SPAF)
 La valutazione economica dei Nuovi Anticoagulanti Orali (NOACs) nella prevenzione di ictus in pazienti con fibrillazione atriale (SPAF) Analisi di Budget Impact a livello nazionale e regionale 159 Analisi
La valutazione economica dei Nuovi Anticoagulanti Orali (NOACs) nella prevenzione di ictus in pazienti con fibrillazione atriale (SPAF) Analisi di Budget Impact a livello nazionale e regionale 159 Analisi
Questi appunti costituiscono soltanto una traccia sintetica del Corso di Laboratorio di Fisica, a prescindere dalle opportune spiegazioni e dai
 Questi appunti costituiscono soltanto una traccia sintetica del Corso di Laboratorio di Fisica, a prescindere dalle opportune spiegazioni e dai necessari chiarimenti forniti a lezione. 1 MISURA DI UNA
Questi appunti costituiscono soltanto una traccia sintetica del Corso di Laboratorio di Fisica, a prescindere dalle opportune spiegazioni e dai necessari chiarimenti forniti a lezione. 1 MISURA DI UNA
Analizzare in termini quantitativi significa basarsi su dati e non su idee o ipotesi
 Statistica La Statistica è una metodologia per l analisi quantitativa dei fenomeni collettivi, cioè fenomeni il cui studio richiede l osservazione di un insieme di manifestazioni individuali Analizzare
Statistica La Statistica è una metodologia per l analisi quantitativa dei fenomeni collettivi, cioè fenomeni il cui studio richiede l osservazione di un insieme di manifestazioni individuali Analizzare
PRINCIPIO DI REVISIONE N 320. Significatività
 PRINCIPIO DI REVISIONE N 320 Significatività Significatività Principio Revisione n 320 gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi se ci si possa ragionevolmente attendere che essi,
PRINCIPIO DI REVISIONE N 320 Significatività Significatività Principio Revisione n 320 gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi se ci si possa ragionevolmente attendere che essi,
MODULAZIONE DI UNA VARIABILE PERCETTIVA IN UN CONTESTO DI DOPPIO-COMPITO
 MODULAZIONE DI UNA VARIABILE PERCETTIVA IN UN CONTESTO DI DOPPIO-COMPITO ROBERTO DELL ACQUA, ANGELO PASCALI E FRANCESCA PERESSOTTI Università di Padova Riassunto. In ogni prova del presente esperimento,
MODULAZIONE DI UNA VARIABILE PERCETTIVA IN UN CONTESTO DI DOPPIO-COMPITO ROBERTO DELL ACQUA, ANGELO PASCALI E FRANCESCA PERESSOTTI Università di Padova Riassunto. In ogni prova del presente esperimento,
CORSO DI PERFEZIONAMENTO
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA DIPARTIMENTO DI FISICA CORSO DI PERFEZIONAMENTO PERCORSI DIDATTICI DI FISICA E MATEMATICA: MODELLI, VERIFICHE SPERIMENTALI, STATISTICA ATOMI E CARICA ELETTRICA: PROPOSTA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA DIPARTIMENTO DI FISICA CORSO DI PERFEZIONAMENTO PERCORSI DIDATTICI DI FISICA E MATEMATICA: MODELLI, VERIFICHE SPERIMENTALI, STATISTICA ATOMI E CARICA ELETTRICA: PROPOSTA
PSICOMETRIA. Corso di laurea triennale (classe 34) VERIFICA DELL IPOTESI CON DUE CAMPIONI
 PSICOMETRIA Corso di laurea triennale (classe 34) VERIFICA DELL IPOTESI CON DUE CAMPIONI CAMPIONI INDIPENDENTI Campioni estratti casualmente dalla popolazione con caratteristiche omogenee Assegnazione
PSICOMETRIA Corso di laurea triennale (classe 34) VERIFICA DELL IPOTESI CON DUE CAMPIONI CAMPIONI INDIPENDENTI Campioni estratti casualmente dalla popolazione con caratteristiche omogenee Assegnazione
IL CARPOOLING IN ITALIA: ANALISI DELL OFFERTA
 TRASPOL REPORT 2/16 IL CARPOOLING IN ITALIA: ANALISI DELL OFFERTA SINTESI DEI RISULTATI Le pratiche di mobilità innovativa (carsharing, carpooling, mobilità elettrica, etc.) mostrano una sempre maggiore
TRASPOL REPORT 2/16 IL CARPOOLING IN ITALIA: ANALISI DELL OFFERTA SINTESI DEI RISULTATI Le pratiche di mobilità innovativa (carsharing, carpooling, mobilità elettrica, etc.) mostrano una sempre maggiore
TEST DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN INGRESSO da Pre alfa A1 ad A2* GUIDA PER L INSEGNANTE, ASCOLTI E SOLUZIONI
 TEST DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN INGRESSO da Pre alfa A1 ad A2* GUIDA PER L INSEGNANTE, ASCOLTI E SOLUZIONI a cura di A. Borri, L. Di Lucca, G. Masiero, T. Pasqualini * Per i livelli dal Pre alfa
TEST DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN INGRESSO da Pre alfa A1 ad A2* GUIDA PER L INSEGNANTE, ASCOLTI E SOLUZIONI a cura di A. Borri, L. Di Lucca, G. Masiero, T. Pasqualini * Per i livelli dal Pre alfa
Grandezze fisiche e loro misura
 Grandezze fisiche e loro misura Cos è la fisica? e di che cosa si occupa? - Scienza sperimentale che studia i fenomeni naturali suscettibili di sperimentazione e caratterizzati da entità o grandezze misurabili.
Grandezze fisiche e loro misura Cos è la fisica? e di che cosa si occupa? - Scienza sperimentale che studia i fenomeni naturali suscettibili di sperimentazione e caratterizzati da entità o grandezze misurabili.
DIAGNOSI NEUROPSICOLOGICA DELL ADHD
 DIAGNOSI NEUROPSICOLOGICA DELL ADHD Chiarenza GA, Acace M, Lo Torto MG, Pozzi C, Raia R, Tomassini E, Olgiati P¹. Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile, Az. Osp. G. Salvini, Rho, Milano. ¹ Università
DIAGNOSI NEUROPSICOLOGICA DELL ADHD Chiarenza GA, Acace M, Lo Torto MG, Pozzi C, Raia R, Tomassini E, Olgiati P¹. Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile, Az. Osp. G. Salvini, Rho, Milano. ¹ Università
ANALISI DELLE PAROLE COMPLESSE Q U E S T I O N I D I M E T O D O P A R T E 1. Francesca Forza - Linguistica Generale 2
 ANALISI DELLE PAROLE COMPLESSE 1 Q U E S T I O N I D I M E T O D O P A R T E 1 Perché? Parole complesse: struttura interna. rappresentare tale struttura in modi espliciti e non ambigui. La struttura che
ANALISI DELLE PAROLE COMPLESSE 1 Q U E S T I O N I D I M E T O D O P A R T E 1 Perché? Parole complesse: struttura interna. rappresentare tale struttura in modi espliciti e non ambigui. La struttura che
Comunicazione Vs. Linguaggio
 Comunicazione Vs. Linguaggio Comunicazione: rete di scambi di informazioni e di relazioni sociali sirealizzaall internodiungruppo(naturasociale) ne costituisce la base dell interazione e delle relazioni
Comunicazione Vs. Linguaggio Comunicazione: rete di scambi di informazioni e di relazioni sociali sirealizzaall internodiungruppo(naturasociale) ne costituisce la base dell interazione e delle relazioni
Mason, Psicologia dell'apprendimento e dell'istruzione, Il Mulino, Capitolo VI.
 Capitolo VI. APPRENDERE STRATEGIE E ABILITÀ: METACOGNIZONE, COMPRENSIONE E PRODUZIONE DEL TESTO 1 Evoluzione per: esperienze sviluppo delle abilità meta cognitive. 2 Cosa è la metacognizione? E la metacomprensione?
Capitolo VI. APPRENDERE STRATEGIE E ABILITÀ: METACOGNIZONE, COMPRENSIONE E PRODUZIONE DEL TESTO 1 Evoluzione per: esperienze sviluppo delle abilità meta cognitive. 2 Cosa è la metacognizione? E la metacomprensione?
Simulazione. D.E.I.S. Università di Bologna DEISNet
 Simulazione D.E.I.S. Università di Bologna DEISNet http://deisnet.deis.unibo.it/ Introduzione Per valutare le prestazioni di un sistema esistono due approcci sostanzialmente differenti Analisi si basa
Simulazione D.E.I.S. Università di Bologna DEISNet http://deisnet.deis.unibo.it/ Introduzione Per valutare le prestazioni di un sistema esistono due approcci sostanzialmente differenti Analisi si basa
RALLENTAMENTO COGNITIVO ED ETA' Dario SALMASO CNR-Istituto di Psicologia, Roma. Sottoprogetto 4
 RALLENTAMENTO COGNITIVO ED ETA' Dario SALMASO CNR-Istituto di Psicologia, Roma. Sottoprogetto 4 Riassunto 2 La diagnosi precoce di un anomalo funzionamento dei processi cognitivi passa attraverso la definizione
RALLENTAMENTO COGNITIVO ED ETA' Dario SALMASO CNR-Istituto di Psicologia, Roma. Sottoprogetto 4 Riassunto 2 La diagnosi precoce di un anomalo funzionamento dei processi cognitivi passa attraverso la definizione
PROCEDURE/TECNICHE DI ANALISI / MISURE DI ASSOCIAZIONE A) ANALISI DELLA VARIANZA
 PROCEDURE/TECNICHE DI ANALISI / MISURE DI ASSOCIAZIONE A) ANALISI DELLA VARIANZA PROCEDURA/TECNICA DI ANALISI DEI DATI SPECIFICAMENTE DESTINATA A STUDIARE LA RELAZIONE TRA UNA VARIABILE NOMINALE (ASSUNTA
PROCEDURE/TECNICHE DI ANALISI / MISURE DI ASSOCIAZIONE A) ANALISI DELLA VARIANZA PROCEDURA/TECNICA DI ANALISI DEI DATI SPECIFICAMENTE DESTINATA A STUDIARE LA RELAZIONE TRA UNA VARIABILE NOMINALE (ASSUNTA
L APPRENDIMENTO MULTIMEDIALE
 L APPRENDIMENTO MULTIMEDIALE Tratto dal 3 capitolo del testo Psicologia dell apprendimento multimediale N. Mammarella, C. Cornoldi, F. Pazzaglia Il Mulino, 2005 Per multimedialità si intende la somministrazione
L APPRENDIMENTO MULTIMEDIALE Tratto dal 3 capitolo del testo Psicologia dell apprendimento multimediale N. Mammarella, C. Cornoldi, F. Pazzaglia Il Mulino, 2005 Per multimedialità si intende la somministrazione
PROVE MT Gruppo Cornoldi. Lettura e comprensione del testo scritto
 PROVE MT Gruppo Cornoldi Lettura e comprensione del testo scritto L'OBIETTIVO DELLA LETTURA È LA COMPRENSIONE PROVE MT Saper leggere non significa soltanto saper tradurre i grafemi in fonemi L abilità
PROVE MT Gruppo Cornoldi Lettura e comprensione del testo scritto L'OBIETTIVO DELLA LETTURA È LA COMPRENSIONE PROVE MT Saper leggere non significa soltanto saper tradurre i grafemi in fonemi L abilità
I^ GIORNATA DI FORMAZIONE
 Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale I^ GIORNATA DI FORMAZIONE Regione MARCHE ASCOLI PICENO San Benedetto del Tronto MARTEDI 20 MARZO 2007 PIANO
Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale I^ GIORNATA DI FORMAZIONE Regione MARCHE ASCOLI PICENO San Benedetto del Tronto MARTEDI 20 MARZO 2007 PIANO
Misure Meccaniche e Termiche. punti massa. Valore atteso: Varianza:
 Fenomeni aleatori Misure Meccaniche e Termiche Sezione di Misure e Tecniche Sperimentali I fenomeni aleatori (o casuali) sono fenomeni empirici il cui risultato non è prevedibile a priori, caratterizzati
Fenomeni aleatori Misure Meccaniche e Termiche Sezione di Misure e Tecniche Sperimentali I fenomeni aleatori (o casuali) sono fenomeni empirici il cui risultato non è prevedibile a priori, caratterizzati
Concordanze e collocazioni. Analisi del testo letterario 1 Isabella Chiari
 Concordanze e collocazioni Analisi del testo letterario 1 Isabella Chiari 1 Analisi degli usi con le concordanze Il cotesto estrazione di informazioni linguistiche essenziali sugli usi della parola individuazione
Concordanze e collocazioni Analisi del testo letterario 1 Isabella Chiari 1 Analisi degli usi con le concordanze Il cotesto estrazione di informazioni linguistiche essenziali sugli usi della parola individuazione
Teoria e tecniche dei test
 Teoria e tecniche dei test Lezione 9 LA STANDARDIZZAZIONE DEI TEST. IL PROCESSO DI TARATURA: IL CAMPIONAMENTO. Costruire delle norme di riferimento per un test comporta delle ipotesi di fondo che è necessario
Teoria e tecniche dei test Lezione 9 LA STANDARDIZZAZIONE DEI TEST. IL PROCESSO DI TARATURA: IL CAMPIONAMENTO. Costruire delle norme di riferimento per un test comporta delle ipotesi di fondo che è necessario
Parole e frequenze. Alessandro Lenci
 Parole e frequenze Alessandro Lenci Università di Pisa, Dipartimento di Linguistica Via Santa Maria, 36, 5600 Pisa, Italy alessandro.lenci@ilc.cnr.it Linguaggio e comunicazione - LO042 Rango di una parola
Parole e frequenze Alessandro Lenci Università di Pisa, Dipartimento di Linguistica Via Santa Maria, 36, 5600 Pisa, Italy alessandro.lenci@ilc.cnr.it Linguaggio e comunicazione - LO042 Rango di una parola
PROGRAMMAZIONE LINGUA ITALIANA. Classe quarta
 PROGRAMMAZIONE LINGUA ITALIANA Classe quarta ASCOLTARE E PARLARE 1. Strategie essenziali dell'ascolto. 2. Processi di controllo da mettere in atto durante l'ascolto. 3. Interazioni fra testo e contesto.
PROGRAMMAZIONE LINGUA ITALIANA Classe quarta ASCOLTARE E PARLARE 1. Strategie essenziali dell'ascolto. 2. Processi di controllo da mettere in atto durante l'ascolto. 3. Interazioni fra testo e contesto.
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO
 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO CLASSE PRIMA OBIETTIVI 1. PRODUZIONE E COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE: ASCOLTARE, COMPRENDERE, PARLARE 1.1 Ascoltare e comprendere semplici messaggi 1.2 Ascoltare
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO CLASSE PRIMA OBIETTIVI 1. PRODUZIONE E COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE: ASCOLTARE, COMPRENDERE, PARLARE 1.1 Ascoltare e comprendere semplici messaggi 1.2 Ascoltare
LE ABILITÀ DI PIANIFICAZIONE IN UN GRUPPO DI BAMBINI CON ADHD
 LE ABILITÀ DI PIANIFICAZIONE IN UN GRUPPO DI BAMBINI CON ADHD VII CONGRESSO NAZIONALE sul Disturbo da Deficit dell Attenzione/Iperattività Relazione di Valagussa S., Merati S.,Valenti V., Ottolini A. e
LE ABILITÀ DI PIANIFICAZIONE IN UN GRUPPO DI BAMBINI CON ADHD VII CONGRESSO NAZIONALE sul Disturbo da Deficit dell Attenzione/Iperattività Relazione di Valagussa S., Merati S.,Valenti V., Ottolini A. e
L analisi della Varianza (ANOVA): i disegni fattoriali tra i soggetti
 Lezione 14 L analisi della Varianza (ANOVA): i disegni fattoriali tra i soggetti Argomenti della lezione: Effetti principali e interazioni Analisi dei disegni fattoriali Disegni fattoriali (o a più vie):
Lezione 14 L analisi della Varianza (ANOVA): i disegni fattoriali tra i soggetti Argomenti della lezione: Effetti principali e interazioni Analisi dei disegni fattoriali Disegni fattoriali (o a più vie):
Le difficoltà di apprendimento e l intervento di aiuto APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA
 Le difficoltà di apprendimento e l intervento di aiuto APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA COSA SONO LA LETTURA E LA SCRITTURA? Come si colloca la funzione della scrittura all interno dei sistemi di comunicazione?
Le difficoltà di apprendimento e l intervento di aiuto APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA COSA SONO LA LETTURA E LA SCRITTURA? Come si colloca la funzione della scrittura all interno dei sistemi di comunicazione?
Matrici di Raven (PM47)
 Matrici di Raven (PM47) Matrici di Raven (PM47) Matrici di Raven (PM47) Matrici di Raven (PM38) TRA I TEST DI TIPICA PERFORMANCE Test proiettivi Test self-report di personalità Questionari psichiatrici
Matrici di Raven (PM47) Matrici di Raven (PM47) Matrici di Raven (PM47) Matrici di Raven (PM38) TRA I TEST DI TIPICA PERFORMANCE Test proiettivi Test self-report di personalità Questionari psichiatrici
PIANO ANNUALE DI LAVORO
 Mod. 102 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA USR-LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LATINA 303 Via Latina, 303 00179 ROMA 17 Distretto Municipio VII (ex IX) - tel. 06 788 00 95 fax 06
Mod. 102 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA USR-LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LATINA 303 Via Latina, 303 00179 ROMA 17 Distretto Municipio VII (ex IX) - tel. 06 788 00 95 fax 06
5 LEZIONE. LA DISGRAFIA: INSEGNARE A SCRIVERE BENE
 5 LEZIONE. LA DISGRAFIA: INSEGNARE A SCRIVERE BENE La scrittura Come abbiamo più volte ripetuto, la scrittura è un abilità altamente complessa che include livelli diversi, dal motorio al concettuale, che
5 LEZIONE. LA DISGRAFIA: INSEGNARE A SCRIVERE BENE La scrittura Come abbiamo più volte ripetuto, la scrittura è un abilità altamente complessa che include livelli diversi, dal motorio al concettuale, che
Testo completo delle prove PISA
 Testo completo delle prove PISA Domanda 1: ANDATURA Se la formula si applica all andatura di Enrico ed Enrico fa 70 passi al minuto, qual è la lunghezza del passo di Enrico? Scrivi qui sotto i passaggi
Testo completo delle prove PISA Domanda 1: ANDATURA Se la formula si applica all andatura di Enrico ed Enrico fa 70 passi al minuto, qual è la lunghezza del passo di Enrico? Scrivi qui sotto i passaggi
I TEST STATISTICI. dott.ssa Gabriella Agrusti
 I TEST STATISTICI dott.ssa Gabriella Agrusti Dulcis in fundo.. come scegliere un test statistico in base all ipotesi come stabilire se due variabili sono associate (correlazione di Pearson) come stabilire
I TEST STATISTICI dott.ssa Gabriella Agrusti Dulcis in fundo.. come scegliere un test statistico in base all ipotesi come stabilire se due variabili sono associate (correlazione di Pearson) come stabilire
Corso di elettrotecnica Materiale didattico: i grafi
 Corso di elettrotecnica Materiale didattico: i grafi A. Laudani 12 ottobre 2005 I grafi costituiscono uno strumento matematico che permette di descrivere e schematizzare una grande varietà di problemi
Corso di elettrotecnica Materiale didattico: i grafi A. Laudani 12 ottobre 2005 I grafi costituiscono uno strumento matematico che permette di descrivere e schematizzare una grande varietà di problemi
DETERMINAZIONE DEI DIAMETRI E CONTROLLO FRA LABORATORI
 Gruppo Interregionale Fibre Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro C.T.I.P.L.L. CLASSIFICAZIONE DI MMVFs DETERMINAZIONE DEI DIAMETRI E CONTROLLO FRA LABORATORI Studio
Gruppo Interregionale Fibre Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro C.T.I.P.L.L. CLASSIFICAZIONE DI MMVFs DETERMINAZIONE DEI DIAMETRI E CONTROLLO FRA LABORATORI Studio
Istituto Comprensivo di Pralboino Curricolo Verticale
 ITALIANO CLASSE 2 a PRIMARIA ASCOLTO E PARLATO -L allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando
ITALIANO CLASSE 2 a PRIMARIA ASCOLTO E PARLATO -L allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando
Il Concetto Intuitivo di Calcolatore. Esercizio. I Problemi e la loro Soluzione. (esempio)
 Il Concetto Intuitivo di Calcolatore Elementi di Informatica e Programmazione Ingegneria Gestionale Università degli Studi di Brescia Docente: Prof. Alfonso Gerevini Variabile di uscita Classe di domande
Il Concetto Intuitivo di Calcolatore Elementi di Informatica e Programmazione Ingegneria Gestionale Università degli Studi di Brescia Docente: Prof. Alfonso Gerevini Variabile di uscita Classe di domande
