Retorica dell immagine
|
|
|
- Fabia Di Giovanni
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 BARTHES Retorica
2 Retorica dell immagine L immagine, come il mito, naturalizza le ideologie attraverso stereotipi, tecniche, abitudini percettive, che costituiscono il piano della connotazione (diverso dalla denotazione: oggetto rappresentato). Attraverso lo studio della retorica dell immagine Barthes giunge a definire i semi connotativi.
3 Analisi dell immagine pubblicitaria la pasta Panzani
4 Il messaggio linguistico è doppio: denotativo e connotativo L immagine presenta una serie di segni discontinui: Un primo segno ha per significante la borsa semiaperta che lascia le provviste spandersi sulla tavola come preconfezionate, il cui significato è un ritorno dal mercato ; tale significato implica due valori euforici: la freschezza dei prodotti e la preparazione interamente casalinga a cui essi sono destinati. Un secondo segno ha per significante l insieme del pomodoro, del peperone e della tinta tricolore (giallo, rosso, verde), il suo significato è l Italia, o meglio l italianità. Questo segno si trova in un rapporto di ridondanza con il segno connotato del messaggio linguistico (assonanza italiana del nome Panzani); il sapere messo in moto da questo segno è propriamente francese (fondato su stereotipi turistici). Terzo segno: l assembramento di oggetti diversi che trasmette l idea di un servizio culinario totale; la scena suggerisce un collegamento tra l origine naturale dei prodotti e il risultato finale. Quarto segno: la composizione evoca il ricordo di pitture alimentari note come natura morta, attivando (e richiedendo) un sapere fortemente culturale. Questi quattro segni di cui si compone l immagine sono tutti discontinui (ritagliano degli elementi per veicolare delle connotazioni), richiedono un sapere genericamente culturale, e rinviano a significati tutti di ordine globale (ad esempio l italianità), penetrati da valori euforici. Il lettore non si accorge subito che determinati colori connotano l italianità o che certi prodotti sono organizzati plasticamente per connotare freschezza.
5 Semi di connotazione I significati connotativi sono semi (elementi minimi di significazione) di natura particolare: es. l italianità della marca Panzani, la femminilità di un certo nome, ecc. «l italianità non è l Italia, è l essenza condensata di tutto ciò che può essere italiano, dagli spaghetti alla pittura» (Barthes, 1964: 38) La connotazione consente di spiegare i significati simbolici e dunque ideologici delle immagini attraverso il riferimento a semi aggiuntivi, elementi di significazione addizionali rispetto ai significati denotativi del lessico. I connotatori sono significanti che in modo erratico e discontinuo rinviano a significati simbolici (o connotativi). L insieme dei connotatori costituisce la retorica, mentre l insieme dei significati connotativi costituisce l ideologia. Il connotativo scivola in un ambito che è più propriamente sociologico che strettamente linguistico (ma vedi Sociologia e sociologica, in L avventura semiologica).
6 Il messaggio linguistico Vi è sempre un testo sotto o vicino all immagine? Il legame tra testo e immagine è molto frequente, ma sembra poco indagato dal punto di vista strutturale. Qual è la struttura significante della illustrazione? L immagine raddoppia certe informazioni del testo, in un fenomeno di ridondanza, oppure il testo aggiunge una informazione inedita all immagine? Non è del tutto giusto parlare oggi di civiltà dell immagine: siamo ancora e più che mai una civiltà della scrittura (l assenza di parola ricopre sempre un intento enigmatico). Quali sono le funzioni del messaggio linguistico in rapporto al messaggio iconico?: ancoraggio e ricambio L immagine è polisemica, la polisemia produce una interrogazione sul senso. L ancoraggio può essere ideologico: il testo dirige il lettore tra i significati dell immagine, gliene fa evitare alcuni e recepire altri, lo guida verso un senso scelto in anticipo. Il testo è il diritto di sguardo del creatore (e dunque della società) nei confronti dell immagine; in rapporto alla libertà dell immagine, il testo ha un valore repressivo, è al suo livello che si investono la morale e l ideologia di una società. L ancoraggio è la funzione più frequente: la si ritrova oltre che in pubblicità nella fotografia sui giornali. La funzione di ricambio è più rara: la si trova soprattutto nei disegni umoristici e nei fumetti. Qui le parole come le immagini sono frammenti di un sintagma più generale, e l unità del messaggio si formula a un livello superiore, quello della storia, dell aneddoto, della diegesi. (Retorica dell immagine, pp. 27 sgg.).
7 L immagine denotata Non si incontra mai (almeno in pubblicità) una immagine letterale allo stato puro. Il messaggio letterale è ciò che resta quando si cancellano (mentalmente) i segni di connotazione. La lettera dell immagine corrisponde al primo grado dell intelligibile (al di qua di tale grado il lettore percepirebbe solo linee, forme, colori). La fotografia possiede il potere di trasmettere l informazione (letterale) senza formarla con l aiuto di segni discontinui e regole di trasformazione, è messaggio senza codice; e l assenza del codice rafforza il mito del naturale fotografico. Gli interventi sulla fotografia (inquadratura, distanza, luce, ecc.) appartengono tutti al piano della connotazione. La fotografia installa non una coscienza dell esserci della cosa (che ogni copia potrebbe suscitare) ma una coscienza dell esserci stato: si tratta di una nuova categoria dello spazio-tempo: locale immediato e temporale anteriore; nella fotografia si produce una congiunzione illogica tra un qui e un tempo. L immagine denotata, nella misura in cui non implica nessun codice (fotografia pubblicitaria), svolge nella struttura generale del messaggio iconico un ruolo particolare: l immagine denotata naturalizza il messaggio simbolico, rende innocente l artificio semantico, molto denso (soprattutto in pubblicità), della connotazione. Nella fotografia resta una specie di esserci naturale degli oggetti; l assenza di codici disintellettualizza il messaggio. È questo, senza dubbio, un paradosso storico importante: più la tecnica sviluppa la diffusione delle informazioni (e soprattutto delle immagini), e più essa fornisce i mezzi per mascherare il senso costruito sotto l apparenza del senso dato. (Retorica dell immagine, pp. 31, sgg).
8 Retorica dell immagine Una stessa lessia mobilizza lessici diversi. Un lessico è una porzione del piano simbolico (del linguaggio) che corrisponde a un corpus di pratiche e di tecniche (cfr. Greimas). Lo stesso vale per le diverse letture dell immagine: ogni segno corrisponde a un insieme di atteggiamenti : il turismo, la vita coniugale, la conoscenza dell arte, alcuni dei quali possono mancare al livello di un individuo. C è una pluralità e una coesistenza di lessici in uno stesso individuo; il numero e l identità di questi lessici formano in qualche modo l idioletto di ciascuno. L immagine, nella sua connotazione, sarebbe dunque costituita da un architettura di segni derivati da una profondità variabile di lessici (di idioletti); e ciascun lessico, per quanto profondo sia, risulta codificato. Retorica è l insieme dei significanti connotatori; i connotatori sono sempre dei segni discontinui, erratici, naturalizzati dal messaggio denotato che fa loro da veicolo. L ideologia sarebbe insomma la forma (nel senso hjelmsleviano) dei significati di connotazione, mentre la retorica sarebbe la forma dei connotatori (Elementi di semiologia, p. 81); la retorica appare cioè come il volto significante della ideologia. Questa retorica non potrà essere costituita se non a partire da un inventario assai ampio, ma si può prevedere sin d ora che vi si ritroveranno alcune delle figure già individuate dagli antichi e dai classici. Così il pomodoro indica l italianità per metonimia. Il sintagma del messaggio denotato naturalizza il sistema del messaggio connotato. La connotazione non è che sistema e non può definirsi se non in termini di paradigma; la denotazione iconica non è che sintagma e associa elementi senza sistema. Il mondo del senso totale è lacerato internamente tra il sistema come cultura e il sintagma come natura: i prodotti delle comunicazioni di massa uniscono, attraverso dialettiche diverse ed esiti diversi, il fascino di una natura, che è quella della narrazione, della diegesi, del sintagma, e l intelligibilità di una cultura, rifugiata in alcuni simboli discontinui, che gli uomini declinano al riparo dalla loro parola vivente (Retorica dell immagine, p. 35 sgg.).
9 Fotografia, narrazione e argomentazione Uso delle fotografie in Barthes di Roland Barthes Chiarimento in La grana della voce, pp : Le fotografie connotano sempre qualche cosa di diverso da quello che mostrano sul piano della denotazione: è attraverso lo stile che la fotografia è linguaggio; ma la fotografia non è lingua perché non lavora con pezzi di materiale che hanno già un senso. Se si vuole veramente parlare della fotografia su un piano serio, bisogna metterla in rapporto con la morte. È vero che la foto è un testimone, ma un testimone di ciò che non è più. Anche se il soggetto è sempre vivo, è un momento del soggetto, quello che è stato fotografato, e quel momento non è più. Ogni atto di cattura e di lettura di una foto è implicitamente, in maniera rimossa, un contatto con ciò che non è più, vale a dire con la morte.
10 La ripresa della retorica antica «una sorta di vulgata aristotelica definisce ancora un tipo di Occidente trans-storico, una civiltà (la nostra) che è quella degli endoxa: [ ] Aristotele (poeta, logico, retorico) fornisce a tutti il linguaggio, narrativo, discorsivo, argomentativo, che viene veicolato dalle comunicazioni di massa, una griglia analitica completa (a partire dalla nozione di verosimile )[ ]»(La retorica antica (1970), p. 109). La struttura del discorso persuasivo posta alla base della retorica aristotelica si trova riproposta nel discorso persuasivo della società di massa contemporanea, dominata da un estetica del verosimile ( quel che il pubblico crede possibile ): Meglio un verosimile impossibile che un possibile inverosimile». «tutta la nostra letteratura, formata dalla retorica e sublimata dall umanesimo, è uscita da una pratica politico-giudiziaria: là dove i conflitti più brutali, di denaro, di proprietà, di classe sono assunti, contenuti, ammansiti e mantenuti da un diritto di Stato, là dove l istituzione regolamenta la parola finta e codifica ogni ricorso al significante, là nasce la nostra letteratura» (RA, 110)
11 Rilevanza delle passioni nella semiotica classica: movere, delectare vs docere (pathos, ethos vs logos) Una psicologia verosimile e non vera, una psicologia proiettata: non quel che c è nella testa del pubblico, ma quel che il pubblico crede che gli altri abbiano nella testa: è un endoxon. La psicologia retorica di Aristotele è una descrizione dell eikos, del verisimile passionale. Le prove psicologiche si dividono in due grandi gruppi: ethe (i caratteri, i toni, le arie) e pathe (le passioni, i sentimenti, gli affetti)
12 Ethos Tratti del carattere (tono) che l oratore deve mostrare all uditorio per fare buona impressione. È una psicologia immaginaria: io devo significare quello che voglio essere per l altro. L ethos è propriamente una connotazione: l oratore enuncia un informazione e nello stesso tempo dice: io sono questo, io sono quest altro. Per Aristotele ci sono tre arie che insieme costituiscono l autorità personale dell oratore: 1) phronesis: è la qualità di colui che delibera bene, che pesa bene il pro e il contro; è una saggezza obiettiva, un buon senso ostentato; 2) aretè: è l ostentazione di una franchezza che non teme le proprie conseguenze e si esprime per propositi diretti, improntati a una lealtà teatrale; 3) eunoia: l essere gradevole (e forse anche simpatico), capacità d entrare in una complicità compiacente nei confronti dell uditorio. Insomma, mentre parla e svolge il protocollo delle prove logiche, l oratore deve anche dire incessantemente: seguitemi (phronesis), stimatemi (aretè) e amatemi (eunoia) (La retorica antica, pp. 86-7).
13 Pathos Pathe sono gli affetti di colui che ascolta, almeno per come se li immagina l oratore. Ogni passione è caratterizzata secondo il suo habitus (le disposizioni generali che la favoriscono), il suo oggetto (per cui essa viene provata) e le circostanze che suscitano la cristallizzazione (collera/calma, odio/amicizia, timore/fiducia, invidia/emulazione, ingratitudine/obbligo ecc.). Bisogna insistere, dato che è questo a caratterizzare la profonda modernità di Aristotele e farne il patrono ideale di una sociologia della cultura detta di massa: tutte queste passioni sono volontariamente prese nella loro banalità: la collera è ciò che tutti pensano della collera, la passione non mai altro che quel che se ne dice: intertestuale puro, citazione (così lo intendevano Paolo e Francesca che non si amarono se non per aver letto gli amori di Lancillotto) (La retorica antica, pp. 87-8).
14 Psicologia retorica «La psicologia retorica è dunque tutto il contrario di una psicologia riduttrice, che tenti di vedere cosa sta dietro a quel che le persone dicono e pretenda di ridurre la collera, per esempio, a qualcos altro di più nascosto. Per Aristotele, l opinione del pubblico è il dato primo e ultimo, non c è in lui nessuna idea ermeneutica (di decifrazione): per lui, le passioni sono pezzi di linguaggio già fatti, che l oratore deve semplicemente conoscere bene: di qui l idea di una griglia delle passioni, non come una collezione di essenze, ma come una raccolta di opinioni. Alla psicologia riduttrice (che oggi prevale), Aristotele sostituisce (in anticipo) una psicologia classificatrice, che distingue i linguaggi» (La retorica antica, p. 88). La retorica antica si offre come una classificazione (opzione ideologica).
15 Il piacere del testo La scrittura è al centro dell opera di Roland Barthes, così come l attenzione per la lettura e il lettore. Il testo non è solo un oggetto ideologico, un oggetto di analisi, ma anche la fonte di un piacere. L impero dei segni (1970). Lo zen, di cui l haiku è l espressione letteraria, appare una immensa pratica volta ad arrestare il linguaggio, a rompere «questa sorta di radiofonia interiore che risuona continuamente in noi, sin dentro il nostro sonno». «La brevità dell haiku non è formale; l haiku non è un pensiero ricco ridotto a forma breve, ma un evento breve che trova tutt a un tratto la sua forma esatta. La parsimonia di linguaggio è ciò in cui l Occidente si rivela meno abile: non è tanto ch esso produca testi troppo lunghi o troppo brevi, ma tutta la sua retorica gli impone di rendere sproporzionato il significante e il significato sia diluendo il secondo sotto i fiotti loquaci del primo, sia approfondendo la forma verso le regioni implicite del contenuto. L esattezza dell haiku [ ] ha la purezza, la sfericità e il vuoto stesso d una nota musicale» (L impero dei segni, p. 88). Questo è anche il modo di lavorare di Barthes, il suo procedere «per forza di levare» nel passaggio dai materiali raccolti al testo definitivo per soppressioni, tagli e riduzioni sia sul piano strutturale che stilistico. Ammiratore di Brecht, che ai suo attori prescriveva: «a digiuno, non ingrassatevi, siate secchi, siate a digiuno». Il frammento è un genere retorico (Lexìa=frammento di lettura). L opera non è mai monumentale, è una proposizione che ciascuno saturerà come vorrà.
16 «il piacere è una nozione che ho utilizzato in modo un po tattico quando ho constato che gli studi, le idee, le teorie sul fatto letterario avevano fatto dei grandi progressi sul piano teorico ma che in questi progressi di tipo teorico la percezione del testo finiva per essere un po astratta, un po fredda e un po sottomessa a dei valori impliciti di autorità [ ] il testo non è solo un oggetto ideologico, un oggetto di analisi, ma [ ] è anche la fonte di un piacere. C è un piacere di lettura del testo [ ].Il godimento è un termine molto più forte, molto più enigmatico, molto più misterioso Ho dunque definito il piacere, soprattutto nella letteratura, come una sorta di godimento diffuso, di godimento trattenuto, di godimento relativo a delle condizioni di situazione di lettura» (Oeuvres complètes, IV, p. 534) Immaginando un estetica fondata interamente sul piacere del fruitore, Barthes intuisce con largo anticipo quello che diventerà un dogma non tanto dell ambito letterario quanto paradossalmente della società dei consumi, e cioè l estetizzazione del quotidiano e il credo del marketing contemporaneo. Eco elaborerà la sua teoria sui modi della cooperazione testuale in Lector in fabula (1979), ponendola esplicitamente sullo sfondo del piacere/godimento barthesiani.
17 Lezione (1978), Einaudi, 1981:3 Barthes e la semiotica «se è vero che sin dall inizio ho legato la mia ricerca alla nascita e allo sviluppo della semiotica, è anche vero che ho pochi diritti di rappresentarla, tanto sono incline a eluderne la definizione, non appena questa mi sembrava formata, e ad appoggiarmi alle forze eccentriche della modernità, più vicino a Tel Quel che non alle numerose riviste che, nel mondo, attestano il vigore della ricerca semiologica».
18 Critica del potere «noi abbiamo creduto che il potere fosse un oggetto eminentemente politico; oggi crediamo che esso sia anche un oggetto ideologico, che si insinua dove non risulta facile individuarlo di primo acchito (nelle istituzioni, nell insegnamento), ma che in definitiva continui ad essere sempre uno solo. [ ]; ovunque, in ogni dove, vi sono capi, centri di potere, siano questi imponenti o minuscoli, gruppi di oppressione o di pressione; ovunque si odono voci autorizzate, che si autorizzano a farsi portavoce del discorso di ogni potere: il discorso dell arroganza. Ecco allora intuiamo che il potere è presente anche nei più delicati meccanismi dello scambio sociale: non solo nello Stato, nelle classi, nei gruppi, ma anche nelle mode, nelle opinioni comuni, negli spettacoli, nei giochi, negli sport, nelle informazioni, nei rapporti familiari e privati, e persino nelle spinte liberatrici che cercano di contestarlo: io chiamo discorso di potere ogni discorso che genera la colpa, e di conseguenza la colpevolezza, di colui che lo riceve [ ] il potere è il parassita d un organismo trans-sociale, legato all intera storia dell uomo, e non solamente alla sua storia politica, storica. Questo oggetto in cui, da che mondo è mondo, s inscrive il potere è: il linguaggio ovvero, per essere più precisi, la sua espressione obbligata: la lingua» (Lezione (1978), 1981:6-7)
19 «Da una parte la lingua è immediatamente assertiva: la negazione, il dubbio, la possibilità, l incertezza di giudizio richiedono degli operatori particolari, i quali vengono essi stessi risucchiati in un gioco di maschere linguistiche; ciò che i linguisti chiamano la modalità non è mai altro che il supplemento della lingua, attraverso cui, come in una supplica, io cerco di piegare il suo inesorabile potere di constatazione. Dall altra parte, i segni di cui la lingua è fatta esistono per quel tanto che sono riconosciuti, ossia per quel tanto che essi si ripetono; il segno è pedissequo, gregario; in ogni segno sonnecchia un mostro: lo stereotipo: io posso parlare solo se raccatto ciò che ricorre continuamente nella lingua [ ]. Dunque, nella lingua servilità e potere si confondono ineluttabilmente». Solo la letteratura permette di «truffare la lingua», di «concepire la lingua al di fuori del potere» (ivi: 9-11)
20 Lingua e discorso «Lingua e discorso si muovono lungo il medesimo asse di potere [ ] Questa distinzione di origine saussuriana (Langue/Parole) ha reso all inizio grandi servigi [ ] A un certo punto, come se fossi stato colpito da una sordità progressiva, io non ho più udito che un solo suono: quello della lingua e del discorso mescolati insieme. La linguistica mi è sembrata allora come un lavorare su un immensa illusione, su un oggetto che essa rendeva abusivamente pulito e puro, asciugandosi le dita con la matassa del discorso [ ]. La semiologia sarebbe perciò quel lavoro che raccoglie l impuro della lingua, lo scarto della linguistica, la corruzione immediata del messaggio: né più né meno che i desideri, i timori, i malumori, le intimidazioni, le avances, le affettuosità, le rimembranze, le scuse, le aggressioni, le musiche di cui è fatta la lingua attiva» (ivi:22-24)
21 Semiologia come critica sociale «per quel che mi riguarda la semiologia ha preso le mosse da un movimento propriamente passionale: mi era parso (intorno al 1954) che una scienza dei segni potesse attivare la critica sociale e che Sartre, Brecht e Saussure potessero trovarsi uniti in questo progetto; si trattava in fondo di capire in che modo una società produce degli stereotipi, ossia degli eccessi di artificio, che essa poi consuma come dei sensi innati, ossia come degli eccessi di natura. La semiologia (la mia, almeno) è nata da una intolleranza nei confronti di questo miscuglio di malafede e di coscienza tranquilla che caratterizza la moralità in generale, e che Brecht ha chiamato, criticandola aspramente, il Grande Uso. La lingua travagliata dal potere: ecco qual è stato l oggetto di questa prima semiologia» (ivi:24-25)
22 Ritorno al testo «Se la semiologia di cui parlo è perciò tornata al Testo, è perché, in questo coro di piccole signorie, il Testo le è apparso come l emblema stesso del de-potere. Il Testo ha in sé la forza di eludere all infinito la parola gregaria (quella che si aggrega), anche quando questa cerca di ricostituirsi in lui; esso spinge sempre più lontano da sé [ ] ricaccia altrove, verso un luogo non classificato, atopico, se così si può dire, lontano dai topoi della cultura politicizzata, «quest obbligo di dover formare dei concetti, delle specie, delle forme, dei fini, delle leggi questo mondo di casi identici», di cui parla Nietzsche; esso solleva debolmente, transitoriamente, la cappa di genericità, di moralità, di in-differenza (separiamo bene il prefisso dal radicale), che grava sul nostro discorso collettivo.
23 Semiologia e letteratura «La letteratura e la semiologia giungono così a coniugarsi per correggersi a vicenda. Da una parte, l incessante ritorno al testo, antico e moderno, il regolare immergersi nella più complessa delle pratiche significanti, e cioè la scrittura [ ] obbligano la semiologia a lavorare su delle differenze e la trattengono dal dogmatizzare, dal prendere dal prendersi per il discorso universale che non è» (ivi: 26-7). E da parte sua, lo sguardo semiotico, posato sul testo, obbliga a rifiutare il mito a cui solitamente si ricorre per salvare la letteratura dalla parola gregaria da cui essa è circondata, incanalata, e che è il mito della creatività pura: il segno deve essere pensato o ripensato per essere meglio tradito.
24 Semiophysis, semioclastia, semiotropia La semiologia come scienza negativa e attiva «non si fonda su una semiophysis, su una inerte naturalità del segno, [ ] essa non è neppure una semioclastia, una distruzione del segno. Essa sarebbe piuttosto, per continuare il paradigma greco, una semiotropia: volta verso il segno, essa ne è catturata e lo recepisce, lo maneggia e all occorrenza lo imita, come uno spettacolo immaginario [ ] non è un ermeneutica: essa dipinge anziché scavare, è piuttosto nella linea del porre che non in quella del levare. I suoi oggetti di predilezione sono i testi dell Immaginario: i racconti, le immagini, i ritratti, le espressioni, gli idioletti, le passioni, le strutture che giocano nello stesso tempo con un apparenza di verosimiglianza e con un indeterminatezza di verità» (ivi: 30-31).
25 Post-strutturalismo Pluralismo vs binarismo: dissolvere i fronteggiamenti e i paradigmi; la differenza sconfigge il conflitto. Polverizzazione, dispersione. Secondo Freud un po di differenza porta al conflitto ma molte ce ne allontanano. Utopia alla Fourier: società infinitamente parcellizzata, filosofia pluralista ostile alla massificazione. Pentecoste vs Babele.
Siamo così arrivati all aritmetica modulare, ma anche a individuare alcuni aspetti di come funziona l aritmetica del calcolatore come vedremo.
 DALLE PESATE ALL ARITMETICA FINITA IN BASE 2 Si è trovato, partendo da un problema concreto, che con la base 2, utilizzando alcune potenze della base, operando con solo addizioni, posso ottenere tutti
DALLE PESATE ALL ARITMETICA FINITA IN BASE 2 Si è trovato, partendo da un problema concreto, che con la base 2, utilizzando alcune potenze della base, operando con solo addizioni, posso ottenere tutti
Ascrizioni di credenza
 Ascrizioni di credenza Ascrizioni di credenza Introduzione Sandro Zucchi 2014-15 Le ascrizioni di credenza sono asserzioni del tipo in (1): Da un punto di vista filosofico, i problemi che pongono asserzioni
Ascrizioni di credenza Ascrizioni di credenza Introduzione Sandro Zucchi 2014-15 Le ascrizioni di credenza sono asserzioni del tipo in (1): Da un punto di vista filosofico, i problemi che pongono asserzioni
Come fare una scelta?
 Come fare una scelta? Don Alberto Abreu www.pietrscartata.com COME FARE UNA SCELTA? Osare scegliere Dio ha creato l uomo libero capace di decidere. In molti occasioni, senza renderci conto, effettuiamo
Come fare una scelta? Don Alberto Abreu www.pietrscartata.com COME FARE UNA SCELTA? Osare scegliere Dio ha creato l uomo libero capace di decidere. In molti occasioni, senza renderci conto, effettuiamo
f(x) = 1 x. Il dominio di questa funzione è il sottoinsieme proprio di R dato da
 Data una funzione reale f di variabile reale x, definita su un sottoinsieme proprio D f di R (con questo voglio dire che il dominio di f è un sottoinsieme di R che non coincide con tutto R), ci si chiede
Data una funzione reale f di variabile reale x, definita su un sottoinsieme proprio D f di R (con questo voglio dire che il dominio di f è un sottoinsieme di R che non coincide con tutto R), ci si chiede
Indice. 1 Il monitoraggio del progetto formativo --------------------------------------------------------------- 3. 2 di 6
 LEZIONE MONITORARE UN PROGETTO FORMATIVO. UNA TABELLA PROF. NICOLA PAPARELLA Indice 1 Il monitoraggio del progetto formativo --------------------------------------------------------------- 3 2 di 6 1 Il
LEZIONE MONITORARE UN PROGETTO FORMATIVO. UNA TABELLA PROF. NICOLA PAPARELLA Indice 1 Il monitoraggio del progetto formativo --------------------------------------------------------------- 3 2 di 6 1 Il
Capitolo 2. Operazione di limite
 Capitolo 2 Operazione di ite In questo capitolo vogliamo occuparci dell operazione di ite, strumento indispensabile per scoprire molte proprietà delle funzioni. D ora in avanti riguarderemo i domini A
Capitolo 2 Operazione di ite In questo capitolo vogliamo occuparci dell operazione di ite, strumento indispensabile per scoprire molte proprietà delle funzioni. D ora in avanti riguarderemo i domini A
La prima pagina uno schema fisso La testata manchette
 IL QUOTIDIANO La prima pagina è la facciata del quotidiano, presenta gli avvenimenti trattati più rilevanti e solitamente sono commentati; gli articoli sono disposti secondo uno schema fisso che ha lo
IL QUOTIDIANO La prima pagina è la facciata del quotidiano, presenta gli avvenimenti trattati più rilevanti e solitamente sono commentati; gli articoli sono disposti secondo uno schema fisso che ha lo
IMMAGINANDO QUELLO CHE NON SI VEDE
 Laboratorio in classe: tra forme e numeri GRUPPO FRAZIONI - CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA PRIMARIA Docenti: Lidia Abate, Anna Maria Radaelli, Loredana Raffa. IMMAGINANDO QUELLO CHE NON SI VEDE 1. UNA FIABA
Laboratorio in classe: tra forme e numeri GRUPPO FRAZIONI - CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA PRIMARIA Docenti: Lidia Abate, Anna Maria Radaelli, Loredana Raffa. IMMAGINANDO QUELLO CHE NON SI VEDE 1. UNA FIABA
APPUNTI DI MATEMATICA ALGEBRA \ INSIEMISTICA \ TEORIA DEGLI INSIEMI (1)
 ALGEBRA \ INSIEMISTICA \ TEORIA DEGLI INSIEMI (1) Un insieme è una collezione di oggetti. Il concetto di insieme è un concetto primitivo. Deve esistere un criterio chiaro, preciso, non ambiguo, inequivocabile,
ALGEBRA \ INSIEMISTICA \ TEORIA DEGLI INSIEMI (1) Un insieme è una collezione di oggetti. Il concetto di insieme è un concetto primitivo. Deve esistere un criterio chiaro, preciso, non ambiguo, inequivocabile,
4 3 4 = 4 x 10 2 + 3 x 10 1 + 4 x 10 0 aaa 10 2 10 1 10 0
 Rappresentazione dei numeri I numeri che siamo abituati ad utilizzare sono espressi utilizzando il sistema di numerazione decimale, che si chiama così perché utilizza 0 cifre (0,,2,3,4,5,6,7,8,9). Si dice
Rappresentazione dei numeri I numeri che siamo abituati ad utilizzare sono espressi utilizzando il sistema di numerazione decimale, che si chiama così perché utilizza 0 cifre (0,,2,3,4,5,6,7,8,9). Si dice
Statistica e biometria. D. Bertacchi. Variabili aleatorie. V.a. discrete e continue. La densità di una v.a. discreta. Esempi.
 Iniziamo con definizione (capiremo fra poco la sua utilità): DEFINIZIONE DI VARIABILE ALEATORIA Una variabile aleatoria (in breve v.a.) X è funzione che ha come dominio Ω e come codominio R. In formule:
Iniziamo con definizione (capiremo fra poco la sua utilità): DEFINIZIONE DI VARIABILE ALEATORIA Una variabile aleatoria (in breve v.a.) X è funzione che ha come dominio Ω e come codominio R. In formule:
know it! do it! IL NOSTRO TEAM
 IL NOSTRO TEAM Siamo due giovani psicologhe, due amiche fin dai primi anni dell'università, due compagne di viaggio. Da sempre siamo vicine a diverse tematiche sociali come disabilità, tossicodipendenza,
IL NOSTRO TEAM Siamo due giovani psicologhe, due amiche fin dai primi anni dell'università, due compagne di viaggio. Da sempre siamo vicine a diverse tematiche sociali come disabilità, tossicodipendenza,
PENSIERO DI LENIN. Fonte: Lenin [Vladimir Ilic Ulianov], Scritti economici, Roma, Editori Riuniti, 1977, pp. 837-840.
![PENSIERO DI LENIN. Fonte: Lenin [Vladimir Ilic Ulianov], Scritti economici, Roma, Editori Riuniti, 1977, pp. 837-840. PENSIERO DI LENIN. Fonte: Lenin [Vladimir Ilic Ulianov], Scritti economici, Roma, Editori Riuniti, 1977, pp. 837-840.](/thumbs/38/17920727.jpg) PENSIERO DI LENIN Fonte: Lenin [Vladimir Ilic Ulianov], Scritti economici, Roma, Editori Riuniti, 1977, pp. 837-840. Articolo datato 6 gennaio 1923 e pubblicato sulla «Pravda» del 27 gennaio 1923. ******
PENSIERO DI LENIN Fonte: Lenin [Vladimir Ilic Ulianov], Scritti economici, Roma, Editori Riuniti, 1977, pp. 837-840. Articolo datato 6 gennaio 1923 e pubblicato sulla «Pravda» del 27 gennaio 1923. ******
Test di Autovalutazione
 Test di Autovalutazione Il test può essere fatto seguendo alcune semplici indicazioni: Nelle aree segnalate (risposta, domanda successiva, spazio con la freccia,) sono collocati già dei comandi Con un
Test di Autovalutazione Il test può essere fatto seguendo alcune semplici indicazioni: Nelle aree segnalate (risposta, domanda successiva, spazio con la freccia,) sono collocati già dei comandi Con un
Lezioni di Matematica 1 - I modulo
 Lezioni di Matematica 1 - I modulo Luciano Battaia 16 ottobre 2008 Luciano Battaia - http://www.batmath.it Matematica 1 - I modulo. Lezione del 16/10/2008 1 / 13 L introduzione dei numeri reali si può
Lezioni di Matematica 1 - I modulo Luciano Battaia 16 ottobre 2008 Luciano Battaia - http://www.batmath.it Matematica 1 - I modulo. Lezione del 16/10/2008 1 / 13 L introduzione dei numeri reali si può
Spinoza e il Male. Saitta Francesco
 Spinoza e il Male di Saitta Francesco La genealogia del male è sempre stato uno dei problemi più discussi nella storia della filosofia. Trovare le origini del male è sempre stato l oggetto principale di
Spinoza e il Male di Saitta Francesco La genealogia del male è sempre stato uno dei problemi più discussi nella storia della filosofia. Trovare le origini del male è sempre stato l oggetto principale di
20 GENNAIO 2011 SCHEMA DELLA RELAZIONE DEL
 20 GENNAIO 2011 SCHEMA DELLA RELAZIONE DEL DOTT. ANDREA TOSI Chi sono i miei interlocutori Quale è il mio ruolo Quale situazione devo affrontare Quale richiesta mi viene effettuata Cosa faccio io di fronte
20 GENNAIO 2011 SCHEMA DELLA RELAZIONE DEL DOTT. ANDREA TOSI Chi sono i miei interlocutori Quale è il mio ruolo Quale situazione devo affrontare Quale richiesta mi viene effettuata Cosa faccio io di fronte
Indice. Giuseppe Galli Presentazione... 1
 Indice Presentazione... 1 Livelli di realtà... 5 1. Realtà fisica e realtà fenomenica... 5 2. Annullamento dell identità numerica tra oggetto fisico e oggetto fenomenico... 8 3. Individualità degli oggetti
Indice Presentazione... 1 Livelli di realtà... 5 1. Realtà fisica e realtà fenomenica... 5 2. Annullamento dell identità numerica tra oggetto fisico e oggetto fenomenico... 8 3. Individualità degli oggetti
CONSIGLI PER POTENZIARE L APPRENDIMENTO DELLA LINGUA
 CONSIGLI PER POTENZIARE L APPRENDIMENTO DELLA LINGUA Possiamo descrivere le strategie di apprendimento di una lingua straniera come traguardi che uno studente si pone per misurare i progressi nell apprendimento
CONSIGLI PER POTENZIARE L APPRENDIMENTO DELLA LINGUA Possiamo descrivere le strategie di apprendimento di una lingua straniera come traguardi che uno studente si pone per misurare i progressi nell apprendimento
UNA LEZIONE SUI NUMERI PRIMI: NASCE LA RITABELLA
 UNA LEZIONE SUI NUMERI PRIMI: NASCE LA RITABELLA Tutti gli anni, affrontando l argomento della divisibilità, trovavo utile far lavorare gli alunni sul Crivello di Eratostene. Presentavo ai ragazzi una
UNA LEZIONE SUI NUMERI PRIMI: NASCE LA RITABELLA Tutti gli anni, affrontando l argomento della divisibilità, trovavo utile far lavorare gli alunni sul Crivello di Eratostene. Presentavo ai ragazzi una
MI ASCOLTO, TI ASCOLTO... CI ASCOLTIAMO.
 MI ASCOLTO, TI ASCOLTO... CI ASCOLTIAMO. Percorso di educazione all ascolto Classi seconde scuola primaria Rosmini Anno scolastico 2009/2010 La principale difficoltà riscontrata negli alunni dall'intero
MI ASCOLTO, TI ASCOLTO... CI ASCOLTIAMO. Percorso di educazione all ascolto Classi seconde scuola primaria Rosmini Anno scolastico 2009/2010 La principale difficoltà riscontrata negli alunni dall'intero
Le funzioni continue. A. Pisani Liceo Classico Dante Alighieri A.S. 2002-03. A. Pisani, appunti di Matematica 1
 Le funzioni continue A. Pisani Liceo Classico Dante Alighieri A.S. -3 A. Pisani, appunti di Matematica 1 Nota bene Questi appunti sono da intendere come guida allo studio e come riassunto di quanto illustrato
Le funzioni continue A. Pisani Liceo Classico Dante Alighieri A.S. -3 A. Pisani, appunti di Matematica 1 Nota bene Questi appunti sono da intendere come guida allo studio e come riassunto di quanto illustrato
Che volontari cerchiamo? Daniela Caretto Lecce, 27-28 aprile
 Che volontari cerchiamo? Daniela Caretto Lecce, 27-28 aprile Premessa All arrivo di un nuovo volontario l intero sistema dell associazione viene in qualche modo toccato. Le relazioni si strutturano diversamente
Che volontari cerchiamo? Daniela Caretto Lecce, 27-28 aprile Premessa All arrivo di un nuovo volontario l intero sistema dell associazione viene in qualche modo toccato. Le relazioni si strutturano diversamente
Funzioni funzione dominio codominio legge argomento variabile indipendente variabile dipendente
 Funzioni In matematica, una funzione f da X in Y consiste in: 1. un insieme X detto dominio di f 2. un insieme Y detto codominio di f 3. una legge che ad ogni elemento x in X associa uno ed un solo elemento
Funzioni In matematica, una funzione f da X in Y consiste in: 1. un insieme X detto dominio di f 2. un insieme Y detto codominio di f 3. una legge che ad ogni elemento x in X associa uno ed un solo elemento
Trascrizione completa della lezione Lezione 002
 Trascrizione completa della lezione Lezione 002 Adam: Salve, il mio nome e Adam Kirin: E io sono Kirin. Adam: e noi siano contenti che vi siete sintonizzati su ChineseLearnOnline.com dove noi speriamo
Trascrizione completa della lezione Lezione 002 Adam: Salve, il mio nome e Adam Kirin: E io sono Kirin. Adam: e noi siano contenti che vi siete sintonizzati su ChineseLearnOnline.com dove noi speriamo
Progetto educativo per bambini 2014 I NUOVI MEZZI EDUCATIVI I MASS-MEDIA: CONOSCIAMO BENE IL LORO OPERARE NELLA NOSTRA SOCIETA?
 Progetto educativo per bambini 2014 I NUOVI MEZZI EDUCATIVI I MASS-MEDIA: CONOSCIAMO BENE IL LORO OPERARE NELLA NOSTRA SOCIETA? Sac. Don Magloire Nkounga Dott. D Ambrosio Giuseppina 1 Quando ci possono
Progetto educativo per bambini 2014 I NUOVI MEZZI EDUCATIVI I MASS-MEDIA: CONOSCIAMO BENE IL LORO OPERARE NELLA NOSTRA SOCIETA? Sac. Don Magloire Nkounga Dott. D Ambrosio Giuseppina 1 Quando ci possono
TNT IV. Il Diavolo è meno brutto di come ce lo dipingono!!! (Guarda il video)
 TNT IV Il Diavolo è meno brutto di come ce lo dipingono!!! (Guarda il video) Al fine di aiutare la comprensione delle principali tecniche di Joe, soprattutto quelle spiegate nelle appendici del libro che
TNT IV Il Diavolo è meno brutto di come ce lo dipingono!!! (Guarda il video) Al fine di aiutare la comprensione delle principali tecniche di Joe, soprattutto quelle spiegate nelle appendici del libro che
Errori più comuni. nelle prove scritte
 Errori più comuni nelle prove scritte Gli errori più frequenti, e reiterati da chi sostiene diverse prove, sono innanzi tutto meta-errori, cioè errori che non riguardano tanto l applicazione delle tecniche,
Errori più comuni nelle prove scritte Gli errori più frequenti, e reiterati da chi sostiene diverse prove, sono innanzi tutto meta-errori, cioè errori che non riguardano tanto l applicazione delle tecniche,
Percezione della sicurezza sul lavoro in Toscana: il caso dei lavoratori immigrati nel settore agro-boschivo - ANOLF/CISL FOCUS GROUP
 Percezione della sicurezza sul lavoro in Toscana: il caso dei lavoratori immigrati nel settore agro-boschivo - ANOLF/CISL FOCUS GROUP PRESENTAZIONE DEL PROGETTO La CISL ha organizzato questo incontro perché
Percezione della sicurezza sul lavoro in Toscana: il caso dei lavoratori immigrati nel settore agro-boschivo - ANOLF/CISL FOCUS GROUP PRESENTAZIONE DEL PROGETTO La CISL ha organizzato questo incontro perché
Il concetto di sfera pubblica viene introdotto dal sociologo tedesco Jurgen Habermas
 Il concetto di sfera pubblica viene introdotto dal sociologo tedesco Jurgen Habermas Con questo termine si identifica lo spazio pubblico, diverso dallo Stato, creato all interno dei café francesi dell
Il concetto di sfera pubblica viene introdotto dal sociologo tedesco Jurgen Habermas Con questo termine si identifica lo spazio pubblico, diverso dallo Stato, creato all interno dei café francesi dell
Salvatore Salamone. Manuale d istruzione per. Coppie che. Scoppiano QUALCOSA SI PUÒ FARE! ... tutto sommato un libro d amore
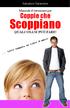 Salvatore Salamone Manuale d istruzione per Coppie che Scoppiano QUALCOSA SI PUÒ FARE!... tutto sommato un libro d amore CAPITOLO 18 Voler avere ragione Spesso le coppie incontrano delle barriere insormontabili
Salvatore Salamone Manuale d istruzione per Coppie che Scoppiano QUALCOSA SI PUÒ FARE!... tutto sommato un libro d amore CAPITOLO 18 Voler avere ragione Spesso le coppie incontrano delle barriere insormontabili
Il fumetto Creazione di storie per immagini
 Il fumetto Creazione di storie per immagini Introduzione Il fumetto è un linguaggio che a sua volta utilizza un linguaggio molto semplice. L efficacia di questo mezzo espressivo è resa dall equilibrio
Il fumetto Creazione di storie per immagini Introduzione Il fumetto è un linguaggio che a sua volta utilizza un linguaggio molto semplice. L efficacia di questo mezzo espressivo è resa dall equilibrio
PROCESSO DI INDICIZZAZIONE SEMANTICA
 PROCESSO DI INDICIZZAZIONE SEMANTICA INDIVIDUAZIONE DEI TEMI/CONCETTI SELEZIONE DEI TEMI/CONCETTI ESPRESSIONE DEI CONCETTI NEL LINGUAGGIO DI INDICIZZAZIONE TIPI DI INDICIZZAZIONE SOMMARIZZAZIONE INDICIZZAZIONE
PROCESSO DI INDICIZZAZIONE SEMANTICA INDIVIDUAZIONE DEI TEMI/CONCETTI SELEZIONE DEI TEMI/CONCETTI ESPRESSIONE DEI CONCETTI NEL LINGUAGGIO DI INDICIZZAZIONE TIPI DI INDICIZZAZIONE SOMMARIZZAZIONE INDICIZZAZIONE
IL SISTEMA INFORMATIVO
 LEZIONE 15 DAL MODELLO DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO AL MODELLO CONTABILE RIPRESA DEL CONCETTO DI SISTEMA AZIENDALE = COMPLESSO DI ELEMENTI MATERIALI E NO CHE DIPENDONO RECIPROCAMENTE GLI UNI DAGLI ALTRI
LEZIONE 15 DAL MODELLO DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO AL MODELLO CONTABILE RIPRESA DEL CONCETTO DI SISTEMA AZIENDALE = COMPLESSO DI ELEMENTI MATERIALI E NO CHE DIPENDONO RECIPROCAMENTE GLI UNI DAGLI ALTRI
FINESTRE INTERCULTURALI
 Scuola Classe 1C FINESTRE INTERCULTURALI DIARIO DI BORDO 2013 / 2014 IC Gandhi - Secondaria di primo grado Paolo Uccello Insegnante / materia lettere Data Febbraio Durata 4h TITOLO DELLA FINESTRA INTERCULTURALE
Scuola Classe 1C FINESTRE INTERCULTURALI DIARIO DI BORDO 2013 / 2014 IC Gandhi - Secondaria di primo grado Paolo Uccello Insegnante / materia lettere Data Febbraio Durata 4h TITOLO DELLA FINESTRA INTERCULTURALE
Proposta di intervento rieducativo con donne operate al seno attraverso il sistema BIODANZA
 Proposta di intervento rieducativo con donne operate al seno attraverso il sistema BIODANZA Tornare a «danzare la vita» dopo un intervento al seno Micaela Bianco I passaggi Coinvolgimento medici e fisioterapiste
Proposta di intervento rieducativo con donne operate al seno attraverso il sistema BIODANZA Tornare a «danzare la vita» dopo un intervento al seno Micaela Bianco I passaggi Coinvolgimento medici e fisioterapiste
Tesina per il corso di Psicotecnologie dell apprendimento per l integrazione delle disabilità
 Tesina per il corso di Psicotecnologie dell apprendimento per l integrazione delle disabilità ANALISI DEL TITOLO Per prima cosa cercheremo di analizzare e capire insieme il senso del titolo di questo lavoro:
Tesina per il corso di Psicotecnologie dell apprendimento per l integrazione delle disabilità ANALISI DEL TITOLO Per prima cosa cercheremo di analizzare e capire insieme il senso del titolo di questo lavoro:
I criteri della scelta e della riforma
 I criteri della scelta e della riforma La preghiera ha il fine di vincere se stessi, vincere la propria ignoranza, la propria pigrizia mentale per conoscere il Signore. Ogni preghiera deve essere mirata
I criteri della scelta e della riforma La preghiera ha il fine di vincere se stessi, vincere la propria ignoranza, la propria pigrizia mentale per conoscere il Signore. Ogni preghiera deve essere mirata
Progetto per la promozione della lettura INTRODUZIONE
 Progetto per la promozione della lettura INTRODUZIONE L interesse verso la lettura ed il piacere ad esercitarla sono obiettivi che, ormai da anni, gli insegnanti della scuola primaria di Attimis si prefiggono
Progetto per la promozione della lettura INTRODUZIONE L interesse verso la lettura ed il piacere ad esercitarla sono obiettivi che, ormai da anni, gli insegnanti della scuola primaria di Attimis si prefiggono
ALLINEARSI: IL DRIVER PER UNA INNOVAZIONE DI SUCCESSO!
 ALLINEARSI: IL DRIVER PER UNA INNOVAZIONE DI SUCCESSO! L allineamento del team esecutivo è definibile come l accordo dei membri del team in merito a: 1. Allineamento personale -consapevolezza dell impatto
ALLINEARSI: IL DRIVER PER UNA INNOVAZIONE DI SUCCESSO! L allineamento del team esecutivo è definibile come l accordo dei membri del team in merito a: 1. Allineamento personale -consapevolezza dell impatto
CIRCOLO DIDATTICO DI SAN MARINO Anno Scolastico 2013/2014
 CIRCOLO DIDATTICO DI SAN MARINO Anno Scolastico 2013/2014 RICERCA-AZIONE Insegnare per competenze: Lo sviluppo dei processi cognitivi Scuola Elementare Fiorentino DESCRIZIONE DELL ESPERIENZA Docente: Rosa
CIRCOLO DIDATTICO DI SAN MARINO Anno Scolastico 2013/2014 RICERCA-AZIONE Insegnare per competenze: Lo sviluppo dei processi cognitivi Scuola Elementare Fiorentino DESCRIZIONE DELL ESPERIENZA Docente: Rosa
FINESTRE INTERCULTURALI
 Scuola Classe 1C FINESTRE INTERCULTURALI DIARIO DI BORDO 2013 / 2014 IC Gandhi - Secondaria di primo grado Paolo Uccello Insegnante / materia Anelia Cassai/lettere Data Febbraio Durata 4h TITOLO DELLA
Scuola Classe 1C FINESTRE INTERCULTURALI DIARIO DI BORDO 2013 / 2014 IC Gandhi - Secondaria di primo grado Paolo Uccello Insegnante / materia Anelia Cassai/lettere Data Febbraio Durata 4h TITOLO DELLA
Teorie Etiche - Kant
 Teorie Etiche - Kant Gianluigi Bellin January 27, 2014 Tratto dalla Stanford Encyclopedia of Philosophy online alle voce Kant s Moral Philosophy. La filosofia morale di Immanuel Kant Immanuel Kant, visse
Teorie Etiche - Kant Gianluigi Bellin January 27, 2014 Tratto dalla Stanford Encyclopedia of Philosophy online alle voce Kant s Moral Philosophy. La filosofia morale di Immanuel Kant Immanuel Kant, visse
2. Semantica proposizionale classica
 20 1. LINGUAGGIO E SEMANTICA 2. Semantica proposizionale classica Ritorniamo un passo indietro all insieme dei connettivi proposizionali che abbiamo utilizzato nella definizione degli enunciati di L. L
20 1. LINGUAGGIO E SEMANTICA 2. Semantica proposizionale classica Ritorniamo un passo indietro all insieme dei connettivi proposizionali che abbiamo utilizzato nella definizione degli enunciati di L. L
PROMUOVERSI MEDIANTE INTERNET di Riccardo Polesel. 1. Promuovere il vostro business: scrivere e gestire i contenuti online» 15
 Indice Introduzione pag. 9 Ringraziamenti» 13 1. Promuovere il vostro business: scrivere e gestire i contenuti online» 15 1. I contenuti curati, interessanti e utili aiutano il business» 15 2. Le aziende
Indice Introduzione pag. 9 Ringraziamenti» 13 1. Promuovere il vostro business: scrivere e gestire i contenuti online» 15 1. I contenuti curati, interessanti e utili aiutano il business» 15 2. Le aziende
E il momento di iniziare: le fondamenta del fundraising
 ENGAGEDin propone corsi di formazione per le organizzazioni che vogliono avviare o sviluppare la propria attività di raccolta fondi attraverso la crescita delle proprie competenze, la discussione di casi
ENGAGEDin propone corsi di formazione per le organizzazioni che vogliono avviare o sviluppare la propria attività di raccolta fondi attraverso la crescita delle proprie competenze, la discussione di casi
PRIME LETTURE Materiali per leggere e fare insieme. con Il mondo del Signor Acqua. Gita alla fattoria di Agostino Traini
 PRIME LETTURE Materiali per leggere e fare insieme con Il mondo del Signor Acqua. Gita alla fattoria di Agostino Traini INDICAZIONI DIDATTICHE Agostino Traini Illustrazioni dell autore serie Il mondo del
PRIME LETTURE Materiali per leggere e fare insieme con Il mondo del Signor Acqua. Gita alla fattoria di Agostino Traini INDICAZIONI DIDATTICHE Agostino Traini Illustrazioni dell autore serie Il mondo del
TNT IV. Il Diavolo è meno brutto di come ce lo dipingono!!! (Guarda il video)
 TNT IV Il Diavolo è meno brutto di come ce lo dipingono!!! (Guarda il video) Al fine di aiutare la comprensione delle principali tecniche di Joe, soprattutto quelle spiegate nelle appendici del libro che
TNT IV Il Diavolo è meno brutto di come ce lo dipingono!!! (Guarda il video) Al fine di aiutare la comprensione delle principali tecniche di Joe, soprattutto quelle spiegate nelle appendici del libro che
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER LA SCUOLA DELL INFANZIA. Contenuti
 PER LA SCUOLA DELL INFANZIA Fonte di legittimazione: Indicazioni per il curricolo 2012 IL SE E L ALTRO - Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie
PER LA SCUOLA DELL INFANZIA Fonte di legittimazione: Indicazioni per il curricolo 2012 IL SE E L ALTRO - Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie
APPUNTI DI MATEMATICA LE FRAZIONI ALGEBRICHE ALESSANDRO BOCCONI
 APPUNTI DI MATEMATICA LE FRAZIONI ALGEBRICHE ALESSANDRO BOCCONI Indice 1 Le frazioni algebriche 1.1 Il minimo comune multiplo e il Massimo Comun Divisore fra polinomi........ 1. Le frazioni algebriche....................................
APPUNTI DI MATEMATICA LE FRAZIONI ALGEBRICHE ALESSANDRO BOCCONI Indice 1 Le frazioni algebriche 1.1 Il minimo comune multiplo e il Massimo Comun Divisore fra polinomi........ 1. Le frazioni algebriche....................................
Gruppo Territoriale Piemonte
 Gruppo Territoriale Piemonte L avvio Verso la fine degli anni Novanta un piccolo gruppo di coordinatori pedagogici e di educatori ha sentito il bisogno di riorganizzare una rete di collegamento tra le
Gruppo Territoriale Piemonte L avvio Verso la fine degli anni Novanta un piccolo gruppo di coordinatori pedagogici e di educatori ha sentito il bisogno di riorganizzare una rete di collegamento tra le
Cittadinanza e Costituzione
 Cittadinanza e Costituzione Anno Scolastico 20010/11 Progetto di Cittadinanza e Costituzione Finalità Essere cittadini di un mondo in continuo cambiamento ha come premessa il conoscere e il porre in atto
Cittadinanza e Costituzione Anno Scolastico 20010/11 Progetto di Cittadinanza e Costituzione Finalità Essere cittadini di un mondo in continuo cambiamento ha come premessa il conoscere e il porre in atto
LA COMBUSTIONE. Proposta didattica per la classe terza. Istituto Comprensivo di Barberino di Mugello Galliano. Anno scolastico 2011-2012
 LA COMBUSTIONE Proposta didattica per la classe terza Istituto Comprensivo di Barberino di Mugello Galliano Anno scolastico 2011-2012 IL FUOCO IO SO CHE Iniziamo il percorso con una conversazione: parliamo
LA COMBUSTIONE Proposta didattica per la classe terza Istituto Comprensivo di Barberino di Mugello Galliano Anno scolastico 2011-2012 IL FUOCO IO SO CHE Iniziamo il percorso con una conversazione: parliamo
Lezione n 2 L educazione come atto ermeneutico (2)
 Lezione n 2 L educazione come atto ermeneutico (2) Riprendiamo l analisi interrotta nel corso della precedente lezione b) struttura dialogica del fatto educativo Per rispondere a criteri ermenutici, l
Lezione n 2 L educazione come atto ermeneutico (2) Riprendiamo l analisi interrotta nel corso della precedente lezione b) struttura dialogica del fatto educativo Per rispondere a criteri ermenutici, l
PROGETTO: TEATRO FORUM
 24 5 PROGETTO: TEATRO FORUM (per Oratori sensibili) Che cos è Il Teatro forum è un metodo e percorso formativo utilizzato spesso in situazioni di disagio socio-culturale e si propone come strumento per
24 5 PROGETTO: TEATRO FORUM (per Oratori sensibili) Che cos è Il Teatro forum è un metodo e percorso formativo utilizzato spesso in situazioni di disagio socio-culturale e si propone come strumento per
Il SENTIMENT E LA PSICOLOGIA
 CAPITOLO 2 Il SENTIMENT E LA PSICOLOGIA 2.1.Cosa muove i mercati? Il primo passo operativo da fare nel trading è l analisi del sentiment dei mercati. Con questa espressione faccio riferimento al livello
CAPITOLO 2 Il SENTIMENT E LA PSICOLOGIA 2.1.Cosa muove i mercati? Il primo passo operativo da fare nel trading è l analisi del sentiment dei mercati. Con questa espressione faccio riferimento al livello
Scopri il piano di Dio: Pace e vita
 Scopri il piano di : Pace e vita E intenzione di avere per noi una vita felice qui e adesso. Perché la maggior parte delle persone non conosce questa vita vera? ama la gente e ama te! Vuole che tu sperimenti
Scopri il piano di : Pace e vita E intenzione di avere per noi una vita felice qui e adesso. Perché la maggior parte delle persone non conosce questa vita vera? ama la gente e ama te! Vuole che tu sperimenti
La post-modernità e noi. Nerviano, 25 marzo, 1 e 8 aprile 2014.
 La post-modernità e noi. Nerviano, 25 marzo, 1 e 8 aprile 2014. Da quando e come se ne parla. 1972 - MIT, club di Roma, I limiti dello sviluppo 1979 - J.F.Lyotard, La condizione post-moderna: rapporto
La post-modernità e noi. Nerviano, 25 marzo, 1 e 8 aprile 2014. Da quando e come se ne parla. 1972 - MIT, club di Roma, I limiti dello sviluppo 1979 - J.F.Lyotard, La condizione post-moderna: rapporto
MODI, TONALITA E SCALE
 Teoria musicale - 2 MODI, TONALITA E SCALE MODO MAGGIORE E MODO MINORE Parafrasando il titolo di un celebre libro di Thomas Merton, No man is an island - Nessun uomo è un isola, mi piace affermare subito
Teoria musicale - 2 MODI, TONALITA E SCALE MODO MAGGIORE E MODO MINORE Parafrasando il titolo di un celebre libro di Thomas Merton, No man is an island - Nessun uomo è un isola, mi piace affermare subito
TNT IV. Il Diavolo è meno brutto di come ce lo dipingono!!! (Guarda il video)
 TNT IV Il Diavolo è meno brutto di come ce lo dipingono!!! (Guarda il video) Al fine di aiutare la comprensione delle principali tecniche di Joe, soprattutto quelle spiegate nelle appendici del libro che
TNT IV Il Diavolo è meno brutto di come ce lo dipingono!!! (Guarda il video) Al fine di aiutare la comprensione delle principali tecniche di Joe, soprattutto quelle spiegate nelle appendici del libro che
LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA
 CLASSE PRIMA LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA 1 RICEZIONE ORALE 1. Familiarizzare coi primi suoni della lingua inglese 2. Comprendere semplici espressioni di uso quotidiano, pronunciate chiaramente. 3. Comprendere,
CLASSE PRIMA LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA 1 RICEZIONE ORALE 1. Familiarizzare coi primi suoni della lingua inglese 2. Comprendere semplici espressioni di uso quotidiano, pronunciate chiaramente. 3. Comprendere,
REVISIONE-CORREZIONE. La Revisione è un momento molto importante nel processo della produzione scritta.
 REVISIONE-CORREZIONE La Revisione è un momento molto importante nel processo della produzione scritta. Il termine viene dato ai ragazzi verso la quarta, ma in realtà dovrebbe essere considerata parte integrante
REVISIONE-CORREZIONE La Revisione è un momento molto importante nel processo della produzione scritta. Il termine viene dato ai ragazzi verso la quarta, ma in realtà dovrebbe essere considerata parte integrante
L uso e il significato delle regole (gruppo A)
 L uso e il significato delle regole (gruppo A) Regole organizzative: devono essere rispettare per far sì che la struttura possa funzionare e che si possa vivere in un contesto di rispetto reciproco; Regole
L uso e il significato delle regole (gruppo A) Regole organizzative: devono essere rispettare per far sì che la struttura possa funzionare e che si possa vivere in un contesto di rispetto reciproco; Regole
Guida Strategica per gli Imprenditori
 Guida Strategica per gli Imprenditori Scopri la Formula atematica del Business 1 La Tavola degli Elementi del Business Come in qualsiasi elemento in natura anche nel Business è possibile ritrovare le leggi
Guida Strategica per gli Imprenditori Scopri la Formula atematica del Business 1 La Tavola degli Elementi del Business Come in qualsiasi elemento in natura anche nel Business è possibile ritrovare le leggi
Identità e filosofia di un ambiente
 Comune di Novellara scuola comunale dell infanzia Arcobaleno Identità e filosofia di un ambiente Storia La scuola dell infanzia Arcobaleno nasce nel 1966 ed accoglie 3 sezioni. La scuola comunale è stata
Comune di Novellara scuola comunale dell infanzia Arcobaleno Identità e filosofia di un ambiente Storia La scuola dell infanzia Arcobaleno nasce nel 1966 ed accoglie 3 sezioni. La scuola comunale è stata
parte III analisi del testo lezione 10 semiotica figurativa 3. retorica visiva, tipi di pubblicità
 Corso di Semiotica per la comunicazione Università di Teramo a.a. 2007/2008 prof. Piero Polidoro parte III analisi del testo lezione 10 semiotica figurativa 3. retorica visiva, tipi di pubblicità Sommario
Corso di Semiotica per la comunicazione Università di Teramo a.a. 2007/2008 prof. Piero Polidoro parte III analisi del testo lezione 10 semiotica figurativa 3. retorica visiva, tipi di pubblicità Sommario
L INDICIZZAZIONE SEMANTICA
 L INDICIZZAZIONE SEMANTICA Nell indicizzazione semantica un documento viene indicizzato per il contento concettuale dell opera che manifesta ovvero secondo il significato. Essa pertanto ha lo scopo di
L INDICIZZAZIONE SEMANTICA Nell indicizzazione semantica un documento viene indicizzato per il contento concettuale dell opera che manifesta ovvero secondo il significato. Essa pertanto ha lo scopo di
SE LA PIANTIAMO DI FAR A INIZIARE LA LEZIONE
 HP 1a PARTE SE LA PIANTIAMO DI FAR CASINO FORSE attenzione! RIUSCIAMO A INIZIARE LA LEZIONE SE LA PIANTIAMO DI FAR CASINO FORSE attenzione! RIUSCIAMO A INIZIARE LA LEZIONE GRAZIE! PREMESSA Il fumetto è
HP 1a PARTE SE LA PIANTIAMO DI FAR CASINO FORSE attenzione! RIUSCIAMO A INIZIARE LA LEZIONE SE LA PIANTIAMO DI FAR CASINO FORSE attenzione! RIUSCIAMO A INIZIARE LA LEZIONE GRAZIE! PREMESSA Il fumetto è
Dall italiano al linguaggio della logica proposizionale
 Dall italiano al linguaggio della logica proposizionale Dall italiano al linguaggio della logica proposizionale Enunciati atomici e congiunzione In questa lezione e nelle successive, vedremo come fare
Dall italiano al linguaggio della logica proposizionale Dall italiano al linguaggio della logica proposizionale Enunciati atomici e congiunzione In questa lezione e nelle successive, vedremo come fare
SENZA PAROLE. Illustrazione di Matteo Pericoli 2001
 SENZA PAROLE Illustrazione di Matteo Pericoli 2001 Agente di viaggio. Vedo che ha deciso per la Transiberiana. Ottima scelta. Un viaggio difficile, ma che le darà enormi soddisfazioni. Cliente. Mi preoccupa
SENZA PAROLE Illustrazione di Matteo Pericoli 2001 Agente di viaggio. Vedo che ha deciso per la Transiberiana. Ottima scelta. Un viaggio difficile, ma che le darà enormi soddisfazioni. Cliente. Mi preoccupa
1.300 2.500 10.000 5.000
 ORDINE DEI PREZZI RITAGLIA I CARTELLINI DEI PREZZI E INCOLLALI NEL QUADERNO METTENDO I NUMERI IN ORDINE DAL PIÙ PICCOLO AL PIÙ GRANDE. SPIEGA COME HAI FATTO A DECIDERE QUALE NUMERO ANDAVA PRIMA E QUALE
ORDINE DEI PREZZI RITAGLIA I CARTELLINI DEI PREZZI E INCOLLALI NEL QUADERNO METTENDO I NUMERI IN ORDINE DAL PIÙ PICCOLO AL PIÙ GRANDE. SPIEGA COME HAI FATTO A DECIDERE QUALE NUMERO ANDAVA PRIMA E QUALE
Perchè il disegno è importante?
 I disegni dei bambini. Nella nostra scuola il disegno è l attività prevalente dei bambini; ed è anche un attività di fondamentale importanza per molti motivi. Per aiutare anche i genitori a comprendere
I disegni dei bambini. Nella nostra scuola il disegno è l attività prevalente dei bambini; ed è anche un attività di fondamentale importanza per molti motivi. Per aiutare anche i genitori a comprendere
La comunicazione e il linguaggio
 Linguaggio = sistema di simboli, suoni, significati e regole per la loro combinazione che costituisce la modalita primaria di comunicazione tra gli esseri umani Caratteristiche fondamentali del linguaggio:
Linguaggio = sistema di simboli, suoni, significati e regole per la loro combinazione che costituisce la modalita primaria di comunicazione tra gli esseri umani Caratteristiche fondamentali del linguaggio:
LA TERAPIA DELLA RICONCILIAZIONE
 Premise 1 LA TERAPIA DELLA RICONCILIAZIONE Ci sono varie forme di riconciliazione, così come ci sono varie forme di terapia e varie forme di mediazione. Noi qui ci riferiamo alla riconciliazione con una
Premise 1 LA TERAPIA DELLA RICONCILIAZIONE Ci sono varie forme di riconciliazione, così come ci sono varie forme di terapia e varie forme di mediazione. Noi qui ci riferiamo alla riconciliazione con una
Con il termine programma Teacch si intende l organizzazione dei servizi per persone autistiche realizzato nella Carolina del Nord, che prevede una
 IL PROGRAMMA TEACCH Con il termine programma Teacch si intende l organizzazione dei servizi per persone autistiche realizzato nella Carolina del Nord, che prevede una presa in carico globale in senso sia
IL PROGRAMMA TEACCH Con il termine programma Teacch si intende l organizzazione dei servizi per persone autistiche realizzato nella Carolina del Nord, che prevede una presa in carico globale in senso sia
IL COLORE DELLE EMOZIONI
 LABORATORIO ESPRESSIVO IL COLORE DELLE EMOZIONI I bambini lo dicono con il colore PREMESSA Il ruolo che ha l adulto nello sviluppo affettivo di un bambino è determinante; il suo atteggiamento, le sue aspettative,
LABORATORIO ESPRESSIVO IL COLORE DELLE EMOZIONI I bambini lo dicono con il colore PREMESSA Il ruolo che ha l adulto nello sviluppo affettivo di un bambino è determinante; il suo atteggiamento, le sue aspettative,
A spasso nel Sistema Solare
 A spasso nel Sistema Solare Un progetto per le scuole dell infanzia Silvia Casu INAF-OAC Alba Murino Scuola dell infanzia Dolianova 3 Perché è importante fare scienze già nella scuola dell infanzia: come
A spasso nel Sistema Solare Un progetto per le scuole dell infanzia Silvia Casu INAF-OAC Alba Murino Scuola dell infanzia Dolianova 3 Perché è importante fare scienze già nella scuola dell infanzia: come
CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA
 CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso
CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso
Le frasi sono state mescolate
 Roma o Venezia? 1 Questo percorso ti aiuterà a capire che cosa sia e come si costruisca un testo argomentativo Nella prossima pagina troverai un testo in cui ad ogni frase corrisponde un diverso colore.
Roma o Venezia? 1 Questo percorso ti aiuterà a capire che cosa sia e come si costruisca un testo argomentativo Nella prossima pagina troverai un testo in cui ad ogni frase corrisponde un diverso colore.
Tra il dire e l educare c è di mezzo il web. Come può la comunicazione educare alla cultura dell incontro?
 Tra il dire e l educare c è di mezzo il web. Come può la comunicazione educare alla cultura dell incontro? Marco Deriu docente di Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa, Università Cattolica per
Tra il dire e l educare c è di mezzo il web. Come può la comunicazione educare alla cultura dell incontro? Marco Deriu docente di Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa, Università Cattolica per
NUOVA PROCEDURA COPIA ED INCOLLA PER L INSERIMENTO DELLE CLASSIFICHE NEL SISTEMA INFORMATICO KSPORT.
 NUOVA PROCEDURA COPIA ED INCOLLA PER L INSERIMENTO DELLE CLASSIFICHE NEL SISTEMA INFORMATICO KSPORT. Con l utilizzo delle procedure di iscrizione on line la società organizzatrice ha a disposizione tutti
NUOVA PROCEDURA COPIA ED INCOLLA PER L INSERIMENTO DELLE CLASSIFICHE NEL SISTEMA INFORMATICO KSPORT. Con l utilizzo delle procedure di iscrizione on line la società organizzatrice ha a disposizione tutti
Innovazioni nella programmazione 2014-2020 e valutazione ex ante. Paola Casavola DPS UVAL 11 luglio 2013
 Innovazioni nella programmazione 2014-2020 e valutazione ex ante Paola Casavola DPS UVAL 11 luglio 2013 Perché le innovazioni nella programmazione sono molto rilevanti per la valutazione ex ante e la VAS?
Innovazioni nella programmazione 2014-2020 e valutazione ex ante Paola Casavola DPS UVAL 11 luglio 2013 Perché le innovazioni nella programmazione sono molto rilevanti per la valutazione ex ante e la VAS?
risulta (x) = 1 se x < 0.
 Questo file si pone come obiettivo quello di mostrarvi come lo studio di una funzione reale di una variabile reale, nella cui espressione compare un qualche valore assoluto, possa essere svolto senza necessariamente
Questo file si pone come obiettivo quello di mostrarvi come lo studio di una funzione reale di una variabile reale, nella cui espressione compare un qualche valore assoluto, possa essere svolto senza necessariamente
LA GRAFICA E LA GEOMETRIA OPERATIVA
 LA GRAFICA E LA GEOMETRIA OPERATIVA La geometria operativa, contrariamente a quella descrittiva basata sulle regole per la rappresentazione delle forme geometriche, prende in considerazione lo spazio racchiuso
LA GRAFICA E LA GEOMETRIA OPERATIVA La geometria operativa, contrariamente a quella descrittiva basata sulle regole per la rappresentazione delle forme geometriche, prende in considerazione lo spazio racchiuso
GRUPPI DI INCONTRO per GENITORI
 Nell ambito delle attività previste dal servizio di Counseling Filosofico e di sostegno alla genitorialità organizzate dal nostro Istituto, si propone l avvio di un nuovo progetto per l organizzazione
Nell ambito delle attività previste dal servizio di Counseling Filosofico e di sostegno alla genitorialità organizzate dal nostro Istituto, si propone l avvio di un nuovo progetto per l organizzazione
A SCUOLA DI GUGGENHEIM
 A SCUOLA DI GUGGENHEIM «ARTE e LETTERATURA» dal segno alla grafia Scuola dell infanzia statale «G. Rodari» di Ceggia VE gruppo bambini di 4 anni a.s. 2012-2013 Insegnanti: Gabriella Barbuio, Roberta Regini,
A SCUOLA DI GUGGENHEIM «ARTE e LETTERATURA» dal segno alla grafia Scuola dell infanzia statale «G. Rodari» di Ceggia VE gruppo bambini di 4 anni a.s. 2012-2013 Insegnanti: Gabriella Barbuio, Roberta Regini,
I libri di testo. Carlo Tarsitani
 I libri di testo Carlo Tarsitani Premessa Per accedere ai contenuti del sapere scientifico, ai vari livelli di istruzione, si usa comunemente anche un libro di testo. A partire dalla scuola primaria, tutti
I libri di testo Carlo Tarsitani Premessa Per accedere ai contenuti del sapere scientifico, ai vari livelli di istruzione, si usa comunemente anche un libro di testo. A partire dalla scuola primaria, tutti
Questionario tipi umani
 Questionario tipi umani Dare solo una risposta, indicandola con una crocetta, ad ogni item in relazione al livello corrispondente. A - Mi riesce spiacevole realizzare un lavoro non diretto da me. - Se
Questionario tipi umani Dare solo una risposta, indicandola con una crocetta, ad ogni item in relazione al livello corrispondente. A - Mi riesce spiacevole realizzare un lavoro non diretto da me. - Se
C omunicazione E fficace
 C omunicazione E fficace "La cosa più importante nella comunicazione è ascoltare ciò che non viene detto"! Peter Drucker filosofia In un mondo dove l'informazione è fin troppo presente, il vero valore
C omunicazione E fficace "La cosa più importante nella comunicazione è ascoltare ciò che non viene detto"! Peter Drucker filosofia In un mondo dove l'informazione è fin troppo presente, il vero valore
Mario Basile. I Veri valori della vita
 I Veri valori della vita Caro lettore, l intento di questo breve articolo non è quello di portare un insegnamento, ma semplicemente di far riflettere su qualcosa che noi tutti ben sappiamo ma che spesso
I Veri valori della vita Caro lettore, l intento di questo breve articolo non è quello di portare un insegnamento, ma semplicemente di far riflettere su qualcosa che noi tutti ben sappiamo ma che spesso
LA COMUNICAZIONE NON VERBALE DEI DISABILI
 LA COMUNICAZIONE NON VERBALE DEI DISABILI Comunicazione Comportamentale Ogni bambino, fin dall'infanzia, cerca di mandare messaggi e di farsi capire da chi gli sta intorno attraverso movimenti del corpo,
LA COMUNICAZIONE NON VERBALE DEI DISABILI Comunicazione Comportamentale Ogni bambino, fin dall'infanzia, cerca di mandare messaggi e di farsi capire da chi gli sta intorno attraverso movimenti del corpo,
La traduzione, per quanto attività linguistica, riguarda più propriamente la semiotica.
 La traduzione, per quanto attività linguistica, riguarda più propriamente la semiotica. La semiotica è quella scienza che studia il sistema di segni o strutture e le sue funzioni. Il processo traduttivo
La traduzione, per quanto attività linguistica, riguarda più propriamente la semiotica. La semiotica è quella scienza che studia il sistema di segni o strutture e le sue funzioni. Il processo traduttivo
Manifesto TIDE per un Educazione allo Sviluppo accessibile
 Manifesto TIDE per un Educazione allo Sviluppo accessibile Pagina 2 Contenuto Il progetto TIDE...4 Il manifesto TIDE...6 La nostra Dichiarazione...8 Conclusioni...12 Pagina 3 Il progetto TIDE Verso un
Manifesto TIDE per un Educazione allo Sviluppo accessibile Pagina 2 Contenuto Il progetto TIDE...4 Il manifesto TIDE...6 La nostra Dichiarazione...8 Conclusioni...12 Pagina 3 Il progetto TIDE Verso un
Presentazione. Obiettivi dell area «Modelli mentali»
 Presentazione In queste schede scoprirai alcuni meccanismi che si mettono in funzione quando cerchi di comprendere un testo. Un lettore esperto infatti è in grado di estrarre dal testo le informazioni
Presentazione In queste schede scoprirai alcuni meccanismi che si mettono in funzione quando cerchi di comprendere un testo. Un lettore esperto infatti è in grado di estrarre dal testo le informazioni
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ITALIANO
 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ITALIANO Livello di base non raggiunto Non ha raggiunto tutte le competenze minime previste nel livello di base Riconosce ed utilizza le strutture linguistiche di base Comprende
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ITALIANO Livello di base non raggiunto Non ha raggiunto tutte le competenze minime previste nel livello di base Riconosce ed utilizza le strutture linguistiche di base Comprende
ANICA, TRA PASSATO E FUTURO
 ANICA, TRA PASSATO E FUTURO Documentario di Massimo De Pascale e Saverio di Biagio Regia di Saverio Di Biagio PREMESSA Il rischio di ogni anniversario è quello di risolversi in una celebrazione, magari
ANICA, TRA PASSATO E FUTURO Documentario di Massimo De Pascale e Saverio di Biagio Regia di Saverio Di Biagio PREMESSA Il rischio di ogni anniversario è quello di risolversi in una celebrazione, magari
www.andreatorinesi.it
 La lunghezza focale Lunghezza focale Si definisce lunghezza focale la distanza tra il centro ottico dell'obiettivo (a infinito ) e il piano su cui si forma l'immagine (nel caso del digitale, il sensore).
La lunghezza focale Lunghezza focale Si definisce lunghezza focale la distanza tra il centro ottico dell'obiettivo (a infinito ) e il piano su cui si forma l'immagine (nel caso del digitale, il sensore).
Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I
 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI E EUROPEE Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I Alfredo Maria Becchetti Notaio in Roma Componente Commissione Affari
CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI E EUROPEE Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I Alfredo Maria Becchetti Notaio in Roma Componente Commissione Affari
Chiara Strada IMMAGINI SONORE LAVORO CON LISA
 Chiara Strada IMMAGINI SONORE LAVORO CON LISA Questo allegato si riferisce al precedente materiale della serie Tasti & Testi, intitolato Immagini Sonore, pubblicato a settembre come primo di quest anno
Chiara Strada IMMAGINI SONORE LAVORO CON LISA Questo allegato si riferisce al precedente materiale della serie Tasti & Testi, intitolato Immagini Sonore, pubblicato a settembre come primo di quest anno
