QUADERNI DI DERMATOLOGIA Rivista ufficiale della SIDEV (Società Italiana di Dermatologia Veterinaria)
|
|
|
- Olivia Mancuso
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 QUADERNI DI DERMATOLOGIA Rivista ufficiale della SIDEV (Società Italiana di Dermatologia Veterinaria) EDIZIONI SCIVAC - Supplemento al N. 5 - Ottobre 1998 della rivista Veterinaria Spedizione in abbonamento postale - 45% - Art. 2 Comma 20/B - Legge 662/96 - Filiale di Piacenza
2 QUADERNI DI DERMATOLOGIA S O M M A R I O Rivista Ufficiale (Società Italiana di Dermatologia Veterinaria) Supplemento della rivista Veterinaria Anno 11, N. 5, Ottobre 1998 Direttore Chiara Noli Comitato scientifico: Alessandra Fondati, Franca Galeotti, Chiara Noli Comitato editoriale: Lamberto Barzon, Claudio Ciriani, Fabrizio Fabbrini, Nicola Gasparinetti, Francesco Ghiani, Luca Mechelli, Roberto Morganti, Graziella Raviri, Paola Scapin, Silvia Schiavi, Chiara Tieghi, Antonella Vercelli Traduzione a cura di: Antonella Vercelli Editore SCIVAC Palazzo Trecchi Cremona Tel. (0372) Telefax E MAIL: info@scivac.it Direttore Responsabile: Antonio Manfredi LE MALATTIE INFIAMMATORIE FOLLICOLARI DEL CANE E DEL GATTO Fabrizio Fabbrini Luca Mechelli 7 TUMORI E LESIONI SIMIL-TUMORALI DEL FOLLICOLO PILIFERO Francesca Abramo 15 Stampa: Press Point - Abbiategrasso (MI) Tel. 02/ Spedizione: Abbonamento postale - 45% Art. 2 comma 20/B - Legge 662/96 Filiale di Piacenza Nacor - Bobbio - Tel. 0523/ Direzione amministrazione pubblicità: SCIVAC - Palazzo Trecchi Cremona Tel. (0372) Telefax E MAIL: info@scivac.it ESAME CITOLOGICO DEI TUMORI FOLLICOLARI Carlo Masserdotti 21
3 EDITORIALE CAMBIO DELLA GUARDIA NEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIDEV Il mandato del primo Consiglio Direttivo della SIDEV scade alla fine di questo anno, il 15 novembre si sono tenute le elezioni del nuovo Consiglio per il triennio Sembra incredibile come questi tre anni siano passati così velocemente, eppure tante cose sono successe in questi 36 mesi! Innanzitutto i suoi soci: in tre anni sono diventati più di 300 e crescono ogni anno. E grazie alla collaborazione dei soci sono stati organizzati cinque incontri centrati sulla presentazione di casi clinici e arricchiti da lezioni magistrali sulle patologie dei follicoli piliferi e sulle infezioni batteriche. Questo numero dei Quaderni di Dermatologia contiene i lavori presentati in occasione degli scorsi incontri di novembre 1997 e febbraio Oltre agli incontri riservati ai soci sono stati organizzati due seminari in collaborazione con la SCIVAC e due corsi avanzati, in cui abbiamo avuto l onore di ospitare in Italia eccellenti relatori stranieri quali Dominique Heripret, Luis Ferrer, Thierry Olivry e Julie Yager. E naturalmente nessuno può dimenticare il Congresso Europeo organizzato un anno fa a Pisa, che ha rappresentato un grande successo per la partecipazione, la qualità delle relazioni e l organizzazione, della quale ringraziamo New Team e la SCIVAC. Ma nuove iniziative sono già in calendario, quale un incontro dei soci SIDEV sulle patologie fungine il 21 febbraio e un corso avanzato sulla terapia dermatologica per la fine di ottobre del Nel lasciare la presidenza al termine del mio mandato auguro alla Presidente entrante, Alessandra Fondati, e al nuovo Consiglio Direttivo, formato da Antonella Vercelli (Vice Presidente), Fabrizio Fabbrini (tesoriere), Franca Galeotti (segretario) e Chiara Tieghi (consigliere), buon lavoro e che il nuovo triennio porti nuovi soci, nuovi relatori stranieri in Italia e nuove attività congressuali. Ci tengo a rigraziare molto tutti i colleghi che hanno fornito il materiale pubblicato e, soprattutto, la Dr.ssa Franca Galeotti che ha corretto, assemblato e armonizzato i lavori. Grazie per averci instancabilmente rincorso per farci rispettare le scadenze! Chiara Noli Past President SIDEV
4 Quaderni di dermatologia, Anno 3, n. 2, Novembre LE MALATTIE INFIAMMATORIE FOLLICOLARI DEL CANE E DEL GATTO FABRIZIO FABBRINI Libero Professionista, Milano LUCA MECHELLI Istituto di Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria, Università di Perugia INTRODUZIONE I processi infiammatori che interessano il follicolo pilifero sono numerosi e frequenti sia nel cane che nel gatto, rappresentando circa il 40% delle malattie flogistiche cutanee 12,16,18,23. Oltre ad essere il bersaglio di malattie primarie, i follicoli sono spesso coinvolti secondariamente da malattie cutanee di varia natura 12,23 come dermatopatie pruriginose, anomalie del processo di cheratinizzazione, endocrinopatie e malattie immunologiche 7,17. Gli agenti eziologici coinvolti nelle malattie follicolari infiammatorie sono molteplici. Tra questi particolare interesse rivestono i batteri, i funghi, i parassiti e gli agenti fisici. 7,15 b) follicolite murale infiltrativa, quando la reazione infiammatoria linfo-istiocitaria è diretta contro antigeni posti all interno della guaina esterna follicolare e si localizza prevalentemente nella regione dell istmo. CLASSIFICAZIONE ISTOLOGICA L attuale classificazione delle follicoliti infiammatorie comprende la follicolite murale, la follicolite luminale e la bulbite 14. Follicolite murale È una reazione infiammatoria il cui bersaglio è rappresentato dalla parete del follicolo pilifero, con particolare riguardo alla guaina esterna della radice del pelo. La follicolite murale può essere suddivisa in: a) follicolite murale dell interfaccia, caratterizzata dalla presenza di necrosi di singole cellule appartenenti allo strato basale e allo strato spinoso, dalla degenerazione idropica delle cellule basali, da incontinenza pigmentaria nel derma perifollicolare ed infiltrato infiammatorio nella porzione media-superiore del follicolo (es. eritema multiforme, lupus eritematoso, demodicosi, dermatomiosite e dermatofitosi) (Fig. 1); FIGURA 1 - Follicolite murale dell interfaccia in un caso di demodicosi. Presenza di Demodex nel lume e di degenerazione vacuolare delle cellule basali della guaina follicolare esterna accompagnata da incontinenza pigmentaria.
5 8 Fabrizio Fabbrini, Luca Mechelli FIGURA 2 - Follicolite murale infiltrativa in un caso di adenite sebacea granulomatosa. Le ghiandole sebacee non sono facilmente evidenziabili a causa dell imponente infiltrato cellulare presente. FIGURA 3 - Follicolite murale necrosante in un caso di foruncolosi eosinofilica facciale. Si noti l infiltrato eosinofilico e le aree di degenerazione e necrosi del collagene. FIGURA 4 - Follicolite murale pustolosa in un pemfigo foliaceo. Presenza di cheratinociti acantolitici all interno della pustola. Assieme alla precedente sono considerate fasi diverse di una stessa reazione immunologica (es. adenite sebacea, follicolite murale idiopatica felina, follicolite granulomatosa idiopatica del cane) (Fig. 2); c) follicolite murale necrosante, dove le cellule predominanti sono rappresentate da granulociti eosinofili, i quali inducono fenomeni di necrosi a livello istmoinfundibulare (es. foruncolosi eosinofilica facciale del cane, ipersensibilità alla puntura di zanzara nel gatto) (Fig. 3); d) follicolite murale pustolosa, in cui si riscontrano pustole nella parete follicolare della regione istmoinfundibolare contenenti granulociti neutrofili o eosinofili e cellule epiteliali acantolitiche (es. pemfigo foliaceo, pemfigo eritematoso) (Fig. 4). Follicolite luminale La follicolite luminale rappresenta certamente il modello istopatologico prevalente ed è caratterizzata da una FIGURA 5 - Follicolite luminale di tipo neutrofilico in un caso di follicolite batterica. infiltrazione di cellule infiammatorie all interno del lume follicolare (Fig. 5). In questo caso gli elementi cellulari prevalenti sono rappresentati da granulociti neutrofili o eosinofili ed il processo può coinvolgere porzioni superficiali o profonde del lume follicolare.
6 Quaderni di dermatologia, Anno 3, n. 2, Novembre Bulbite La bulbite, infine, indica una infiammazione del segmento follicolare profondo. L infiltrato è costituito da cellule prevalentemente linfocitarie le quali, circondando ed invadendo il bulbo pilifero in fase di anagen, inducono atrofia, displasia e telogenizzazione follicolare. CLASSIFICAZIONE CLINICA Da un punto di vista clinico le malattie follicolari si identificano per la presenza di lesioni quali eritema, papule, pustole, bolle emorragiche, alopecia, comedoni, collaretti epidermici, manicotti cherato-seborroici alla base dei peli, scaglie, croste, ulcere, fistole, noduli ed iperpigmentazione (Figg. 6-8). L alopecia focale, multifocale o diffusa è il quadro clinico più suggestivo delle malattie follicolari e suggerisce la presenza di Demodex, dermatofiti o infezioni batteriche a localizzazione follicolare. Segnalamento, anamnesi e visita clinica Alcune malattie a coinvolgimento follicolare come la demodicosi, l adenite sebacea, la dermatomiosite, il pemfigo foliaceo, la dermatite zinco-sensibile, presentano predisposizione di razza. Inoltre i soggetti giovani sono più colpiti da demodicosi e dermatofitosi. Le piodermiti invece, essendo secondarie ad altre dermatosi, possono interessare soggetti di qualsiasi età. Anche la distribuzione topografica delle lesioni può essere d aiuto nella formulazione delle diagnosi differenziali, così lesioni alopeciche focali o multifocali a localizzazione facciale o agli arti anteriori sono suggestive della demodicosi, mentre lesioni vescicolo-pustolose o crostose, localizzate ai padiglioni auricolari, dorso del naso, giunzioni muco cutanee, lo sono di malattie autoimmuni. Diagnosi L iter diagnostico da seguire prevede inizialmente l esecuzione di raschiati cutanei multipli, di esami microscopici e/o colturali del pelo e di esami citologici. Una volta escluse le cause più frequenti di follicolopatie, si eseguono altri esami in base alle diagnosi differenziali e/o ai risultati degli esami citologici. Ad esempio esami colturali batteriologici e/o micologici, se si sospettano infezioni batteriche atipiche o fungine profonde, o esami istopatologici da prelievi bioptici multipli, se si sospettano malattie come il pemfigo, l adenite sebacea o la foruncolosi eosinofilica. In questo lavoro saranno prese in esame a titolo d esempio, sia da un punto di vista clinico che istopatologico, solo alcune delle malattie flogistiche ad interessamento follicolare del cane. Demodicosi La demodicosi è causata da Demodex canis, acaro commensale endofollicolare. Questa malattia è relativamente frequente nei cani sotto l anno d età, ed è rara nei soggetti anziani dove rappresenta un marker cutaneo di malattie sistemiche gravi sottostanti 6. FIGURA 6 - Ipersensibilità alla puntura di zanzara. Presenza di papule, ulcere e piccole croste sul tartufo, dorso del naso e palpebra destra. FIGURA 7 - Alopecia e comedoni ad un arto in un caso di demodicosi localizzata. FIGURA 8 - Manicotti cherato-seborroici alla base dei peli in un caso di adenite sebacea. L eziopatogenesi proposta coinvolge un possibile deficit specifico dei linfociti T verso il Demodex che, moltiplicandosi, induce ulteriore depressione linfocitaria (tramite la produzione di fattori umorali 2 ). Le razze predisposte sono il Dalmata, il Carlino, l Alano, lo Shar-pei, il Dobermann, i
7 10 Fabrizio Fabbrini, Luca Mechelli FIGURA 9 - Demodicosi pustolosa generalizzata in un giovane incrocio Pinscher. FIGURA 10 - Adenite sebacea in un Akita-inu. Eritema ed alopecia al tronco. Bulldog Inglese e Francese, il Boxer, il Bobtail, il Pastore Tedesco, il Pinscher ed in generale tutti i Terrier. La demodicosi si classifica clinicamente in localizzata e generalizzata, squamosa o pustolosa. La forma localizzata si caratterizza per la presenza di alopecia focale o multifocale, eritema, comedoni, scaglie ed iperpigmentazione agli arti anteriori (Fig. 7) e/o al muso (forma squamosa). Se complicata da batteri compaiono prurito, papule, pustole e croste (forma pustolosa). La guarigione avviene spontaneamente nel 90% dei casi. Il 10% dei casi, che progrediscono verso la forma generalizzata, si caratterizza per la presenza di alopecia multifocale (lesioni coalescenti) o diffusa con eritema, comedoni, scaglie, detriti seborroici alla base dei peli e iperpigmentazione (f. squamosa). Quando complicata da piodermite profonda, (f. pustolosa) compaiono pustole, bolle emorragiche, ulcere, fistole, croste e linfoadenopatia generalizzata (Fig. 9). La diagnosi si ottiene tramite esame microscopico del pelo, raschiati cutanei profondi e biopsie (talvolta necessarie nelle pododemodicosi ed in alcune razze come lo Shar-pei.). Istologicamente la demodicosi è caratterizzata dalla presenza di una follicolite linfocitaria murale dell interfaccia (Fig. 1), spesso associata ad una follicolite luminale e ad una foruncolosi 3. L infiltrato linfocitario è associato alla degenerazione vacuolare dello strato basale della guaina esterna della radice del pelo e alla incontinenza pigmentaria 4. Adenite sebacea granulomatosa Si tratta di una malattia rara, caratterizzata dalla distruzione progressiva delle ghiandole sebacee, osservata in cani giovani o di media età. Sono state proposte ben quattro diverse ipotesi riguardo all eziopatogenesi. Si potrebbe trattare di una distruzione geneticamente programmata della ghiandola, una malattia immunomediata, un difetto primario della cheratinizzazione o un anomalia metabolica dei lipidi prodotti dalla ghiandola 8,22. Le razze predisposte sono soprattutto il Barbone standard (dove sembrerebbe esserci un modo di trasmissione autosomico recessivo), il Vizla, l Akita-inu e il Samoiedo. Sono comunque segnalati casi sporadici in molte altre razze. Clinicamente si distinguono due forme di adenite sebacea. La prima si riscontra nelle razze a pelo lungo (Barbone, Akita e Samoiedo) ed è caratterizzata dalla presenza nella regione dorsale del collo, sul tronco e sulla coda di scaglie, manicotti cherato-seborroici attorno alla base dei peli (Fig. 8), alopecia parziale e presenza di pelo opaco e fragile (Fig. 10). Spesso vi è interessamento del dorso del naso, della fronte e dei padiglioni auricolari, dove si osservano scaglie biancastre (Fig. 11). L odore di rancido e il prurito sono spesso causati dalla presenza di una piodermite secondaria. La seconda forma di adenite sebacea è meno grave ed interessa le razze a pelo corto come il Vizla. Si presenta lungo il tronco con alopecia multifocale (mantello tarmato ) e scaglie a mimare una follicolite batterica. La piodermite e il prurito, in questi casi, sono complicanze rare. La diagnosi si ottiene tramite l esame istopatologico di più campioni bioptici. Istologicamente si evidenzia la presenza di una grave ipercheratosi epidermica e follicolare accompagnata da una follicolite murale infiltrativa linfocitaria/macrofagica nella regione dell istmo e da un infiltrato linfo-istiocitario o da una reazione piogranulomatosa che coinvolge le ghiandole sebacee (Fig. 2). Nelle forme avanzate, in particolare nel Barbone e nell Akita, si osserva l assenza di ghiandole sebacee, la fibrosi perifollicolare e l atrofia dei follicoli piliferi 8,14.
8 Quaderni di dermatologia, Anno 3, n. 2, Novembre FIGURA 11 - Adenite sebacea. Scaglie biancastre adese al padiglione auricolare. FIGURA 12 - Foruncolosi eosinofilica facciale in un giovane Golden retriever. Presenza di placche e noduli ulcerati. Foruncolosi eosinofilica facciale Si tratta di una malattia rara che colpisce cani giovani adulti di taglia media o grande (esordio sotto i 2 anni di età in circa il 50% dei casi e sotto i 4 anni in circa l 80% dei casi). Non sembra esserci predisposizione sessuale o stagionalità 11. Il meccanismo eziopatogenetico di questa malattia resta ancora sconosciuto ma si sospetta possa trattarsi di un ipersensibilità alla puntura/morsi di insetti e/o artropodi (api, vespe, mosche, ragni, ecc.) sia per la frequente segnalazione da parte dei proprietari dell animale di una passeggiata poche ore prima dell esordio, sia per le similitudini clinico-patologiche di questa dermatopatia con l ipersensibilità alla puntura di zanzara descritta nella specie felina (Fig. 6). Inoltre la rapida e completa risposta terapeutica (in 2-3 settimane) utilizzando dosi antinfiammatorie di corticosteroidi tenderebbe ad avvalorare questa ipotesi. Clinicamente è caratterizzata dalla repentina comparsa di lesioni pruriginose facciali quali eritema, edema, papule/placche e noduli, che rapidamente si ulcerano ed esitano in croste emorragiche (Fig. 12). Le sedi preferenziali sono il dorso del naso, le palpebre, le labbra, e i padiglioni auricolari ma si possono osservare lesioni anche a livello di ascelle, arti e addome 9. Talvolta si osserva interessamento generale con piressia, letargia ed anoressia. La diagnosi si basa sui dati clinici e sulla presenza massiva di eosinofili nelle aree lesionate, rilevabile citologicamente ed istologicamente. Le biopsie eseguite da lesioni recenti non ulcerate permettono di evidenziare quadri di follicolite murale necrotizzante e foruncolosi eosinofilica. Nel derma è possibile osservare notevole edema e mucinosi, infiltrato eosinofilico nodulare e/o diffuso e spesso aree focali di degenerazione e necrosi del collagene 5,9,11 (Fig. 3). Pemfigo foliaceo e pemfigo eritematoso Il pemfigo foliaceo rappresenta la forma più frequentemente diagnosticata di malattia cutanea autoimmune nel cane e nel gatto. Resta comunque una malattia rara (0,6% delle dermatosi del cane), senza predilezione di sesso o età 19,20. Le razze predisposte sono l Akita, il Chow-Chow, il Bassotto, il Bearded Collie, il Terranova e il Dobermann. FIGURA 13 - Pemfigo foliaceo in uno Schnauzer. Presenza di una dermatite crostosa facciale. Il meccanismo patogenetico prevede l attacco da parte di auto-anticorpi della desmogleina-1, componente strutturale glicoproteica dei desmosomi. A questo consegue il distacco (acantolisi) dei cheratinociti e formazione di lesioni vescicolo-pustolose intraepidermiche o sottocorneali 24. Clinicamente, nel cane, si riconoscono tre forme di pemfigo foliaceo 10, 23 :
9 12 Fabrizio Fabbrini, Luca Mechelli Istologicamente la caratteristica principale del pemfigo foliaceo e di quello eritematoso è la presenza di pustole intra epidermiche e/o intrafollicolari, contenenti neutrofili ben conservati e numerosi cheratinociti acantolitici 13,25. Nelle lesioni facciali si possono evidenziare anche quadri di follicolite murale pustolosa dove l acantolisi coinvolge la struttura follicolare infundibolare, solitamente al di sotto della guaina esterna della radice del pelo. Nel pemfigo eritematoso si riscontra inoltre una dermatite lichenoide e/o idropica dell interfaccia. Bibliografia FIGURA 14 - Citologia eseguita da una pustola in un caso di pemfigo foliaceo in un gatto. Presenza di molti cheratinociti acantolitici, neutrofili e assenza di batteri. a) una forma spontanea, autoimmune, frequente negli Akita e Chow-chow b) una forma farmacoindotta, immunomediata, segnalata per lo più in Labrador e Dobermann c) una forma associata a dermatiti croniche, vista soprattutto in cani anziani. La distinzione tra queste forme di pemfigo si basa sui dati anamnestici e sulla risposta terapeutica. Per quanto riguarda l anamnesi, la correlazione tra insorgenza della sintomatologia e somministrazione di farmaci, quali ad esempio antibiotici, antielmintici o vaccini, è suggestiva di pemfigo farmacoindotto e la remissione clinica dopo la sospensione del farmaco incriminato rafforza l ipotesi diagnostica. Il pemfigo foliaceo è caratterizzato da un quadro di dermatite pustolosa/crostosa simmetrica a localizzazione facciale (Fig. 13), auricolare e podale (ipercheratosi dei cuscinetti), talvolta con interessamento ventrale (addome/inguine) o generalizzato (gradualmente in più mesi), oppure associato ad alopecia multifocale (in particolare nel Bassotto). La malattia presenta classicamente un andamento ciclico, con nuove lesioni primarie (eritema e pustole) che si alternano a fasi di quiescenza, in cui sono presenti solo lesioni secondarie (croste, collaretti). Nel pemfigo eritematoso si hanno lesioni simili a quelle viste nel pemfigo foliaceo, solitamente confinate al capo ma fotosensibili (si aggravano in estate) 21. Alcuni Autori suggeriscono che questa malattia sia una via di mezzo tra un pemfigo ed un lupus a causa delle sue caratteristiche cliniche, istopatologiche ed immunopatologiche 25. Il pemfigo eritematoso è caratterizzato da una dermatite eritematoso/pustolosa a localizzazione facciale, auricolare e talvolta mucocutanea a livello dei genitali. Esita frequentemente in croste ed ulcere. Il tartufo diventa spesso depigmentato, in particolare nel Collie e nel Pastore Tedesco. Il sospetto diagnostico di queste malattie è suggerito dai dati anamnestici, clinici e citologici (Fig. 14) mentre la diagnosi definitiva si basa prevalentemente sulle caratteristiche istopatologiche (Fig. 4) ed immunologiche delle biopsie. 1. Ackerman, A.B.: Histologic Diagnosis of Inflammatory Skin Diseases. Lea & Fabinger, Philadelphia, Barriga, O.O., et al.: Evidence of immunosupression by Demodex canis. Vet. Immunol. Immunopathol. 32: 37, Caswell, J.L.: Canine demodicosi: A retrospective histopathologic study. Proc. Am. Acad. Vet. Dermatol. 9: 93, Cayatte, S.M., et al.: Perifollicular melanosis in the dog. Vet. Dermatol. 3: 165, Curtis, F.C., Bond, R., Blunden, A.S., et coll.: Canine eosinophilic folliculitis and furuncolosis in three cases. Journ. Small Animal Pract. 36: , Duclos, D.D., et al.: Prognosis for treatament of adult-onset demodicosis in dogs: 34 cases ( ). J. Am.Vet. Med. Assoc. 204: 616, Dunstan, R.W.: Controversies in Veterinary Dermatology, European School for Advanced Veterinary Studies, Bad Kreuznach, Dunstan, R.W., Hargis, A.M.: The diagnosis of sebaceous adenitis in standard Poodle dog. In: Bonagura, J,D, (ed.) Kirk s Current Veterinary Therapy XII. W.B.Saunders, Philadelphia, Fondati, A., Fabbrini, F., Mechelli, L.: Due casi di follicolite e foruncolosi eosinofilica facciale nel cane. Veterinaria 11 (6): , Griffin, C.E.: Pemphigus foliaceus: Recent findings on the pathophysiology and result of treatment. Presentation, William Dick Bicentenary, Edinburgh, Gross, T.L.: Canine eosinophilic furuncolosis of the face. In: Ihrke, P.J., et al.(ed): Advances in Veterinary Dermatology II. Pergamon Press, New York, Gross,T.L.: Workshop on Veterinary Dermatopathology, ESVD, Royal Veterinary College, Hatfield, England, Gross, T.L., Ihrke, P.J., Walder, E.J.: Veterinary Dermatopathology. A macroscopic and microscopic evaluation of canine and feline skin disease. Mosby Year Book, St. Louis, Gross, T.L., Stannard A.A. and Yager, J.A.: An Anatomical Classification of folliculitis, Veterinary Dermatology, 1997, 8: Jobb, K.V. et al.: Pathology of Domestic Animals. Academic Press, San Diego, California, Kummel, B.A.: Color Atlas of Small Animal Dermatology. Mosby Years Book, St. Louis, Lloyd, D., Halliwel, R.: Course Note in Veterinary Dermatology. European School for Advanced Veterinary Studies, Centre Universitaire de Luxembourg Ville, Mechelli, L.: Patologie infiammatorie del follicolo pilifero nel cane e nel gatto. Atti del XV Cong. Nazionale A.P.I.V., 1996, Scott, D.W., et al.: Immune-mediated dermatosis in domestic animals: ten years after- part I. Comp. Cont. Educ. 9: 423, Scott D. W., et al.: Immune-mediated dermatosis in domestic animals: ten years after- part II. Conm. Cont. Educ. 9: 539, Scott, D.W., et al.: Pemphigus erythematosus in the dog and cat. J. Anim. Hosp. Assoc. 16: 815, Scott, D.W.: Sterile granulomatous sebaceous adenitis in dogs and cats. Vet. Ann. 33: 236, Scott, D.W., Miller, W.H., Griffin, C.E.: Muller and Kirk s Small Animal Dermatology, 5th ed. W.B. Saunders, Philadelphia, Sutter, M.M., et al.: Identification of canine pemphigus antigens. In: Ihrke, P.J., et al. (ed.): Advances in Veterinary Dermatology II. Pergamon Press, New York, Yager, J.A., Wilcock B.P. Color Atlas and Text of Surgical Pathology of the Dog and Cat. Vol. 1, 1994.
10 Quaderni di dermatologia, Anno 3, n. 2, Novembre TUMORI E LESIONI SIMIL-TUMORALI DEL FOLLICOLO PILIFERO FRANCESCA ABRAMO Dipartimento di Patologia Animale, Università degli Studi di Pisa INTRODUZIONE Il gruppo di oncologia comparata della World Health Organization 1 ha pubblicato nel 1974 la prima classificazione istologica internazionale dei tumori degli animali domestici e tra questi venivano considerati anche i tumori del follicolo pilifero. Da allora sono seguite altre classificazioni non ufficiali dei tumori cutanei che identificano o un numero limitato di neoplasie 9 o una sottoclassificazione in molteplici piccoli gruppi, considerando la morfologia delle cellule neoplastiche nella loro differenziazione dalle cellule di origine 4. Quest ultima classificazione ha il vantaggio di offrire per la prima volta una dettagliata descrizione delle lesioni simil-tumorali e di classificare alcuni dei tumori a cellule basali come tumori derivanti non dalle cellule dello strato basale dell epidermide ma dal germe pilifero. La nuova entità tumorale è stata denominata tricoblastoma, analogamente a quanto già previsto nella classificazione umana. Nella seguente rassegna verranno presi in considerazione casi di tumori e lesioni simil-tumorali del follicolo pilifero: 308 nel cane (pari al 10,4% di tutti i tumori cutanei) e 50 nel gatto (pari all 8,1% di tutti i tumori cutanei), pervenuti al Registro Tumori del Dipartimento di Patologia Animale della Facoltà di Medicina Veterinaria di Pisa nel periodo compreso tra il 1985 e il Di ogni forma tumorale, classificata in base allo schema proposto da E.J. Walder e T.L. Gross 4, verranno riportati alcuni dati epidemiologici e descritti i principali aspetti macroscopici e microscopici. Nella tabella vengono specificati per ogni tipo di tumore e per alcune delle lesioni simil-tumorali i diversi segmenti del follicolo pilifero da cui prendono origine. LESIONI SIMIL-TUMORALI DEL FOLLICOLO PILIFERO Tra le lesioni simil-tumorali vengono descritte le cisti follicolari, le cisti dermoidi, la displasia focale degli annessi e il poro dilatato del gatto. Cisti follicolari Possono essere congenite, frequenti sulla linea mediana della testa, o conseguire a traumi cronici come nelle zone di pressione, secondarie in questo ad ostruzione degli osti follicolari per fenomeni fibrotico-cicatriziali, o avere origine ignota. Macroscopicamente si presentano come noduli intradermici e/o sottocutanei, singoli o multipli, ben delimitati e del diametro variabile da 1 a 2 cm, alla superficie di taglio evidenziano un materiale omogeneo poltaceo che facilmente fuoriesce dalla cavità (Fig. 1). Istologicamente le cisti follicolari che originano dai tre diversi segmenti del follicolo pilifero si differenziano in base alle caratteristiche della parete e al contenuto di cheratina, riproponendo le diverse modalità di cheratinizzazione della zona infundibolare, dell istmo e della regione bulbare (Fig. 2). La ciste follicolare infundibolare è rivestita da epitelio squamoso con evidenti granuli cheratoialini e contiene frammenti di cheratina ad andamento tipicamente lamellare ondulato (cheratinizzazione cheratoialina). La ciste follicolare istmo-catagena è rivestita da epitelio mancante di uno strato granulare con cheratinociti a citoplasma pallido e vitreo e contiene frammenti di cheratina amorfa e pallida (cheratinizzazione trichilemmale). La ciste follicolare matricale è rivestita da cellule epiteliali basaloidi con nucleo evidente, scarso citoplasma e con passaggio netto ad una cheratinizzazione di tipo matricale, nella cavità sono presenti materiale amorfo con cellule chiare refrattarie ai coloranti o debolmente eosinofile dette cellule ombra ( shadow o ghost cells), aree di melanizzazione e mineralizzazione (cheratinizzazione matricale). La rottura della parete di una ciste follicolare è un evento frequente e spesso rende evidente una lesione che altrimenti potrebbe passare inosservata. In tale caso istologicamente si rileva la presenza di un infiltrato flogistico misto costituito essenzialmente da macrofagi, cellule giganti, linfociti e plasmacellule. Ciste dermoide Spesso congenita ed ereditaria, è considerata una duplicazione dell intera struttura cutanea per anomalia di sviluppo. Nel Rhodesian Ridgeback le cisti dermoidi, definite seni dermoidi, sono localizzate sulla linea mediana del dorso e possono estendersi fino al canale spinale. Istologicamente risultano rivestite da un epitelio che mantiene connessioni con gli annessi riproponendo la normale struttura epidermica (Fig. 3). Nella cavità sono presenti frammenti di cheratina, secreto sebaceo e alcuni residui di peli.
11 16 Francesca Abramo Displasia focale degli annessi È considerata una distorsione dell unità pilo-sebacea per fenomeno cicatriziale o un amartoma comprendente tessuto collagene. Macroscopicamente si presenta come una formazione nodulare solitaria e circoscritta, delle dimensioni variabili tra 1 e 4 cm, frequentemente localizzata agli arti soprattutto in corrispondenza degli spazi interdigitali e dei punti di pressione. All esame istologico si osservano ghiandole sebacee ipertrofiche, follicoli piliferi tortuosi e dilatati ed uno stroma di collagene maturo che tende ad inglobare, separandole, le varie unità pilo-sebacee distorte. FIGURA 1 - Cute regione della testa di un Boxer di 9 anni. Presenza di numerose piccole cisti follicolari contenenti materiale poltaceo brunastro. Poro dilatato del gatto Simile al poro di Winer dell uomo, si riscontra solo nel gatto e si presenta come una massa solitaria, delle dimensioni di solito inferiori ad 1 cm e localizzata sul collo o sulla testa di soggetti sia giovani che adulti. Istologicamente appare come una dilatazione cistica dell infundibolo follicolare con una cavità centrale contenente cheratina. Il rivestimento è costituito da epitelio squamoso marcatamente iperplastico con papille epidermiche perpendicolari alla superficie basale ed allineate in modo parallelo tra loro (aspetto tipicamente dentellato). TUMORI DEL FOLLICOLO PILIFERO FIGURA 2 - Ciste follicolare intradermica caratterizzata da una sottile parete e dalla presenza di strati concentrici di cheratina all interno della cavità (E-E, 5X). FIGURA 3 - Ciste dermoide intradermica. La cavità, contenente cheratina e residui di pelo, è rivestita da epitelio e stutture annessiali (E-E, 5X). Acantoma infundibolare cheratinizzante Nodulo intradermico e/o sottocutaneo delle dimensioni variabili da 1 a 5 cm che, nella maggior parte dei casi, presenta un poro di connessione con la superficie cutanea da cui fuoriesce cheratina. Frequentemente localizzato su dorso, tronco e collo può presentarsi anche in forma multipla (razze nordiche e Pastore Tedesco). Al taglio evidenzia una cavità più o meno ampia contenente materiale omogeneo, poltaceo e brunastro. Istologicamente è possibile evidenziare la tipica struttura con concavità rivolta verso l esterno della superficie cutanea e la connessione con l epidermide. Il punto di passaggio con la superficie cutanea è caratterizzato da un brusco ispessimento dell epitelio che si continua in profondità con piccole formazioni cistiche che producono vortici di cheratina lamellare, trabecole e cordoni cellulari misti a tessuto mixoide (Fig. 4). Nella forma solitaria l escissione chirurgica è ritenuta risolutiva. Nella forma multipla l escissione è consigliata solo se i noduli sono in numero limitato. Nelle forme multiple è stata consigliata la terapia a base di etretinato ed isotretinoina, ma gli studi in proposito sono ancora limitati 3,5. Pilomatricoma Massa sottocutanea delle dimensioni variabili tra 2 e 6 cm, con cavità centrali non in connessione con l esterno, si localizza preferenzialmente nella regione dorsale del collo ma può svilupparsi in qualsiasi altra regione del corpo. Al taglio appare multilobato e possono essere visibili aree di melanizzazione e mineralizzazione (Fig. 5). Istologicamente
12 Quaderni di dermatologia, Anno 3, n. 2, Novembre FIGURA 4 - Acantoma infundibulare cheratinizzante. La parete è costituita da trabecole, cordoni di cellule epiteliali e piccole cisti contenenti vortici di cheratina (E-E, 10X). FIGURA 5 - Cute regione della testa di un Barboncino di 9 anni. Pilomatricoma: massa intradermica lobulata, color bianco calce e brunastro. FIGURA 6 - Pilomatricoma: grossa formazione cistica tappezzata da uno strato di cellule basaloidi e contenente cheratina di tipo matricale, pigmento melaninico ed aree di mineralizzazione (E-E, 10X). FIGURA 7 - Cute del dorso di un cane Pastore Maremmano di 6 anni. Tricoepitelioma: massa intradermica esofitica, con piccole lobulature bianche immerse in uno stroma grigiastro. le formazioni cistiche sono rivestite da cellule basaloidi, basofile, con citoplasma a bordi indistinti e rare aree di epitelio squamoso. Il passaggio dallo strato di cellule basaloidi alla cheratinizzazione di tipo matricale è netto. Essendo solitario e ben demarcato generalmente l escissione chirurgica è risolutiva. Non infrequente è l insorgenza di nuovo tumore in altre sedi (tumore multicentrico). Sono segnalati casi di pilomatricoma maligno 7. Tricoepitelioma Massa solitaria di dimensioni variabili tra 1 e 10 cm, intradermica e/o sottocutanea, induce spesso alterazioni della cute soprastante (alopecia e ulcere). Si riscontra frequentemente sul collo, sul dorso e sugli arti. Al taglio mostra lobulature con piccoli focolai bianchi circondati da uno stroma connettivale grigiastro (Fig. 7). ZONE DEL FOLLICOLO PILIFERO TUMORI LESIONI SIMIL-TUMORALI Infundibolo Acantoma infundibolare Ciste follicolare infundibolare cheratinizzante Istmo Ciste follicolare istmo-catagena Bulbo Pilomatricoma Ciste follicolare matricale Tutti e 3 i segmenti Tricoepitelioma Cisti follicolare mista o ibrida Guaina radice esterna Trichilemmoma Germe primitivo del pelo Tricoblastoma
13 18 Francesca Abramo FIGURA 8 - Tricoepitelioma basaloide: numerose formazioni cistiche tappezzate da cellule basaloidi e contenenti cheratina (E-E, 10X). FIGURA 9 - Trichilemmoma: numerose isole epiteliali circondate da una spessa membrana vitrea e costituite da cellule con citoplasma chiaro e vacuolizzato (PAS, 10X). FIGURA 10 - Cute regione della testa di un Pastore Tedesco di 11 anni. Tricoblastoma: massa intradermica esofitica, color bianco grigiastro, particolarmente traslucida al taglio. FIGURA 11 - Tricoblastoma medusoide. Cordoni di cellule epiteliali, con tipico aspetto a medusa e al centro aree di cheratinizzazione trichilemmale, immersi in abbondante stroma di collagene (E-E, 10X). Istologicamente è costituito da strutture cistiche con epitelio sia di tipo squamoso che basaloide e isole epiteliali di varie dimensioni. Il prevalere di una delle due strutture epiteliali ci permette di distinguere due entità indipendenti, il tricoepitelioma squamoso e il basaloide (Fig. 8). L escissione chirurgica è risolutiva ma occasionalmente può svilupparsi in altre sedi (tumore multicentrico). Trichilemmoma Massa solitaria e circoscritta delle dimensioni variabili da 1 a 7 cm, di solito riscontrata in soggetti adulti. Istologicamente sono descritti il tipo bulbare e l istmo-catageno; nel primo tipo le cellule con citoplasma chiaro e vacuolizzato sono delimitate da una membrana basale spessa e vitrea, nel secondo tipo sono presenti cordoni e trabecole con tendenza alla cheratinizzazione trichilemmale (Fig. 9). Andamento biologico: sono riportati ancora troppi pochi casi per poter prevedere il comportamento biologico del tumore. Tricoblastoma Noduli intradermici e/o sottocutanei di dimensioni variabili tra 1 e 5 cm, cupoliformi, che si localizzano preferenzialmente sulla testa di soggetti in età avanzata (nel gatto spesso dopo i 10 anni). Al taglio mostrano un aspetto traslucido (Fig. 10). Istologicamente possiamo riconoscere due forme, il tipo cordoniforme, frequentemente riscontrato nel cane e caratterizzato da cordoni di cellule che talvolta assumono un tipico aspetto a medusa (Fig. 11), e il tipo trabecolare, di più facile riscontro nel gatto, caratterizzato da isole di cellule che tendono a formare una palizzata periferica. L escissione chirurgica è ritenuta risolutiva ma possono insorgere recidive locali. CONCLUSIONE Anche se per la maggior parte dei tumori del follicolo pilifero considerati il comportamento biologico è beni-
14 Quaderni di dermatologia, Anno 3, n. 2, Novembre gno, è necessario sottolineare come per alcuni di essi sia già stata segnalata la controparte maligna, esempio di ciò è il pilomatricoma maligno o carcinoma matricale 7. Alcuni dei tumori del follicolo pilifero hanno inoltre la tendenza, soprattutto in alcune razze, a localizzarsi in sede multipla, rendendo spesso improponibile un intervento chirurgico (da 30 a 40 noduli nell acantoma infundibolare cheratinizzante multicentrico) 8. Più recentemente è stata anche segnalata l evoluzione verso il carcinoma squamoso da cisti follicolari multiple in un cane 6 e in pecore Merinos 2. Un vantaggio della nuova classificazione è quello di aver distinto il tricoblastoma, tumore ad andamento esclusivamente benigno, dai tumori a cellule basali che, soprattutto nel gatto, possono presentare un quadro istologico con caratteri di malignità ed una evoluzione verso il carcinoma squamoso 3. Bibliografia 1. Bulletin of the World Health Organization. International Histological Classification of Tumors of Domestic Animals. Vol. 50, No 1-2, Carne H.R., Lloyd L.C., Carter H.B. Squamous cell carcinoma associated with cysts in the skin in Merino sheep. Journal of Pathology and Bacteriology. 1963, 86: Goldschmidt M.H., F.S. Shofer. Skin Tumors of the Dog and Cat. Pergamon Press, Oxford, Gross T.L., P.J. Ihrke, E.J. Walder. Veterinary Dermatology. A Macroscopic and Microscopic Evaluation of Canine and Feline Skin Diseease. Mosby Year Book, St. Louis Power H.T., Ihrke P.J. Synthetic retinoids in veterinary dermatology. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice 1990, 20: Scott D.W., E.A.C. Teixeira. Multiple squamous cell carcinomas arising from multiple cutaneous follicular cysts in a dog. Vet. Dermatol. 1995, 6: Sells D.M., Conroy D.J. Malignant epithelial neoplasia with hair follicle differentiation in dogs. Malignant pilomatrixoma. Journal of Comparative Pathology 1976, 86; Stannard A.A., Pulley L.T. Tumors in Domestic Animals. Ed. Moulton J.E., 2nd edition, University of California, Berkeley, Yager J.A., B.P. Wilcock. Color Atlas and Text: Surgical Pathology of the dog and cat: Dermatopathology and skin tumors. Vol 1 ed. Wolfe 1: 230, 1994.
15 Quaderni di dermatologia, Anno 3, n. 2, Novembre ESAME CITOLOGICO DEI TUMORI FOLLICOLARI CARLO MASSERDOTTI Libero Professionista, Salò INTRODUZIONE La classificazione delle neoplasie follicolari benigne in dermatologia veterinaria segue la nomenclatura adottata in medicina umana e, come per la medicina umana, si basa sull indagine istopatologica 3,4,5,6,8. Tuttavia l esame citologico di queste neoplasie, eseguibile tramite aspirazione con ago sottile, può indirizzare il clinico verso la diagnosi. Oggetto di questa breve trattazione è l analisi dei reperti microscopici che permettono di formulare considerazioni diagnostiche e, quindi, di adottare decisioni terapeutiche. Il follicolo pilifero è suddiviso, dal punto di vista morfologico, in tre porzioni (Fig. 1): la più superficiale detta infundibolo, che si estende fino allo sbocco della ghiandola sebacea, quella media, detta istmo, tra lo sbocco della ghiandola sebacea e l inserzione del muscolo piloerettore, e quella profonda, detta bulbo, supportata dalla papilla dermica. Possiamo individuare tre strutture fondamentali costituenti il follicolo pilifero: la guaina epiteliale esterna e la guaina epiteliale interna, che rappresentano la parete portante del follicolo, e le cellule matricali, localizzate sul fondo che formano il fusto pilifero 1,6. Ciascuna di queste strutture cheratinizza in maniera differente. TIPI DI CHERATINIZZAZIONE FIGURA 1 - Suddivisione stratigrafica del follicolo nelle tre porzioni infundibolo, istmo e bulbo sulla base dei punti di riferimento anatomici. FIGURA 2 - Infundibolo follicolare che produce squame cornee tipiche della cheratinizzazione lamellare (Ingr.: 100X; colorazione EMATOSSILI- NA-EOSINA).
16 22 Carlo Masserdotti FIGURA 3 - Lo sbocco della ghiandola sebacea rappresenta il confine tra infundibolo ed istmo, ed è caratterizzato da cheratinizzazione trichilemmale (Ingr.: 100X; colorazione EMATOSSILINA-EOSINA). FIGURA 4 - La cheratina amorfa e compatta prodotta dalle cellule dell istmo caratterizza la cheratinizzazione della guaina epiteliale interna (Ingr.: 100X; colorazione EMATOSSILINA-EOSINA). Cheratinizzazione lamellare Tale processo è localizzato alla porzione infundibolare della guaina epiteliale esterna, che continua gli strati epidermici superficiali. La sua caratteristica è la produzione di lamelle cornee anucleate, con sintesi di granuli cheratoialini, in maniera sovrapponibile a quanto si verifica a livello dell epidermide (Fig. 2). Cheratinizzazione trichilemmale Tale processo è tipico della guaina epiteliale esterna. Si verifica a livello istmico in fase anagena, mentre in fase catagena si estende alla porzione bulbare (Fig. 3). Questo tipo di cheratinizzazione è caratterizzato dall assenza di granuli cheratoialini e dalla sintesi di un materiale cheratinico grezzo, amorfo e privo di struttura laminare. Cheratinizzazione della guaina epiteliale interna È caratterizzata dalla formazione di granuli tricoialini con produzione di materiale cheratinico amorfo e compatto (Fig. 4). Questi processi preludono, tramite intervento enzimatico, alla disintegrazione della guaina. Cheratinizzazione matricale La cheratinizzazione matricale si verifica nelle cellule matricali del bulbo e porta alla formazione del fusto pilifero (Fig. 5). Tale processo è caratterizzato da una ritenzione prolungata delle strutture nucleari 1. ESAME CITOLOGICO L esame citologico non permette di distinguere il tipo di neoplasia follicolare, ma individua il tipo di cheratinizzazione proprio di un tumore follicolare. Inoltre ci permette di esaminare la popolazione epiteliale nucleata e le cellule infiammatorie presenti. L indagine citologica viene condotta utilizzando aghi di calibro compreso tra i 22 ed i 26 FIGURA 5 - Bulbo pilifero e cheratinizzazione matricale (Ingr.: 100X; colorazione EMATOSSILINA-EOSINA). Gauge raccordati a siringhe da 10 o 20 ml. Generalmente si ottiene materiale di consistenza caseosa e di colorito variabile tra il grigiastro ed il bruno 2. I principali reperti microscopici sono: Materiale cheratinico di tipo squamolaminare È il risultato del processo di cheratinizzazione lamellare che, come precedentemente esposto, si verifica a livello delle porzioni più superficiali del follicolo pilifero (Fig. 6). Il suo aspetto è facilmente interpretabile poiché simile alle squame cornee anucleate che si osservano per esempio con gli esami citologici per apposizione. Gli elementi cellulari sono anucleati, di forma poligonale, di dimensione uniforme, basofili od eosinofili, a seconda delle colorazioni impiegate. Occasionalmente il margine delle figure poligonali può apparire ripiegato o arrotolato, per effetto delle modalità di allestimento del campione. Non è raro il reperimento di granuli cheratoialini intracitoplasmatici e di granuli di melanina, in numero variabile in sede intra- ed
17 Quaderni di dermatologia, Anno 3, n. 2, Novembre TABELLA 1 TIPO DI MATERIALE CHERATINICO TUMORI FOLLICOLARI ASSOCIATI Squamolaminare Cisti infundibolari Acantoma infundibolare cheratinizzante Alcuni tricoepiteliomi Amorfo Alcuni tricoepiteliomi Pilomatrixoma (con ghost cells) Trichilemmoma Cisti istmo-catagene Cisti matricali Cisti miste o ibride FIGURA 6 - Squame cornee anucleate in aggregato, provenienti da una cisti follicolare a differenziazione lamellare (Ingr.: 400X; colorazione HEMACOLOR). extracellulare. Il quadro descritto caratterizza le cisti infundibolari a contenuto cheratinico, l acantoma infundibolare cheratinizzante e alcuni tricoepiteliomi (Tab. 1). Materiale cheratinico amorfo Tale materiale è il risultato di processi di cheratinizzazione che si verificano in più settori a livello istmico o bulbare. Può presentarsi come grossolani aggregati di materiale amorfo basofilo, a margini irregolari, e a disposizione globulare (Fig. 7). Spesso risulta difficoltoso osservare a fuoco tali aggregazioni, a causa della loro disposizione tridimensionale. Interessante è l osservazione di occasionali ghost cells (cellule fantasma), che sono squame cornee con centro citoplasmatico acromatico, sede dei processi di regressione del nucleo 7. I reperti descritti caratterizzano il tricoepitelioma, il pilomatrixoma, il trichilemmoma e le cisti cheratiniche istmo-catagene, matricali o ibride (Tab. 1). FIGURA 7 - Materiale cheratinico amorfo, proveniente da una cisti follicolare a differenziazione trichilemmale (Ingr.: 1000X; colorazione HEMACOLOR). Cellularità epiteliale Aggregati epiteliali di tumori follicolari benigni vanno differenzialti da quelli di neoplasie più aggressive, quali il carcinoma a cellule basali o il carcinoma squamocellulare. È possibile osservare elementi epiteliali in aggregati di dimensioni variabili, frequentemente disposti a palizzata 2. Tali elementi hanno un citoplasma scarso e un nucleo piccolo, isocariotico, privo di atipie, con cromatina finemente irregolare. Il numero degli elementi epiteliali può essere abbondante in caso di tricoblastoma, tricoepitelioma, trichilemmoma o pilomatrixoma (Fig. 8). Cellularità infiammatoria È frequente osservare granulociti neutrofili (con nucleo degenerato qualora sia presente una concomitante irruzione batterica secondaria) o cellule mono- polinucleate della linea istiocitico-macrofagica 2 (Fig. 9). Generalmente tali reperti derivano dalla rottura della parete cistica con reazione tissutale da corpo estraneo nei confronti del materiale cheratinico e infezione batterica secondaria. FIGURA 8 - Elevato numero di cellule nucleate, associate a materiale tendenzialmente amorfo e ipercromatico, provenienti da un pilomatrixoma (Ingr.: 1000X; colorazione EMATOSSILINA-EOSINA).
18 24 Carlo Masserdotti FIGURA 9 - Numerosi granulociti neutrofili che circondano due squame cornee anucleate: la rottura della capsula cistica scatena sempre una reazione infiammatoria da corpo estraneo (Ingr.: 1000X; colorazione HEMACOLOR). FIGURA 10 - I cristalli poligonali di colesterolo sono esito dei processi di cheratinizzazione che comportano l estrusione di materiale lipidico citoplasmatico (Ingr.: 400X; colorazione HEMACOLOR). Cristalli È occasionale ma non infrequente il reperimento di cristalli di colesterolo (Fig. 10), che si formano per effetto dell estrusione di materiale citoplasmatico dalle cellule in fase di corneificazione. Essi appaiono di colore giallastro rifrangente, di aspetto poligonale e sono sparsi negli spazi intercellulari 2. CONCLUSIONI Ben lontano dal rappresentare un metodo accurato per la differenziazione specifica dei tumori follicolari benigni, l esame citologico serve tuttavia come guida per indirizzare il dermatologo verso la diagnosi. Bibliografia 1. Alhaidari Z., Von Tscharner C.: Anatomie et physiologie du follicule pileux chez les carnivores domestiques. Prat. Med. Chir. An. Comp. 32: ; Cowell R.L., Tyler R.D.: Diagnostic Cytology of the Dog and Cat. AVP, California Elder D., Elenitsas R., Ragsdale B.D.: Tumors of Epidermal Appendages; in Lever s Histopathology of the Skin Lippincott - Raven Publishers, pp Goldschmit M.H., Shofer F.S.: Skin tumor of the Dog and Cat. Pergamon Press, Lever W.L., Schaumburg Lever G.: Histopathology of the Skin. VII Ed. Lippincott. 6. Scott D.W.,. Miller W.H., Griffin C.E.: Small Animal Dermatology. 5th Ed Saunders, pp Woyke S., Olzewsky W., Eichelkraut A.: Pilomatrixoma, a pitfall in aspiration cytology of skin tumors. Acta Cytologica Vol.26, n 2, March-April 1982; pag Yager J.A., Wilcock B.P.: Surgical Pathology of the dogmand cat. Dermatopathology and skin tumors. Wolfe, Con l autunno 98 la Divisione Piccoli Animali della Farmaceutici Gellini mette a disposizione del Medico Veterinario la prima registrazione di un antibiotico a base di clindamicina cloridrato presentato sotto forma di compresse. Clindacyn infatti è l unico antibiotico a base di clindamicina presente in campo veterinario, appositamente studiato in questa forma farmaceutica in due diverse formulazioni da 75 e 150 mg destinato ai cani. La clindamicina è un antimicrobico semisintetico appartenente alla classe delle lincosamidi, si differenzia dal suo congenere già noto in veterinaria (lincomicina) per la presenza di un atomo di cloro nella catena propilica e per l inversione CLINDACYN L antibiotico che conosce la strada della configurazione sterica. Tali caratteristiche determinano una maggiore attività della clindamicina, oltre ad un più elevato assorbimento intestinale e ad una minore tossicità. La particolare costituzione chimica della clindamicina permette, inoltre, un ampliamento dello spettro d azione sui batteri aerobi Gram+, batteri anaerobi Gram+ e Gram nonché su alcuni protozoi, quali Toxoplasma gondii, Babesia spp, Plasmodium falciparum, Pneumocistis carinii. Peculiarità assoluta della clindamicina è l elevata concentrazione raggiunta dopo somministrazione orale in particolari tessuti quali pelle, tessuti molli ed ossa con livelli terapeutici efficaci per ore a seconda della posologia utilizzata. Clindacyn dunque rappresenta l antibiotico d elezione per la terapia delle infezioni della pelle, del cavo orale e delle ossa, in particolare piodermiti, ferite infette, ascessi, periodontiti, gengiviti, osteomieliti; è inoltre indicato nella terapia della toxoplasmosi. Clindacyn deve essere somministrato per via orale alle dosi di 5,5 mg/kg p.c. ogni 12 ore oppure 11 mg/kg p.c. ogni 24 ore fino a 48 ore dopo la remissione della sintomatologia. Nei casi di osteomielite è necessaria una posologia di 11 mg/kg p.c. ogni 12 ore per almeno 4 settimane. Clindacyn si trova in commercio in 2 confezioni contenenti 20 compresse da 75 e da 150 mg.
19 Quaderni di dermatologia, Anno 3, n. 2, Novembre SOCIETÀ CULTURALE ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA COMPAGNIA SOCIETÀ ITALIANA DI DERMATOLOGIA VETERINARIA (Società Specialistica collegata SCIVAC) Un immagine dell aula Didattica del Centro Studi SCIVAC durante lo svolgimento del Corso Corso di Immunologia Cutanea ottobre 1998 Centro Studi SCIVAC - Palazzo Trecchi Cremona Nei giorni ottobre 1998 si è svolto a Cremona il Corso di Immunologia e Immunopatologia Cutanea organizzato dalla SIDEV, che ha visto impegnati due eccezionali relatori, il Dr. Thierry Olivry (Università del North Carolina, USA) e la Dr.ssa Julie Yager (Università di Guelph, Ontario) con un programma particolarmente ricco e di elevato livello scientifico. I relatori hanno affrontato le principali malattie cutanee di natura allergica, autoimmunitaria, le reazioni da farmaco e molte altre malattie immunomediate. Il corso era aperto anche a colleghi stranieri e ha registrato circa 80 presenze anche da Francia, Germania, Svizzera, Austria, Ungheria, Croazia e addirittura dal Giappone. Da sinistra in piedi: Luca Mechelli, Fabrizio Fabbrini, Antonella Vercelli, Julie Yager, Thierry Olivry, Chiara Tieghi. In basso: Silvia Schiavi, Chiara Noli, Franca Galeotti.
TUMORI E LESIONI SIMIL-TUMORALI DEL FOLLICOLO PILIFERO
 Quaderni di dermatologia, Anno 3, n. 2, Novembre 1998 15 TUMORI E LESIONI SIMIL-TUMORALI DEL FOLLICOLO PILIFERO FRANCESCA ABRAMO Dipartimento di Patologia Animale, Università degli Studi di Pisa INTRODUZIONE
Quaderni di dermatologia, Anno 3, n. 2, Novembre 1998 15 TUMORI E LESIONI SIMIL-TUMORALI DEL FOLLICOLO PILIFERO FRANCESCA ABRAMO Dipartimento di Patologia Animale, Università degli Studi di Pisa INTRODUZIONE
LE MALATTIE INFIAMMATORIE FOLLICOLARI DEL CANE E DEL GATTO
 Quaderni di dermatologia, Anno 3, n. 2, Novembre 1998 7 LE MALATTIE INFIAMMATORIE FOLLICOLARI DEL CANE E DEL GATTO FABRIZIO FABBRINI Libero Professionista, Milano LUCA MECHELLI Istituto di Patologia Generale
Quaderni di dermatologia, Anno 3, n. 2, Novembre 1998 7 LE MALATTIE INFIAMMATORIE FOLLICOLARI DEL CANE E DEL GATTO FABRIZIO FABBRINI Libero Professionista, Milano LUCA MECHELLI Istituto di Patologia Generale
parte prima INTRODUZIONE ALLA DERMATOLOGIA E APPROCCIO AL PAZIENTE
 parte prima INTRODUZIONE ALLA DERMATOLOGIA E APPROCCIO AL PAZIENTE capitolo 1 Struttura e funzione della cute ed ecosistema cutaneo Struttura cutanea Funzioni di cute e annessi Microflora cutanea capitolo
parte prima INTRODUZIONE ALLA DERMATOLOGIA E APPROCCIO AL PAZIENTE capitolo 1 Struttura e funzione della cute ed ecosistema cutaneo Struttura cutanea Funzioni di cute e annessi Microflora cutanea capitolo
Università degli Studi di Roma La Sapienza, Polo Pontino. Dipartimento di Malattie Cutanee-Veneree e di Chirurgia Plastica Ricostruttiva
 Università degli Studi di Roma La Sapienza, Polo Pontino Dipartimento di Malattie Cutanee-Veneree e di Chirurgia Plastica Ricostruttiva Lesioni pigmentarie benigne : correlazioni clinico-patologiche Diagnosi
Università degli Studi di Roma La Sapienza, Polo Pontino Dipartimento di Malattie Cutanee-Veneree e di Chirurgia Plastica Ricostruttiva Lesioni pigmentarie benigne : correlazioni clinico-patologiche Diagnosi
STORIE DI SUCCESSO CASI DI DERMATOLOGIA
 STORIE DI SUCCESSO CASI DI DERMATOLOGIA CASO CLINICO: ALOPECIA X Febbraio 2013 Dado è un cane Spitz tedesco nano, maschio, intero, di 2 anni e 10 mesi, venuto in Ospedale a febbraio del 2013 per alopecia
STORIE DI SUCCESSO CASI DI DERMATOLOGIA CASO CLINICO: ALOPECIA X Febbraio 2013 Dado è un cane Spitz tedesco nano, maschio, intero, di 2 anni e 10 mesi, venuto in Ospedale a febbraio del 2013 per alopecia
ATTI III Congresso Nazionale
 AIPVet Associazione Italiana di Patologia Veterinaria ATTI III Congresso Nazionale ISSN 1825-2265 con la partecipazione della Società Italiana di Patologia Tossicologica e Sperimentale del Gruppo di Patologia
AIPVet Associazione Italiana di Patologia Veterinaria ATTI III Congresso Nazionale ISSN 1825-2265 con la partecipazione della Società Italiana di Patologia Tossicologica e Sperimentale del Gruppo di Patologia
TUMORI DELLA CUTE E DEGLI ANNESSI: CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE
 TUMORI DELLA CUTE E DEGLI ANNESSI: CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE Prof. Paola Maiolino e-mail:maiolino@unina.it CLASSIFICAZIONE ISTOLOGICA DEI TUMORI EPITELIALI CUTANEI Goldschmidt MH,
TUMORI DELLA CUTE E DEGLI ANNESSI: CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE Prof. Paola Maiolino e-mail:maiolino@unina.it CLASSIFICAZIONE ISTOLOGICA DEI TUMORI EPITELIALI CUTANEI Goldschmidt MH,
Cisti odontogene neoplastiche Ameloblastoma. Corrado Rubini
 Scuola Nazionale di Surgical Pathology Corso di Patologia del distretto Testa-collo Bologna 24-26 Febbraio 2015 Cisti odontogene neoplastiche Ameloblastoma Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica
Scuola Nazionale di Surgical Pathology Corso di Patologia del distretto Testa-collo Bologna 24-26 Febbraio 2015 Cisti odontogene neoplastiche Ameloblastoma Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica
clicca qui Caso n. 2 occasionali nuclei voluminosi ipercromatici nuclei rotondo ovali con cromatina pallida, a fine disegno
 CORSO PRATICO DI CITOLOGIA DIAGNOSTICA AGOASPIRATIVA DELLE GHIANDOLE SALIVARI Gargnano 15-16 aprile 2011 Sergio Fiaccavento Caso n. 2 Palazzo Feltrinelli - Gargnano Dati Clinici : Ragazza di di 13 anni,
CORSO PRATICO DI CITOLOGIA DIAGNOSTICA AGOASPIRATIVA DELLE GHIANDOLE SALIVARI Gargnano 15-16 aprile 2011 Sergio Fiaccavento Caso n. 2 Palazzo Feltrinelli - Gargnano Dati Clinici : Ragazza di di 13 anni,
Alopecia diffusa/simmetrica nel cane
 Alopecia diffusa/simmetrica nel cane Cause congenite ed ereditarie razze nude (ipotricosi) displasia dei peli neri alopecia da diluizione del colore Cause immunomediate alopecia areata adenite sebacea
Alopecia diffusa/simmetrica nel cane Cause congenite ed ereditarie razze nude (ipotricosi) displasia dei peli neri alopecia da diluizione del colore Cause immunomediate alopecia areata adenite sebacea
Tumori del rene. Prof. Serenella Papparella
 Tumori del rene Prof. Serenella Papparella Epidemiologia e Patologia Cane: meno del 2% di tutti i tumori canini. Più spesso si tratta di tumori maligni epiteliali (Renall Cell Carcinoma-RCC). Più comuni
Tumori del rene Prof. Serenella Papparella Epidemiologia e Patologia Cane: meno del 2% di tutti i tumori canini. Più spesso si tratta di tumori maligni epiteliali (Renall Cell Carcinoma-RCC). Più comuni
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria Anno Accademico 2019/2020
 Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria Anno Accademico 019/00 Programma dell insegnamento di ANATOMIA PATOLOGICA 3 dell esame integrato di ANATOMIA PATOLOGICA Anno di corso IV Bimestre IV N
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria Anno Accademico 019/00 Programma dell insegnamento di ANATOMIA PATOLOGICA 3 dell esame integrato di ANATOMIA PATOLOGICA Anno di corso IV Bimestre IV N
I tumori del cavo orale non di origine dentaria
 I tumori del cavo orale non di origine dentaria I tumori del cavo orale Tumori benigni Tumori maligni I tumori benigni Tumori benigni dell epitelio dell epitelio ghiandolare del sistema melanogenico del
I tumori del cavo orale non di origine dentaria I tumori del cavo orale Tumori benigni Tumori maligni I tumori benigni Tumori benigni dell epitelio dell epitelio ghiandolare del sistema melanogenico del
TUMORI DELL EPIDERMIDE
 Quaderni di dermatologia, Anno 9, n. 2, Dicembre 2004 23 TUMORI DELL EPIDERMIDE FRANCESCA ABRAMO Dipartimento di Patologia Animale, Università di Pisa La disciplina oncologica veterinaria ha subito nell
Quaderni di dermatologia, Anno 9, n. 2, Dicembre 2004 23 TUMORI DELL EPIDERMIDE FRANCESCA ABRAMO Dipartimento di Patologia Animale, Università di Pisa La disciplina oncologica veterinaria ha subito nell
Canale anale. (La classificazione si applica soltanto ai carcinomi; melanomi, tumori carcinoidi e sarcomi sono esclusi)
 13 Canale anale (La classificazione si applica soltanto ai carcinomi; melanomi, tumori carcinoidi e sarcomi sono esclusi) C21.0 Ano, NAS C21.1 Canale anale C21.2 Zona cloacogenica C21.8 Lesione sovrapposta
13 Canale anale (La classificazione si applica soltanto ai carcinomi; melanomi, tumori carcinoidi e sarcomi sono esclusi) C21.0 Ano, NAS C21.1 Canale anale C21.2 Zona cloacogenica C21.8 Lesione sovrapposta
ADENITE SEBACEA IN UN GATTO
 Veterinaria, Anno 20, n. 3, Giugno 2006 19 ADENITE SEBACEA IN UN GATTO ALESSANDRO BONINO, ANTONELLA VERCELLI, FRANCESCA ABRAMO* Libero professionista, S. Margherita Ligure (GE); Libero professionista,
Veterinaria, Anno 20, n. 3, Giugno 2006 19 ADENITE SEBACEA IN UN GATTO ALESSANDRO BONINO, ANTONELLA VERCELLI, FRANCESCA ABRAMO* Libero professionista, S. Margherita Ligure (GE); Libero professionista,
I DISTURBI DI CHERATINIZZAZIONE PRIMARI E SECONDARI
 Quaderni di dermatologia, Anno 10, n. 2, Dicembre 2005 15 I DISTURBI DI CHERATINIZZAZIONE PRIMARI E SECONDARI CHIARA NOLI, DVM, Dip ECVD Ospedale Veterinario Cuneese Via Cuneo 52/N, Borgo S. Dalmazzo (CN)
Quaderni di dermatologia, Anno 10, n. 2, Dicembre 2005 15 I DISTURBI DI CHERATINIZZAZIONE PRIMARI E SECONDARI CHIARA NOLI, DVM, Dip ECVD Ospedale Veterinario Cuneese Via Cuneo 52/N, Borgo S. Dalmazzo (CN)
Corso di Istologia. Titolare: dott.ssa Donatella Farini
 Corso di Istologia Titolare: dott.ssa Donatella Farini Tel:.06 72596152 e-mail: donatella.farini@uniroma2.it didatticaweb aa 2017/2018 ortottica Modulo istologia files Il microscopio ottico Preparazione
Corso di Istologia Titolare: dott.ssa Donatella Farini Tel:.06 72596152 e-mail: donatella.farini@uniroma2.it didatticaweb aa 2017/2018 ortottica Modulo istologia files Il microscopio ottico Preparazione
Il Nodulo Tiroideo. "Diagnostica Citologica" SOC Anatomia Patologica - Casale/Valenza
 Il Nodulo Tiroideo "Diagnostica Citologica" SOC Anatomia Patologica - Casale/Valenza FNAC Con il termine di FNAC (Fine Needle Aspiration Cytology) si intende un prelievo citologico eseguito mediante un
Il Nodulo Tiroideo "Diagnostica Citologica" SOC Anatomia Patologica - Casale/Valenza FNAC Con il termine di FNAC (Fine Needle Aspiration Cytology) si intende un prelievo citologico eseguito mediante un
DERMATOSI FACCIALI DEL GATTO
 Quaderni di dermatologia, Anno 8, n. 1, Giugno 2003 13 DERMATOSI FACCIALI DEL GATTO FABIA SCARAMPELLA Studio Dermatologico Veterinario - Milano INTRODUZIONE Il muso del gatto è il bersaglio frequente di
Quaderni di dermatologia, Anno 8, n. 1, Giugno 2003 13 DERMATOSI FACCIALI DEL GATTO FABIA SCARAMPELLA Studio Dermatologico Veterinario - Milano INTRODUZIONE Il muso del gatto è il bersaglio frequente di
Pastore belga, femmina non castrata, 9.5 anni
 DUCA Segnalamento e anamnesi Pastore belga, femmina non castrata, 9.5 anni Duca da 1.5 anni ha un problema di "ferite" nasali estese col tempo al mento e alla vulva Secondo il proprietario il cane non
DUCA Segnalamento e anamnesi Pastore belga, femmina non castrata, 9.5 anni Duca da 1.5 anni ha un problema di "ferite" nasali estese col tempo al mento e alla vulva Secondo il proprietario il cane non
INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO DELLE LESIONI GHIANDOLARI: DIFFERENZE MORFOLOGICHE IN CITOLOGIA CONVENZIONALE E IN FASE LIQUIDA
 WORKSHOP PRECONGRESSUALE GISCi Centro Direzionale di Napoli, Università Parthenope MERCOLEDI, 8 GIUGNO 2016 INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO DELLE LESIONI GHIANDOLARI: DIFFERENZE MORFOLOGICHE IN CITOLOGIA CONVENZIONALE
WORKSHOP PRECONGRESSUALE GISCi Centro Direzionale di Napoli, Università Parthenope MERCOLEDI, 8 GIUGNO 2016 INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO DELLE LESIONI GHIANDOLARI: DIFFERENZE MORFOLOGICHE IN CITOLOGIA CONVENZIONALE
APPARATO TEGUMENTARIO
 APPARATO TEGUMENTARIO Con tale definizione si possono intendere tutte le strutture di rivestimento della SUPERFICIE ESTERNA del corpo e delle CAVITA' comunicanti con la superficie esterna. Tuttavia, in
APPARATO TEGUMENTARIO Con tale definizione si possono intendere tutte le strutture di rivestimento della SUPERFICIE ESTERNA del corpo e delle CAVITA' comunicanti con la superficie esterna. Tuttavia, in
LARINGE.
 LARINGE www.fisiokinesiterapia.biz SUPRAGLOTTICA epiglottide/corda vocale falsa (e il ventricolo) GLOTTICA corda vocale vera e commissura anteriore SUB-GLOTTICA margine inf. corda vocale vera fino alla
LARINGE www.fisiokinesiterapia.biz SUPRAGLOTTICA epiglottide/corda vocale falsa (e il ventricolo) GLOTTICA corda vocale vera e commissura anteriore SUB-GLOTTICA margine inf. corda vocale vera fino alla
UN CASO DI METASTASI DIGITALI DI CARCINOMA POLMONARE IN UN GATTO
 UN CASO DI METASTASI DIGITALI DI CARCINOMA POLMONARE IN UN GATTO Oncologia cutanea SIDEV - Cremona 17/10/2004 Elisa Antoniazzi, Voghera (PV) Walter Bertazzolo, Lodi Segnalamento ed anamnesi Cino, gatto,
UN CASO DI METASTASI DIGITALI DI CARCINOMA POLMONARE IN UN GATTO Oncologia cutanea SIDEV - Cremona 17/10/2004 Elisa Antoniazzi, Voghera (PV) Walter Bertazzolo, Lodi Segnalamento ed anamnesi Cino, gatto,
Citopatologia delle neoformazioni cutanee. Prof. Paola Maiolino e-mail:maiolino@unina.it
 Citopatologia delle neoformazioni cutanee. Prof. Paola Maiolino e-mail:maiolino@unina.it Primo obiettivo nella valutazione citologica è determinare la natura del processo patologico e cioè se si è in presenza
Citopatologia delle neoformazioni cutanee. Prof. Paola Maiolino e-mail:maiolino@unina.it Primo obiettivo nella valutazione citologica è determinare la natura del processo patologico e cioè se si è in presenza
CORSO PRATICO DI CITOLOGIA DIAGNOSTICA AGOASPIRATIVA DELLE GHIANDOLE SALIVARI
 CORSO PRATICO DI CITOLOGIA DIAGNOSTICA AGOASPIRATIVA DELLE GHIANDOLE SALIVARI Gargnano 15-16 aprile 2011 Sergio Fiaccavento Caso n. 5 Notizie cliniche: soggetto di sesso maschile di anni 63 presenta alla
CORSO PRATICO DI CITOLOGIA DIAGNOSTICA AGOASPIRATIVA DELLE GHIANDOLE SALIVARI Gargnano 15-16 aprile 2011 Sergio Fiaccavento Caso n. 5 Notizie cliniche: soggetto di sesso maschile di anni 63 presenta alla
DIAGNOSI DESCRITTIVA NEGATIVO PER LESIONI INTRAEPITELIALI O MALIGNE
 DIAGNOSI DESCRITTIVA NEGATIVO PER LESIONI INTRAEPITELIALI O MALIGNE Esamineremo in questo capitolo quelle condizioni patologiche non neoplastiche che possono essere osservate in un Pap Test e che possono
DIAGNOSI DESCRITTIVA NEGATIVO PER LESIONI INTRAEPITELIALI O MALIGNE Esamineremo in questo capitolo quelle condizioni patologiche non neoplastiche che possono essere osservate in un Pap Test e che possono
Caso cito 1 e istologico 4
 Caso cito 1 e istologico 4 Dott.ssa Licia LAURINO Dott.ssa Matilde CACCIATORE TREVISO AGGREGATI TRIDIMENSIONALI Storia clinica RN, data di nascita 23-01-1959 Marzo 2009: esame citologico nodulo QSC
Caso cito 1 e istologico 4 Dott.ssa Licia LAURINO Dott.ssa Matilde CACCIATORE TREVISO AGGREGATI TRIDIMENSIONALI Storia clinica RN, data di nascita 23-01-1959 Marzo 2009: esame citologico nodulo QSC
caratterizzano per una riduzione quantitativa dei peli in una qualsiasi regione del corpo che ne sia normalmente dotata. Sono state descritte numerose
 CLASSIFICAZIONE DELLE ALOPECIE CICATRIZIALI A. Rossi alfredo.rossi@uniroma1.it Introduzione Con il termine di alopecia si fa riferimento ad una serie di condizioni che si caratterizzano per una riduzione
CLASSIFICAZIONE DELLE ALOPECIE CICATRIZIALI A. Rossi alfredo.rossi@uniroma1.it Introduzione Con il termine di alopecia si fa riferimento ad una serie di condizioni che si caratterizzano per una riduzione
Curriculum vitae. Olivieri Lara DVM CES Dermatologie
 Curriculum vitae Olivieri Lara DVM CES Dermatologie Formazione 20 marzo 2001: Laurea in Medicina Veterinaria presso la facoltà di Medicina Veterinaria dell Università degli Studi di Bologna, con punti
Curriculum vitae Olivieri Lara DVM CES Dermatologie Formazione 20 marzo 2001: Laurea in Medicina Veterinaria presso la facoltà di Medicina Veterinaria dell Università degli Studi di Bologna, con punti
INTERPRETAZIONE DELLA MORFOLOGIA FOLLICOLARE PATOLOGICA NEL CANE
 Quaderni di dermatologia, Anno 5, n. 1, Giugno 2000 15 INTERPRETAZIONE DELLA MORFOLOGIA FOLLICOLARE PATOLOGICA NEL CANE D. FONDEVILA Facoltà di Veterinaria, Università Autonoma di Barcelona Il follicolo
Quaderni di dermatologia, Anno 5, n. 1, Giugno 2000 15 INTERPRETAZIONE DELLA MORFOLOGIA FOLLICOLARE PATOLOGICA NEL CANE D. FONDEVILA Facoltà di Veterinaria, Università Autonoma di Barcelona Il follicolo
La citologia diagnostica: le buone pratiche. Pierangela Grassi
 La citologia diagnostica: le buone pratiche Pierangela Grassi Una volta acceso il microscopio Un giro ad basso ingrandimento Cellularità (cellule intatte ) Fondo del vetrino Distribuzione Rapporti tra
La citologia diagnostica: le buone pratiche Pierangela Grassi Una volta acceso il microscopio Un giro ad basso ingrandimento Cellularità (cellule intatte ) Fondo del vetrino Distribuzione Rapporti tra
CARCINOMA ENDOMETRIOIDE
 CARCINOMA ENDOMETRIOIDE Carcinoma mesonefrico/carcinoma a Cellule Chiare MACROSCOPICA Dimensioni variabili Superficie liscia Alternarsi di strutture cistiche, solide, compatte o midollari Carcinoma mesonefrico
CARCINOMA ENDOMETRIOIDE Carcinoma mesonefrico/carcinoma a Cellule Chiare MACROSCOPICA Dimensioni variabili Superficie liscia Alternarsi di strutture cistiche, solide, compatte o midollari Carcinoma mesonefrico
Citopatologia come descrivere cosa descrivere
 Citopatologia come descrivere cosa descrivere PRIMA DI TUTTO, DESCRIVERE! 1) QUALITA DEL CAMPIONE!!! 1.1 cellularità E necessario avere un adeguato numero di cellule Ottima cellularità, abbondante Moderata
Citopatologia come descrivere cosa descrivere PRIMA DI TUTTO, DESCRIVERE! 1) QUALITA DEL CAMPIONE!!! 1.1 cellularità E necessario avere un adeguato numero di cellule Ottima cellularità, abbondante Moderata
PERCORSO DI DERMATOLOGIA
 2017 MILANO PERCORSO DI DERMATOLOGIA PROPEDEUTICO ALL EXECUTIVE MASTER IN DERMATOLOGIA 2018-2020 DIRETTORE DEL CORSO Dott.ssa Fabia Scarampella, DVM, MSc, Dipl. ECVD RELATORI ED ISTRUTTORI: Dott.ssa Luisa
2017 MILANO PERCORSO DI DERMATOLOGIA PROPEDEUTICO ALL EXECUTIVE MASTER IN DERMATOLOGIA 2018-2020 DIRETTORE DEL CORSO Dott.ssa Fabia Scarampella, DVM, MSc, Dipl. ECVD RELATORI ED ISTRUTTORI: Dott.ssa Luisa
NEOPLASIE II CRITERI DI MALIGNITA
 NEOPLASIE II ----- CRITERI DI MALIGNITA CRITERI DI MALIGNITA I criteri e le regole per il riconoscimento di una neoplasia hanno valenza generale e non valore assoluto E fondamentale la conoscenza dell
NEOPLASIE II ----- CRITERI DI MALIGNITA CRITERI DI MALIGNITA I criteri e le regole per il riconoscimento di una neoplasia hanno valenza generale e non valore assoluto E fondamentale la conoscenza dell
Acni Endogene : Acne volgare Acne conglobata: si tratta di una grave forma di acne caratterizzata da lesioni nodulari anche confluenti con frequente
 INTRODUZIONE L acne vulgaris è una patologia della pelle caratterizzata da un processo infiammatorio del follicolo pilifero e delle ghiandole sebacee annesse, che esordisce alla pubertà e ha un picco d
INTRODUZIONE L acne vulgaris è una patologia della pelle caratterizzata da un processo infiammatorio del follicolo pilifero e delle ghiandole sebacee annesse, che esordisce alla pubertà e ha un picco d
30/05/2011. Melanoma. Anatomia. scaricato da 1
 Melanoma 1 Anatomia 2 scaricato da www.sunhope.it 1 Epidemiologia ed Eziologia In Europa circa 60.000 nuovi casi all anno L'incidenzaé Lincidenza leggermentepiù alta tra la popolazione femminile rispetto
Melanoma 1 Anatomia 2 scaricato da www.sunhope.it 1 Epidemiologia ed Eziologia In Europa circa 60.000 nuovi casi all anno L'incidenzaé Lincidenza leggermentepiù alta tra la popolazione femminile rispetto
GHIANDOLE SALIVARI: QUADRI PATOLOGICI
 GHIANDOLE SALIVARI: QUADRI PATOLOGICI SCIALOADENITE-PAROTITE Le infiammazioni acute delle ghiandole salivari (viralibatteriche) presentano, di solito, segni ecografici aspecifici ( aumento volumetrico
GHIANDOLE SALIVARI: QUADRI PATOLOGICI SCIALOADENITE-PAROTITE Le infiammazioni acute delle ghiandole salivari (viralibatteriche) presentano, di solito, segni ecografici aspecifici ( aumento volumetrico
PATOLOGIE DELLA PELLE:
 AIMAV Associazione Italiana di Medicina dell Assicurazione Vita, Malattia e Danni alla Persona Milano 4 ottobre 2016 GIORNATA DI FORMAZIONE SULL ASSUNZIONE DEL RISCHIO E LA GESTIONE DEI SINISTRI PATOLOGIE
AIMAV Associazione Italiana di Medicina dell Assicurazione Vita, Malattia e Danni alla Persona Milano 4 ottobre 2016 GIORNATA DI FORMAZIONE SULL ASSUNZIONE DEL RISCHIO E LA GESTIONE DEI SINISTRI PATOLOGIE
I carcinomi cutanei sono i tumori maligni più frequenti con milioni di pazienti ogni anno.
 I carcinomi cutanei sono i tumori maligni più frequenti con milioni di pazienti ogni anno. 2.000.000 di nuovi casi ogni anno. 238% negli ultimi 14 anni. 2-3% ogni anno. L incidenza cresce annualmente ma
I carcinomi cutanei sono i tumori maligni più frequenti con milioni di pazienti ogni anno. 2.000.000 di nuovi casi ogni anno. 238% negli ultimi 14 anni. 2-3% ogni anno. L incidenza cresce annualmente ma
clicca qui Caso n. 3 Reperto citologico:
 CORSO PRATICO DI CITOLOGIA DIAGNOSTICA AGOASPIRATIVA DELLE GHIANDOLE SALIVARI Gargnano 15-16 aprile 2011 Sergio Fiaccavento Caso n. 3 Notizie cliniche : Uomo di 34 anni presenta in regione sottomandibolare
CORSO PRATICO DI CITOLOGIA DIAGNOSTICA AGOASPIRATIVA DELLE GHIANDOLE SALIVARI Gargnano 15-16 aprile 2011 Sergio Fiaccavento Caso n. 3 Notizie cliniche : Uomo di 34 anni presenta in regione sottomandibolare
Il cavallo fu riferito alla clinica con una diagnosi di sinusite caratterizzata da scolo nasale sieroso monolaterale dalla narice sinistra.
 Segnalamento Saltatore castrone di 14 anni Anamnesi Il cavallo fu riferito alla clinica con una diagnosi di sinusite caratterizzata da scolo nasale sieroso monolaterale dalla narice sinistra. Il proprietario
Segnalamento Saltatore castrone di 14 anni Anamnesi Il cavallo fu riferito alla clinica con una diagnosi di sinusite caratterizzata da scolo nasale sieroso monolaterale dalla narice sinistra. Il proprietario
Sostanza fondamentale amorfa
 TESSUTO CONNETTIVO PROPRIAMENTE DETTO COSTITUZIONE SOSTANZA FONDAMENTALE COMPONENTE AMORFA : Acqua Sali Proteoglicani Glicoproteine Fibre collagene COMPONENTE FIBRILLARE: Fibre reticolari Fibre elastiche
TESSUTO CONNETTIVO PROPRIAMENTE DETTO COSTITUZIONE SOSTANZA FONDAMENTALE COMPONENTE AMORFA : Acqua Sali Proteoglicani Glicoproteine Fibre collagene COMPONENTE FIBRILLARE: Fibre reticolari Fibre elastiche
Il Patologo parla al Clinico... Varianti e Tipi del Linfoma Follicolare
 Il Patologo parla al Clinico... Varianti e Tipi del Linfoma Follicolare Dott.ssa Silvia Ardoino Dott.ssa Sara Bruno ASL2 Ospedale di Savona Anatomia Patologica LINFOMA FOLLICOLARE Classificazione WHO:
Il Patologo parla al Clinico... Varianti e Tipi del Linfoma Follicolare Dott.ssa Silvia Ardoino Dott.ssa Sara Bruno ASL2 Ospedale di Savona Anatomia Patologica LINFOMA FOLLICOLARE Classificazione WHO:
Anatomia e Fisiologia della cute e degli annessi cutanei
 Anatomia e Fisiologia della cute e degli annessi cutanei Andrea Stefano Bigardi Specialista in Dermatologia Università di Milano Cute E l organo più esteso del corpo umano (1,5-2 mq), formato da: Epidermide:
Anatomia e Fisiologia della cute e degli annessi cutanei Andrea Stefano Bigardi Specialista in Dermatologia Università di Milano Cute E l organo più esteso del corpo umano (1,5-2 mq), formato da: Epidermide:
Osservazione di un campione citologico
 Osservazione di un campione citologico Campione citologico significativo Valutazione della cellularità, della conservazione delle cellule, qualità della colorazione ecc Valutazione del fondo Riconoscimento
Osservazione di un campione citologico Campione citologico significativo Valutazione della cellularità, della conservazione delle cellule, qualità della colorazione ecc Valutazione del fondo Riconoscimento
Ostruzioni all efflusso ventricolare *** Malformazioni delle valve AV **
 MALATTIE CARDIOVASCOLARI CONGENITE Prof. Carlo Guglielmini CLASSIFICAZIONE E PREVALENZA DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI CONGENITE Cardiopatie con shunt sx dx ***** Ostruzioni all efflusso ventricolare ***
MALATTIE CARDIOVASCOLARI CONGENITE Prof. Carlo Guglielmini CLASSIFICAZIONE E PREVALENZA DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI CONGENITE Cardiopatie con shunt sx dx ***** Ostruzioni all efflusso ventricolare ***
APPARATO TEGUMENTARIO. Prof.ssa S. Di Giulio
 Prof.ssa S. Di Giulio L apparato tegumentario è l organo più esteso del nostro corpo ed è costituito da: 1. PELLE o CUTE 2. ANNESSI CUTANEI: ghiandole sudoripare, ghiandole sebacee, peli, capelli, unghie
Prof.ssa S. Di Giulio L apparato tegumentario è l organo più esteso del nostro corpo ed è costituito da: 1. PELLE o CUTE 2. ANNESSI CUTANEI: ghiandole sudoripare, ghiandole sebacee, peli, capelli, unghie
Infiammazione cronica
 Infiammazione cronica Cronicizzazione di un processo infiammatorio conseguente alla persistenza dello stimolo lesivo. Può verificarsi nei seguenti casi: Infezione persistente da microrganismi difficilmente
Infiammazione cronica Cronicizzazione di un processo infiammatorio conseguente alla persistenza dello stimolo lesivo. Può verificarsi nei seguenti casi: Infezione persistente da microrganismi difficilmente
Ricordate di iscrivervi alla Sezione SIRM di Radiologia Addominale Gastroenterologica
 Ricordate di iscrivervi alla Sezione SIRM di Radiologia Addominale Gastroenterologica http://www.sirm.org/homepage/sezioni-studio/addominale http://www.sirmgastrointestinal.weebly.com/ ROBERTO DI MIZIO
Ricordate di iscrivervi alla Sezione SIRM di Radiologia Addominale Gastroenterologica http://www.sirm.org/homepage/sezioni-studio/addominale http://www.sirmgastrointestinal.weebly.com/ ROBERTO DI MIZIO
A livello nazionale si è valutato in anni più recenti un incremento dei tassi di mortalità per carcinoma prostatico solamente in pazienti al di sopra
 1. INTRODUZIONE La maggior parte dei registri tumori fa rilevare un aumentata incidenza del carcinoma prostatico, che attualmente rappresenta il secondo tumore più frequente nel sesso maschile in molti
1. INTRODUZIONE La maggior parte dei registri tumori fa rilevare un aumentata incidenza del carcinoma prostatico, che attualmente rappresenta il secondo tumore più frequente nel sesso maschile in molti
Esercizi Lesioni multiple del Colon retto
 Esercizi Lesioni multiple del Colon retto CASO A) Anatomia patologica data esame: 26/05/2009 Prestazione: Digerente Retto Biopsia Endoscopica (Sede Unica) Materiale: Retto. Diagnosi: Adenocarcinoma Infiltrante.
Esercizi Lesioni multiple del Colon retto CASO A) Anatomia patologica data esame: 26/05/2009 Prestazione: Digerente Retto Biopsia Endoscopica (Sede Unica) Materiale: Retto. Diagnosi: Adenocarcinoma Infiltrante.
Sindromi da malassorbimento
 Sindromi da malassorbimento Definizione Patologia causata da diversi fattori che riducono l assorbimento di grassi, carboidrati, proteine, lipidi Malassorbimenti primitivi : - difetto di assorbimento dovuto
Sindromi da malassorbimento Definizione Patologia causata da diversi fattori che riducono l assorbimento di grassi, carboidrati, proteine, lipidi Malassorbimenti primitivi : - difetto di assorbimento dovuto
FORMAZIONE CONTINUA IN DERMATOLOGIA
 FORMAZIONE CONTINUA IN DERMATOLOGIA Modulo 1: L ARTE E IL METODO Modulo 2: PROBLEMI E SOLUZIONI IN DERMATOLOGIA DEL CANE (Come affrontare e risolvere i problemi utilizzando il POA e l EBM) Modulo 3: PROBLEMI
FORMAZIONE CONTINUA IN DERMATOLOGIA Modulo 1: L ARTE E IL METODO Modulo 2: PROBLEMI E SOLUZIONI IN DERMATOLOGIA DEL CANE (Come affrontare e risolvere i problemi utilizzando il POA e l EBM) Modulo 3: PROBLEMI
MELANOMA. Il melanoma piano mostra in genere
 MELANOMA Neoplasia maligna dei melanociti che, nella cute, inizia come una lesione pigmentata piana (macula) progredendo quindi in placca o nodulo irregolarmente rilevato Il melanoma piano mostra in genere
MELANOMA Neoplasia maligna dei melanociti che, nella cute, inizia come una lesione pigmentata piana (macula) progredendo quindi in placca o nodulo irregolarmente rilevato Il melanoma piano mostra in genere
Morfologia ed immunofenotipo del. Inserire titolo. carcinoma colorettale eredofamiliare. Inserire Autori
 Morfologia ed immunofenotipo del Inserire titolo carcinoma colorettale eredofamiliare Inserire Autori Dott.ssa Rossella Fante SC Anatomia Patologia ASST Mantova WHO CARCINOMA COLORETTALE EREDOFAMILIARE
Morfologia ed immunofenotipo del Inserire titolo carcinoma colorettale eredofamiliare Inserire Autori Dott.ssa Rossella Fante SC Anatomia Patologia ASST Mantova WHO CARCINOMA COLORETTALE EREDOFAMILIARE
ANORMALITA' DELLE CELLULE EPITELIALI
 ANORMALITA' DELLE CELLULE EPITELIALI Cellule Squamose Cellule squamose atipiche di incerto significato (ASC-US) Cellule squamose atipiche non si può escludere luna lesione di alto grado HSIL (ASC- H) Lesioni
ANORMALITA' DELLE CELLULE EPITELIALI Cellule Squamose Cellule squamose atipiche di incerto significato (ASC-US) Cellule squamose atipiche non si può escludere luna lesione di alto grado HSIL (ASC- H) Lesioni
Requisiti minimi e standard di refertazione per carcinoma della mammella
 SIAPEC PIEMONTE RETE ONCOLOGICA 2009 Concordanza e uniformità di refertazione diagnostica nelle anatomie patologiche della Regione Piemonte Requisiti minimi e standard di refertazione per carcinoma della
SIAPEC PIEMONTE RETE ONCOLOGICA 2009 Concordanza e uniformità di refertazione diagnostica nelle anatomie patologiche della Regione Piemonte Requisiti minimi e standard di refertazione per carcinoma della
PARETE TORACICA. Massimo Vignoli
 PARETE TORACICA Massimo Vignoli maxvignoli@alice.it Differenze tra anatomia radiologica e convenzionale: Proiezione su un piano (sommazione) di organi tridimensionali Contenuto degli organi Forza di gravità
PARETE TORACICA Massimo Vignoli maxvignoli@alice.it Differenze tra anatomia radiologica e convenzionale: Proiezione su un piano (sommazione) di organi tridimensionali Contenuto degli organi Forza di gravità
Clinici e anatomo-patologi a confronto. Il ruolo dei biomarcatori. B. Ghiringhello
 Clinici e anatomo-patologi a confronto Il ruolo dei biomarcatori B. Ghiringhello COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS (CAP) AMERICAN SOCIETY FOR COLPOSCOPY AND CERVICAL PATHOLOGY (ASCCP) SCOPO DEL LAVORO Ridurre
Clinici e anatomo-patologi a confronto Il ruolo dei biomarcatori B. Ghiringhello COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS (CAP) AMERICAN SOCIETY FOR COLPOSCOPY AND CERVICAL PATHOLOGY (ASCCP) SCOPO DEL LAVORO Ridurre
LA LEISHMANIOSI protozoo parassita Leishmania Leishmania infantum flebotomi pappataci insetti ematofagi ore serali
 LA LEISHMANIOSI La leishmaniosi è una malattia causata da un protozoo parassita chiamato Leishmania. Può colpire sia il cane sia l uomo; la principale specie di Leishmania che infetta il cane è Leishmania
LA LEISHMANIOSI La leishmaniosi è una malattia causata da un protozoo parassita chiamato Leishmania. Può colpire sia il cane sia l uomo; la principale specie di Leishmania che infetta il cane è Leishmania
Malattie cutanee allergiche nel gatto. Le allergie del gatto. DA : Come chiamarla???? 07/09/2016
 Malattie cutanee allergiche nel gatto Dr. Chiara Noli, Dip ECVD Servizi Dermatologici Veterinari Peveragno (CN) Le allergie del gatto Allergia alimentare (Allergia al morso delle pulci) Allergia agli insetti
Malattie cutanee allergiche nel gatto Dr. Chiara Noli, Dip ECVD Servizi Dermatologici Veterinari Peveragno (CN) Le allergie del gatto Allergia alimentare (Allergia al morso delle pulci) Allergia agli insetti
Il trattamento delle displasie laringee in microlaringoscopia diretta con l impiego del laser a CO 2
 Il trattamento delle displasie laringee in microlaringoscopia diretta con l impiego del laser a CO 2 Introduzione Sono stati studiati 141 pazienti con displasie delle corde vocali più o meno gravi. Abbiamo
Il trattamento delle displasie laringee in microlaringoscopia diretta con l impiego del laser a CO 2 Introduzione Sono stati studiati 141 pazienti con displasie delle corde vocali più o meno gravi. Abbiamo
MANIFESTAZIONI NEUROLOGICHE IN CORSO DI INFEZIONE DA HIV
 MANIFESTAZIONI NEUROLOGICHE IN CORSO DI INFEZIONE DA HIV L'HIV è stato isolato nel tessuto cerebrale e nel liquor, edèpresente nel SNC fin dai primi stadi dell'infezione virale generalizzata I disturbi
MANIFESTAZIONI NEUROLOGICHE IN CORSO DI INFEZIONE DA HIV L'HIV è stato isolato nel tessuto cerebrale e nel liquor, edèpresente nel SNC fin dai primi stadi dell'infezione virale generalizzata I disturbi
ISTOLOGIA E CITOLOGIA PATOLOGICA VETERINARIA
 CORSO DI ISTOLOGIA E CITOLOGIA PATOLOGICA VETERINARIA Insegnamento del Corso integrato di Anatomia Patologica Veterinaria Docente P. Maiolino E-mail: maiolino@unina.it -Dipartimento di Patologia e Sanità
CORSO DI ISTOLOGIA E CITOLOGIA PATOLOGICA VETERINARIA Insegnamento del Corso integrato di Anatomia Patologica Veterinaria Docente P. Maiolino E-mail: maiolino@unina.it -Dipartimento di Patologia e Sanità
26/11/2009. scaricato da
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MICOSI CUTANEO MUCOSE DERMATOFITI DIAGNOSI DI LABORATORIO Luce di Wood: utile solo in presenza di M. audouinii e M. canis Esame microscopico: prelievo del materiale (peli, squame),
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MICOSI CUTANEO MUCOSE DERMATOFITI DIAGNOSI DI LABORATORIO Luce di Wood: utile solo in presenza di M. audouinii e M. canis Esame microscopico: prelievo del materiale (peli, squame),
V = vascolari I = infiammatorie * T = traumi A = anomalie congenite ** M = malattie metaboliche I = idiopatiche N = neoplastiche D = degenerative
 MALATTIE DELL ENDOCARDIO Prof. Carlo Guglielmini Malattie dell endocardio V = vascolari I = infiammatorie * T = traumi A = anomalie congenite ** M = malattie metaboliche I = idiopatiche N = neoplastiche
MALATTIE DELL ENDOCARDIO Prof. Carlo Guglielmini Malattie dell endocardio V = vascolari I = infiammatorie * T = traumi A = anomalie congenite ** M = malattie metaboliche I = idiopatiche N = neoplastiche
Il mastocitoma è un tumore che si riscontra sia nel cane che nel gatto. Origina dai mastociti, cellule normalmente presenti nel sangue e nei tessuti.
 IL MASTOCITOMA Il mastocitoma è un tumore che si riscontra sia nel cane che nel gatto. Origina dai mastociti, cellule normalmente presenti nel sangue e nei tessuti. Per quanto riguarda il cane è il tumore
IL MASTOCITOMA Il mastocitoma è un tumore che si riscontra sia nel cane che nel gatto. Origina dai mastociti, cellule normalmente presenti nel sangue e nei tessuti. Per quanto riguarda il cane è il tumore
Malattie negli animali da laboratorio
 Corso di formazione in Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (ai sensi dell Allegato V del D.L n 26/2014) Dott. ALBERTO SBRANA Malattie negli animali da laboratorio Malattia Un animale
Corso di formazione in Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (ai sensi dell Allegato V del D.L n 26/2014) Dott. ALBERTO SBRANA Malattie negli animali da laboratorio Malattia Un animale
Malattie rare, polmone e fumo Sergio Harari U.O. di Pneumologia e Terapia Semi Intensiva Osp. San Giuseppe - MultiMedica, Milano
 Malattie rare, polmone e fumo Sergio Harari U.O. di Pneumologia e Terapia Semi Intensiva Osp. San Giuseppe - MultiMedica, Milano 29 maggio 2019, Milano Recent Advances BPCO Tumore del polmone Fumo Enfisema
Malattie rare, polmone e fumo Sergio Harari U.O. di Pneumologia e Terapia Semi Intensiva Osp. San Giuseppe - MultiMedica, Milano 29 maggio 2019, Milano Recent Advances BPCO Tumore del polmone Fumo Enfisema
Cellule infiammatorie
 Cellule infiammatorie Le principali cellule coinvolte nella risposta infiammatoria sono: - Granulociti - Macrofagi e cellule derivate - Linfociti e Plasmacellule Mastociti - Fibroblasti Le vie attraverso
Cellule infiammatorie Le principali cellule coinvolte nella risposta infiammatoria sono: - Granulociti - Macrofagi e cellule derivate - Linfociti e Plasmacellule Mastociti - Fibroblasti Le vie attraverso
of Ultrasound New Journal of Ultrasound e diagnostica per immagini. La rivista è curata dal Dott. Antonio De Fiores che tiene internistica.
 New Journal of Ultrasound FEBBRAIO 2015 VOLUME 1, NUMERO 1 Ref Italia S.r.l. New Journal of Ultrasound E una rivista medica specializzata in ecografia interventistica e diagnostica per immagini. La rivista
New Journal of Ultrasound FEBBRAIO 2015 VOLUME 1, NUMERO 1 Ref Italia S.r.l. New Journal of Ultrasound E una rivista medica specializzata in ecografia interventistica e diagnostica per immagini. La rivista
IL REGISTRO TUMORI ANIMALI REGIONE UMBRIA: LE PREVALENZE AL 2016
 IL REGISTRO TUMORI ANIMALI REGIONE UMBRIA: LE PREVALENZE AL 2016 La prevalenza La prevalenza per tumore indica il numero di persone o animali che in un passato recente o lontano hanno ricevuto diagnosi
IL REGISTRO TUMORI ANIMALI REGIONE UMBRIA: LE PREVALENZE AL 2016 La prevalenza La prevalenza per tumore indica il numero di persone o animali che in un passato recente o lontano hanno ricevuto diagnosi
Citologia dei versamenti Massimo Bongiovanni, MD
 Citologia dei versamenti Massimo Bongiovanni, MD Istituto cantonale di Patologia, Locarno Istituto cantonale di Patologia, Locarno Citologia dei versamenti Quattro cavità sierose: 1. Pleurica
Citologia dei versamenti Massimo Bongiovanni, MD Istituto cantonale di Patologia, Locarno Istituto cantonale di Patologia, Locarno Citologia dei versamenti Quattro cavità sierose: 1. Pleurica
IL CONCETTO DI ZOONOSI CLASSIFICAZIONE DELLE ZOONOSI. Zoonosi dirette. Ciclozoonosi. Metazoonosi. Saprozoonosi
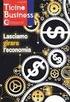 IL CONCETTO DI ZOONOSI Malattie ed infezioni che si trasmettono naturalmente dagli animali vertebrati all uomo e viceversa (O.M.S.) CLASSIFICAZIONE DELLE ZOONOSI Zoonosi dirette Trasmissione dall animale
IL CONCETTO DI ZOONOSI Malattie ed infezioni che si trasmettono naturalmente dagli animali vertebrati all uomo e viceversa (O.M.S.) CLASSIFICAZIONE DELLE ZOONOSI Zoonosi dirette Trasmissione dall animale
BIOSTIMOLAZIONE/ BIORIVITALIZZAZIO NE TISSUTALE. Dott.ssa Leticia Molinaro
 BIOSTIMOLAZIONE/ BIORIVITALIZZAZIO NE TISSUTALE Dott.ssa Leticia Molinaro BIOSTIMOLAZIONE MEDICINA ANTIAGING NO TREATING ILLNESS BUT SUPPORTING WELLNESS. INVECCHIAMENTO CUTANEO Intrinseco/cronologico Atrofia
BIOSTIMOLAZIONE/ BIORIVITALIZZAZIO NE TISSUTALE Dott.ssa Leticia Molinaro BIOSTIMOLAZIONE MEDICINA ANTIAGING NO TREATING ILLNESS BUT SUPPORTING WELLNESS. INVECCHIAMENTO CUTANEO Intrinseco/cronologico Atrofia
S.C. di Otorinolaringoiatria
 S.C. di Otorinolaringoiatria Direttore: F. Balzarini Otorinostudio.tortona@aslal.it Ospedale SS. Antonio e Margherita ASL AL Tortona LE MALATTIE DELLA TIROIDE (DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA) Focus sui percorsi
S.C. di Otorinolaringoiatria Direttore: F. Balzarini Otorinostudio.tortona@aslal.it Ospedale SS. Antonio e Margherita ASL AL Tortona LE MALATTIE DELLA TIROIDE (DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA) Focus sui percorsi
REGISTRO TUMORI ANIMALI UMBRIA LE PREVALENZE AL SECONDO ANNO DI ATTIVITA
 REGISTRO TUMORI ANIMALI UMBRIA LE PREVALENZE AL SECONDO ANNO DI ATTIVITA La prevalenza La prevalenza per tumore indica il numero di persone o animali che in un passato recente o lontano hanno ricevuto
REGISTRO TUMORI ANIMALI UMBRIA LE PREVALENZE AL SECONDO ANNO DI ATTIVITA La prevalenza La prevalenza per tumore indica il numero di persone o animali che in un passato recente o lontano hanno ricevuto
Raro caso di Tumore pseudo-papillare papillare del pancreas in età pediatrica
 Riunione del Gruppo Chirurgico Oncologico Pediatrico Italiano Raro caso di Tumore pseudo-papillare papillare del pancreas in età pediatrica V. Di Benedetto, M.G. Scuderi Cattedra di Chirurgia Pediatrica
Riunione del Gruppo Chirurgico Oncologico Pediatrico Italiano Raro caso di Tumore pseudo-papillare papillare del pancreas in età pediatrica V. Di Benedetto, M.G. Scuderi Cattedra di Chirurgia Pediatrica
Citopatologia delle neoformazioni cutanee. Prof. Paola Maiolino
 Citopatologia delle neoformazioni cutanee. Prof. Paola Maiolino E-mail:maiolino@unina.it Lesioni Neoplastiche - Citologicamente sono classificate in: Neoplasie epiteliali Neoplasie mesenchimali/a cellule
Citopatologia delle neoformazioni cutanee. Prof. Paola Maiolino E-mail:maiolino@unina.it Lesioni Neoplastiche - Citologicamente sono classificate in: Neoplasie epiteliali Neoplasie mesenchimali/a cellule
SEGNI CLINICI CHE PIU FREQUENTEMENTE INDUCONO A SOSPETTARE UNA NEOPLASIA
 SEGNI CLINICI CHE PIU FREQUENTEMENTE INDUCONO A SOSPETTARE UNA NEOPLASIA FEBBRE LINFOADENOPATIE MASSE ADDOMINALI O MEDIASTINICHE DOLORI OSSEI NODULI SOTTOCUTANEI PUNTO DI RIFERIMENTO PEDIATRA DI BASE QUANDO
SEGNI CLINICI CHE PIU FREQUENTEMENTE INDUCONO A SOSPETTARE UNA NEOPLASIA FEBBRE LINFOADENOPATIE MASSE ADDOMINALI O MEDIASTINICHE DOLORI OSSEI NODULI SOTTOCUTANEI PUNTO DI RIFERIMENTO PEDIATRA DI BASE QUANDO
Registro Tumori Animali della Sicilia Roberto Puleio Guido R. Loria
 Registro Tumori Animali della Sicilia 2003-2017 Roberto Puleio Guido R. Loria Registro Tumori Animale Strumento conoscitivo che può avere un ruolo primario nello studio dei fattori di rischio per l uomo
Registro Tumori Animali della Sicilia 2003-2017 Roberto Puleio Guido R. Loria Registro Tumori Animale Strumento conoscitivo che può avere un ruolo primario nello studio dei fattori di rischio per l uomo
Peripheral T-cell lymphomas (Cutaneous)
 Peripheral T-cell lymphomas (Cutaneous) Alma Mater Studiorum 1088 d.c. Generalised skin lesions epidermotropic CD8 PRIMITIVITA CUTANEA CRITERI MAGGIORI Stadiazione clinica, compresa biopsia osteo-midollare!
Peripheral T-cell lymphomas (Cutaneous) Alma Mater Studiorum 1088 d.c. Generalised skin lesions epidermotropic CD8 PRIMITIVITA CUTANEA CRITERI MAGGIORI Stadiazione clinica, compresa biopsia osteo-midollare!
V = vascolari I = infiammatorie ***** T = traumi ** denti A = anomalie congenite * M = malattie metaboliche ** I = idiopatiche N = neoplastiche *** D
 MALATTIE DELLA BOCCA E DEL CAVO ORALE Prof. Carlo Guglielmini MALATTIE DEL CAVO ORALE Comprendono le malattie (congenite e acquisite) di: labbra cavo orale lingua palato denti V = vascolari I = infiammatorie
MALATTIE DELLA BOCCA E DEL CAVO ORALE Prof. Carlo Guglielmini MALATTIE DEL CAVO ORALE Comprendono le malattie (congenite e acquisite) di: labbra cavo orale lingua palato denti V = vascolari I = infiammatorie
Linfoma di Hodgkin Carla Giordano
 Linfoma di Hodgkin Carla Giordano LINFOMA DI HODGKIN Descritto per la prima volta da Thomas Hodgkin circa 150 anni fa. Inizialmente considerato una malattia infiammatoria. Infatti, la massa neoplastica
Linfoma di Hodgkin Carla Giordano LINFOMA DI HODGKIN Descritto per la prima volta da Thomas Hodgkin circa 150 anni fa. Inizialmente considerato una malattia infiammatoria. Infatti, la massa neoplastica
La Fascite Necrotizzante. Ospedale di Chioggia AULSS3 Serenissima U.O.C. Chirurgia Generale S. Ramuscello
 Ospedale di Chioggia AULSS3 Serenissima U.O.C. Chirurgia Generale S. Ramuscello Il termine coniato originariamente da BL. Wilson nel 1952 su Am Surg NSTIs Necrotizing Soft Tissue Infections Definizione
Ospedale di Chioggia AULSS3 Serenissima U.O.C. Chirurgia Generale S. Ramuscello Il termine coniato originariamente da BL. Wilson nel 1952 su Am Surg NSTIs Necrotizing Soft Tissue Infections Definizione
LE MEMBRANE DEL CORPO. Rivestono le superfici Delimitano le cavità Formano lamine con funzione protettiva intorno ad organi
 LE MEMBRANE DEL CORPO Rivestono le superfici Delimitano le cavità Formano lamine con funzione protettiva intorno ad organi LE MEMBRANE DEL CORPO Membrane epiteliali: sono membrane di rivestimento Membrane
LE MEMBRANE DEL CORPO Rivestono le superfici Delimitano le cavità Formano lamine con funzione protettiva intorno ad organi LE MEMBRANE DEL CORPO Membrane epiteliali: sono membrane di rivestimento Membrane
NEFROPATIE INTERSTIZIALI
 NEFROPATIE INTERSTIZIALI Nefropatie in cui le alterazioni sono primitivamente e prevalentemente localizzate nell'interstizio renale, associate a compromissione tubulare di entità variabile. 1) Da infezione
NEFROPATIE INTERSTIZIALI Nefropatie in cui le alterazioni sono primitivamente e prevalentemente localizzate nell'interstizio renale, associate a compromissione tubulare di entità variabile. 1) Da infezione
ACNE Un delitto annunciato
 ACNE Un delitto annunciato ACNE L acne è una condizione caratterizzata dalla presenza di peculiari alterazioni cutanee quali punti bianchi, punti neri, papule, pustole e, più raramente noduli, prevalentemente
ACNE Un delitto annunciato ACNE L acne è una condizione caratterizzata dalla presenza di peculiari alterazioni cutanee quali punti bianchi, punti neri, papule, pustole e, più raramente noduli, prevalentemente
Abbronzatura sì, ma con giudizio.
 Abbronzatura sì, ma con giudizio. Parola d ordine: protezione La protezione è un aiuto per l abbronzatura, questo non significa che con la crema ci si possa esporre al sole per periodi di tempo molto lunghi;
Abbronzatura sì, ma con giudizio. Parola d ordine: protezione La protezione è un aiuto per l abbronzatura, questo non significa che con la crema ci si possa esporre al sole per periodi di tempo molto lunghi;
PRURITO. Malattia surrenalica (comune) Rogna sarcoptica (rara) FURETTO. Otite parassitaria. Dermatite allergica al morso CONIGLIO
 Quaderni di dermatologia, Anno 13, n. 1, Giugno 2008 7 PRURITO MARTA AVANZI Med Vet, Castelfranco Veneto (TV) Nei piccoli mammiferi, il prurito si può manifestare con grattamento, mordicchiamento, leccamento,
Quaderni di dermatologia, Anno 13, n. 1, Giugno 2008 7 PRURITO MARTA AVANZI Med Vet, Castelfranco Veneto (TV) Nei piccoli mammiferi, il prurito si può manifestare con grattamento, mordicchiamento, leccamento,
Corso di Laurea in Igiene e Sicurezza degli alimenti di Origine Animale Anno Accademico
 Corso di Laurea in Igiene e Sicurezza degli alimenti di Origine Animale Anno Accademico 07-08 Programma dell insegnamento di Istopatologia dell esame integrato di Anatomia, Endocrinologia ed istopatologia
Corso di Laurea in Igiene e Sicurezza degli alimenti di Origine Animale Anno Accademico 07-08 Programma dell insegnamento di Istopatologia dell esame integrato di Anatomia, Endocrinologia ed istopatologia
LA TECNICA DEL PRGF: IL PLASMA RICCO DI FATTORI di CRESCITA (Plasma Riched of Growth Factors)
 LA TECNICA DEL PRGF: IL PLASMA RICCO DI FATTORI di CRESCITA (Plasma Riched of Growth Factors) PERCHE QUESTA TERAPIA? Il corpo umano è fatto in modo di autodifendersi dai danni che possono colpirlo, e soprattutto
LA TECNICA DEL PRGF: IL PLASMA RICCO DI FATTORI di CRESCITA (Plasma Riched of Growth Factors) PERCHE QUESTA TERAPIA? Il corpo umano è fatto in modo di autodifendersi dai danni che possono colpirlo, e soprattutto
ONCOLOGIA. La malattia neoplastica è una patologia MULTIFATTORIALE (cancerogenesi)
 ONCOLOGIA La malattia neoplastica è una patologia MULTIFATTORIALE (cancerogenesi) La neoplasia o tumore è determinata da una proliferazione incontrollata di cellule trasformate Il tumore è una patologia
ONCOLOGIA La malattia neoplastica è una patologia MULTIFATTORIALE (cancerogenesi) La neoplasia o tumore è determinata da una proliferazione incontrollata di cellule trasformate Il tumore è una patologia
IFCCP 2011 NOMENCLATURE MISCELLANEA
 IFCCP 2011 NOMENCLATURE Gian Piero Fantin Zona di trasformazione congenita Condiloma Polipo (eso/endocervicale) Infiammazione Stenosi Anomalia congenita Esiti di trattamento Endometriosi Zona di trasformazione
IFCCP 2011 NOMENCLATURE Gian Piero Fantin Zona di trasformazione congenita Condiloma Polipo (eso/endocervicale) Infiammazione Stenosi Anomalia congenita Esiti di trattamento Endometriosi Zona di trasformazione
Definizione diagnostica
 Definizione diagnostica Guido Mazzoleni Direttore Anatomia Patologica, Registro Tumori e COR Provincia autonoma di Bolzano In collaborazione con: Dottoressa Maria Basciu Anatomia Patologica Bolzano Aspetti
Definizione diagnostica Guido Mazzoleni Direttore Anatomia Patologica, Registro Tumori e COR Provincia autonoma di Bolzano In collaborazione con: Dottoressa Maria Basciu Anatomia Patologica Bolzano Aspetti
Ghiandole salivari maggiori (parotide, sottomandibolare e sottolinguale)
 7 Ghiandole salivari maggiori (parotide, sottomandibolare e sottolinguale) C07.9 Ghiandola parotide C08.0 Ghiandola sottomandibolare C08.1 Ghiandola sottolinguale C08.8 Lesione sovrapposta delle ghiandole
7 Ghiandole salivari maggiori (parotide, sottomandibolare e sottolinguale) C07.9 Ghiandola parotide C08.0 Ghiandola sottomandibolare C08.1 Ghiandola sottolinguale C08.8 Lesione sovrapposta delle ghiandole
