I sistemi d area. Dipartimento di Elettronica Informatica e Sistemistica. Marina Barbiroli Propagazione M
|
|
|
- Giustina Alberti
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 I sistemi d area
2 I sistemi d area I sistemi che si prefiggono di realizzare collegamenti tra corrispondenti di cui uno almeno all interno di un area, detta area di servizio, si dicono sistemi d area. Possono essere monodirezionali (o diffusivi) o bidirezionali (simmetrici o asimmetrici). I sistemi d'area possono fornire all'utente servizi in mobilità, poiché possono consentirgli di muoversi nell'area di servizio e di posizionarsi per comunicare in un punto qualunque di essa. I tipi di mobilità possono essere così classificate: mobilità di accesso: consente all utente di posizionarsi dovunque nell area di servizio senza bisogno di un filo di connessione. E la più classica delle applicazioni wireless e può essere fornita in aree limitate cordless casalingo o assai vaste broadcasting satellitare con il solo impiego delle tecnologie radio ovvero sostituendo alla borchia di comunicazione una porta di accesso radio. mobilità personale: può essere assicurata semplicemente con tecnologie di rete. Essa si verifica quando la rete è in grado di dare alla persona le prestazioni che richiede indipendentemente dal punto fisico della rete cui è connesso. mobilità del terminale: la comunicazione può essere mantenuta anche quando il terminale è in movimento. In forma limitata per estensione e per velocità di movimento essa è quasi sempre presente nei sistemi wireless.
3 Sia per i sistemi diffusivi che per i sistemi radiomobili motivi strettamente legati alle leggi di propagazione impediscono che tutta l area di servizio possa essere coperta attraverso un unica stazione. Esiste un attenuazione in funzione della distanza che è sempre presente il segnale finisce per scendere al di sotto della soglia di sensibilità che consente di distinguerlo dal rumore (rapporto S/N). L attenuazione presente sul territorio agisce dunque come un filtro spaziale, in grado di discriminare il segnale utile dai segnali interferenti purché essi provengano da una sufficiente distanza. In pratica un ricevitore che si trovi in una posizione dove è prevalente il segnale di una data stazione percepisce spesso quello delle stazioni più distanti operanti sulla stessa frequenza come una interferenza dannosa, che però non inficia la qualità del collegamento se il suo livello si mantiene al di sotto di quello del segnale utile di un prefissato margine analogamente a quanto si era già indicato per il rumore. Ulteriore elemento da tenere sotto controllo, il cosiddetto C/I: il rapporto tra segnale utile ed interferenza.
4 Se l'informazione è la stessa per tutte le stazioni (diffusione circolare) le scelte di modulazione e le imperfezioni realizzative (come le instabilità degli oscillatori di trasmissione), non rendono possibile per i sistemi più tradizionali, come la versione standard della televisione analogica, che due stazioni che servono porzioni di territorio contigue utilizzino la stessa banda di frequenza. Il segnale più debole viene infatti percepito come una interferenza a causa della sua diversità comunque presente. Possibile per reti isofrequenziali, e per la versione digitale terrestre della televisione. Come il C/N anche il C/I limite varia a seconda delle caratteristiche dei segnali utilizzati e deve essere fornito al pianificatore del radiosistema come vincolo da rispettare. Le scelte sistemistiche possono dunque portare a pianificazioni diverse e di diversa efficienza nell uso della banda sul territorio. Il territorio deve dunque essere diviso in tante porzioni per ciascuna delle quali si deve prevedere una stazione dedicata che funge da tramite per la distribuzione del segnale in quella porzione del territorio. Due stazioni che servono porzioni di territorio contigue non possono utilizzare la stessa banda di frequenza. Un ricevitore che si trovi in una posizione dove è prevalente il segnale di una data stazione percepisce quello delle stazioni più vicine operanti sulla stessa frequenza come interferenza. Il livello dell interferenza deve mantenersi al di sotto del livello del segnale utile di un prefissato margine se si vuole mantenere la qualità del collegamento.
5 Valutazione della distanza tra stazioni Rapporto di protezione R p Rumore D u distanza utile (Area di servizio) D u D D u Area di perturbazione (Emettitori su altre frequenze) Deve essere realizzato uno schema a interferenza controllata (rigido o dinamicamente adattabile)
6 Suddivisione del territorio in celle L'area di servizio viene divisa in tante porzioni (celle elementari), ciascuna servita da una porta radio. Se l attenuazione è uniforme e esiste solo il termine dominante, ciascuna cella è rappresentabile come un cerchio se l antenna in emissione è isotropa. Le risorse spettrali a disposizione sono distribuite in modo che l interferenza portata sul territorio di ogni cella dalle emissioni originate in quelle che operano sulla stessa frequenza sia sotto al rapporto di protezione. riduzione delle risorse radio attribuibili ad una cella rispetto alla situazione ideale nella quale la cella opera isolata. F: fattore di riduzione tra situazione reale e quella ideale di assenza di interferenza. In assenza di questa situazione ideale, anche in presenza di una rilevante attenuazione con la distanza, si verifica quasi sempre questa riduzione di efficienza.
7 Sistemi d area a canali limitati Se i canali sono virtualmente illimitati di tratta semplicemente di distribuirli in numero sufficiente in ciascuna cella per far fronte alle necessità. Es. per un sistema radiomobile occorre servire il traffico medio offerto nella cella (Erlang per utente x il numero medio di utenti) con una determinata qualità (probabilità di blocking) Se i canali sono limitati allora occorre suddivi-derli fra le celle e riusarli nello spazio per ottenere suff. C/I: si ha allora il cluster Sottoinsiemi D R 6 canali Es: 2 canali, 3 per cella, 7 sottinsiemi cluster size m=7 Celle iso-canale
8 Suddivisione cellulare del territorio Per non ottenere sovrapposizioni ci si serve di una rappresentazione con suddivisione ideale del territorio in celle derivate da una geometria poligonale regolare (nessuna legge propagativa) Tassellazione (tessellation): disposizione di piastrelle eguali sul pavimento. E' possibile realizzare la tassellazione con diverse figure poligonali. Tutte quelle che hanno come elemento base costitutivo il triangolo equilatero sono ben utilizzabili. Cluster con tre frequenze: f, f2, f3. F=/m Mappa territorio
9 Suddivisione cellulare del territorio Le risorse spettrali a disposizione sono distribuite in modo che l interferenza portata sul territorio di ogni cella dalle emissioni originate in quelle che operano sulla stessa frequenza sia al di sotto del rapporto di protezione. Riduzione delle risorse radio rispetto al caso ideale di cella isolata (di un fattore F=/m, m= cluster size). La capacità di un sistema dipende dalle strategie di copertura cellulare Cluster con sette frequenze: f, f 2, f 3, f 4, f 5, f 6, f
10 Sistema di coordinate per la geometria esagonale P(u*, v*) = (2, 3) v u* = u + ki v* = v + lj I centri delle celle hanno coordinate espresse attraverso una coppia di numeri interi. i e j: parametri di shift u e v: coordinate del centro del sistema di riferimento, ad esempio (0,0). 2,3 P -,0 0, 0,0,0 u u: asse orizzontale che passa per tutti i centri di cella che stanno sulla stessa retta di quella scelta come origine; v: asse obliquo, che congiunge i centri di cella che sono sulla retta a 60 gradi rispetto alla precedente.
11 Reticoli simmetrici Per ottenere reti simmetriche è possibile operare nel seguente modo: a. Shift Parameters (i, j) 0 (caratteristici della struttura); b. A partire dal centro di una cella ci si sposti di i unità u in direzione perpendicolare ad ogni lato;( u=r 3, R= Raggio cfr circoscritta); c. Dal punto così raggiunto, ci si muova di j unità nella direzione a 60 gradi in senso antiorario rispetto alla direzione precedente; d. Si prenda il punto ottenuto come centro di un interferente cocanale alla cella di partenza; Gli interferenti più vicini ad ogni cella sono sempre 6 e sono disposti su di una circonferenza di raggio D (Distanza di Riuso)
12 Relazioni Geometriche Le grandezze che descrivono la suddivisione cellulare del territorio (D, R, m) sono evidentemente legate da relazioni di reciproca dipendenza: Dal teorema di Carnot è immediato ricavare: 2 2 D = i + ij + j (in unita' R Poiché A CLUSTER =A PARALLELOGRAMMA 2 3) } sin 60 r r 3 3 A U " U D R CLUSTER m = = = = i + ij + j ACELLA A CELLA 3R 3 U r U r U = U 2 = D D 2 R = i 2 + ij + j 3 = 3m
13 Cluster size Il numero m di celle che costituiscono il cluster è quindi dato da: m = i 2 + ij + j 2 Che, come dimostrato, rappresenta anche il quadrato della distanza tra centro di una cella e centro di una interferente del primo anello espressa, nell unità di misura già definita. Non tutti i valori di m interi sono utili per ottenere geometrie simmetriche. I primi valori ottenibili per m sono: m =, 3, 4, 7, 9, 2,...
14 Suddivisione cellulare del territorio CLUSTER 3 Mappa territorio
15 Suddivisione cellulare del territorio CLUSTER 4 Mappa territorio
16 Suddivisione cellulare del territorio CLUSTER 7 6 7
17 Suddivisione cellulare del territorio CLUSTER 9
18 m in funzione del C/I - up-link (/2) Ipotesi di lavoro: Mobile utile a bordo cella (distanza utile = R); Considerati solo mobili interferenti della prima cerchia, supposti al centro delle rispettive celle (distanza interferente = D); Stessa potenza (P MS ) trasmessa da ogni mobile; Territorio ad attenuazione uniforme di tipo Hata-like: L( r) ( ) " r # = L r0 $% & r0 ' ( MS fref D C PMS " r0 # = PU = $ L( r0 ) % R & I 6P MS " r0 # = P = $ % 0 D & ' ( I ' ( L( r )
19 m in funzione del C/I - up-link (2/2) C I = 6 ' (% & D R $ " # C I2 C I = " 6 D = R ( 3m) 2 3m I I6 I5 I4 I3 Es: SIR th =0, α=3 ( ) 2 6 m = SIRth = 5. " m = 7 3
20 m in funzione del C/I - down-link (/2) Ipotesi di lavoro: Mobile utile a bordo cella (distanza utile = R); Considerate solo BS interferenti della prima cerchia; Stessa potenza (P BS ) trasmessa da ogni BS; Territorio ad attenuazione uniforme di tipo Hata-like: D D-R D-R C PBS " r0 # = PU = $ L( r0 ) % R & ' ( D+R D+R fref D I 2PBS $ r " 0 # = PI = $ + + L( r0 ) % ( D ' R) D ( D + R) & ( )
21 " " # $ % % & ' ( " # $ % & ' + ) ) * +,, -. " # $ % & ' ( + " # $ % & ' + / " # $ % & ' " " # $ % % & ' ( " # $ % & ' / " # $ % & ' / = R D R D R D R D R D R D 2 I C 2 2 3m R D = I I3 I4 I5 I6 C I2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) " + " + + # " # # = 3m 3m 3m 3m 3m 3m 2 I C 2 2 m in funzione del C/I - down-link (2/2) è praticamente uguale alla formula per l up-link se si possono trascurare gli uni, cioè m è grande
22 Il valore medio del C/I e la sua deviazione standard devono essere valutati dal progettista Tramite simulazioni devono essere considerati i seguenti parametri di sistema: dimensione del cluster coefficiente di propagazione α deviazione standard σ delle variabili Log-normali correlazione esistente tra segnali utili e segnali interferenti posizione del mobile utile all interno della cella numero di segnali interferenti considerati controllo di potenza (se previsto dal sistema) distribuzione del traffico offerto caratteristiche di copertura delle celle (dimensione delle celle, caratteristiche radioelettriche delle antenne, puntamento e posizione dell antenna, ecc)
23 Il C/I è funzione del cluster size m e del filtraggio spaziale α
24 Filtraggio spaziale α E' ipotizzabile aumentare artificialmente, attraverso la progettazione di antenne direttive, il filtraggio spaziale, ottenendo così una più marcata selettività. Una prima misura che si può adottare consiste nel sistemare al posto di una antenna omnidirezionale tre antenne settoriali che coprano ciascuna 20. La copertura totale è dunque ottenuta con l insieme delle tre antenne opportunamente orientate. Se in relazione alla posizione del mobile si attiva l antenna settoriale utile, nulla cambia per il segnale utile, mentre soltanto un terzo dei segnali interferenti possono essere captati. Si ha dunque, con riferimento allo schema già adottato, un vantaggio sul C/I pari a tre. Se le stazioni radiobase sono posizionate su uno dei vertici degli esagoni la maggior distanza che deve essere percorsa dal segnale utile è compensata dal guadagno aggiuntivo delle antenne. Ulteriore vantaggio per il costo e la difficoltà di reperimento dei siti.
25 la dipendenza del C/I dal cluster è condizionata dall attenuazione presente nel territorio: più l'attenuazione aumenta con la distanza e più facilmente (cioè con m minori) si ottiene il valore di C/I che deve essere garantito. Il minimo C/I è un vincolo imposto dal sistema che si utilizza e dunque il compito del calcolatore della pianificazione cellulare è solo quello di garantirlo. Per migliorare il C/I si può adottare la tattica di attivare solo una frazione p dei canali disponibili in ogni cella; si ha allora: C/I = (3m) α/2 /p 6 Questo accorgimento, detto fractional loading può contribuire a ridurre l'interferenza, ottenendo valori intermedi tra due cluster possibili. In questo caso F=mp, e il sistema deve essere dotato di un controllo di ingresso che assicuri, deterministicamente o statisticamente, che le celle abbiano solo carico percentuale p su ogni distribuzione di risorse al cluster.
26 Settorizzazione Anziché montare le stazioni a centro cella si usa spesso montarle in un angolo e dotare la stazione di tre antenne direttive: in questo modo si servono 3 celle con un solo sito (palo), al modesto prezzo di una minore uniformità di copertura. Si parla di settorizzazione. In questo modo inoltre le antenne direttive (lobo di circa 20 ) hanno un guadagno maggiore Inoltre, l interferenza da celle isocanale è ridotta di circa un terzo (es: collegamento mobile-base) Tipiche coperture sono con m=2, in cui le 2 celle del cluster sono servite da 4 siti. Si parla perciò di cluster 3x4.
27 Esempi di siti settorizzati trasportabile macro mimetizzato small
28 Cluster con celle settoriali La regola per ottenere i cluster più generali è dunque: m = p q= 3, 9,... dove p vale 3, per questa configurazione a trifoglio mentre risulta valida per q la: q = i 2 + ij + j 2
29 Miglioramento del C/I se si utilizzassero le stesse frequenze per le antenne del trifoglio. Il vantaggio del filtraggio, ovvero la riduzione del numero degli interferenti, si mantiene anche se si attribuiscono frequenze diverse ai settori del trifoglio. In tal caso si riduce anche il numero di canali per cella di un fattore tre e dunque si deve fare il confronto con un cluster size tre volte più grande. Un confronto significativo richiede dunque l'adozione di una procedura statistica di valutazione della distribuzione del C/I in funzione della distribuzione dei mobili. In questo modo lo schema che si ottiene da un dato m con il trifoglio finisce per fornire migliori prestazioni rispetto allo schema che adotta lo stesso m con antenne omnidirezionali, anche se di non grande entità. L ottimo sarebbe mantenere gli stessi canali per l'intera cella circolare e poi operare con antenne settoriali: questo schema si è detto che ha l'inconveniente di imporre di cambiare l'antenna in funzione della posizione angolare del mobile, individuabile solo con criteri di valutazione dei diversi segnali ricevuti. Nel passato questo schema non ha trovato applicazione, per le complicazioni tecniche che comportava, mentre più recentemente, sotto il nome di switched antenna system è stato introdotto come il primo schema con antenne intelligenti o smart antennas.
30 Metodi di Canalizzazione (o di accesso multiplo) (/3) All interno di ogni cluster vengono utilizzate tutte le risorse assegnate al servizio, opportunamente suddivise fra le celle. Tali risorse possono in generale essere descritte come un set [ψ (t), ψ 2 (t),, ψ Nc (t)] di funzioni ortonormali: +" * $ se i = j (auto-correlazione) i ( t), j ( t) = ) i ( t) % j ( t) dt = & 0 se i ' j (cross-correlazione) #" ( Ogni volta si attiva un canale di comunicazione, una (o più) fra le Nc funzioni ortonormali viene assegnata in maniera esclusiva alla comunicazione. Le forme d onda trasmesse dall i-mo trasmettitore sono quindi del tipo: s t = u t " t ( ) ( ) ( ) i i i dove l informazione viene trasmessa tramite i simboli u ij.(es. u ij = ±) presenti in u i (t)
31 Metodi di Canalizzazione (2/3) Poiché il canale radio è per sua natura condiviso, il ricevitore i-mo riceve tutti i segnali trasmessi; per recuperare l informazione desiderata (i simboli u ij ) esegue quindi la correlazione del segnale complessivo ricevuto con tutte le funzioni ortonormali assegnate al canale utile. r ( t) s k ( t) u ( t ) = k * i Filtro i-mo RX i * sincronizzazione
32 Metodi di Canalizzazione (3/3) Caso particolare di utile riferimento: n = (una funzione ortonormale assegnata ad ogni comunicazione) TX TX 2 ( ) = ( )" ( ) s t u t t ( ) = ( )" ( ) r( t) = s k ( t) s t u t t ( ) = ( )" ( ) s t u t t i i i Canale di Propagazione m k= * Filtro * 2 Filtro u u2 ( t) ( t) TX i TX m ( ) = ( )" ( ) s t u t t m m m * i * m Filtro Filtro ui um ( t) ( t)
33 Frequency Division Multiple Access (FDMA) P $ & 2 B ( i ' % " i ( t) = K ( sin $ -(# 0 + # i ) t%. = K ( sin + # 0 +, t )- / Nc 0 *. F T B per 0 t T Si hanno funzioni ortogonali in frequenza, ovvero di lunghezza temporale pari all intero periodo T e bande praticamente disgiunte; la separazione dei canali può essere quindi ottenuta mediante filtri passa-banda. Necessarie bande di guardia per limitare l interferenza da canale adiacente. Esempio: AMPS (Advanced Mobile Phone System) analogico (dismesso): N C =790 canali, ciascuno avente banda pari a 30 KHz.
34 Time Division Multiple Access (TDMA) F P ' ( t) = K sin( t) $ i # 0 T (i -) T N C " t " i T N C Si hanno funzioni ortogonali in tempo, ovvero non nulle su intervalli temporali disgiunti ed aventi banda pari a tutta la banda disponibile; la separazione dei canali può essere quindi ottenuta mediante porte temporali; Necessari tempi di guardia per limitare l interferenza da canale adiacente;
35 Esempio: GSM (Global System for Mobile Communication) P F GSM 900: T Ibrido TDMA-FDMA: 248 canali di 200 KHz ciascuno multiplati in frequenza, ognuno dei quali supporta 8 canali multiplati nel tempo (0.577 ms per slot temporale). 24 frequenze vengono usate per il collegamento mobile-base (uplink) e 24 per il collegamento base-mobile (down-link). In totale quindi 24*8=992 canali bidirezionali a disposizione degli Operatori.
36 Code Division Multiple Access (CDMA) $ i ( ) ( j t = b ) # D( t jt ) " j i C D(t) + ψ i (t) T C t ψ i (t) : codice o (parola di codice); es: b (j) = ±; T C : tempo di chip, con T C << T S + - T s t Ogni utente ha assegnato un codice, cioè una Ψ i Il codice può essere utilizzato per costruire il segnale s i (t) in 2 modi diversi:. CDMA-DS (Direct Sequence): il codice va a moltiplicare il segnale informativo (sequenza dei simboli c i ) secondo l opportuno operatore 2. CDMA-FH (Frequency Hopping): il codice determina i salti in frequenza della portante di modulazione;
37 Uso ottimo dello spettro: l efficienza spettrale L efficienza spettrale è un rapporto fra costi e benefici di un sistema radiomobile. Il costo è costituito dallo spettro radio che è una risorsa limitata. Non è necessariamente < Nel caso ideale con un numero N c limitato di canali si può fare la seguente formulazione Efficienza spettrale " = MB r B M numero utenti del sistema (subscribers) B r bitrate per utente B banda totale allocata al servizio Si può definire una banda equivalente per canale B 0 B N = N c numero totale di canali c Data una certa probabilità di blocco (blocking) con N c canali si possono servire (formula Erlang-B per code a lunghezza nulla) M 0 utenti. M 0 è il numero di utenti in un cluster.
38 Le efficienze spettrali parziali Si possono allora definire 3 efficienze spettrali parziali: Efficienza nel tempo = t M N Efficienza in frequenza = f 0 c B B Efficienza nello spazio M s = = M 0 r 0 N cluster È più alta quando il traffico offerto da ciascun utente è basso (gli utenti usano il servizio in una bassa % di tempo): si possono multiplare più utenti sugli stessi canali È la classica efficienza frequenziale e dipende dalla tecnica di mo-dem. Tecniche ad alta efficienza richiedono un alto SIR th. È la più importante per noi. Indica il grado di riuso spaziale dei canali. N cluster è il numero di cluster sull area di servizio.
39 Fattorizzazione della efficienza spettrale Si ricava immediatamente: M B M MB MB 0 r r r = t " f " s = " " = = Nc B0 M 0 NcB0 B Se n è il numero di canali per cella, in modo cioè che N c = n m, si ha allora M M N = " N = " 0 0 celle f cluster f Nc Nc m N celle. È il numero di celle totali del sistema Si vede che l efficienza spettrale dipende dal numero di celle. Se si desidera una figura di merito indipendente da questo parametro, e quindi più indicativo della bontà del progetto, si può utilizzare l efficienza spettrale per cella M 0 c = f $ " % # & $ N N m celle ' c (
40 Analisi dell efficienza spettrale per cella (/2) I primi due fattori dipendono dal modem e da problematiche di traffico. Per sistemi con molti canali il secondo tende ad una costante. Dato che M=M(C/I) come si è visto si ottiene perciò: c = f " k " m C I ( / ) A prima vista si potrebbe aumentare l efficienza aumentando η f, ma modulazioni efficienti in banda richiedono anche un C/I maggiore e quindi un m maggiore. Nel caso semplice dell up-link si ha: $ C % " c = " f & k & = 3& " 6 2 f & k & ' ( $ C % ) I * ' 6 ( 3 ) I * # 2 Cioè facendo il logaritmo da entrambe le parti e riorganizzando si ha: 2 C # C $ ' ' log c = log f + k % log = log f + k % & ' " I 5" ( I ) db
41 Analisi dell efficienza spettrale per cella (2/2) Cioè: # C $ ' ( ) I * db = 5 % log" & 5 % log" + f c k '' Quindi in un diagramma logaritmico C/I in funzione di log(η f ) è una retta di coefficiente angolare proporzionale ad α e intercetta decrescente con η c. Sullo stesso diagramma, assimilando l interferenza a rumore AWGN si potrebbe rappresentare la curva del teorema di Shannon e vedere come il sistema si comporta rispetto al caso ideale. C " # $ % I & db 0 α=3.5 η c =0. η c =0.25 η c =0.5 Shannon varie tecniche mo-dem -5-0 Sistema ottimo dato α 0. 0 f
D SISTEMI, COPERTURE, PIANIFICAZIONE
 D SISTEMI, COPERTURE, PIANIFICAZIONE Tecniche di trasmissione spread-spectrum Sistemi radiomobili cellulari Coperture cellulari in sistemi a canali limitati, geometria, cluster, settorizzazione Tecniche
D SISTEMI, COPERTURE, PIANIFICAZIONE Tecniche di trasmissione spread-spectrum Sistemi radiomobili cellulari Coperture cellulari in sistemi a canali limitati, geometria, cluster, settorizzazione Tecniche
Reti locali. Protocolli di accesso per reti locali
 Protocolli di accesso per reti locali Gruppo Reti TLC nome.cognome@polito.it http://www.telematica.polito.it/ PROTOCOLLI DI ACCESSO PER RETI LOCALI - 1 Caratteristiche reti locali Piccola estensione geografica
Protocolli di accesso per reti locali Gruppo Reti TLC nome.cognome@polito.it http://www.telematica.polito.it/ PROTOCOLLI DI ACCESSO PER RETI LOCALI - 1 Caratteristiche reti locali Piccola estensione geografica
D SISTEMI, COPERTURE, PIANIFICAZIONE
 D SISTEMI, COPERTURE, PIANIFICAZIONE Tecniche di trasmissione spread-spectrum Sistemi radiomobili cellulari Coperture cellulari in sistemi a canali limitati, geometria, cluster, settorizzazione Tecniche
D SISTEMI, COPERTURE, PIANIFICAZIONE Tecniche di trasmissione spread-spectrum Sistemi radiomobili cellulari Coperture cellulari in sistemi a canali limitati, geometria, cluster, settorizzazione Tecniche
2 - Canali e Multiplazione
 Università degli studi di Bergamo Università degli studi di Bergamo Dipartimento di Ingegneria dell Informazione e Metodi Matematici Reti di Calcolatori prof. F. Martignon 2 - Canali e Multiplazione 1
Università degli studi di Bergamo Università degli studi di Bergamo Dipartimento di Ingegneria dell Informazione e Metodi Matematici Reti di Calcolatori prof. F. Martignon 2 - Canali e Multiplazione 1
Modulazione PAM Multilivello, BPSK e QPSK
 Modulazione PAM Multilivello, BPSK e QPSK P. Lombardo DIET, Univ. di Roma La Sapienza Modulazioni PAM Multilivello, BPSK e QPSK - 1 Rappresentazione analitica del segnale Sia {b(n)} una qualsiasi sequenza
Modulazione PAM Multilivello, BPSK e QPSK P. Lombardo DIET, Univ. di Roma La Sapienza Modulazioni PAM Multilivello, BPSK e QPSK - 1 Rappresentazione analitica del segnale Sia {b(n)} una qualsiasi sequenza
Sistemi di Telecomunicazione
 Sistemi di Telecomunicazione Parte 11: Accesso Multiplo Universita Politecnica delle Marche A.A. 2013-2014 A.A. 2013-2014 Sistemi di Telecomunicazione 1/20 Tecniche di multiplazione o accesso multiplo?
Sistemi di Telecomunicazione Parte 11: Accesso Multiplo Universita Politecnica delle Marche A.A. 2013-2014 A.A. 2013-2014 Sistemi di Telecomunicazione 1/20 Tecniche di multiplazione o accesso multiplo?
E02 ESERCIZI SU MODI DI TRASFERIMENTO
 E02 ESERCIZI SU MODI DI TRASFERIMENTO Esercizio 1 Un file di lunghezza F byte è trasferito in una rete a pacchetto, utilizzando n rami in cascata. I nodi attraversati possono essere ritenuti praticamente
E02 ESERCIZI SU MODI DI TRASFERIMENTO Esercizio 1 Un file di lunghezza F byte è trasferito in una rete a pacchetto, utilizzando n rami in cascata. I nodi attraversati possono essere ritenuti praticamente
RETI DI CALCOLATORI - Reti locali
 Protocolli di accesso per reti locali Gruppo Reti TLC nome.cognome@polito.it http://www.telematica.polito.it/ RETI DI CALCOLATORI Reti locali - 1 Copyright Quest opera è protetta dalla licenza Creative
Protocolli di accesso per reti locali Gruppo Reti TLC nome.cognome@polito.it http://www.telematica.polito.it/ RETI DI CALCOLATORI Reti locali - 1 Copyright Quest opera è protetta dalla licenza Creative
Modulazioni di ampiezza
 Modulazioni di ampiezza 1) Si consideri un segnale z(t) modulato in ampiezza con soppressione di portante dal segnale di informazione x(t): z(t) = Ax(t)cos(2πf 0 t) Il canale di comunicazione aggiunge
Modulazioni di ampiezza 1) Si consideri un segnale z(t) modulato in ampiezza con soppressione di portante dal segnale di informazione x(t): z(t) = Ax(t)cos(2πf 0 t) Il canale di comunicazione aggiunge
La modulazione numerica
 La modulazione numerica Mauro Giaconi 26/05/2009 trasmissione numerica 1 Principi di modulazione numerica 26/05/2009 trasmissione numerica 2 Modulazione numerica La modulazione trasla l informazione di
La modulazione numerica Mauro Giaconi 26/05/2009 trasmissione numerica 1 Principi di modulazione numerica 26/05/2009 trasmissione numerica 2 Modulazione numerica La modulazione trasla l informazione di
Corso di Fondamenti di Telecomunicazioni
 Corso di Fondamenti di Telecomunicazioni 1 - INTRODUZIONE Prof. Giovanni Schembra 1 Argomenti della lezione Definizioni: Sorgente di informazione Sistema di comunicazione Segnali trasmissivi determinati
Corso di Fondamenti di Telecomunicazioni 1 - INTRODUZIONE Prof. Giovanni Schembra 1 Argomenti della lezione Definizioni: Sorgente di informazione Sistema di comunicazione Segnali trasmissivi determinati
Sistemi di Telecomunicazione
 Sistemi di Telecomunicazione Progetto di collegamenti radio troposferici tra punti fissi Universita Politecnica delle Marche A.A. 2014-2015 A.A. 2014-2015 Sistemi di Telecomunicazione 1/29 Evoluzione dei
Sistemi di Telecomunicazione Progetto di collegamenti radio troposferici tra punti fissi Universita Politecnica delle Marche A.A. 2014-2015 A.A. 2014-2015 Sistemi di Telecomunicazione 1/29 Evoluzione dei
Reti di Calcolatori a.a
 Analogico e digitale 2 Corso di laurea in Informatica Reti di Calcolatori a.a. 2007-2008 Prof. Roberto De Prisco Capitolo 3 Dati e segnali Per essere trasmessi i dati devono essere trasformati in segnali
Analogico e digitale 2 Corso di laurea in Informatica Reti di Calcolatori a.a. 2007-2008 Prof. Roberto De Prisco Capitolo 3 Dati e segnali Per essere trasmessi i dati devono essere trasformati in segnali
Problema ( ) = 0,!
 Domanda. Problema ( = sen! x ( è! Poiché la funzione seno è periodica di periodo π, il periodo di g x! = 4. Studio di f. La funzione è pari, quindi il grafico è simmetrico rispetto all asse y. È sufficiente
Domanda. Problema ( = sen! x ( è! Poiché la funzione seno è periodica di periodo π, il periodo di g x! = 4. Studio di f. La funzione è pari, quindi il grafico è simmetrico rispetto all asse y. È sufficiente
Antenne per Stazioni Radio Base: Antenne per UMTS
 Antenne per Stazioni Radio Base: Antenne per UMTS Docente: Filiberto Bilotti Sommario Antenne per stazioni radio base di sistemi UMTS concetto di dipolo a larga banda concetto di dipolo parassita per aumentare
Antenne per Stazioni Radio Base: Antenne per UMTS Docente: Filiberto Bilotti Sommario Antenne per stazioni radio base di sistemi UMTS concetto di dipolo a larga banda concetto di dipolo parassita per aumentare
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
 Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni METODO PER IL RENDERING DEI DIAGRAMMI DI IRRADIAZIONE VERTICALI BASATO SUI DATI PREVISTI DALLE SPECIFICHE DI FORMATO DEL CATASTO AGCOM 1. Premessa Per calcolare
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni METODO PER IL RENDERING DEI DIAGRAMMI DI IRRADIAZIONE VERTICALI BASATO SUI DATI PREVISTI DALLE SPECIFICHE DI FORMATO DEL CATASTO AGCOM 1. Premessa Per calcolare
Il tema proposto può essere risolto seguendo due ipotesi:
 Per la trattazione delle tecniche TDM, PM e Trasmissione dati si rimanda alle schede 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del libro Le Telecomunicazioni del Prof. F. Dell Aquila. Il tema proposto può essere
Per la trattazione delle tecniche TDM, PM e Trasmissione dati si rimanda alle schede 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del libro Le Telecomunicazioni del Prof. F. Dell Aquila. Il tema proposto può essere
Strumentazione per la misura a banda stretta del campo elettromagnetico. Laura Vallone
 Strumentazione per la misura a banda stretta del campo elettromagnetico Laura Vallone Strumentazione a banda stretta Un misuratore di campo EM a banda stretta si compone di varie parti: o Sistema di ricezione
Strumentazione per la misura a banda stretta del campo elettromagnetico Laura Vallone Strumentazione a banda stretta Un misuratore di campo EM a banda stretta si compone di varie parti: o Sistema di ricezione
Corso di Laurea a Distanza in Ingegneria Elettrica Corso di Comunicazioni Elettriche. Modulazione A.A Alberto Perotti
 Corso di Laurea a Distanza in Ingegneria Elettrica Corso di Comunicazioni Elettriche Modulazione A.A. 8-9 Alberto Perotti DELEN-DAUIN Modello di sistema di comunicazione Il modello di sistema di comunicazione
Corso di Laurea a Distanza in Ingegneria Elettrica Corso di Comunicazioni Elettriche Modulazione A.A. 8-9 Alberto Perotti DELEN-DAUIN Modello di sistema di comunicazione Il modello di sistema di comunicazione
Antenne e Telerilevamento. Esame
 ESAME DEL 21/05/2001 ESERCIZIO 1 (10 punti) Si progetti un antenna filare a monopolo con top loading per la frequenza di 2 MHz, in modo che presenti una resistenza di irradiazione di 1 Ω. La distribuzione
ESAME DEL 21/05/2001 ESERCIZIO 1 (10 punti) Si progetti un antenna filare a monopolo con top loading per la frequenza di 2 MHz, in modo che presenti una resistenza di irradiazione di 1 Ω. La distribuzione
PONTI RADIO. Generalità
 PONTI RADIO Generalità È un sistema di radiocomunicazione puntopunto che impiega frequenze nel campo delle microonde, in grado di convogliare informazioni telefoniche, televisive e dati ad alta velocità.
PONTI RADIO Generalità È un sistema di radiocomunicazione puntopunto che impiega frequenze nel campo delle microonde, in grado di convogliare informazioni telefoniche, televisive e dati ad alta velocità.
Informatica. Caratterizzazione del canale I simboli emessi dalla sorgente passano attraverso un canale di trasmissione.
 Informatica Pietro Storniolo storniolo@csai.unipa.it http://www.pa.icar.cnr.it/storniolo/info267 Entropia e flusso di informazione di una sorgente La sorgente viene caratterizzata dal valor medio di I(x
Informatica Pietro Storniolo storniolo@csai.unipa.it http://www.pa.icar.cnr.it/storniolo/info267 Entropia e flusso di informazione di una sorgente La sorgente viene caratterizzata dal valor medio di I(x
SPECIFICHE RADIO A.1 INTRODUZIONE
 SPECIFICHE RADIO A.1 INTRODUZIONE Il ricetrasmettitore Bluetooth TM opera nella banda ISM a 2.4 GHz. Le seguenti specifiche definiscono i requisiti che devono soddisfare i ricetrasmettitori Bluetooth TM
SPECIFICHE RADIO A.1 INTRODUZIONE Il ricetrasmettitore Bluetooth TM opera nella banda ISM a 2.4 GHz. Le seguenti specifiche definiscono i requisiti che devono soddisfare i ricetrasmettitori Bluetooth TM
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
 ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA N. 402/15/CONS FREQUENZE AGGIUNTIVE PIANIFICATE PER LE RETI LOCALI Regione N. mux pianificati Struttura mux Piemonte 1 SFN Mux A: canale 58 Lombardia 1 SFN Mux A: canale 7 Mux
ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA N. 402/15/CONS FREQUENZE AGGIUNTIVE PIANIFICATE PER LE RETI LOCALI Regione N. mux pianificati Struttura mux Piemonte 1 SFN Mux A: canale 58 Lombardia 1 SFN Mux A: canale 7 Mux
LABORATORIO DI CIRCUITI ELETTRICI Nozioni generali e guida agli esperimenti. Rappresentazione grafica dei risultati sperimentali
 LABORATORIO DI CIRCUITI ELETTRICI Nozioni generali e guida agli esperimenti Rappresentazione grafica dei risultati sperimentali Uno strumento molto utile per comunicare e leggere risultati sperimentali
LABORATORIO DI CIRCUITI ELETTRICI Nozioni generali e guida agli esperimenti Rappresentazione grafica dei risultati sperimentali Uno strumento molto utile per comunicare e leggere risultati sperimentali
Multiplazione dei segnali
 Multiplazione dei segnali (*) 1 (*) Rif. Valdoni- Vatalaro: Telecomunicazioni, Cap. 6, pp. 231 e seguenti. 136 Generalità sui trattamenti multipli 2 Multiplazione dei segnali in banda base Riunire i segnali
Multiplazione dei segnali (*) 1 (*) Rif. Valdoni- Vatalaro: Telecomunicazioni, Cap. 6, pp. 231 e seguenti. 136 Generalità sui trattamenti multipli 2 Multiplazione dei segnali in banda base Riunire i segnali
Reti di Telecomunicazioni 1
 Reti di Telecomunicazioni 1 Corso on-line - AA2005/06 Blocco 2 (v2) Ing. Stefano Salsano e-mail: stefano.salsano@uniroma2.it 1 Richiami sul concetto di multiplazione 2 Riprendendo il discorso sulle diverse
Reti di Telecomunicazioni 1 Corso on-line - AA2005/06 Blocco 2 (v2) Ing. Stefano Salsano e-mail: stefano.salsano@uniroma2.it 1 Richiami sul concetto di multiplazione 2 Riprendendo il discorso sulle diverse
Antenne e Collegamento Radio
 Antenne e Collegamento Radio Trasmissione irradiata Oltre ad essere guidato attraverso le linee di trasmissione, il campo elettromagnetico si può propagare nello spazio (radiazione) Anche la radiazione
Antenne e Collegamento Radio Trasmissione irradiata Oltre ad essere guidato attraverso le linee di trasmissione, il campo elettromagnetico si può propagare nello spazio (radiazione) Anche la radiazione
REGRESSIONE E CORRELAZIONE
 REGRESSIONE E CORRELAZIONE Nella Statistica, per studio della connessione si intende la ricerca di eventuali relazioni, di dipendenza ed interdipendenza, intercorrenti tra due variabili statistiche 1.
REGRESSIONE E CORRELAZIONE Nella Statistica, per studio della connessione si intende la ricerca di eventuali relazioni, di dipendenza ed interdipendenza, intercorrenti tra due variabili statistiche 1.
Fondamenti teorici dello SS
 Tecniche a spettro espanso Un sistema a spettro espanso è realizzato sulla base di tecniche per cui il segnale trasmesso ha un occupazione spettrale maggiore (10 3 10 6 ) di quella che avrebbe il convenzionale
Tecniche a spettro espanso Un sistema a spettro espanso è realizzato sulla base di tecniche per cui il segnale trasmesso ha un occupazione spettrale maggiore (10 3 10 6 ) di quella che avrebbe il convenzionale
Corso di Fondamenti di Telecomunicazioni 1 - INTRODUZIONE
 Corso di Fondamenti di Telecomunicazioni 1 - INTRODUZIONE 1 Argomenti della lezione Definizioni: Sorgente di informazione Sistema di comunicazione Segnali trasmissivi determinati e aleatori Architettura
Corso di Fondamenti di Telecomunicazioni 1 - INTRODUZIONE 1 Argomenti della lezione Definizioni: Sorgente di informazione Sistema di comunicazione Segnali trasmissivi determinati e aleatori Architettura
Risposte ai quesiti D E H D
 Perugia, dic. 2009/gen. 2010 Risposte ai quesiti 1. Dati i quadrati CD e C D, come in figura, provare che la perpendicolare uscente da alla retta DD passa per il punto medio del segmento quale che sia
Perugia, dic. 2009/gen. 2010 Risposte ai quesiti 1. Dati i quadrati CD e C D, come in figura, provare che la perpendicolare uscente da alla retta DD passa per il punto medio del segmento quale che sia
1 Nozioni utili sul piano cartesiano
 Nozioni utili sul piano cartesiano Nozioni utili sul piano cartesiano Il piano cartesiano è un sistema di riferimento costituito da due rette perpendicolari (una orizzontale detta asse delle ascisse x
Nozioni utili sul piano cartesiano Nozioni utili sul piano cartesiano Il piano cartesiano è un sistema di riferimento costituito da due rette perpendicolari (una orizzontale detta asse delle ascisse x
Tecnologie Radio Cellulari. Reti Cellulari. Forma e Dimensione delle Celle. Organizzazione di una Rete Cellulare
 I semestre 04/05 Tecnologie Radio Cellulari Reti Cellulari Prof. Vincenzo Auletta auletta@dia.unisa.it http://www.dia.unisa.it/professori/auletta/ Università degli studi di Salerno Laurea in Informatica
I semestre 04/05 Tecnologie Radio Cellulari Reti Cellulari Prof. Vincenzo Auletta auletta@dia.unisa.it http://www.dia.unisa.it/professori/auletta/ Università degli studi di Salerno Laurea in Informatica
DIRECT SEQUENCE CDMA... 2 1 DESCRIZIONE DELLA TECNICA DI SPREADING A SEQUENZA DIRETTA... 2 2 PROPRIETÀ DELLE SEQUENZE DI CODICE PN...
 DRCT SQUNC CDMA... 2 DSCRZON DLLA TCNCA D SPRADNG A SQUNZA DRTTA... 2 2 PROPRTÀ DLL SQUNZ D CODC PN... 4 L CONTROLLO D POTNZA LA CAPACTÀ D UNA RT CLLULAR CDMA... 5 L CONTROLLO D POTNZA... 5 2 LA CAPACTÀ
DRCT SQUNC CDMA... 2 DSCRZON DLLA TCNCA D SPRADNG A SQUNZA DRTTA... 2 2 PROPRTÀ DLL SQUNZ D CODC PN... 4 L CONTROLLO D POTNZA LA CAPACTÀ D UNA RT CLLULAR CDMA... 5 L CONTROLLO D POTNZA... 5 2 LA CAPACTÀ
1) Entropia di variabili aleatorie continue. 2) Esempi di variabili aleatorie continue. 3) Canali di comunicazione continui. 4) Canale Gaussiano
 Argomenti della Lezione 1) Entropia di variabili aleatorie continue ) Esempi di variabili aleatorie continue 3) Canali di comunicazione continui 4) Canale Gaussiano 5) Limite di Shannon 1 Entropia di una
Argomenti della Lezione 1) Entropia di variabili aleatorie continue ) Esempi di variabili aleatorie continue 3) Canali di comunicazione continui 4) Canale Gaussiano 5) Limite di Shannon 1 Entropia di una
Reti di Telecomunicazione Lezione 2
 Reti di Telecomunicazione Lezione 2 Marco Benini Corso di Laurea in Informatica marco.benini@uninsubria.it Programma della lezione Commutazione di circuito multiplexing divisione di frequenza divisione
Reti di Telecomunicazione Lezione 2 Marco Benini Corso di Laurea in Informatica marco.benini@uninsubria.it Programma della lezione Commutazione di circuito multiplexing divisione di frequenza divisione
UNITA DI MISURA LOGARITMICHE
 UNITA DI MISURA LOGARITMICHE MOTIVAZIONI Attenuazione del segnale trasmesso esponenziale con la lunghezza mentre si propaga sulle linee di trasmissione (conduttori metallici) Utilizzando le unità logaritmiche
UNITA DI MISURA LOGARITMICHE MOTIVAZIONI Attenuazione del segnale trasmesso esponenziale con la lunghezza mentre si propaga sulle linee di trasmissione (conduttori metallici) Utilizzando le unità logaritmiche
Piano cartesiano e retta
 Piano cartesiano e retta Il punto, la retta e il piano sono concetti primitivi di cui non si da una definizione rigorosa, essi sono i tre enti geometrici fondamentali della geometria euclidea. Osservazione
Piano cartesiano e retta Il punto, la retta e il piano sono concetti primitivi di cui non si da una definizione rigorosa, essi sono i tre enti geometrici fondamentali della geometria euclidea. Osservazione
Descrizione della struttura e delle funzioni di una stazione radio base TACS
 c.so Duca degli Abruzzi 4 1019 Torino (Italy) Fax +39 011 564 4099 pag. /34 Premessa Il seguente capitolo illustra i principi tecnici fondamentali a cui si ispirano le tecnologie utilizzate per i serivizi
c.so Duca degli Abruzzi 4 1019 Torino (Italy) Fax +39 011 564 4099 pag. /34 Premessa Il seguente capitolo illustra i principi tecnici fondamentali a cui si ispirano le tecnologie utilizzate per i serivizi
4.2 Accesso Multiplo, Canali di traffico e di controllo, Bursts ed Acquisizione dei sincronismi nel GSM
 1 Comunicazioni Mobili 2 R. Cusani Laurea Specialistica in: Ingegneria delle TLC anno 1 Ingegneria Elettronica anno 2 4.2 Accesso Multiplo, Canali di traffico e di controllo, Bursts ed Acquisizione dei
1 Comunicazioni Mobili 2 R. Cusani Laurea Specialistica in: Ingegneria delle TLC anno 1 Ingegneria Elettronica anno 2 4.2 Accesso Multiplo, Canali di traffico e di controllo, Bursts ed Acquisizione dei
Filtri passivi Risposta in frequenza dei circuiti RC-RL-RLC
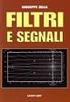 23. Guadagno di un quadripolo Filtri passivi isposta in frequenza dei circuiti C-L-LC In un quadripolo generico (fig. ) si definisce guadagno G il rapporto tra il valore d uscita e quello d ingresso della
23. Guadagno di un quadripolo Filtri passivi isposta in frequenza dei circuiti C-L-LC In un quadripolo generico (fig. ) si definisce guadagno G il rapporto tra il valore d uscita e quello d ingresso della
UNITÀ DIDATTICA 2 LE FUNZIONI
 UNITÀ DIDATTICA LE FUNZIONI. Le funzioni Definizione. Siano A e B due sottoinsiemi non vuoti di R. Si chiama funzione di A in B una qualsiasi legge che fa corrispondere a ogni elemento A uno ed un solo
UNITÀ DIDATTICA LE FUNZIONI. Le funzioni Definizione. Siano A e B due sottoinsiemi non vuoti di R. Si chiama funzione di A in B una qualsiasi legge che fa corrispondere a ogni elemento A uno ed un solo
Sistemi di Telecomunicazione
 Sistemi di Telecomunicazione Doppi bipoli rumorosi: esercizi ed esempi numerici Universita Politecnica delle Marche A.A. 2014-2015 A.A. 2014-2015 Sistemi di Telecomunicazione 1/15 Esempio 1 Il segnale
Sistemi di Telecomunicazione Doppi bipoli rumorosi: esercizi ed esempi numerici Universita Politecnica delle Marche A.A. 2014-2015 A.A. 2014-2015 Sistemi di Telecomunicazione 1/15 Esempio 1 Il segnale
Coverage. Visto che il coverage si basa su aree dell ambiente che vengono monitorate non è
 L. Pallottino, Sistemi Robotici Distribuiti - Versione del 10 Dicembre 2015 393 Coverage Si consideri ora il problema di coordinare una squadra di robot con dei sensori omnidirezionali in modo da garantire
L. Pallottino, Sistemi Robotici Distribuiti - Versione del 10 Dicembre 2015 393 Coverage Si consideri ora il problema di coordinare una squadra di robot con dei sensori omnidirezionali in modo da garantire
Test A Teoria dei numeri e Combinatoria
 Test A Teoria dei numeri e Combinatoria Problemi a risposta secca 1. Determinare con quanti zeri termina la scrittura in base 12 del fattoriale di 2002. 2. Determinare quante sono le coppie (x, y) di interi
Test A Teoria dei numeri e Combinatoria Problemi a risposta secca 1. Determinare con quanti zeri termina la scrittura in base 12 del fattoriale di 2002. 2. Determinare quante sono le coppie (x, y) di interi
Comunicazioni Elettriche Esercizi
 Comunicazioni Elettriche Esercizi Alberto Perotti 9 giugno 008 Esercizio 1 Un processo casuale Gaussiano caratterizzato dai parametri (µ = 0, σ = 0.5) ha spettro nullo al di fuori dellintervallo f [1.5kHz,
Comunicazioni Elettriche Esercizi Alberto Perotti 9 giugno 008 Esercizio 1 Un processo casuale Gaussiano caratterizzato dai parametri (µ = 0, σ = 0.5) ha spettro nullo al di fuori dellintervallo f [1.5kHz,
PROVE SCRITTE DI MATEMATICA APPLICATA, ANNO 2006/07
 PROVE SCRITTE DI MATEMATICA APPLICATA, ANNO 006/07 Esercizio 1 Prova scritta del 16/1/006 In un ufficio postale lavorano due impiegati che svolgono lo stesso compito in maniera indipendente, sbrigando
PROVE SCRITTE DI MATEMATICA APPLICATA, ANNO 006/07 Esercizio 1 Prova scritta del 16/1/006 In un ufficio postale lavorano due impiegati che svolgono lo stesso compito in maniera indipendente, sbrigando
Comunicazioni Digitali per Radioamatori
 Comunicazioni Introduzione alle comunicazioni Duration: approx. 1h 30 minutes Cont@ct: IW6BFE Arrio Antonelli iw6bfe@gmail.com 1.1 Perché digitale Le comunicazioni digitali sono state sviluppate come esigenza
Comunicazioni Introduzione alle comunicazioni Duration: approx. 1h 30 minutes Cont@ct: IW6BFE Arrio Antonelli iw6bfe@gmail.com 1.1 Perché digitale Le comunicazioni digitali sono state sviluppate come esigenza
PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO
 PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO DOCENTI : MASSERINI MARIO GIUSEPPE, LUIGI GIAVARINI (ITP) CLASSE: 4 IB DISCIPLINA: TELECOMUNICAZIONI 1) ELENCO UDA DEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO CONCORDATE NELLE RIUNIONI DI
PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO DOCENTI : MASSERINI MARIO GIUSEPPE, LUIGI GIAVARINI (ITP) CLASSE: 4 IB DISCIPLINA: TELECOMUNICAZIONI 1) ELENCO UDA DEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO CONCORDATE NELLE RIUNIONI DI
CAP. 1 - GLI ELEMENTI PRIMITIVI
 CP. 1 - GLI ELEMENTI PRIMITIVI 1 Geometria e realtà 2 Elementi primitivi della geometria 3 Punto 4 Figura geometrica 5 Figure congruenti 6 Linea 7 Retta 8 Proprietà della retta 9 Punti allineati 10 Semiretta
CP. 1 - GLI ELEMENTI PRIMITIVI 1 Geometria e realtà 2 Elementi primitivi della geometria 3 Punto 4 Figura geometrica 5 Figure congruenti 6 Linea 7 Retta 8 Proprietà della retta 9 Punti allineati 10 Semiretta
Capitolo 11. Conclusioni
 Capitolo 11 Conclusioni In questo lavoro di tesi sono state analizzate le prestazioni dei protocolli a pacchetto per la trasmissione sull interfaccia radio dei sistemi di comunicazione mobile cellulare
Capitolo 11 Conclusioni In questo lavoro di tesi sono state analizzate le prestazioni dei protocolli a pacchetto per la trasmissione sull interfaccia radio dei sistemi di comunicazione mobile cellulare
QUANTIZZAZIONE E CONVERSIONE IN FORMA NUMERICA. 1 Fondamenti Segnali e Trasmissione
 UANTIZZAZIONE E CONVERSIONE IN FORMA NUMERICA Fondamenti Segnali e Trasmissione Campionamento e quantizzazione di un segnale analogico Si consideri il segnale x(t) campionato con passo T c. Campioni del
UANTIZZAZIONE E CONVERSIONE IN FORMA NUMERICA Fondamenti Segnali e Trasmissione Campionamento e quantizzazione di un segnale analogico Si consideri il segnale x(t) campionato con passo T c. Campioni del
SCHEDA N 8 DEL LABORATORIO DI FISICA
 SCHEDA N 1 IL PENDOLO SEMPLICE SCHEDA N 8 DEL LABORATORIO DI FISICA Scopo dell'esperimento. Determinare il periodo di oscillazione di un pendolo semplice. Applicare le nozioni sugli errori di una grandezza
SCHEDA N 1 IL PENDOLO SEMPLICE SCHEDA N 8 DEL LABORATORIO DI FISICA Scopo dell'esperimento. Determinare il periodo di oscillazione di un pendolo semplice. Applicare le nozioni sugli errori di una grandezza
RETI CELLULARI. Principi generali. Definizioni
 RETI CELLULARI Principi generali Copyright Gruppo Reti di Telecomunicazioni Politecnico di Torino Rete wireless Definizioni (sotto)rete in cui l accesso da un terminale avviene attraverso un canale radio,
RETI CELLULARI Principi generali Copyright Gruppo Reti di Telecomunicazioni Politecnico di Torino Rete wireless Definizioni (sotto)rete in cui l accesso da un terminale avviene attraverso un canale radio,
Wireless Ethernet: tecnologie e possibili applicazioni
 Wireless Ethernet: tecnologie e possibili applicazioni Marco Caliari Phoenix Contact Gruppo Rilevamento Misura e Analisi e Gruppo PLC e I/O distribuiti Agenda Trend nell automazione industriale; Perchè
Wireless Ethernet: tecnologie e possibili applicazioni Marco Caliari Phoenix Contact Gruppo Rilevamento Misura e Analisi e Gruppo PLC e I/O distribuiti Agenda Trend nell automazione industriale; Perchè
RETI CELLULARI. La copertura cellulare. Copyright. Definizioni. La copertura cellulare teorica. La copertura cellulare teorica
 Copyright RETI CELLULARI Principi generali (T.S. Rappaport, Wireless Communications: Principles and Practice, Prentice Hall, 1996) Quest opera è protetta dalla licenza Creative Commons NoDerivs-NonCommercial.
Copyright RETI CELLULARI Principi generali (T.S. Rappaport, Wireless Communications: Principles and Practice, Prentice Hall, 1996) Quest opera è protetta dalla licenza Creative Commons NoDerivs-NonCommercial.
Capitolo 2: Canali e Multiplazione
 Fabio Martignon: Appunti del corso di Reti di Calcolatori Capitolo : Canali e Multiplazione. Canali. Canali punto-punto I canali punto-punto sono canali permanenti fra un trasmettitore ed un ricevitore,
Fabio Martignon: Appunti del corso di Reti di Calcolatori Capitolo : Canali e Multiplazione. Canali. Canali punto-punto I canali punto-punto sono canali permanenti fra un trasmettitore ed un ricevitore,
Reti cellulari. Cenni Storici. Cenni Storici. Introduzione, storia e principi generali. Cenni Storici
 Cenni Storici Reti cellulari Introduzione, storia e principi generali La propagazione nello spazio libero è utilizzata da quasi 100 anni per le telecomunicazioni I primi rudimentali sistemi di telecomunicazione
Cenni Storici Reti cellulari Introduzione, storia e principi generali La propagazione nello spazio libero è utilizzata da quasi 100 anni per le telecomunicazioni I primi rudimentali sistemi di telecomunicazione
ANALISI DI FREQUENZA
 Giada Grosoli matr. 1391 Lezione del 19/1/ ora 8:3-1:3 ANALISI DI FREQUENZA Nello studio dell acustica è molto importante l analisi di frequenza del suono. E fondamentale infatti valutare, oltre al livello
Giada Grosoli matr. 1391 Lezione del 19/1/ ora 8:3-1:3 ANALISI DI FREQUENZA Nello studio dell acustica è molto importante l analisi di frequenza del suono. E fondamentale infatti valutare, oltre al livello
Coperture cellulari. Marco Listanti. Reti cellulari - Prof. Marco Listanti - A.A. 2008/2009. INFOCOM Dept
 Coperture cellulari Marco Listanti Reti cellulari - Prof. Marco Listanti - A.A. 008/009 Indice Le reti cellulari Architettura di una rete cellulare Coperture cellulari Motivazioni Il canale radiomobile
Coperture cellulari Marco Listanti Reti cellulari - Prof. Marco Listanti - A.A. 008/009 Indice Le reti cellulari Architettura di una rete cellulare Coperture cellulari Motivazioni Il canale radiomobile
Cenni di propagazione e tecniche di trasmissione Parte Copyright. Propagazione nello spazio libero (vuoto)
 Cenni di propagazione e tecniche di trasmissione Parte 1 Renato Lo Cigno www.dit.unitn.it/locigno/didattica/wn/...copyright Quest opera è protetta dalla licenza Creative Commons NoDerivs-NonCommercial.
Cenni di propagazione e tecniche di trasmissione Parte 1 Renato Lo Cigno www.dit.unitn.it/locigno/didattica/wn/...copyright Quest opera è protetta dalla licenza Creative Commons NoDerivs-NonCommercial.
Breve formulario di matematica
 Luciano Battaia a 2 = a ; lim sin = 1, se 0; sin(α + β) = sin α cos β + cos α sin β; f() = e 2 f () = 2e 2 ; sin d = cos + k; 1,2 = b± ; a m a n = 2a a n+m ; log a 2 = ; = a 2 + b + c; 2 + 2 = r 2 ; e
Luciano Battaia a 2 = a ; lim sin = 1, se 0; sin(α + β) = sin α cos β + cos α sin β; f() = e 2 f () = 2e 2 ; sin d = cos + k; 1,2 = b± ; a m a n = 2a a n+m ; log a 2 = ; = a 2 + b + c; 2 + 2 = r 2 ; e
Funzioni vettoriali di variabile scalare
 Capitolo 11 Funzioni vettoriali di variabile scalare 11.1 Curve in R n Abbiamo visto (capitolo 2) come la posizione di un punto in uno spazio R n sia individuata mediante le n coordinate di quel punto.
Capitolo 11 Funzioni vettoriali di variabile scalare 11.1 Curve in R n Abbiamo visto (capitolo 2) come la posizione di un punto in uno spazio R n sia individuata mediante le n coordinate di quel punto.
Inquinamento acustico
 Programma Regionale I.N.F.E.A. Informazione Formazione ed Educazione Ambientale PROGETTO GEO Sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale Inquinamento acustico Dott.ssa Barbara Bracci Controllo Agenti
Programma Regionale I.N.F.E.A. Informazione Formazione ed Educazione Ambientale PROGETTO GEO Sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale Inquinamento acustico Dott.ssa Barbara Bracci Controllo Agenti
Il livello fisico, responsabile della trasmissione del segnale nei diversi mezzi fisici:
 Il livello fisico, responsabile della trasmissione del segnale nei diversi mezzi fisici: -lo spettro elettromagnetico; -la modulazione - il teorema di Shannon -la trasmissione guidata Lo spettro elettromagnetico
Il livello fisico, responsabile della trasmissione del segnale nei diversi mezzi fisici: -lo spettro elettromagnetico; -la modulazione - il teorema di Shannon -la trasmissione guidata Lo spettro elettromagnetico
LA CIRCONFERENZA e IL CERCHIO
 LA CIRCONFERENZA e IL CERCHIO La circonferenza è un poligono regolare con un numero infinito di lati Bisogna fare innanzitutto una distinzione: la circonferenza è la misura del perimetro; C (se sono più
LA CIRCONFERENZA e IL CERCHIO La circonferenza è un poligono regolare con un numero infinito di lati Bisogna fare innanzitutto una distinzione: la circonferenza è la misura del perimetro; C (se sono più
Copertura cellulare e Multiplazione. Università di Pavia Sistemi di Trsmissione Radio
 Copertura cellulare e Multiplazione Accesso Multiplo Copertura cellulare Resource reuse Reuse pattern: There exists a border area where signals overlap: intererence Unacceptable when a user pays or service
Copertura cellulare e Multiplazione Accesso Multiplo Copertura cellulare Resource reuse Reuse pattern: There exists a border area where signals overlap: intererence Unacceptable when a user pays or service
METODI E TECNOLOGIE PER L INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA. Lezione n 14
 METODI E TECNOLOGIE PER L INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA Lezione n 14 L equivalenza di figure piane Due figure piane si dicono equivalenti (o equiestese) se hanno la stessa estensione nel piano. L area
METODI E TECNOLOGIE PER L INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA Lezione n 14 L equivalenza di figure piane Due figure piane si dicono equivalenti (o equiestese) se hanno la stessa estensione nel piano. L area
Conoscenze. L operazione di divisione (la divisione di due polinomi) - La divisibilità fra polinomi (la regola di Ruffini, il teorema. del resto.
 Classe: TERZA (Liceo Artistico) Pagina 1 / 2 della Matematica La scomposizione dei polinomi in fattori primi L operazione di divisione (la divisione di due polinomi) - La divisibilità fra polinomi (la
Classe: TERZA (Liceo Artistico) Pagina 1 / 2 della Matematica La scomposizione dei polinomi in fattori primi L operazione di divisione (la divisione di due polinomi) - La divisibilità fra polinomi (la
Soluzione Problema 1
 Soluzione Problema 1 1. Ricordiamo che una funzione h(x) è derivabile in un punto c se esiste finita la sua derivata nel punto c. Per il significato geometrico della derivata ciò significa che esiste ed
Soluzione Problema 1 1. Ricordiamo che una funzione h(x) è derivabile in un punto c se esiste finita la sua derivata nel punto c. Per il significato geometrico della derivata ciò significa che esiste ed
Programma del corso. Introduzione Rappresentazione delle Informazioni Calcolo proposizionale Architettura del calcolatore Reti di calcolatori
 Programma del corso Introduzione Rappresentazione delle Informazioni Calcolo proposizionale Architettura del calcolatore Reti di calcolatori Evoluzione dei sistemi informatici Cos è una rete? Insieme di
Programma del corso Introduzione Rappresentazione delle Informazioni Calcolo proposizionale Architettura del calcolatore Reti di calcolatori Evoluzione dei sistemi informatici Cos è una rete? Insieme di
4.5 Sistemi 2.5G: GPRS (Global Packet Radio System) e EDGE (Enhanced Data rate for GSM)
 1 INFO-COM Dpt. Dipartimento di Scienza e Tecnica dell Informazione e della Comunicazione Università degli Studi di Roma La Sapienza Comunicazioni Mobili 2 Roberto Cusani Laurea Specialistica in: Ingegneria
1 INFO-COM Dpt. Dipartimento di Scienza e Tecnica dell Informazione e della Comunicazione Università degli Studi di Roma La Sapienza Comunicazioni Mobili 2 Roberto Cusani Laurea Specialistica in: Ingegneria
Comunicazioni ottiche Wireless
 Comunicazioni ottiche Wireless Propagazione nello spazio libero (RF) Il canale radio (RF) presenta notevoli caratteristiche, alcune di queste sono Attenuazione Cammini multipli Problemi di compatibilità
Comunicazioni ottiche Wireless Propagazione nello spazio libero (RF) Il canale radio (RF) presenta notevoli caratteristiche, alcune di queste sono Attenuazione Cammini multipli Problemi di compatibilità
1.4 Geometria analitica
 1.4 Geometria analitica IL PIANO CARTESIANO Per definire un riferimento cartesiano nel piano euclideo prendiamo: Un punto detto origine i Due rette orientate passanti per. ii Due punti e per definire le
1.4 Geometria analitica IL PIANO CARTESIANO Per definire un riferimento cartesiano nel piano euclideo prendiamo: Un punto detto origine i Due rette orientate passanti per. ii Due punti e per definire le
La distribuzione delle frequenze. T 10 (s)
 1 La distribuzione delle frequenze Si vuole misurare il periodo di oscillazione di un pendolo costituito da una sferetta metallica agganciata a un filo (fig. 1). A Figura 1 B Ricordiamo che il periodo
1 La distribuzione delle frequenze Si vuole misurare il periodo di oscillazione di un pendolo costituito da una sferetta metallica agganciata a un filo (fig. 1). A Figura 1 B Ricordiamo che il periodo
Elementi di informatica musicale Conservatorio G. Tartini a.a Sintesi del suono. Sintesi del suono
 Elementi di informatica musicale Conservatorio G. Tartini a.a. 2001-2002 Sintesi del suono Ing. Antonio Rodà Sintesi del suono E neccessaria una tecnica di sintesi, ossia un particolare procedimento per
Elementi di informatica musicale Conservatorio G. Tartini a.a. 2001-2002 Sintesi del suono Ing. Antonio Rodà Sintesi del suono E neccessaria una tecnica di sintesi, ossia un particolare procedimento per
1 I solidi a superficie curva
 1 I solidi a superficie curva PROPRIETÀ. Un punto che ruota attorno ad un asse determina una circonferenza. PROPRIETÀ. Una linea, un segmento o una retta che ruotano attorno ad un asse determinano una
1 I solidi a superficie curva PROPRIETÀ. Un punto che ruota attorno ad un asse determina una circonferenza. PROPRIETÀ. Una linea, un segmento o una retta che ruotano attorno ad un asse determinano una
Campionamento e quantizzazione
 Corso di Laurea a Distanza in Ingegneria Elettrica Corso di Comunicazioni Elettriche Campionamento e quantizzazione A.A. 2008-09 Alberto Perotti DELEN-DAUIN Conversione analogico-digitale L elaborazione
Corso di Laurea a Distanza in Ingegneria Elettrica Corso di Comunicazioni Elettriche Campionamento e quantizzazione A.A. 2008-09 Alberto Perotti DELEN-DAUIN Conversione analogico-digitale L elaborazione
Funzioni. iniettiva se x y = f (x) f (y) o, equivalentemente, f (x) = f (y) = x = y
 Funzioni. Dati due insiemi A e B (non necessariamente distinti) si chiama funzione da A a B una qualunque corrispondenza (formula, regola) che associa ad ogni elemento di A uno ed un solo elemento di B.
Funzioni. Dati due insiemi A e B (non necessariamente distinti) si chiama funzione da A a B una qualunque corrispondenza (formula, regola) che associa ad ogni elemento di A uno ed un solo elemento di B.
DIGITALE TERRESTRE. Non Solo Televisione
 DIGITALE TERRESTRE Non Solo Televisione Parte.3 Trattamento dei segnali tv digitali - esempi applicativi per l ottimizzazione della ricezione utilizzando apparecchiature di filtraggio, conversione di frequenza
DIGITALE TERRESTRE Non Solo Televisione Parte.3 Trattamento dei segnali tv digitali - esempi applicativi per l ottimizzazione della ricezione utilizzando apparecchiature di filtraggio, conversione di frequenza
Geometria euclidea. Alessio del Vigna. Lunedì 15 settembre
 Geometria euclidea Alessio del Vigna Lunedì 15 settembre La geometria euclidea è una teoria fondata su quattro enti primitivi e sulle relazioni che tra essi intercorrono. I quattro enti primitivi in questione
Geometria euclidea Alessio del Vigna Lunedì 15 settembre La geometria euclidea è una teoria fondata su quattro enti primitivi e sulle relazioni che tra essi intercorrono. I quattro enti primitivi in questione
Quesito 1 Si calcoli. 3 2 2 4 3 3 = 3 2 4 3 = 2 ln3 = 8 81 2,3. 1 = 2 3 2 3 = 2 3 1+1 2 1 = = =ln81. Soluzione 1
 ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO Sessione Ordinaria 0 PIANO NAZIONALE INFORMATICA Questionario Quesito Si calcoli 3 3 è 0 0 Applicando De L Hospital si ha: -,3 3 3 4 3 3 = infatti: 0 = 3 4 3 3 = 3 4
ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO Sessione Ordinaria 0 PIANO NAZIONALE INFORMATICA Questionario Quesito Si calcoli 3 3 è 0 0 Applicando De L Hospital si ha: -,3 3 3 4 3 3 = infatti: 0 = 3 4 3 3 = 3 4
RETI CELLULARI Principi generali
 RETI CELLULARI Principi generali Copyright Quest opera è protetta dalla licenza Creative Commons NoDerivs-NonCommercial. Per vedere una copia di questa licenza, consultare: http://creativecommons.org/licenses/nd-nc/1.0/
RETI CELLULARI Principi generali Copyright Quest opera è protetta dalla licenza Creative Commons NoDerivs-NonCommercial. Per vedere una copia di questa licenza, consultare: http://creativecommons.org/licenses/nd-nc/1.0/
Quadro riassuntivo di geometria analitica
 Quadro riassuntivo di geometria analitica IL PIANO CARTESIANO (detta ascissa o coordinata x) e y quella dall'asse x (detta ordinata o coordinata y). Le coordinate di un punto P sono: entrambe positive
Quadro riassuntivo di geometria analitica IL PIANO CARTESIANO (detta ascissa o coordinata x) e y quella dall'asse x (detta ordinata o coordinata y). Le coordinate di un punto P sono: entrambe positive
TRASMISSIONE NUMERICA IN BANDA BASE
 TRASMISSIONE NUMERICA IN BANDA BASE 1 Fondamenti di segnali Fondamenti e trasmissione TLC Trasmissione numerica in banda base Per trasmettere una sequenza di cifre binarie su un canale di trasmissione
TRASMISSIONE NUMERICA IN BANDA BASE 1 Fondamenti di segnali Fondamenti e trasmissione TLC Trasmissione numerica in banda base Per trasmettere una sequenza di cifre binarie su un canale di trasmissione
Il contrasto. La percezione del contrasto. Contrasto e filling-in. Il contrasto simultaneo. Le distribuzioni di luminanza (ii)
 20 Aprile 2006 Corso di Laurea in Informatica Multimediale Facoltà di Scienze MMFFNN Università di Verona Il contrasto La percezione del contrasto Chiara Della Libera DSNV Università di Verona Sezione
20 Aprile 2006 Corso di Laurea in Informatica Multimediale Facoltà di Scienze MMFFNN Università di Verona Il contrasto La percezione del contrasto Chiara Della Libera DSNV Università di Verona Sezione
01CXGBN Trasmissione numerica. parte 1: Introduzione ai sistemi di trasmissione numerica. Grandezze fondamentali.
 01CXGBN Trasmissione numerica parte 1: Introduzione ai sistemi di trasmissione numerica. Grandezze fondamentali. 1 TRASMISSIONE NUMERICA Trasmissione da un utente TX a un utente RX di informazione discreta
01CXGBN Trasmissione numerica parte 1: Introduzione ai sistemi di trasmissione numerica. Grandezze fondamentali. 1 TRASMISSIONE NUMERICA Trasmissione da un utente TX a un utente RX di informazione discreta
Band Plan MHz IARU San Marino Band Plan MHz IARU San Marino 2002
 Band Plan 50-51 MHz Band Plan 144-146 MHz 144.000 144.035 144.050 Frequenza di chiamata DX CW 144.100 Random MS in CW 144.135 144.138 PSK 31 Centro Attività 144.140 Attività FAI & EME in CW 144.150 Attività
Band Plan 50-51 MHz Band Plan 144-146 MHz 144.000 144.035 144.050 Frequenza di chiamata DX CW 144.100 Random MS in CW 144.135 144.138 PSK 31 Centro Attività 144.140 Attività FAI & EME in CW 144.150 Attività
LE RETTE PERPENDICOLARI E LE RETTE PARALLELE Le rette perpendicolari Le rette tagliate da una trasversale Le rette parallele
 PROGRAMMA DI MATEMATICA Classe prima (ex quarta ginnasio) corso F NUMERI: Numeri per contare: insieme N. I numeri interi: insieme Z. I numeri razionali e la loro scrittura: insieme Q. Rappresentare frazioni
PROGRAMMA DI MATEMATICA Classe prima (ex quarta ginnasio) corso F NUMERI: Numeri per contare: insieme N. I numeri interi: insieme Z. I numeri razionali e la loro scrittura: insieme Q. Rappresentare frazioni
RETI DI TELECOMUNICAZIONE
 RETI DI TELECOMUNICAZIONE Modelli delle Sorgenti di Traffico Generalità Per la realizzazione di un modello analitico di un sistema di telecomunicazione dobbiamo tenere in considerazione 3 distinte sezioni
RETI DI TELECOMUNICAZIONE Modelli delle Sorgenti di Traffico Generalità Per la realizzazione di un modello analitico di un sistema di telecomunicazione dobbiamo tenere in considerazione 3 distinte sezioni
Ogni stazione base viene collegata via cavo ad altri nodi della rete fissa.
 Reti cellulari La rete cellulare è una rete per cui la copertura geografica è realizzata con una tassellazione a celle: porzioni di area geografica che unite ricoprono perfettamente una zona. La prerogativa
Reti cellulari La rete cellulare è una rete per cui la copertura geografica è realizzata con una tassellazione a celle: porzioni di area geografica che unite ricoprono perfettamente una zona. La prerogativa
Teoria dell informazione
 Corso di Laurea a Distanza in Ingegneria Elettrica Corso di Comunicazioni Elettriche Teoria dell informazione A.A. 2008-09 Alberto Perotti DELEN-DAUIN Modello di sistema di comunicazione Il modello di
Corso di Laurea a Distanza in Ingegneria Elettrica Corso di Comunicazioni Elettriche Teoria dell informazione A.A. 2008-09 Alberto Perotti DELEN-DAUIN Modello di sistema di comunicazione Il modello di
BER e fattore Q 1/2. È pratica comune nel settore R&D (ricerca e sviluppo) dei sistemi ottici utilizzare il cosiddetto fattore Q per esprimere il BER.
 Reti in fibra ottica 1/21 BER e fattore Q 1/2 È pratica comune nel settore R&D (ricerca e sviluppo) dei sistemi ottici utilizzare il cosiddetto fattore Q per esprimere il BER. 2/21 BER e fattore Q 2/2
Reti in fibra ottica 1/21 BER e fattore Q 1/2 È pratica comune nel settore R&D (ricerca e sviluppo) dei sistemi ottici utilizzare il cosiddetto fattore Q per esprimere il BER. 2/21 BER e fattore Q 2/2
Tema d esame del 15/02/12
 Tema d esame del 15/0/1 Volendo aprire un nuovo locale, una catena di ristoranti chiede ad un consulente di valutare la posizione geografica ideale all interno di un centro abitato. A questo scopo, avvalendosi
Tema d esame del 15/0/1 Volendo aprire un nuovo locale, una catena di ristoranti chiede ad un consulente di valutare la posizione geografica ideale all interno di un centro abitato. A questo scopo, avvalendosi
Esame di maturità scientifica, corso di ordinamento a. s
 Problema 1 Esame di maturità scientifica, corso di ordinamento a. s. -4 Sia f la funzione definita da: f()=- Punto 1 Disegnate il grafico G di f()=-. La funzione f()=- è una funzione polinomiale (una cubica).
Problema 1 Esame di maturità scientifica, corso di ordinamento a. s. -4 Sia f la funzione definita da: f()=- Punto 1 Disegnate il grafico G di f()=-. La funzione f()=- è una funzione polinomiale (una cubica).
RISPOSTE MOTIVATE QUIZ D AMMISSIONE MATEMATICA
 RISPOSTE MOTIVATE QUIZ D AMMISSIONE 1999-2000 MATEMATICA 76. A cosa è uguale: a-b? A) a-b = (- b-a) B) a-b = (- a-b) C) a-b = (a/b) D) a-b = -( b- a) E) a-b = 1/(ab) L espressione a-b costituisce un polinomio,
RISPOSTE MOTIVATE QUIZ D AMMISSIONE 1999-2000 MATEMATICA 76. A cosa è uguale: a-b? A) a-b = (- b-a) B) a-b = (- a-b) C) a-b = (a/b) D) a-b = -( b- a) E) a-b = 1/(ab) L espressione a-b costituisce un polinomio,
[ dbm] = (3 " 0,2 # 50 " 3) dbm = "10 dbm
![[ dbm] = (3 0,2 # 50 3) dbm = 10 dbm [ dbm] = (3 0,2 # 50 3) dbm = 10 dbm](/thumbs/53/33069264.jpg) Esercizi di comunicazioni ottiche (SNR, Q, BER) Es. ) Consideriamo il caso di una linea in fibra ottica lunga 50 km con attenuazione di 0, db/km e dispersione cromatica compensata mediante un modulo di
Esercizi di comunicazioni ottiche (SNR, Q, BER) Es. ) Consideriamo il caso di una linea in fibra ottica lunga 50 km con attenuazione di 0, db/km e dispersione cromatica compensata mediante un modulo di
Band Plan 50-52 MHz IARU San Marino 2002. Band Plan 144-146 MHz IARU San Marino 2002 50.000 50.080 50.090 50.100. 50.110 QRG DX SSB Intercont.
 Band Plan 50-52 MHz Band Plan 144-146 MHz 50.000 50.080 50.090 50.100 50.110 QRG DX SSB Intercont. (*) 50.130 50.150 SSB (Centro Attività) 50.185 CROSSBAND (Centro Attività) 50.200 METEOR SCATTER CW -
Band Plan 50-52 MHz Band Plan 144-146 MHz 50.000 50.080 50.090 50.100 50.110 QRG DX SSB Intercont. (*) 50.130 50.150 SSB (Centro Attività) 50.185 CROSSBAND (Centro Attività) 50.200 METEOR SCATTER CW -
Il blocco amplificatore realizza la funzione di elevare il livello (di tensione o corrente) del segnale (in tensione o corrente) in uscita da una
 l blocco amplificatore realizza la funzione di elevare il livello (di tensione o corrente) del segnale (in tensione o corrente) in uscita da una sorgente. Nel caso, come riportato in figura, il segnale
l blocco amplificatore realizza la funzione di elevare il livello (di tensione o corrente) del segnale (in tensione o corrente) in uscita da una sorgente. Nel caso, come riportato in figura, il segnale
