Efficacia dello spironolattone sulla sopravvivenza di cani affetti da rigurgito mitralico spontaneo causato da mixomatosi della valvola mitralica*
|
|
|
- Enrico Pace
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Rivista di Zootecnia e Veterinaria, vol. 43, n. 2, 2010 Efficacia dello spironolattone sulla sopravvivenza di cani affetti da rigurgito mitralico spontaneo causato da mixomatosi della valvola mitralica* F. Bernay, J.M. Bland, J. Haggstrom, L. Baduel, B. Combes, A. Lopez, V. Kaltsatos BACKGROUND È stato dimostrato che lo spironolattone, un antagonista dell aldosterone, riduce la mortalità nell uomo, quando è associato ad altre terapie cardiache. IPOTESI Nei cani affetti da patologia spontanea mixomatosa della valvola mitralica (MMVD) lo spironolattone, associato alla sola terapia convenzionale, aumenta il tasso di sopravvivenza in confronto alla sola terapia convenzionale. ANIMALI Tra febbraio 2003 e marzo 2005 sono stati selezionati in Europa 221 cani. Nove soggetti in seguito sono stati esclusi dall indagine, riducendo così a 212 il numero dei cani con rigurgito mitralico (MR) da moderato a grave causato da MMVD. (International Small Animal Cardiac Health Councils Classification classe II (n=190) e classe III (n=21). METODI È stato condotto uno studio di campo in doppio cieco su cani randomizzati che ricevevano lo spironolattone (2 mg/kg una volta al giorno) o il placebo in associazione alla terapia convenzionale (inibitori dell enzima di conversione dell angiotensina, più furosemide e digossina se necessario). L endpoint primario includeva la morte cardiaca, l eutanasia o un grave peggioramento dell MR. RISULTATI L endpoint primario è stato raggiunto da 11/102 cani (10.8%) nel gruppo dello spironolattone (6 morti, 5 peggioramenti) vs i 28//110 cani (25.5%) del gruppo di controllo (4 morti, 8 eutanasie, *Articolo apparso su: J. Vet. Intern. Med. 2010; II:1-11. Efficacy of Spironolactone on Survival in Dogs with Naturally Occurring Mitral Regurgitation Caused by Myxomatous Mitral Valve Disease. Testo tradotto a cura della Redazione. 6 peggioramenti). Il rischio di raggiungere l endpoint composto è stato significativamente ridotto del 55% (rapporto di rischio [HR] =0.45; limiti di confidenza [CL], ; log rank test, P=.017). Il rischio di morte cardiaca o di eutanasia si è significativamente ridotto del 69% (HR =0.31; 95% CL, ; P=.0071). Il numero di cani che non hanno completato lo studio per problemi cardiaci o per altri motivi è risultato simile nel gruppo dello spironolattone (67/102) e nei gruppi di controllo (66/110). CONCLUSIONI E RILEVANZA CLINICA Lo spironolattone associato alla terapia cardiaca convenzionale riduce il rischio di raggiungere l endpoint primario (morte cardiaca, eutanasia o grave peggioramento) nei cani con moderata o grave MR causata da MMVD. PAROLE CHIAVE Cane, Prova Clinica, Medicina basata sull evidenza, Insufficienza cardiaca. SIGLE ACEi: inibitore dell enzima di conversione dell angiotensina CHF: insufficienza cardiaca congestizia CL: limiti di confidenza DCM: cardiomiopatia dilatativa GCP: Buone Pratiche Cliniche HF: insufficienza cardiaca HR: rapporto di rischio ISACHC: International Small Animal Cardiac Health Council MMVD: degenerazione mixomatosa della valvola mitralica MR: rigurgito mitralico RAAS: Sistema renina-angiotensina-aldosterone RALES: Randomized Aldactone Evaluation Study VHS: vertebral heart size La fisiopatologia dell insufficienza cardiaca congestizia (CHF) nel cane coinvolge diversi meccanismi neuro-ormonali, quali il sistema 29
2 F. Bernay adrenergico, il sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS) e l endotelina. Tutti questi sistemi agiscono per compensare il deterioramento della funzionalità cardiaca, ma alcuni hanno effetti deleteri a lungo termine promuovendo in tal modo la progressione del CHF. È noto che l aldosterone regola la ritenzione di acqua e di sodio, con conseguente aumento dei volume del liquidi intracellulari che porta ad un aumento del precarico cardiaco (1). Inoltre, l aldosterone ha un azione diretta sul miocardio e sull endotelio vascolare (2-4). L esposizione cronica ad alte concentrazioni di aldosterone ha dimostrato di indurre fibrosi nell uomo e nei roditori, condizione questa peggiorativa delle cardiopatie (1, 5, 6). Gli inibitori dell enzima di conversione dell angiotensina (ACEi) e la furosemide sono comunemente prescritti per il trattamento del CHF. Gli ACEi inibiscono la cascata del sistema renina-angiotensinaaldosterone, ma il grado di soppressione dell enzima di conversione dell angiotensina (ACE) appare insufficiente per prevenire completamente la secrezione di aldosterone nell uomo o nel cane affetti da CHF che ricevono la terapia standard (7-10). In modo particolare, i diuretici come la furosemide hanno mostrato di stimolare la secrezione di aldosterone (11). L aggiunta di un antagonista selettivo recettoriale dell aldosterone appare pertanto essere indicato in questo contesto. Lo spironolattone, un 17-lattone di sintesi, è un antagonista competitivo dei recettori dei mineralcorticoidi (12). In pazienti umani affetti da CHF, il Randomized Aldactone Evaluation Study (RALES) ha dimostrato il benefico effetto dello spironolattone quando associato alla terapia convenzionale (ACEi, diuretici d ansa, digossina) (13). Il rilevamento di un 31% di riduzione del rischio mortalità (cause cardiache) nei pazienti trattati con spironolattone ha indotto, per motivi etici, un anticipata conclusione dello studio. Dato che per l aldosterone è possibile pensare ad un suo coinvolgimento nella fiosiopatologia dell insufficienza cardiaca del cane (HF), studi clinici di campo sono stati condotti allo scopo di verificare l ipotesi che la somministrazione di spironolattone, in cani che ricevono la terapia convenzionale, possa determinare un esito più favorevole rispetto a cani che ricevono un placebo in aggiunta alla sola terapia convenzionale. Scopo della prova è stato quello di valutare l effetto della terapia con spironolattone sulla morte cardiaca improvvisa, nell eutanasia per motivi cardiaci o sul peggioramento dello scompenso cardiaco in confronto con un placebo in cani con moderato o grave rigurgito mitralico dovuto alla degenerazione mixomatosa della valvola mitralica (MMVD). MATERIALI E METODI Animali Duecentoventuno (221) cani provenienti da 32 ambulatori in Francia (94 cani), Germania (81 cani), Belgio (42 cani) e Italia (4 cani) sono stati selezionati durante il periodo febbraio marzo Lo studio è terminato nel maggio I cani inclusi arrivavano da una prima visita o da referenza. Disegno dello Studio Lo studio, di tipo multicentrico, è stato effettuato in doppio cieco, prospettico, controllato e randomizzato. Lo svolgimento completo della prova clinica (ideazione, monitoraggio, gestione dei dati, analisi e rapporto) è stato condotto in accordo alle Buone Pratiche Cliniche (GCP) (14) e alle richieste dell Agenzia Europea per i Medicinali (EMA). I proprietari hanno rilasciato il loro consenso informato prima dell inizio dello studio e hanno avuto la possibilità di ritirare il loro animale in qualunque momento dello studio. Al momento della pianificazione dello studio la maggior parte dei farmaci veterinari era già stata autorizzata e prove cliniche erano già state condotte per un periodo di pochi mesi. Lo studio è stato concepito con lo scopo di verificare a breve e a lungo termine gli effetti cronici dei farmaci usati. Per tale motivo il follow-up è stato suddiviso in due stadi consecutivi. Nel primo stadio i cani sono stati reclutati in due studi separati: uno studio di 2 mesi, in cui il trattamento con furosemide era obbligatorio per l inclusione, e uno studio di 3 mesi in cui il furosemide non era permesso al momento dell inclusione. Dopo un breve periodo di valutazione, l omogeneità del trattamento è stata considerata cruciale e giustificata la separazione dei due protocolli. Entrambi gli studi sono stati condotti in parallelo usando lo stesso protocollo valutativo e gli stessi endpoints. Il secondo stadio era composto da uno studio di 12 mesi ed includeva i cani che avevano completato entrambi i primi studi (Fig. I). I cani che avevano completato i primi studi entravano nello studio di 12 mesi, dove continuavano a ricevere il medesimo trattamento. Criteri di inclusione All inizio del primo stadio sono stati selezionati cani di qualunque razza e sesso che presentavano rigurgito mitralico (RM) di grado moderato o grave causato da mixomatosi della valvola mitralica (secondo la classificazione dell International Small Animal Cardiac Health Council [ISACHC] di classe II e III). Il protocollo originale dello studio includeva inoltre cani con cardiomiopatia dilatativa (DCM), ma questi soggetti sono stati esclusi dall analisi per via del numero esiguo di animali selezionati (vedi Risultati ). La conferma della mixomatosi della valvola mitralica (MMVD), che è causa della patologia cardiaca e del suo grado di gravità, è stata ottenuta sulla base della sintomatologia di questa sindrome (MMVD) (tipiche lesioni valvolari e rigurgito mitralico (MR) rilevati mediante esame ecocardiografico (15) e misurazione della dilatazione del cuore mediante radiografia del torace (vertebral heart size - [VHS] >10.5) (16). Per essere inclusi, i cani dovevano inoltre aver presentato almeno 3 dei seguenti sintomi clinici, con almeno uno tra tosse, dispena, sincope e almeno uno tra diminuita attività, diminuita mobilità e comportamento anomalo. 30
3 Rivista di Zootecnia e Veterinaria, vol. 43, n. 2, 2010 Studio a 3 mesi cani Terapia Standard: ACEI +/- Digossina (no Furosemide al Giorno 0) Studio a 2 mesi - 99 cani Terapia Standard: ACEI + Furosemide al Giorno 0 +/- Digossina 9 cani ritirati per malattie cardiache 9 cani ritirati non a causa di malattie cardiache 9 cani ritirati per malattie cardiache 9 cani ritirati non a causa di malattie cardiache 35 non selezionati nello studio a 12 mesi 60 cani 63 cani 21 non selezionati nello studio a 12 mesi Studio a 12 mesi cani Terapia Standard: ACEI +/- Furosemide +/- Digossina 21 ritirati per cause cardiache 23 ritirati non per cause cardiache 79 cani che hanno completato lo studio Figura I - Disegno degli Studi. Tutti i cani hanno ricevuto un ACE inibitore al momento o prima dell inclusione nello studio a 3 mesi, o almeno un mese prima nello studio a 2 mesi. Qualsiasi ACE inibitore era prescrivibile, alle dosi preconizzate dal produttore, purché regolarmente presente sul mercato in Europa. La terapia con Furosemide non era permessa al momento dell inclusione nello studio a 3 mesi ed era invece obbligatoria all inclusione nello studio a 2 mesi. Tutti i cani che avevano completato uno dei due studi iniziali potevano essere inclusi nello studio a 12 mesi, col consenso del proprietario. Criteri di esclusione I cani non potevano essere selezionati per lo studio se stavano assumendo farmaci per il cuore, in aggiunta ad ACE inibitori, furosemide, digossina e L-carnitina. Non erano inclusi anche se presentavano edema polmonare acuto, una malattia cardiaca congenita, una aritmia grave o altre patologie quali diabete, iperadrenocorticismo, neoplasie, grave compromissione epatica o renale, o se erano già trattati con farmaci, i β-bloccanti e i calcio antagonisti, in grado di interferire con la valutazione d efficacia dei farmaci dello studio. Le cagne gravide non erano selezionabili poiché non erano a disposizione dati sulla sicurezza d impiego dei farmaci di saggio in animali gravidi. Randomizzazione e condizioni in cieco Le liste di randomizzzazione sono state create mediante uno specifico programma, formando blocchi di 6 con un rapporto di 1:1, allo scopo di assicurare un equivalente numero di cani per ciascun gruppo di trattamento. Gli sperimentatori hanno ricevuto un gruppo di schede per i trattamenti che riportavano 6 numeri consecutivi corrispondenti ad un blocco. Ciascuna scheda di trattamento era identificata dal numero randomizzato. Dato che il placebo era identico, sia in apparenza sia nel confezionamento, allo spironolattone, né il Veterinario né il proprietario erano al corrente di quale gruppo di trattamento si trattasse, assicurando in tal modo la condizione di doppio cieco. La condizione di doppio cieco era interrotta solo dallo statistico dopo il completamento del primo studio e l elaborazione dei dati. Le condizioni di doppio cieco sono state mantenute per tutto il periodo di follow-up dei due stadi per gli sperimentatori, i proprietari e i monitor. 31
4 F. Bernay I cani hanno mantenuto lo stesso numero identificativo per tutto il periodo dello studio e sono stati tenuti nello stesso gruppo di trattamento. Non è stata fatta alcuna riallocazione. Trattamento Tutti gli animali hanno ricevuto una terapia convenzionale che includeva almeno un ACE inibitore. La furosemide era autorizzata dopo il Giorno 5, se necessario, nello studio a 3 mesi e da almeno un giorno prima della inclusione nello studio a 2 mesi. Durante la fase di follow-up i veterinari potevano modificare il dosaggio di furosemide, iniziare o interrompere il trattamento con il farmaco. Era permessa la terapia con digossina, L-carnitina o con entrambi. Oltre alla terapia convenzionale, i cani hanno ricevuto sia lo spironolattone sia il placebo. Lo spironolattone è stato somministrato per via orale al dosaggio di 2 mg/kg /giorno con il cibo. Il dosaggio reale raggiunto è stato di 2.33±0.34 mg/kg/die (Media±DS), sulla base dei risultati ottenuti nello studio per la determinazione della dose e i risultati degli studi di farmacocinetica 17. Sono state impiegate compresse frazionabili da 10, 40 e 80 mg. Piano di valutazione In entrambi i primi studi gli esami sono stati effettuati secondo un piano valutativo simile. L esame clinico completo, la radiografia toracica, l elettrocardiogramma, l ecocardiografia, l esame delle urine e la raccolta di campioni di sangue sono stati eseguiti al Giorno 0. Gli esami clinici e radiografici e la raccolta di campioni di sangue sono stati condotti durante la prima settimana, al Giorno 28 (tranne la radiografia), al Giorno 56 e al Giorno 84. Nello studio a lungo termine gli accertamenti clinici e radiografici sono stati condotti con scadenze trimestrali. Gli esami ecocardiografici sono stati intrapresi al momento dell inclusione e dopo 6 e 12 mesi. I dati prospettici e le variabili di sicurezza saranno descritti in un successivo articolo. VALUTAZIONE CLINICA Il protocollo includeva la valutazione di variabili cliniche quali tosse, dispnea, intolleranza all esercizio (vale a dire mobilità all aperto, attività in casa, comportamento in ambulatorio) e sincope (Tabella 1). Radiografie laterali e dorsali toraciche sono state eseguite per valutare le dimensioni del cuore (mediante Buchanan VHS) (16) e la presenza di edema polmonare. Sono state effettuate misurazioni ecocardiografiche di routine: misurazione M-Mode per la dimensione del ventricolo sinistro (LV), 2D (bidimensionale) per la diagnosi e misurazione del rapporto atrio sinistro/aorta (LA/Ao) (15). La classificazione dello stadio di scompenso cardiaco (HF) al momento dell inclusione è stato valutato in accordo all ISACHC (18). Valutazione della sopravvivenza L endpoint primario era costituito da morte cardiaca, eutanasia per rigurgito mitralico (MR) o grave peggioramento del rigurgito mitralico (MR). Il peggioramento del rigurgito mitralico si aveva quando si riteneva necessario avviare una terapia cardiaca non autorizzata o aumentare il dosaggio della furosemide oltre i 10 mg/kg/die, allo scopo di prevenire il rischio mortalità da scompenso cardiaco congestizio (CHF). Quando i cani morivano spontaneamente o erano sottoposti ad eutanasia, lo sperimentatore doveva specificare se la causa della morte era dovuta a problemi cardiaci e specificare la causa precisa. La mortalità cardiaca è stata determinata raggruppando le morti naturali e le eutanasie conseguenti a cause cardiache. Gestione Dati I dati grezzi sono stati inseriti da due operatori indipendenti, automaticamente confrontati e aggiustati in funzione delle risposte degli sperimentatori alle domande. È stato condotto un audit del database prima della sua finalizzazione e della sua valutazione statistica. La gestione dei dati e il controllo qualità sono stati condotti da CEVA SANTE ANIMALE secondo le procedure interne per le GCP. Analisi Statistica Le analisi sono state condotte con software SAS (Institute Inc. versione 9.1) e Stata versione 8.0. Tutte le analisi erano a due code. Le condizioni di applicabilità sono state verificate prima di avviare l analisi statistica. Variabili quantitative: normalità della distribuzione, assunzione della omogeneità delle varianze (F-test, t-test, test di Satterthwaite ove opportuno). Variabili qualitative: test del Chi quadro o test esatto di Fisher secondo le frequenze attese. Analisi della sopravvivenza: long rank test, che è un test non parametrico e come tale non richiede alcuna ipotesi distribuzionale degli eventi nel tempo. Modello di Cox: ipotizza che il grado dell evento rischio non si modifica nel tempo ma che il rapporto degli eventi rischio tra due individui è costante. È nota come ipotesi dei rischi proporzionali che richiede che il rapporto dei rischi fra 2 valori qualsiasi di una covariata non si modifichi col tempo. L analisi descrittiva e l iniziale comparabilità tra i gruppi di trattamento sono stati fatti in base alle caratteristiche e i criteri clinici registrati al momento dell inclusione nei 2 primi studi. I dati di base sono stati confrontati fra i gruppi di trattamento allo scopo di controllare che l esclusione di un cane richiesta da un proprietario non producesse bias (errori sistematici) e anche errori tra questi due gruppi (effetto dello studio). Per le variabili quantitative è stato usato il t-test a due campioni (Student s t-test) per confron- 32
5 Rivista di Zootecnia e Veterinaria, vol. 43, n. 2, 2010 TABELLA 1 Caratteristiche di base di 212 cani con MMVD in popolazione ITT (media±ds o numero e percentuale). Spironolattone (n=102) Controllo (n=110) Valore di P (Effetto del trattamento) Valore di P (Effetto dello Studio) Età (anni) 11.2 ± ± Peso (kg) 11.1 ± ± Sesso Maschio 64 (62.7%) 62 (56.4%) Femmina 38 (37.3%) 48 (43.6%) Razze a Poodle 19 (18.8%) 19 (17.3%) Dachshund 10 (9.9%) 7 (6.4%) Yorkshire Terrier 9 (8.9%) 13 (11.8%) Cavalier King Charles 10 (9.9%) 6 (5.5%) Incroci 19 (18.8%) 30 (27.3%) Altre 34 (33.7%) 35 (31.8%) Eziologia a MMVD 94 (92.2%) 100 (90.9%) MMVD+DCM 8 (7.8%) 10 (9.1%) Classificazione ISACHC a Stadio iniziale II 24 (23.5%) 20 (18.4%) Stadio II 65 (63.7%) 81 (74.3%) Stadio III 13 (12.8%) 8 (7.3%) Trattamento prima dell inclusione ACE-Inibitore 102 (100%) 110 (100%) Benazepril 49 (48.0%) 62 (56.4%) Enalapril 21 (20.6%) 15 (13.6%) Imidapril 7 (6.9%) 11 (10.0%) Ramipril 25 (24.5%) 22 (20.0%) Furosemide 42 (41.2%) 56 (50.9%) Digossina 5 (4.9%) 4 (3.6%) Durata del trattamento cardiaco prima dell inclusione ACEI (giorni) 290 ± ± Furosemide (giorni) 169 ± ± Tosse Nessuna 5 (4.9%) 6 (5.5%) Occasionale 44 (43.1%) 48 (43.6%) Frequente 48 (47.1%) 44 (40.0%) Persistente 5 (4.9%) 12 (10.9%) Dispnea Nessuna 31 (30.4%) 35 (31.8%) Moderata 66 (64.7%) 73 (66.4%) Grave 5 (4.9%) 2 (1.8%) Sincope Nessuna 85 (83.3%) 99 (90.0%) < 4 al mese 13 (12.8%) 11 (10.0%) > 4 al mese 4 (3.9%) 0 (0%) Mobilità Alta 17 (16.7%) 19 (17.3%) Moderata 63 (61.8%) 68 (61.8%) Bassa 19 (18.6%) 21 (19.1%) Nessuna 3 (2.9%) 2 (1.8%) Attività Alta 12 (11.8%) 16 (14.6%) Moderata 73 (71.6%) 79 (71.8%) Bassa 17 (16.7%) 14 (12.7%) Nessuna 0 (0%) 1 (0.9%) Atteggiamento Normale 39 (38.2%) 49 (44.6%) Ridotto 60 (58.8%) 55 (50.0%) Minimo 3 (2.9%) 5 (4.6%) Inattivo 0 (0%) 1 (0.9%) 33
6 F. Bernay TABELLA 1 (continuazione) Spironolattone (n=102) Controllo (n=110) Valore di P (Effetto del trattamento) Valore di P (Effetto dello Studio) Raggi X/Ecocardiografia Dimensione cuore (vertebrale) a 11.8 ± ± Rapporto La/Ao b 1.8 ± ± Esami Biochimici c Creatinina (μmol/l) 80.6 ± ± Urea (mmol/l) 8.6 ± ± Potassio (mmol/l) 4.7 ± ± a Un valore mancante. b Due valori mancanti. c Tre valori mancanti. Mobilità (all aperto): Alta, il cane ha un forte desiderio e interesse di uscire per passeggiare o giocare. Sembra attento e responsivo all ambiente circostante. Moderata, il cane ha un certo interesse e desiderio di uscire a passeggiare o a giocare. Appare attento all ambiente circostante. Bassa, il cane ha poco interesse ad uscire per correre e o passeggiare, gioca di rado, non appare molto attento all ambiente circostante. Nessuna, il cane non ha alcun interesse ad uscire, incapace di camminare per brevi distanze senza sviluppare dispnea. Attività: (in casa): Alta: il cane si muove a suo agio, sale le scale o corre per brevi distanze. Il cane è attento, reagisce all ambiente e risponde agli stimoli esterni. Moderato, il cane ha una tendenza a rimanere inattivo, ma si alza e gira per casa poche volte al giorno. Ha difficoltà con le scale e non riesce a percorrere lunghe distanze. E responsivo agli stimoli esterni. Bassa, il cane è inattivo per tutto il giorno e sì alza sol per mangiar, bere e urinare. Risponde agli stimoli con difficoltà. Nessuna, il cane si alza o si muove solo se fortemente incoraggiato, incapace a percorre brevi distanze senza sviluppare dispnea. Comportamento (in ambulatorio): Normale, mostra la sua usuale attività, cane attento e responsivo. Ridotta, attività moderatamente depressa anche se il cane risponde agli stimoli esterni, s alza e si muove per l ambiente. Minima: livelli di attività minimi, il cane risponde con difficoltà e s alza o si muove solo dietro un significativo incoraggiamento. Inattivo, il cane è molto abbattuto o ipossico, non si muove se non forzato a farlo. MMVD sindrome mixomatosa della valvola mitrale, DCM, cardiomiopatia dilatativa; ISACHC, International Small Animal Cardiac Health Council. tare i valori medi. L ipotesi della omogeneità delle varianze è stata verificata mediante l F-test (Fisher). In caso di assenza di omogeneità, si è applicata la correzione di Satterthwaite. Per le variabili qualitative sono stati usati i test del chi quadro e il test esatto di Fischer per confrontare le frequenze tra i gruppi di trattamento. La percentuale di morbidità-mortalità o eventi di mortalità alla fine del follow-up è stata comparata fra gruppi col test esatto di Fisher. Le curve di sopravvivenza sono state ottenute mediante metodo Kaplan-Meier. L analisi di sopravvivenza, che ammette la censura dei cani quando non potevano più essere osservati, è stata condotta tramite il long rank test per comparare la sopravvivenza dei due gruppi di trattamento e per mezzo del modello multifattoriale di Cox a rischi proporzionali, per valutare l impatto di alcune covariate quali: studio di origine, durata del trattamento cardiaco prima dell inclusione (< o > durata mediana di 140 giorni) e prescrizione di furosemide (sì/no). Sono stati inoltre valutati il rapporto di rischio (HR) coi suoi limiti di confidenza al 95%. L analisi dell omogeneità della popolazione è stata ricavata dai dati della Intention To Treat (ITT) (la popolazione selezionata e trattata qualunque fosse stata l aderenza al protocollo). Questo perché le ragioni di non aderenza al protocollo possono essere relative alla prognosi e alla possibile introduzione di errori sistematici nell analisi della sopravvivenza condotti sulla popolazione selezionata secondo il protocollo (protocollo di studio strettamente rispettato) (19). Le analisi della sopravvivenza sono state condotte sia per l ITT sia per le popolazioni selezionate secondo il protocollo. Le esclusioni dalla popolazione selezionate secondo il protocollo sono state fatte in condizioni di cieco. Il livello di significatività è stato fissato per P<.05. I valori sono riportati come media±ds. RISULTATI Caratteristiche di base dei cani all inclusione Sono stati selezionati duecentoventuno (221) cani. Solo sette soggetti presentavano cardiomiopatia dilatativa (DCM) e sono stati esclusi dalla prova. Altri due cani sono andati persi durante il follow-up prima della prima visita, abbassando così a 212 il numero di cani con MMVD (popolazione Intention To Treat). Di questi 212 cani, 22 non hanno proseguito lo studio perché in base al protocollo presentavano: ingrossamento del cuore (VHS <10.5) al momento dell inclusione (3 per ciascun gruppo), inadeguato trattamento prima dell inclusione (3 nel gruppo spironolattone e 1 nel gruppo di controllo), scarsa aderenza al regime di trattamento previsto (7 e 5 nel gruppo spironolattone e nel gruppo di controllo, rispettivamente). Complessivamente, il numero della popolazione selezionata secondo il protocollo ammontava a 190 cani. I dati presentati riguardano solo i 212 cani della popolazione ITT (Intention To Treat) e sono stati comparati fra i due gruppi di trattamento (Tabella 1: effetto del trattamento). A causa dei differenti protocolli nei due studi a 34
7 Rivista di Zootecnia e Veterinaria, vol. 43, n. 2, 2010 TABELLA 2 Risultati durante i 15 mesi di follow-up dei 212 cani nella popolazione Intention To Treat e dei 190 cani nella popolazione secondo il protocollo (in parentesi). Gruppo Spironolattone Gruppo Controllo Totale n = 1 Studi Studio Totale n = 1 Studi Studio Totale n = 212 (190) 12 mesi 102 (88) 12 mesi 110 (102) Endpoint raggiunto 6 (4) 5 (5) 11 (9) 12 (11) 16 (15) 28 (26) 39 (35) Morte cardiaca 4 (2) 2 (2) 6 (4) 6 (6) 8 (8) 14 (14) Eutanasia per MR (3) 4 (4) 8 (7) Grave peggioramento dell MR 2 (2) 3 (3) 5 (5) 2 (2) 4 (3) 6 (5) Casi Censurati 40 (32) 51 (47) 91 (79) 31 (28) 51 (48) 82 (76) 173 (155) Ritiro prematuro per motivi diversi da HF 10 (5) 16 (15) 26 (20) 5 (4) 7 (6) 12 (10) 38 (30) Malattie concomitanti 4 (2) 8 (7) 12 (9) 3 (3) 2 (2) 5 (5) Incidenti d auto 0 2 (2) 2 (2) 0 1 (1) 1 (1) Deviazione dal protocollo 2 (0) 0 2 (0) Perdita al follow-up 1 (1) 1 (1) 2 (2) 1 (0) 2 (2) 3 (2) Volontà del proprietario 3 (2) 5 (5) 8 (7) 1 (1) 2 (1) 3 (2) Non inclusi nello studio di 12 mesi per volontà del proprietario 30 (27) 30 (27) 26 (24) 26 (24) 56 (51) Follow-up di 15 mesi completato 35 (32) 35 (32) 44 (42) 44 (42) 79 (74) breve termine (la furosemide è stata ammessa in uno studio ma non nell altro) c erano significative differenze fra gli studi (Tabella 1: effetto dello studio), ma queste differenze non producevano differenze tra i gruppi di trattamento. Dalla popolazione ITT composta di 212 cani con MMVD, 123 cani di 179 che avevano completato il primo studio confluivano nello studio a 12 mesi. I rimanenti 56 cani non sono stati selezionati poiché i proprietari non erano intenzionati a sottoporre i loro animali agli esami previsti nel protocollo a 12 mesi. Questi 56 casi erano ben bilanciati tra i gruppi di trattamento (30/102 nel gruppo spironolattone e 26/110 nel gruppo di controllo, P=.34). Nelle popolazioni selezionate secondo il protocollo il numero di cani dopo il primo studio è risultato simile (Tabella 2). RISULTATO COMPLESSIVO Effetti della terapia Nei gruppi trattati con spironolattone e in quelli di controllo, rispettivamente il 34.3% (35/102) e il 40% (44/110) dei cani hanno completato lo studio a 15 mesi (Tabella 2). Nel gruppo trattato con spironolattone il 10.8% (11/102) dei cani ha raggiunto l endpoint primario e il 25.5% (28/110) nel gruppo di controllo (Test esatto di Fisher P=.0046) (Tabella 3). Cause di ritiro non correlate a scompenso cardiaco hanno riguardato la volontà del proprietario di fermarsi dopo il primo studio, insorgenza di malattie concomitanti, trasferimento dei proprietari e incidenti d auto. Ci sono stati un 54.9% (56/102) ed un 34.5% (28/110) rispettivamente nel gruppo spironolattone e in quello di controllo. La quota stimata di sopravvivenza nei 15 mesi è stata dell 84% per i cani trattati con spironolattone e terapia convenzionale, e del 66% per i cani appartenenti al gruppo di controllo (long rank test P=.071) (Tabella 3 e Figura II). Se si considera la sola mortalità (morte cardiaca ed eutanasia per rigurgito mitralico) la quota di sopravvivenza nei 15 mesi è stato del 92% nel gruppo dello spironolattone e del 73% nel gruppo di controllo (long rank test, P=.0071) (Tabella 3 e Figura III). I risultati della popolazione selezionata secondo il protocollo sono stati simili (Tabella 2 e 3). MODELLO DI RISCHIO PROPORZIONALE DI COX Il rapporto di rischio (HR) dell effetto del trattamento è stato di 0.45 (95% limiti confidenza (CL), , P=0.23). Questo rappresenta un 55% di riduzione nel rischio di morbidità-mortalità (grave deterioramento, morte naturale o eutanasia per rigurgito mitralico [HR]). Se fosse stata calcolata solo la mortalità (morte naturale ed eutanasia da HR) il rapporto di rischio sarebbe stato di 0.31 (95% CL, , P=.011), che avrebbe rappresentato un significativo 69% di riduzione nel rischio di mortalità. Le analisi dei dati di sopravvivenza hanno perciò mostrato che lo spironolattone ha diminuito la morbidità-mortalità a meno della metà e la mortalità a circa un terzo di quanto registrato nel gruppo di controllo (Figure IV, V; Tabella 3). Lo studio d origine (2 mesi o 3 mesi) e la durata del trattamento cardiaco prima del giorno 0 non hanno modificato il rapporto di rischio stimato sull effetto del trattamento, di suoi limiti di confidenza o la sua significatività statistica (Figure IV, V). Il concomitante trattamento con furosemide (che è stato ben bilanciato in entrambi i gruppi di trattamento) ha diminuito significativamente la probabilità di sopravvivenza (Figure IV, V). Non ha influito sul rapporto di rischio stimato sull effetto del trattamento. I risultati della popolazione secondo il protocollo sono stati simili (Tabelle 2 e 3). 35
8 F. Bernay TABELLA 3 Rapporto di rischio, tasso di sopravvivenza, tasso di eventi e long rank test che tiene conto sia gli eventi di morbilità-mortalità (morte cardiaca, eutanasia per MR e peggioramento dell MR) sia gli eventi di mortalità (morte cardiaca e eutanasia per MR). Popolazione Popolazione Intention Secondo To Treat Protocollo (n=212) (n=190) Effetto sull endpoint primario (morte cardiaca, eutanasia per MR e peggioramento dell MR) Rapporto di rischio a 0.45 [ ] 0.40 [ ] Riduzione del rischio b 55% 60% Grado di sopravvivenza stimato 84 versus 66% 85 versus 67% a 15 mesi (spiro vs ref.) Analisi della sopravvivenza P =.017 P =.015 (long rank test) Valore di P % di eventi alla fine del 10.8 versus versus 25.5 follow-up (spiro vs ref.) e Test esatto di Fisher P =.0046 P =.0053 Effetto sulla mortalità (morte cardiaca e eutanasia a causa dell MR) Rapporto di rischio a 0.31 [ ] 0.22 [ ] Riduzione del rischio b 69% 78% Grado di sopravvivenza stimato 92 versus 73% 93 versus 72% a 15 mesi (spiro vs ref.) Analisi della sopravvivenza P =.0071 P =.0026 (long rank test) Valore di P % di eventi alla fine del 5.9 versus versus 20.6 follow-up (spiro vs ref.) e Test esatto di Fisher P =.0019 P =.0006 Il tasso di sopravvivenza è risultato significativamente più elevato nei cani trattati con spironolattone. Similmente, i rischi per raggiungere l endpoint mortalità o dell endpoint morbidità-mortalità sono stati significativamente ridotti nei cani trattati con spironolattone. I risultati sono stati simili sia nell Intention To Treat sia per la popolazione secondo il protocollo. a Rapporto di rischio e 95% di limiti di confidenza. b Riduzione del rischio = 1-rapporto di rischio. DISCUSSIONE Conclusione dello studio Questo studio ha dimostrato che l aggiunta di spironolattone alla terapia cardiaca convenzionale riduce in modo significativo il rischio di morbilità e mortalità nei cani con MMVD se confrontato con la sola terapia convenzionale (ACE inibitori, più furosemide o digossina, se necessario). È stato registrato un 55% di riduzione del rischio di morbilità-mortalità cardiaca. Un maggiore 69% di riduzione del rischio di mortalità si è osservato quando sono stati analizzati solo i dati sulla mortalità. Questa differenza tra i gruppi di trattamento era basata sul maggior numero di cani che hanno raggiunto l endpoint nel gruppo di controllo (28/110) piuttosto che nel gruppo spironolattone (11/102), mentre il numero totale di cani che non ha completato lo studio Probabilità di sopravvivenza Figura II - Plot delle percentuali secondo Kaplan-Meier dei cani rimasti nello studio in funzione de tempo nei 212 cani della popolazione Intention To Treat. L endpoint includeva da morte cardica, eutanasia a causa di rigurgito mitralico e peggioramento del rigurgito mitralico. I cani trattati con spironolattone hanno avuto un significativo periodo più lungo di sopravvivenza nello studio. Probabilità di sopravvivenza Spironolattone Endpoint composto Giorni Controllo Morti per cause cardiache Spironolattone Giorni Controllo Figura III - Plot delle percentuali secondo Kaplan-Meier dei cani rimasti nello studio in funzione de tempo nei 212 cani della popolazione Intention To Treat quando le morti, correlate a cause cardiache (morte instantanea o per eutanasia per cause cardiache), erano incluse nell endpoint. I cani con degenerazione mixomatosa della valvola mitrale trattati con spironolattone hanno mostrato un significativo allungamento del tempo di sopravvivenza durante lo studio. per ragioni cardiache o altre ragioni (principalmente i cani non arruolati nello studio a 12 mesi e i prematuri ritiri per ragioni non imputabili al cuore) è risultato similare fra i gruppi di trattamento (67/102 e 66/110), rispettivamente nel gruppo spironolattone e nel gruppo di controllo) (Tabella 2). Quando le covariate sono state calcolate col modello dei rischi proporzionali di Cox, al trattamento con furosemide si è associato un significativo effetto negativo, sebbene il positivo effetto dello spi- 36
9 Rivista di Zootecnia e Veterinaria, vol. 43, n. 2, 2010 Bernay et al. Effetto spironolattone (Modello 1) Effetto Primo Studio (Modello 2) 2 mesi vs 3 mesi Durata del trattamento prima dell inclusione (Modello 3) >140 giorni (mediana) vs <140 giorni Prescrizione furosemide (Modello 4) prescrizione vs non prescrizione Aumento probabilità Diminuzione probabilità 0,1 di sopravvivenza 1 di sopravvivenza 10 HR e 95% CL, scala log Figura IV - Rapporti di rischio ( ) e 95% intervallo di confidenza (linee orizzontali, scala log) ottenute dalle analisi multifattoriali per i rischi proporzionali di Cox dei 212 cani nella popolazione Intention To Treat. L endpoint era l endpoint composto morte cardiaca, eutanasia da rigurgito mitralico o peggioramento del rigurgito mitralico. Modello di rischio proporzionale di Cox: Modello 1: regressione del Cox dell effetto trattamento senza qualsiasi altra variabile. Gruppo ditrattamento: HR=0.45, 95% CL [ ]; P=.023 Modello 2: regressione del Cox dell effetto trattamento e 1 studio. Gruppo di trattamento: HR=0.46 ; 95% CL [ ]; P= studio HR=0.67; 95% CL [ ]; P=.22 L HR (0.46) è simile all HR (0.45) prima dell aggiustamento. Modello 3: regressione del Cox dell effetto trattamento e durata del trattamento prima dell inclusione. Gruppo di trattamento: HR =0.45; 95% CL [ ]; P=.023 Durata del trattamento prima dell inclusione:: HR 1.00; 95% CL [ ], P=.99 L HR (0.45) è uguale all HR (0.45) prima dell aggiustamento. Modello 4: regressione del Cox dell effetto trattamento e trattamento con furosemide Gruppo di trattamento: HR =0.46; 95% CL [ ]; P=.031 Trattamento con Furosemide: HR=2.56; 95% CL[ ]; P=.013 L HR (0.46) è simile a quello stimato prima dell aggiustamento. Effetto del trattamento: il rapporto di rischio è stimato come 0.45 o 0.46 in tutti i modelli con P= e con 95% CL attorno a Il trattamento con spironolattone è significativamente associato ad una riduzione del rischio di raggiungere l endpoint. ronolattone non venisse modificato. In questa analisi, la covariata furosemide è stata definita come prescritta in ogni momento dello studio o non prescritta affatto, perché è stato impossibile analizzare questa covariata nel dettaglio (dosaggio, durata) per via dei molteplici cambiamenti nel dosaggio e, in taluni casi, per via della discontinuità di trattamento con furosemide nei 15 mesi di followup. Una possibile spiegazione per la maggiore morbilità/mortalità e probabilità di morte, osservata in entrambi i gruppi di trattamento quando la furosemide era prescritta, potrebbe essere che i cani trattati con furosemide erano in uno stato di malattia più avanzato al momento dell inclusione. È possibile fare confronti con altri studi pubblicati sulla sopravvivenza di cani con scompenso cardiaco (HF) causato da MMVD, prestando particolare attenzione alla definizione degli endpoints, alla gravità e alla diagnosi di HF al momento dell inclusione e ai trattamenti cardiaci concomitanti. Il presente studio è uno dei più ampi studi clinici di campo condotti sulla sopravvivenza nei cani con moderato o grave HF da MMVD con 221 cani selezionati vs i 260, 162 e 110 degli studi QUEST (20), BENCH (21), e LIVE (22), rispettivamente. I dati di base e l analisi della sopravvivenza indicano che la popolazione inclusa in questo studio era composta da un più elevato numero di casi meno gravi in confronto con gli studi citati precedentemente: l 86.9% (190/212) dei casi con MMVD hanno iniziato lo studio con un ISACHC di classe II in confronto con il 67% dei casi del BENCH, lo 0 e l 89% al New York Heart Association classi II e III rispettivamente, nello studio LIVE e soprattutto negli stadi più avanzati nello studio QUEST. Così, la quota di sopravvivenza stimata (morbilità-mortalità) è stata del 66% nel nostro gruppo di 37
10 F. Bernay Mortalità Effetto spironolattone (Modello 1) Effetto primo studio (Modello 2) 2 mesi vs 3 mesi Durata del trattamento prima dell inclusione (Modello 3) >140 giorni (mediana) vs <140 giorni Prescrizione furosemide (Modello 4) prescrizione vs non prescrizione Aumento probabilità Diminuzione probabilità 0,1 di sopravvivenza 1 di sopravvivenza 10 HR e 95% CL, scala log Figura V - Rapporti di rischio ( ) e 95% intervallo di confidenza (linee orizzontali, scala log) ottenute dalle analisi multifattoriali per i rischi proporzionali di Cox dei 212 cani nella popolazione Intention To Treat quando la morte per cause cardiache (morte instantanea o eutanasia per rigurgito mitralico) è stata usata come endpoint. Modello di rischio proporzionale di Cox: Modello 1: regressione del Cox dell effetto trattamento senza qualsiasi altra variabile. Gruppo ditrattamento: HR=0.31, 95% CL [ ]; P=.011 Modello 2: regressione del Cox dell effetto trattamento e 1 studio. Gruppo di trattamento: HR=0.32 ; 95% CL [ ]; P= studio HR=0.63; 95% CL [ ]; P=.24 L HR (0.32) è simile all HR (0.31) prima dell aggiustamento. Modello 3: regressione del Cox dell effetto trattamento e durata del trattamento prima dell inclusione. Gruppo di trattamento: HR =0.31; 95% CL [ ]; P=.011 Durata del trattamento prima dell inclusione:: HR 1.07; 95% CL [ ], P=.88 L HR (0.31) è uguale all HR (0.31) prima dell aggiustamento. Modello 4: regressione del Cox dell effetto trattamento e trattamento con furosemide Gruppo di trattamento: HR = % CL [ ]; P=.031 Trattamento con Furosemide: HR=2.78; 95% CL[ ]; P=.023 L HR (0.32) è simile a quello stimato prima dell aggiustamento. Effetto del trattamento: il rapporto di rischio è stimato come 0.31 o 0.32 in tutti i modelli con P= e con 95% CL attorno a Il trattamento con spironolattone è significativamente associato ad una riduzione del rischio di raggiungere l endpoint. controllo a 15 mesi vs il 49% nel gruppo benazepril a 12 mesi (BENCH Study). La quota di prematuri ritiri per problemi cardiaci (grave deterioramento e morte) è stata del 25.5% nel nostro gruppo di controllo a 15 mesi, a fronte di un 48.1% nel gruppo enalapril a 17 mesi (LIVE Study). Il numero di pazienti che hanno raggiunto l endpoint nel presente studio è stato limitato dal ritiro di soggetti per altri motivi, principalmente dal desiderio dei proprietari di fermarsi dopo il primo studio. Nella maggioranza dei precedenti studi sulla sopravvivenza che hanno coinvolto cani con scompenso cardiaco congestizio (CHF), è stato calcolato il tempo medio di sopravvivenza. Poiché <50% della popolazione ha raggiunto gli endpoint nel presente studio, questi dati non potrebbero essere calcolati. Comunque il modo migliore di stimare le differenze fra 2 curve di sopravvivenza è la stima del rapporto di rischio che confronta la possibilità che un membro di ciascuna popolazione possa presentare un evento ad un dato momento. Questo è il metodo statistico consueto per riportare i risultati delle analisi di sopravvivenza in medicina umana. Esso è stato valutato solo in questo studio e negli studi BENCH e QUEST. Lo studio BENCH ha mostrato che il benazepril diminuiva il rischio di gravi o letali deterioramenti del 55% dopo 18 mesi. Nel presente studio tutti i cani erano stati trattati con un ACE inibitore, tuttavia lo spironolattone ha portato ad una riduzione del 55% del rischio di morte cardiaca, eutanasia a causa di MR suo peggioramento durante i 15 mesi di follow-up, a dimostrazione che l effetto positivo del trattamento con spironolattone è aggiuntivo a quello derivato dall uso di solo ACE inibitori. Dato che lo studio QUEST è uno studio controllato positivo, il rapporto di rischio non 38
11 Rivista di Zootecnia e Veterinaria, vol. 43, n. 2, 2010 può essere posto a confronto coi risultati provenienti da studi placebo controllati. Se consideriamo la riduzione del rischio di mortalità per cause cardiache, i dati conseguiti nei cani sono risultati più evidenti con un 69% di riduzione a 15 mesi con lo spironolattone che può essere positivamente confrontato con il 31% di riduzione osservato a 3 anni nel RALES (Studio Randomizzato di Valutazione di Aldolattone) in medicina umana (13). POSSIBILE MECCANISMO D AZIONE DELLO SPIRONOLATTONE Il positivo effetto dello spironolattone sulla sopravvivenza non è spiegato solo dagli effetti diuretici del farmaco. È stato osservato nei ratti (4, 23-25) e nell uomo (3, 26) che l aldosterone provoca fibrosi miocardica e perivascolare e modifica le funzioni endoteliali dei vasi (12, 37). Studi condotti in pazienti umani con CHF hanno mostrato che questi effetti sono contrastati dagli antagonisti dell aldosterone (27, 28). Studi in cani da laboratorio con MR causato da dissezione cordale hanno mostrato che il processo di rimodellamento miocardico in risposta al rigurgito mitralico è caratterizzato da una perdita del collagene interstiziale, processo che si ritiene mediato da metalloproteinasi (29). La perdita del collagene che circonda i miociti induce lo scivolamento dei miociti che è importante nella dilatazione cardiaca. Questi studi sperimentali hanno coinvolto cani sani di età comparabile con rigurgito mitralico indotto. La popolazione canina con MMVD e MR spontanee era costituita da soggetti di mezza età o anziana e i modelli sperimentali non possono completamente mimare la situazione in questi soggetti. Studi recenti hanno evidenziato che una percentuale di cani con MMVD spontanea presentava modificazioni dell arterie intramiocardiche che erano associate ad aree di fibrosi nel miocardio, le cosiddette fibrosi riparative (30). Gli stessi autori hanno suggerito che i più gravi cambiamenti arteriosclerotici intramiocardici e le più gravi fibrosi riparative riducono il tempo di sopravvivenza dall inizio della terapia cardiaca alla morte cardiaca o all eutanasia. Un effetto antifibrotico è stato inoltre descritto con l impiego di spironolattone ed eplerenone, un altro antagonista dell aldosterone, in situazioni di microembolizzazione coronarica e rapido pacing ventricolare in modelli sperimentali di cani con CHF (32, 33). Il modello del rapido pacing ventricolare causa un sovraccarico nelle camere cardiache (32). Questo modello ha mostrato una correlazione tra l aumento della frazione di volume del collagene interstiziale e le anormalità di conduzione nell atrio destro. In quello studio, lo spironolattone (15 mg/kg), ha avuto un significativo effetto positivo sullo sviluppo della fibrosi e sui cambiamenti di conduzione nell atrio destro in confronto al gruppo di controllo. Nel modello di microembolizzazione, un trattamento a tre mesi con eplelerone ha significativamente diminuito la frazione del volume di fibrosi interstiziale reattiva e ha diminuito la quantità di fibrosi riparativa nel miocardio. Quel modello ha indotto lo stress di parete a fine diastole del ventricolo sinistro ma in modo del tutto artificiale in confronto a quello che occorre spontaneamente nei cani. È possibile ritenere che i positivi effetti dello spironolattone sul tempo di sopravvivenza nel presente studio potrebbero in parte dipendere da un effetto contrastante dello spironolattone sulle modificazioni arteriosi e sul rimodellamento fibrotico. Limiti dello studio e ulteriori accertamenti A causa del basso tasso di occorrenza, non si sono potute includere tutte le covariate di interesse nella stessa analisi, ma gli effetti sono stati esaminati uno per uno. Siccome nessuna delle covariate ha avuto alcun effetto sull HR, si può ritenere che l HR sarebbe rimasto immodificato e significativo se si fosse potuto includere il tutto in una singola analisi. La perdita di follow-up a causa dei proprietari che desideravano che i loro cani non fossero selezionati per lo studio più lungo ha aumentato significativamente i casi di cani censurati (32.4% di casi censurati, 56/173, Tabella 2). Il tipo di ACE inibitore non è stato controllato nel presente studio, salvo che il farmaco doveva essere regolarmente registrato nella Comunità Europea. Per assicurare omogeneità dei gruppi e anche a causa del fatto che il pimobendan non era largamente usato in questi cani nei Paesi dove erano situate le strutture veterinarie al momento della pianificazione ( ), come terapia convenzionale è stata definita quella che includeva un ACE inibitore ±furosemide±digossina. In ogni caso sono aumentate le prescrizioni di pimobendan che ha mostrato di permettere il prolungamento del periodo di sopravvivenza dei cani con CHF come conseguenza di MMVD in confronto con un ACE inibitore (20, 34). Lo spironolattone era parte dell endpoint di insuccesso del trattamento nello studio QUEST, anche se questo studio non era stato concepito per studiare l interazione dell uso combinato delle sostanze. Ulteriori studi sono necessari per valutare i benefici clinici del pimobendan quando associato allo spironolattone. Inoltre, la ridotta dimensione della popolazione con DCM non ha permesso un analisi separata. Il vantaggio dello spironolattone in caso di cardiomiopatia dilatativa necessita di ulteriori approfondimenti. Concludendo, questo studio clinico di terapia con spironolattone per un periodo di 15 mesi in cani con moderata o grave MR causato da MMVD ha dimostrato un positivo effetto dello spironolattone quando associato alla terapia convenzionale. Il rischio di morte per causa cardiaca o di eutanasia è stato ridotto del 69% se comparato alla sola terapia convenzionale (ACE inibitore più furosemide o digossina, se necessario). Questi risultati supportano l uso dello spironolattone come parte del protocollo di trattamento dei cani con MMVD. 39
12 F. Bernay Note a Discussione Scientifica del Prilactone, European Medicine Agency, RINGRAZIAMENTI Gli Autori ringraziano i 32 sperimentatori che hanno selezionato i cani e se ne sono presi cura: Drs Abele, Bergerot, Borgarelli, Boudaroua, Bruyère, Chetboul, Colleie, Deprest, Desperiez, Doucet, Etienne, Gadeyne, Guéant, Kupfer, Hébert, Land, Leclerc, Louvet, Lutz, Mallet, Mens, Mergenthal, Planeix, Poirier, Porciello, Ramette, Rheinard-Muller, Rousselot, Roux, Spina, Vinck, Wittmann. BIBLIOGRAFIA 1. Tan LB, Schlosshan D, Barker D. Fiftieth anniversary of aldosterone: From discovery to cardiovascular therapy. Int J Cardiol 2004; 96: Weber KT, Brilla CG. Pathological hypertrophy and cardiac interstitium. Fibrosis and renin-angiotensin-aldosterone system. Circulation 1991; 83: Farquharson CA, Struthers AD. Aldosterone induces acute endothelial dysfunction in vivo in humans: Evidence for an aldosterone-induced vasculopathy. Clin Sci (Lond) 2002; 103: Pu Q, Neves MF, Virdis A, et al. Endothelin antagonism on aldosteroneinduced oxidative stress and vascular remodeling. Hypertension 2003; 42: Brilla CG, Weber KT. Reactive and reparative myocardial fibrosis in arterial hypertension in the rat. Cardiovasc Res 1992; 26: Brilla CG, Matsubara LS, Weber KT. Anti-aldosterone treatment and the prevention of myocardial fibrosis in primary and secondary hyperaldosteronism. J Mol Cell CardioI1993; 25: Pitt B. Escape of aldosterone production in patients with left ventricular dysfunction treated with an angiotensin converting enzyme inhibitor: Implications for therapy. Cardiovasc Drugs Ther 1995; 9: Haggstriim J, Hansson K, Karlberg BE, et al. Effects of longterm treatment with enalapril or hydralazine on the renin-angiotensinaldosterone system and fluid balance in dogs with naturally acquired mitral valve regurgitation. Am J Vet Res 1996; 57: Kvart C, Haggstriim J, Pedersen HD, et al. Efficacy of enalapril for prevention of congestive heart failure in dogs with myxomatous valve disease and asymptomatic mitral regurgitation. J Vet Intern Med 2002; 16: Atkins CE, Keene W, Brown W A, et al. Results of the veterinary enalapril trial to prove reduction in onset of heart failure in dogs chronically treated with enalapril alone for compensated, naturally occurring mitral valve insufficiency. J Am Vet Med Assoc 2007; 231: Hori Y, Katou A, Tsubaki M, et al. Assessment of diuretic effects and changes in plasma aldosterone concentration following oral administration of a single dose of furosemide or azosemide in healthy dogs. Am J Vet Res 2008; 69: Rocha R, Williams GH. Rationale for the use of aldosterone antagonists in congestive heart failure. Drugs 2002; 62: Pitt B, Zannad F, Remme WJ, et al. The effect of spironolactone on morbidity and mortality in patients with severe heart failure. N Eng J Med 1999; 341: US Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, Center for Veterinary Medicine. Good Clinical Practices, VICH GL9 final guidance, Chetboul V, Pouchelon JL, Bureau-Amaglio S, et al. Echocardiographie et echo-doppler du chien et du chat, Chapter 3, 1st ed. Masson: Paris; 1999: Buchanan JW, Bucheler J. Vertebral scale system to measure canine. heart size in radiographs. J Am Vet Med Assoc 1995; 206: Elliot J, Guyonnet J, Kaltsatos V. Experimental studies of the pharmacology of spironolactone in dogs. Proceedings of 18th ECVIM Congress, Ghent, Fox PR, Sisson D, Moise NS. Textbook of Canine and Feline Cardiology: Principles and Clinical Practice, 2nd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders; 1999: Montori VM, Gordon HG.Intention-to-treat principle. Can Med Assoc J 2001; 165: Haggstriim J, Boswood A, O Grady M, et at Effect of pimobendan or benazepril hydrochloride on survival times in dogs with congestive heart failure caused by naturally occurring myxomatous mitral valve disease: The Quest study. J Vet Intern Med 2008; The BENCH Study Group. The effect of benazepril on survival times and clinical signs of dogs with congestive heart failure: Results of a multicenter, prospective, randomized, double-blinded, placebo-controlled, long-term clinical trial. J Vet CardioI1999; 1: Ettinger SJ, Benitz AM, Ericsson GF, et al. Effects of enalapril maleate on survival of dogs with naturally acquired heart failure. J Am Vet Med Assoc 1998; 213: Virdis A, Neves MF, Amiri F, et al. Spironolactone improves angiotensin-induced vascular changes and oxidative stress. Hypertension 2002; 40: Sun Y, Zhang J, Lu L, et al. Aldosterone-induced inflammation in the rat heart: Role of oxidative stress. Am J Pathol 2002; 161: Blasi ER, Rocha R, Rudolph AE, et al. Aldosterone/salt induces renal inflammation and fibrosis in hypertensive rats. Kidney Int 2003; 63: Duprez DA, De Buyzere ML, Rietzschel ER, et al. Inverse relationship between aldosterone and large artery compliance in chronically treated heart failure patients. Eur Heart J 1998; 19: Shieh FK, Kotlyar E, Sam F. Aldosterone and cardiovascular remodelling: Focus on myocardial failure. J Renin Angiotensin Aldosterone Syst 2004; 5: Zannad F, Alia F, Dousset B, et al. Limitation of excessive extra-cellular matrix turnover may contribute to survival benefit of spironolactone therapy in patients with congestive heart failure: Insights from the randomized aldactone evaluation study (RALES). Rales investigators. Circulation 2000; 102: Dellltalia LJ, Balcells E, Meng QC, et al. Volume-overload cardiac hyperthrophy is unaffected by ACE inhibitor treatment in dogs. Am J PhysioI 1997; 273:H961-H Falk T, Jiinsson L, Olsen LH, et al. Arteriosclerotic changes in the myocardium, lung, and kidney in dogs with chronic congestive heart failure and myxomatous mitral valve disease. Cardiovasc PathoI 2006; 15: Falk T, Jiinsson L, Olsen LH, et al. Correlation of cardiac pathology and clinical findings in dogs with naturally occurring congestive heart failure. Proceedings of 17th Annual ECVIM Congress, Budapest, Yang S, Han W, Zhou H, et al. Effects of spironolactone on electrical and structural remodeling of atrium in congestive heart failure dogs. Chin Med J 2008; 121: Suzuki G, Morita H, Mishima T, et al. Effects of a long-term monotherapy with Eplerenone, a novel aldosterone blocker, on progression of left ventricular dysfunction and remodelling in dogs with heart failure. Circulation 2002; 106: Fuentes VL. Use of pimobendan in the management of heart failure. Vet Clin North Am Small Anim Pract 2004; 34:
Trials clinici. Disegni di studio
 Trials Clinici Dott.ssa Pamela Di Giovanni Studi descrittivi Disegni di studio Popolazioni Individui Studi analitici Osservazionali Sperimentali Studi di correlazione o ecologici Case report - Case series
Trials Clinici Dott.ssa Pamela Di Giovanni Studi descrittivi Disegni di studio Popolazioni Individui Studi analitici Osservazionali Sperimentali Studi di correlazione o ecologici Case report - Case series
Prilactone Offrite più Vita!
 Offrite più Vita! INNOVAZIONE IN CARDIOLOGIA Per offrire più vita completa il tuo protocollo terapeutico Il primo antagonista dell aldosterone con effetto antifibrotico in Veterinaria Miglioramento clinico
Offrite più Vita! INNOVAZIONE IN CARDIOLOGIA Per offrire più vita completa il tuo protocollo terapeutico Il primo antagonista dell aldosterone con effetto antifibrotico in Veterinaria Miglioramento clinico
INSUFFICIENZA CARDIACA CONGESTIZIA. L unica associazione di Benazepril & Spironolattone
 INSUFFICIENZA CARDIACA CONGESTIZIA L unica associazione di Benazepril & Spironolattone Angiotensina II e Aldosterone: 2 fattori chiave Durante la progressione dell insufficienza cardiaca, una riduzione
INSUFFICIENZA CARDIACA CONGESTIZIA L unica associazione di Benazepril & Spironolattone Angiotensina II e Aldosterone: 2 fattori chiave Durante la progressione dell insufficienza cardiaca, una riduzione
Effetti sull opinione di pazienti riguardo all utilizzo di un computer in uno studio medico nell assistenza ordinaria
 Effetti sull opinione di pazienti riguardo all utilizzo di un computer in uno studio medico nell assistenza ordinaria Christopher N. Sciamanna, Scott P. Novak, Bess H. Marcus. International Journal of
Effetti sull opinione di pazienti riguardo all utilizzo di un computer in uno studio medico nell assistenza ordinaria Christopher N. Sciamanna, Scott P. Novak, Bess H. Marcus. International Journal of
Scompenso cardiaco cronico: conoscerlo per aiutare il tuo cuore a farti vivere meglio
 Scompenso cardiaco cronico: conoscerlo per aiutare il tuo cuore a farti vivere meglio Scompenso cardiaco cronico: che cosa e? Il tuo medico ti ha detto che sei ammalato di scompenso cardiaco.... Ma che
Scompenso cardiaco cronico: conoscerlo per aiutare il tuo cuore a farti vivere meglio Scompenso cardiaco cronico: che cosa e? Il tuo medico ti ha detto che sei ammalato di scompenso cardiaco.... Ma che
Università del Piemonte Orientale. Corsi di Laurea Triennale. Corso di Statistica e Biometria. Elementi di Epidemiologia
 Università del Piemonte Orientale Corsi di Laurea Triennale Corso di Statistica e Biometria Elementi di Epidemiologia Corsi di Laurea Triennale Corso di Statistica e Biometria: Elementi di epidemiologia
Università del Piemonte Orientale Corsi di Laurea Triennale Corso di Statistica e Biometria Elementi di Epidemiologia Corsi di Laurea Triennale Corso di Statistica e Biometria: Elementi di epidemiologia
Comparabilità fra le somministrazioni successive effetto di trascinamento ( carry-over ) effetto di periodo
 Metodo epidemiologici per la clinica _efficacia / 2 Gli studi crossover Periodo 1 Periodo 2 R A N D O M A B A B Valutazione Tempo 1 0 1 1 2 0 2 1 Gli studi crossover Metodo epidemiologici per la clinica
Metodo epidemiologici per la clinica _efficacia / 2 Gli studi crossover Periodo 1 Periodo 2 R A N D O M A B A B Valutazione Tempo 1 0 1 1 2 0 2 1 Gli studi crossover Metodo epidemiologici per la clinica
Allegato I. Conclusioni scientifiche e motivi della variazione dei termini delle autorizzazioni all immissione in commercio
 Allegato I Conclusioni scientifiche e motivi della variazione dei termini delle autorizzazioni all immissione in commercio Conclusioni scientifiche Vista la relazione di valutazione del comitato di valutazione
Allegato I Conclusioni scientifiche e motivi della variazione dei termini delle autorizzazioni all immissione in commercio Conclusioni scientifiche Vista la relazione di valutazione del comitato di valutazione
L EFFICACIA DELLE MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO REALIZZATE IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2007-08
 1 La valutazione L EFFICACIA DELLE MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO REALIZZATE IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2007-08 Esiti occupazionali a 24 dalla partecipazione Vengono qui riassunti i risultati della
1 La valutazione L EFFICACIA DELLE MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO REALIZZATE IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2007-08 Esiti occupazionali a 24 dalla partecipazione Vengono qui riassunti i risultati della
Tasso di occupazione per fasce di età. Provincia di Piacenza, 2009 90,3 83,1 77,7 27,6 16,4. 15-24 anni. 25-34 anni. 45-54 anni.
 La situazione occupazionale dei giovani in provincia di Piacenza Premessa Una categoria di soggetti particolarmente debole nel mercato del lavoro è rappresentata, di norma, dai lavoratori di età più giovane
La situazione occupazionale dei giovani in provincia di Piacenza Premessa Una categoria di soggetti particolarmente debole nel mercato del lavoro è rappresentata, di norma, dai lavoratori di età più giovane
della Valvola Mitrale
 Informazioni sul Rigurgito Mitralico e sulla Terapia con Clip della Valvola Mitrale Supporto al medico per le informazioni al paziente. Informazioni sul Rigurgito Mitralico Il rigurgito mitralico - o RM
Informazioni sul Rigurgito Mitralico e sulla Terapia con Clip della Valvola Mitrale Supporto al medico per le informazioni al paziente. Informazioni sul Rigurgito Mitralico Il rigurgito mitralico - o RM
VERIFICA DELLE IPOTESI
 VERIFICA DELLE IPOTESI Nella verifica delle ipotesi è necessario fissare alcune fasi prima di iniziare ad analizzare i dati. a) Si deve stabilire quale deve essere l'ipotesi nulla (H0) e quale l'ipotesi
VERIFICA DELLE IPOTESI Nella verifica delle ipotesi è necessario fissare alcune fasi prima di iniziare ad analizzare i dati. a) Si deve stabilire quale deve essere l'ipotesi nulla (H0) e quale l'ipotesi
POLITERAPIE NEL PAZIENTE ANZIANO. Dipartimento Farmaceutico Azienda USL di Reggio Emilia
 POLITERAPIE NEL PAZIENTE ANZIANO Dipartimento Farmaceutico Azienda USL di Reggio Emilia PAZIENTI ANZIANI Maggiori utilizzatori di farmaci per la presenza di polipatologie spesso croniche Ridotte funzionalità
POLITERAPIE NEL PAZIENTE ANZIANO Dipartimento Farmaceutico Azienda USL di Reggio Emilia PAZIENTI ANZIANI Maggiori utilizzatori di farmaci per la presenza di polipatologie spesso croniche Ridotte funzionalità
Statistica. Lezione 6
 Università degli Studi del Piemonte Orientale Corso di Laurea in Infermieristica Corso integrato in Scienze della Prevenzione e dei Servizi sanitari Statistica Lezione 6 a.a 011-01 Dott.ssa Daniela Ferrante
Università degli Studi del Piemonte Orientale Corso di Laurea in Infermieristica Corso integrato in Scienze della Prevenzione e dei Servizi sanitari Statistica Lezione 6 a.a 011-01 Dott.ssa Daniela Ferrante
Corso di. Dott.ssa Donatella Cocca
 Corso di Statistica medica e applicata Dott.ssa Donatella Cocca 1 a Lezione Cos'è la statistica? Come in tutta la ricerca scientifica sperimentale, anche nelle scienze mediche e biologiche è indispensabile
Corso di Statistica medica e applicata Dott.ssa Donatella Cocca 1 a Lezione Cos'è la statistica? Come in tutta la ricerca scientifica sperimentale, anche nelle scienze mediche e biologiche è indispensabile
Rischio di ospedalizzazione successiva alla prima dialisi nel Lazio: differenze per titolo di studio, età e genere.
 Rischio di ospedalizzazione successiva alla prima dialisi nel Lazio: differenze per titolo di studio, età e genere. Claudia Marino, Nera Agabiti, Anna Maria Bargagli, Laura Cacciani, Salvatore Di Giulio,
Rischio di ospedalizzazione successiva alla prima dialisi nel Lazio: differenze per titolo di studio, età e genere. Claudia Marino, Nera Agabiti, Anna Maria Bargagli, Laura Cacciani, Salvatore Di Giulio,
Sperimentazione Clinica: ruolo e responsabilità dell Infermiere
 Sperimentazione Clinica: ruolo e responsabilità dell Infermiere Fasi dello studio Disegni di ricerca sperimentale Barbara Gorini, Investigator Site Development Lead, Development Operations- Pfizer ITALIA
Sperimentazione Clinica: ruolo e responsabilità dell Infermiere Fasi dello studio Disegni di ricerca sperimentale Barbara Gorini, Investigator Site Development Lead, Development Operations- Pfizer ITALIA
STATISTICA IX lezione
 Anno Accademico 013-014 STATISTICA IX lezione 1 Il problema della verifica di un ipotesi statistica In termini generali, si studia la distribuzione T(X) di un opportuna grandezza X legata ai parametri
Anno Accademico 013-014 STATISTICA IX lezione 1 Il problema della verifica di un ipotesi statistica In termini generali, si studia la distribuzione T(X) di un opportuna grandezza X legata ai parametri
ALLEGATO 1 Analisi delle serie storiche pluviometriche delle stazioni di Torre del Lago e di Viareggio.
 ALLEGATO 1 Analisi delle serie storiche pluviometriche delle stazioni di Torre del Lago e di Viareggio. Per una migliore caratterizzazione del bacino idrologico dell area di studio, sono state acquisite
ALLEGATO 1 Analisi delle serie storiche pluviometriche delle stazioni di Torre del Lago e di Viareggio. Per una migliore caratterizzazione del bacino idrologico dell area di studio, sono state acquisite
Informazioni per potenziali partecipanti. Possiamo sciogliere l'amiloidosi AL?
 Informazioni per potenziali partecipanti Possiamo sciogliere l'amiloidosi AL? È ora di affrontare diversamente l amiloidosi AL? L amiloidosi AL è una malattia rara e spesso fatale causata dall accumulo
Informazioni per potenziali partecipanti Possiamo sciogliere l'amiloidosi AL? È ora di affrontare diversamente l amiloidosi AL? L amiloidosi AL è una malattia rara e spesso fatale causata dall accumulo
CAPITOLO 8 LA VERIFICA D IPOTESI. I FONDAMENTI
 VERO FALSO CAPITOLO 8 LA VERIFICA D IPOTESI. I FONDAMENTI 1. V F Un ipotesi statistica è un assunzione sulle caratteristiche di una o più variabili in una o più popolazioni 2. V F L ipotesi nulla unita
VERO FALSO CAPITOLO 8 LA VERIFICA D IPOTESI. I FONDAMENTI 1. V F Un ipotesi statistica è un assunzione sulle caratteristiche di una o più variabili in una o più popolazioni 2. V F L ipotesi nulla unita
Potenza dello studio e dimensione campionaria. Laurea in Medicina e Chirurgia - Statistica medica 1
 Potenza dello studio e dimensione campionaria Laurea in Medicina e Chirurgia - Statistica medica 1 Introduzione Nella pianificazione di uno studio clinico randomizzato è fondamentale determinare in modo
Potenza dello studio e dimensione campionaria Laurea in Medicina e Chirurgia - Statistica medica 1 Introduzione Nella pianificazione di uno studio clinico randomizzato è fondamentale determinare in modo
STORE MANAGER.. LE COMPETENZE CARATTERISTICHE E I BISOGNI DI FORMAZIONE
 STORE MANAGER.. LE COMPETENZE CARATTERISTICHE E I BISOGNI DI FORMAZIONE 1 Indice 1. Premessa 2. Obiettivo 3. Le competenze del profilo ideale Competenze 3.1. Età ed esperienza 3.2. Le reali competenze
STORE MANAGER.. LE COMPETENZE CARATTERISTICHE E I BISOGNI DI FORMAZIONE 1 Indice 1. Premessa 2. Obiettivo 3. Le competenze del profilo ideale Competenze 3.1. Età ed esperienza 3.2. Le reali competenze
Premessa. Tratto da American Heart Journal 2004; 147: 705-712
 Effetti del cambiamento di terapia con statine sul raggiungimento delle concentrazioni lipidiche ottimali: lo studio Measuring Effective Reductions in Cholesterol Using Rosuvastatin Therapy (MERCURY I)
Effetti del cambiamento di terapia con statine sul raggiungimento delle concentrazioni lipidiche ottimali: lo studio Measuring Effective Reductions in Cholesterol Using Rosuvastatin Therapy (MERCURY I)
Epidemiologia generale
 Epidemiologia Da un punto di vista etimologico, epidemiologia è una parola di origine greca, che letteralmente significa «discorso riguardo alla popolazione» Epidemiologia generale Disciplina che ha come
Epidemiologia Da un punto di vista etimologico, epidemiologia è una parola di origine greca, che letteralmente significa «discorso riguardo alla popolazione» Epidemiologia generale Disciplina che ha come
www.ecocardiografiaveterinaria.it www.clinicaveterinariagransasso.it
 Stenosi polmonare www.ecocardiografiaveterinaria.it www.clinicaveterinariagransasso.it Arteria polmonare L arteria polmonare è il vaso sanguigno che porta il sangue dal ventricolo destro ai polmoni dove
Stenosi polmonare www.ecocardiografiaveterinaria.it www.clinicaveterinariagransasso.it Arteria polmonare L arteria polmonare è il vaso sanguigno che porta il sangue dal ventricolo destro ai polmoni dove
Monitoraggio sulla conversione dei prezzi al consumo dalla Lira all Euro
 ISTAT 17 gennaio 2002 Monitoraggio sulla conversione dei prezzi al consumo dalla Lira all Euro Nell ambito dell iniziativa di monitoraggio, avviata dall Istat per analizzare le modalità di conversione
ISTAT 17 gennaio 2002 Monitoraggio sulla conversione dei prezzi al consumo dalla Lira all Euro Nell ambito dell iniziativa di monitoraggio, avviata dall Istat per analizzare le modalità di conversione
Buone pratiche di sperimentazione clinica negli animali dei medicinali veterinari
 negli animali dei medicinali veterinari Modelli innovativi di lotta alla varroa: l acido formico in gel. Dr. Salvatore Macrì Dirigente Veterinario Ministero della Salute Roma Istituto Zooprofilattico Sperimentale
negli animali dei medicinali veterinari Modelli innovativi di lotta alla varroa: l acido formico in gel. Dr. Salvatore Macrì Dirigente Veterinario Ministero della Salute Roma Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Il sale è un elemento fondamentale per l alimentazione umana ed è costituito da cloruro di sodio (NaCl). Una sua eccessiva introduzione però può
 Sale e salute Il sale è un elemento fondamentale per l alimentazione umana ed è costituito da cloruro di sodio (NaCl). Una sua eccessiva introduzione però può causare gravi problemi alla salute. La quantità
Sale e salute Il sale è un elemento fondamentale per l alimentazione umana ed è costituito da cloruro di sodio (NaCl). Una sua eccessiva introduzione però può causare gravi problemi alla salute. La quantità
Misure della relazione di occorrenza
 Misure della relazione di occorrenza (associazione tra un determinante e l outcome) Misure di effetto (teoriche) Misure di associazione (stime empiriche delle precedenti) EFFETTO: quantità di cambiamento
Misure della relazione di occorrenza (associazione tra un determinante e l outcome) Misure di effetto (teoriche) Misure di associazione (stime empiriche delle precedenti) EFFETTO: quantità di cambiamento
APPROPRIATEZZA IN ECOCARDIOGRAFIA. MARIA CUONZO Cardiologia UTIC AUSL BA Terlizzi
 APPROPRIATEZZA IN ECOCARDIOGRAFIA MARIA CUONZO Cardiologia UTIC AUSL BA Terlizzi SOGGETTO CON CMD NOTA IN COMPENSO PREGRESSO DOLORE TORACICO Quale esame stato richiesto con appropriatezza? SOGGETTO CON
APPROPRIATEZZA IN ECOCARDIOGRAFIA MARIA CUONZO Cardiologia UTIC AUSL BA Terlizzi SOGGETTO CON CMD NOTA IN COMPENSO PREGRESSO DOLORE TORACICO Quale esame stato richiesto con appropriatezza? SOGGETTO CON
LE CARTE DI CONTROLLO (4)
 LE CARTE DI CONTROLLO (4) Tipo di carta di controllo Frazione difettosa Carta p Numero di difettosi Carta np Dimensione campione Variabile, solitamente >= 50 costante, solitamente >= 50 Linea centrale
LE CARTE DI CONTROLLO (4) Tipo di carta di controllo Frazione difettosa Carta p Numero di difettosi Carta np Dimensione campione Variabile, solitamente >= 50 costante, solitamente >= 50 Linea centrale
LE META-ANALISI. Graziella D Arrigo, Fabio Provenzano, Claudia Torino, Carmine Zoccali, Giovanni Tripepi
 G Ital Nefrol 2011; 28 (5): 531-536 MASTER IN EPIDEMIOLOGIA CLINICA LE META-ANALISI Graziella D Arrigo, Fabio Provenzano, Claudia Torino, Carmine Zoccali, Giovanni Tripepi CNR-IBIM, Unità di Ricerca di
G Ital Nefrol 2011; 28 (5): 531-536 MASTER IN EPIDEMIOLOGIA CLINICA LE META-ANALISI Graziella D Arrigo, Fabio Provenzano, Claudia Torino, Carmine Zoccali, Giovanni Tripepi CNR-IBIM, Unità di Ricerca di
Titolo. Background. Obiettivi. Metodi Tipo di studio (disegno) Centro/i partecipante/i Popolazione
 La SIFC promuove la ricerca clini ca nel campo della Fibrosi Cistica in Italia mediante la valutazione di progetti scientifici multicentrici e m ultidisciplinari. La Commissione Permanente Ricerca e Sviluppo
La SIFC promuove la ricerca clini ca nel campo della Fibrosi Cistica in Italia mediante la valutazione di progetti scientifici multicentrici e m ultidisciplinari. La Commissione Permanente Ricerca e Sviluppo
Criteri di selezione del collettivo e definizioni
 Appendice A Criteri di selezione del collettivo e definizioni Introduzione L indagine sull integrazione sociale delle persone con disabilità è stata realizzata nell ambito del progetto Sistema di Informazione
Appendice A Criteri di selezione del collettivo e definizioni Introduzione L indagine sull integrazione sociale delle persone con disabilità è stata realizzata nell ambito del progetto Sistema di Informazione
Dott. Giovanni Ferrari
 Manifestazioni cardiache delle malattie neurologiche acute Comobrain Ottobre 2009 Dott. Giovanni Ferrari Dimensioni del problema George Khechinashvili, 2002 Analisi multivariata della mortalità
Manifestazioni cardiache delle malattie neurologiche acute Comobrain Ottobre 2009 Dott. Giovanni Ferrari Dimensioni del problema George Khechinashvili, 2002 Analisi multivariata della mortalità
PROGETTO INDAGINE DI OPINIONE SUL PROCESSO DI FUSIONE DEI COMUNI NEL PRIMIERO
 PROGETTO INDAGINE DI OPINIONE SUL PROCESSO DI FUSIONE DEI COMUNI NEL PRIMIERO L indagine si è svolta nel periodo dal 26 agosto al 16 settembre 2014 con l obiettivo di conoscere l opinione dei residenti
PROGETTO INDAGINE DI OPINIONE SUL PROCESSO DI FUSIONE DEI COMUNI NEL PRIMIERO L indagine si è svolta nel periodo dal 26 agosto al 16 settembre 2014 con l obiettivo di conoscere l opinione dei residenti
sembra una Anche qui sembra questione di sesso: Aspirina e donne
 sembra una Anche qui sembra questione di sesso: Aspirina e donne The Women s Health Study Razionale per l uso di bassi dosaggi di aspirina nella prevenzione primaria Nella prevenzione secondaria delle
sembra una Anche qui sembra questione di sesso: Aspirina e donne The Women s Health Study Razionale per l uso di bassi dosaggi di aspirina nella prevenzione primaria Nella prevenzione secondaria delle
Seconda Parte Specifica di scuola - Statistica sanitaria e Biometria - 31/07/2015
 Domande relative alla specializzazione in: Statistica sanitaria e Biometria Domanda #1 (codice domanda: n.641) : In epidemiologia, una variabile di confondimento è una variabile: A: associata sia alla
Domande relative alla specializzazione in: Statistica sanitaria e Biometria Domanda #1 (codice domanda: n.641) : In epidemiologia, una variabile di confondimento è una variabile: A: associata sia alla
Terapia farmacologica e non dello scompenso cardiaco
 Terapia farmacologica e non dello scompenso cardiaco Statine e scompenso cardiaco: un associazione imprevista Verona, 21 Gennaio 2006 Mariantonietta Cicoira, MD, PhD Divisione di Cardiologia Direttore:
Terapia farmacologica e non dello scompenso cardiaco Statine e scompenso cardiaco: un associazione imprevista Verona, 21 Gennaio 2006 Mariantonietta Cicoira, MD, PhD Divisione di Cardiologia Direttore:
SMID a.a. 2004/2005 Corso di Metodi Statistici in Biomedicina Tassi di incidenza 9/2/2005
 SMID a.a. 2004/2005 Corso di Metodi Statistici in Biomedicina Tassi di incidenza 9/2/2005 Ricerca epidemiologica Gli epidemiologi sono interessati a conoscere l incidenza delle malattie per prevedere i
SMID a.a. 2004/2005 Corso di Metodi Statistici in Biomedicina Tassi di incidenza 9/2/2005 Ricerca epidemiologica Gli epidemiologi sono interessati a conoscere l incidenza delle malattie per prevedere i
Diagnosi precoce delle neoplasie del collo dell utero
 Diagnosi precoce delle neoplasie del collo dell utero La neoplasia del collo dell utero a livello mondiale rappresenta ancora il secondo tumore maligno della donna, con circa 500.000 nuovi casi stimati
Diagnosi precoce delle neoplasie del collo dell utero La neoplasia del collo dell utero a livello mondiale rappresenta ancora il secondo tumore maligno della donna, con circa 500.000 nuovi casi stimati
Valutazione dell IG di Frollini tradizionali e preparati con farina con l aggiunta del % di Freno SIGI.
 Valutazione dell IG di Frollini tradizionali e preparati con farina con l aggiunta del % di Freno SIGI. Premessa L'indice glicemico (IG) di un alimento, definito come l'area sotto la curva (AUC) della
Valutazione dell IG di Frollini tradizionali e preparati con farina con l aggiunta del % di Freno SIGI. Premessa L'indice glicemico (IG) di un alimento, definito come l'area sotto la curva (AUC) della
FINASTERIDE ZENTIVA 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM. Variazioni degli stampati relativamente agli aspetti della sicurezza
 FARMACOVIGILANZA FINASTERIDE ZENTIVA 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM Variazioni degli stampati relativamente agli aspetti della sicurezza Le modifiche agli stampati sono conseguenti alla Determinazione
FARMACOVIGILANZA FINASTERIDE ZENTIVA 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM Variazioni degli stampati relativamente agli aspetti della sicurezza Le modifiche agli stampati sono conseguenti alla Determinazione
Analizza/Confronta medie. ELEMENTI DI PSICOMETRIA Esercitazione n. 7-8-9-107. Test t. Test t. t-test test e confronto tra medie chi quadrato
 Analizza/Confronta medie ELEMENTI DI PSICOMETRIA Esercitazione n. 7-8-9-107 t-test test e confronto tra medie chi quadrato C.d.L. Comunicazione e Psicologia a.a. 2008/09 Medie Calcola medie e altre statistiche
Analizza/Confronta medie ELEMENTI DI PSICOMETRIA Esercitazione n. 7-8-9-107 t-test test e confronto tra medie chi quadrato C.d.L. Comunicazione e Psicologia a.a. 2008/09 Medie Calcola medie e altre statistiche
Trattamento integrato dei disturbi mentali nelle Cure Primarie: il Programma Regionale G. Leggieri
 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia Trattamento integrato dei disturbi mentali nelle Cure Primarie: il Programma Regionale G. Leggieri Dr.ssa Marina
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia Trattamento integrato dei disturbi mentali nelle Cure Primarie: il Programma Regionale G. Leggieri Dr.ssa Marina
Igiene. Dott. Pamela Di Giovanni. Definizione
 Igiene Dott. Pamela Di Giovanni Definizione Disciplina medica che ha come obiettivo la tutela e la promozione della salute umana, intendendo per salute umana un completo stato di benessere psichico, fisico
Igiene Dott. Pamela Di Giovanni Definizione Disciplina medica che ha come obiettivo la tutela e la promozione della salute umana, intendendo per salute umana un completo stato di benessere psichico, fisico
Elementi di Psicometria con Laboratorio di SPSS 1
 Elementi di Psicometria con Laboratorio di SPSS 1 12-Il t-test per campioni appaiati vers. 1.2 (7 novembre 2014) Germano Rossi 1 germano.rossi@unimib.it 1 Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca
Elementi di Psicometria con Laboratorio di SPSS 1 12-Il t-test per campioni appaiati vers. 1.2 (7 novembre 2014) Germano Rossi 1 germano.rossi@unimib.it 1 Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca
Studio di ricerca clinica sul dolore da endometriosi. Il dolore che Lei sente è reale... anche se gli altri non possono vederlo.
 Studio di ricerca clinica sul dolore da endometriosi Il dolore che Lei sente è reale... anche se gli altri non possono vederlo. A822523 Lo studio SOLSTICE verrà condotto in circa 200 centri di ricerca
Studio di ricerca clinica sul dolore da endometriosi Il dolore che Lei sente è reale... anche se gli altri non possono vederlo. A822523 Lo studio SOLSTICE verrà condotto in circa 200 centri di ricerca
ANALISI DELLA SOPRAVVIVENZA
 ANALISI DELLA SOPRAVVIVENZA Prof. Giuseppe Verlato Sezione di Epidemiologia e Statistica Medica Università degli Studi di Verona OBIETTIVI DELL ANALISI DELLA SOPRAVVIVENZA 1) STIMARE la funzione di sopravvivenza
ANALISI DELLA SOPRAVVIVENZA Prof. Giuseppe Verlato Sezione di Epidemiologia e Statistica Medica Università degli Studi di Verona OBIETTIVI DELL ANALISI DELLA SOPRAVVIVENZA 1) STIMARE la funzione di sopravvivenza
DISTURBI AFFETTIVI. Antonio Lora DISTURBI AFFETTIVI NEI DSM LOMBARDI (2009) 27/09/2012 8.223 PAZIENTI CON DISTURBO BIPOLARE
 DISTURBI AFFETTIVI Antonio Lora DISTURBI AFFETTIVI NEI DSM LOMBARDI (2009) DIST. BIPOLARE DIST. 6% DEPRESSIVO 17% 8.223 PAZIENTI CON DISTURBO BIPOLARE 22.234 CON DISTURBO DEPRESSIVO PREVALENZA TRATTATA
DISTURBI AFFETTIVI Antonio Lora DISTURBI AFFETTIVI NEI DSM LOMBARDI (2009) DIST. BIPOLARE DIST. 6% DEPRESSIVO 17% 8.223 PAZIENTI CON DISTURBO BIPOLARE 22.234 CON DISTURBO DEPRESSIVO PREVALENZA TRATTATA
ESERCITAZIONE. CdL Fisioterapia e Podologia. 25 novembre 2015
 ESERCITAZIONE CdL Fisioterapia e Podologia 25 novembre 2015 Epidemiologia Domanda 1 Le neoplasie gastriche sono: a. diminuite in tutta Europa b. diminuite fino agli anni 80, poi stabili c. aumentate in
ESERCITAZIONE CdL Fisioterapia e Podologia 25 novembre 2015 Epidemiologia Domanda 1 Le neoplasie gastriche sono: a. diminuite in tutta Europa b. diminuite fino agli anni 80, poi stabili c. aumentate in
ANCHE IL LINFEDEMA SECONDARI O E MALATTIA DISABILITAN TE: UN INDICE DA PROPORRE ALL INPS
 ANCHE IL LINFEDEMA SECONDARI O E MALATTIA DISABILITAN TE: UN INDICE DA PROPORRE ALL INPS Dott. Maurizio Ricci U. O. Medicina Riabilitativa Azienda Ospedaliero- Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona
ANCHE IL LINFEDEMA SECONDARI O E MALATTIA DISABILITAN TE: UN INDICE DA PROPORRE ALL INPS Dott. Maurizio Ricci U. O. Medicina Riabilitativa Azienda Ospedaliero- Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona
Documento di accompagnamento: mediane dei settori bibliometrici
 Documento di accompagnamento: mediane dei settori bibliometrici 1. Introduzione Vengono oggi pubblicate sul sito dell ANVUR e del MIUR 3 tabelle, deliberate nel CD dell ANVUR del 13 agosto 2012, relative
Documento di accompagnamento: mediane dei settori bibliometrici 1. Introduzione Vengono oggi pubblicate sul sito dell ANVUR e del MIUR 3 tabelle, deliberate nel CD dell ANVUR del 13 agosto 2012, relative
Igiene nelle Scienze motorie
 Igiene nelle Scienze motorie Epidemiologia generale Epidemiologia Da un punto di vista etimologico, epidemiologia è una parola di origine greca, che letteralmente significa «discorso riguardo alla popolazione»
Igiene nelle Scienze motorie Epidemiologia generale Epidemiologia Da un punto di vista etimologico, epidemiologia è una parola di origine greca, che letteralmente significa «discorso riguardo alla popolazione»
VALORE DELLE MERCI SEQUESTRATE
 La contraffazione in cifre: NUOVA METODOLOGIA PER LA STIMA DEL VALORE DELLE MERCI SEQUESTRATE Roma, Giugno 2013 Giugno 2013-1 Il valore economico dei sequestri In questo Focus si approfondiscono alcune
La contraffazione in cifre: NUOVA METODOLOGIA PER LA STIMA DEL VALORE DELLE MERCI SEQUESTRATE Roma, Giugno 2013 Giugno 2013-1 Il valore economico dei sequestri In questo Focus si approfondiscono alcune
Il RUOLO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE NELLA IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE CON SOSPETTA DEMENZA. T. Mandarino (MMG ASL RMA )
 Il RUOLO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE NELLA IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE CON SOSPETTA DEMENZA T. Mandarino (MMG ASL RMA ) La Malattia di Alzheimer La malattia di Alzheimer è la forma più frequente
Il RUOLO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE NELLA IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE CON SOSPETTA DEMENZA T. Mandarino (MMG ASL RMA ) La Malattia di Alzheimer La malattia di Alzheimer è la forma più frequente
7.2 Indagine di Customer Satisfaction
 7.2 Indagine di Customer Satisfaction Il campione L indagine è stata condotta su un campione a più stadi di 373 clienti di Tiemme Spa sede operativa di Piombino (errore di campionamento +/- 2%) rappresentativo
7.2 Indagine di Customer Satisfaction Il campione L indagine è stata condotta su un campione a più stadi di 373 clienti di Tiemme Spa sede operativa di Piombino (errore di campionamento +/- 2%) rappresentativo
La programmazione di uno studio clinico: dalla domanda al disegno
 Metodo epidemiologici per la clinica _efficacia / 1 La programmazione di uno studio clinico: dalla domanda al disegno La buona ricerca clinica Non è etico ciò che non è rilevante scientificamente Non è
Metodo epidemiologici per la clinica _efficacia / 1 La programmazione di uno studio clinico: dalla domanda al disegno La buona ricerca clinica Non è etico ciò che non è rilevante scientificamente Non è
Operatori Socio Sanitari risorsa e opportunità per il miglioramento della qualità e dell assistenza. Attribuzione o delega?
 Operatori Socio Sanitari risorsa e opportunità per il miglioramento della qualità e dell assistenza. Attribuzione o delega? Pordenone, Marzo 2014 Dott.ssa Catia Cassin Delega In ambito gestionale per delega
Operatori Socio Sanitari risorsa e opportunità per il miglioramento della qualità e dell assistenza. Attribuzione o delega? Pordenone, Marzo 2014 Dott.ssa Catia Cassin Delega In ambito gestionale per delega
ESERCITAZIONE 2. TRATTO E MODIFICATO DA: Esercizi di epidemiologia - MORO, DAVOLI, PIRASTU Il pensiero scientifico editore
 ESERCITAZIONE 2 TRATTO E MODIFICATO DA: Esercizi di epidemiologia - MORO, DAVOLI, PIRASTU Il pensiero scientifico editore Modalità di lettura della tabella di contingenza 2x2 sull associazione tra l esposizione
ESERCITAZIONE 2 TRATTO E MODIFICATO DA: Esercizi di epidemiologia - MORO, DAVOLI, PIRASTU Il pensiero scientifico editore Modalità di lettura della tabella di contingenza 2x2 sull associazione tra l esposizione
Comparing health related quality of life for severe chronic heart failure in home care and outpatient services
 Barbara Bini Phd Student, Laboratorio di Management e Sanità, Istituto di Management, scuola Superiore Sant Anna Comparing health related quality of life for severe chronic heart failure in home care and
Barbara Bini Phd Student, Laboratorio di Management e Sanità, Istituto di Management, scuola Superiore Sant Anna Comparing health related quality of life for severe chronic heart failure in home care and
UTILIZZATORI A VALLE: COME RENDERE NOTI GLI USI AI FORNITORI
 UTILIZZATORI A VALLE: COME RENDERE NOTI GLI USI AI FORNITORI Un utilizzatore a valle di sostanze chimiche dovrebbe informare i propri fornitori riguardo al suo utilizzo delle sostanze (come tali o all
UTILIZZATORI A VALLE: COME RENDERE NOTI GLI USI AI FORNITORI Un utilizzatore a valle di sostanze chimiche dovrebbe informare i propri fornitori riguardo al suo utilizzo delle sostanze (come tali o all
Il confronto fra proporzioni
 L. Boni Il rapporto Un rapporto (ratio), attribuendo un ampio significato al termine, è il risultato della divisione di una certa quantità a per un altra quantità b Il rapporto Spesso, in maniera più specifica,
L. Boni Il rapporto Un rapporto (ratio), attribuendo un ampio significato al termine, è il risultato della divisione di una certa quantità a per un altra quantità b Il rapporto Spesso, in maniera più specifica,
L indagine svolta da AlmaLaurea nel 2013 ha coinvolto quasi 450mila laureati di primo e
 1 L indagine svolta da AlmaLaurea nel 2013 ha coinvolto quasi 450mila laureati di primo e secondo livello di tutti i 64 atenei aderenti al Consorzio, che rappresentano circa l 80% del complesso dei laureati
1 L indagine svolta da AlmaLaurea nel 2013 ha coinvolto quasi 450mila laureati di primo e secondo livello di tutti i 64 atenei aderenti al Consorzio, che rappresentano circa l 80% del complesso dei laureati
Incidenza dell ipoglicemia nei pazienti della SOS di Diabetologia di Udine
 Incidenza dell ipoglicemia nei pazienti della SOS di Diabetologia di Udine Agus S, Tonutti L, Pellegrini MA, Venturini G, Cannella S, Toffoletti V, Vidotti F, Sartori C, Boscariol C, Pellarini L, Rutigliano
Incidenza dell ipoglicemia nei pazienti della SOS di Diabetologia di Udine Agus S, Tonutti L, Pellegrini MA, Venturini G, Cannella S, Toffoletti V, Vidotti F, Sartori C, Boscariol C, Pellarini L, Rutigliano
Dronedarone e insufficienza renale acuta: analisi delle segnalazioni della Rete Nazionale di Farmacovigilanza
 Dronedarone e insufficienza renale acuta: analisi delle segnalazioni della Rete Nazionale di Farmacovigilanza Domenico Motola Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Unità di farmacologia Università
Dronedarone e insufficienza renale acuta: analisi delle segnalazioni della Rete Nazionale di Farmacovigilanza Domenico Motola Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Unità di farmacologia Università
ANALISI CRITICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA CENTRALE TERMOELETTRICA DI QUILIANO E VADO LIGURE
 6.1 Salute umana Dall analisi della documentazione di progetto sottoposta ad autorizzazione emerge come la tematica della Salute Umana sia stata affrontata in modo inadeguato, ovvero con estrema superficialità
6.1 Salute umana Dall analisi della documentazione di progetto sottoposta ad autorizzazione emerge come la tematica della Salute Umana sia stata affrontata in modo inadeguato, ovvero con estrema superficialità
L Investigator s Brochure. Marisa Dell Aera Comitato Etico Azienda Ospedaliera Policlinico Bari. Maglie 25 novembre 2004
 L Investigator s Brochure Marisa Dell Aera Comitato Etico Azienda Ospedaliera Policlinico Bari Maglie 25 novembre 2004 Investigator s Brochure Good Clinical Practice DM 15/07/97 Cosa è? L IB è una raccolta
L Investigator s Brochure Marisa Dell Aera Comitato Etico Azienda Ospedaliera Policlinico Bari Maglie 25 novembre 2004 Investigator s Brochure Good Clinical Practice DM 15/07/97 Cosa è? L IB è una raccolta
MH e imaging cerebrale
 Novità dalla ricerca sulla Malattia di Huntington In un linguaggio semplice. Scritto da ricercatori. Per la comunità mondiale MH. La MH fa si che il cervello si sviluppi in modo diverso Volumi cerebrali
Novità dalla ricerca sulla Malattia di Huntington In un linguaggio semplice. Scritto da ricercatori. Per la comunità mondiale MH. La MH fa si che il cervello si sviluppi in modo diverso Volumi cerebrali
STUDI CLINICI 1. Che cosa è uno studio clinico e a cosa serve? 2. Come nasce la sperimentazione clinica e che tipi di studi esistono?
 STUDI CLINICI 1. Che cosa è uno studio clinico e a cosa serve? Si definisce sperimentazione clinica, o studio clinico controllato, (in inglese: clinical trial), un esperimento scientifico che genera dati
STUDI CLINICI 1. Che cosa è uno studio clinico e a cosa serve? Si definisce sperimentazione clinica, o studio clinico controllato, (in inglese: clinical trial), un esperimento scientifico che genera dati
Rapporto dal Questionari Insegnanti
 Rapporto dal Questionari Insegnanti SCUOLA CHIC81400N N. Docenti che hanno compilato il questionario: 60 Anno Scolastico 2014/15 Le Aree Indagate Il Questionario Insegnanti ha l obiettivo di rilevare la
Rapporto dal Questionari Insegnanti SCUOLA CHIC81400N N. Docenti che hanno compilato il questionario: 60 Anno Scolastico 2014/15 Le Aree Indagate Il Questionario Insegnanti ha l obiettivo di rilevare la
Analisi dei residui. Test Esatto di Fisher. Differenza fra proporzioni
 Statistica Economica Materiale didattico a cura del docente Analisi dei residui Test Esatto di Fisher Differenza fra proporzioni 1 Analisi dei residui Il test statistico ed il suo p-valore riassumono la
Statistica Economica Materiale didattico a cura del docente Analisi dei residui Test Esatto di Fisher Differenza fra proporzioni 1 Analisi dei residui Il test statistico ed il suo p-valore riassumono la
ANALISI DI IMPATTO DI BUDGET DI UNA NUOVA STRATEGIA VACCINALE PATRIZIA BERTO, NICOLA PRINCIPI
 ANALISI DI IMPATTO DI BUDGET DI UNA NUOVA STRATEGIA VACCINALE PATRIZIA BERTO, NICOLA PRINCIPI INTRODUZIONE Le Infezioni da Pneumococco (PNU) rappresentano un problema sanitario grave, soprattutto a causa
ANALISI DI IMPATTO DI BUDGET DI UNA NUOVA STRATEGIA VACCINALE PATRIZIA BERTO, NICOLA PRINCIPI INTRODUZIONE Le Infezioni da Pneumococco (PNU) rappresentano un problema sanitario grave, soprattutto a causa
Numero 20 /2013 Le malattie professionali nell anno 2012 nelle statistiche INAIL
 Numero 20 /2013 Le malattie professionali nell anno 2012 nelle statistiche INAIL L'INAIL ha presentato i dati degli infortuni e delle malattie professionali relativi all'anno 2012. Nel 2012 si è avuto
Numero 20 /2013 Le malattie professionali nell anno 2012 nelle statistiche INAIL L'INAIL ha presentato i dati degli infortuni e delle malattie professionali relativi all'anno 2012. Nel 2012 si è avuto
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
Calcolo delle probabilità
 Calcolo delle probabilità Laboratorio di Bioinformatica Corso A aa 2005-2006 Statistica Dai risultati di un esperimento si determinano alcune caratteristiche della popolazione Calcolo delle probabilità
Calcolo delle probabilità Laboratorio di Bioinformatica Corso A aa 2005-2006 Statistica Dai risultati di un esperimento si determinano alcune caratteristiche della popolazione Calcolo delle probabilità
GESTIONE DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI PER SCARICHI INDUSTRIALI ED EMISSIONI NOCIVE LEZIONE 10. Angelo Bonomi
 GESTIONE DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI PER SCARICHI INDUSTRIALI ED EMISSIONI NOCIVE LEZIONE 10 Angelo Bonomi CONSIDERAZIONI SUL MONITORAGGIO Un monitoraggio ottimale dipende dalle considerazioni seguenti:
GESTIONE DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI PER SCARICHI INDUSTRIALI ED EMISSIONI NOCIVE LEZIONE 10 Angelo Bonomi CONSIDERAZIONI SUL MONITORAGGIO Un monitoraggio ottimale dipende dalle considerazioni seguenti:
IL RUOLO DELL INFERMIERE
 A06 152 Maria Grazia Belvedere Paolo Ruggeri IL RUOLO DELL INFERMIERE NELL ASSISTENZA AL PAZIENTE AFFETTO DA IPERTENSIONE ARTERIOSA POLMONARE ANALISI DI UN CASO CLINICO E REVISIONE DELLA LETTERATURA Copyright
A06 152 Maria Grazia Belvedere Paolo Ruggeri IL RUOLO DELL INFERMIERE NELL ASSISTENZA AL PAZIENTE AFFETTO DA IPERTENSIONE ARTERIOSA POLMONARE ANALISI DI UN CASO CLINICO E REVISIONE DELLA LETTERATURA Copyright
MService La soluzione per ottimizzare le prestazioni dell impianto
 MService La soluzione per ottimizzare le prestazioni dell impianto Il segreto del successo di un azienda sta nel tenere sotto controllo lo stato di salute delle apparecchiature degli impianti. Dati industriali
MService La soluzione per ottimizzare le prestazioni dell impianto Il segreto del successo di un azienda sta nel tenere sotto controllo lo stato di salute delle apparecchiature degli impianti. Dati industriali
Valvulopatie. Stenosi Mitralica Insufficienza Mitralica
 Valvulopatie Stenosi Mitralica Insufficienza Mitralica Stenosi Mitralica:Eziologia Patologia ormai rara nei paesi sviluppati:nella quasi totalità dei casi è di origine reumatica. Predilige il sesso femminile
Valvulopatie Stenosi Mitralica Insufficienza Mitralica Stenosi Mitralica:Eziologia Patologia ormai rara nei paesi sviluppati:nella quasi totalità dei casi è di origine reumatica. Predilige il sesso femminile
LA METANALISI. Franco Merletti Unità di Epidemiologia dei Tumori Università di Torino
 LA METANALISI Franco Merletti Unità di Epidemiologia dei Tumori Università di Torino È causa di grande preoccupazione constatare come la professione medica non abbia saputo organizzare un sistema in grado
LA METANALISI Franco Merletti Unità di Epidemiologia dei Tumori Università di Torino È causa di grande preoccupazione constatare come la professione medica non abbia saputo organizzare un sistema in grado
ANALISI DELLA STRUTTURA FINANZIARIA a cura Giuseppe Polli SECONDA PARTE clicca QUI per accedere direttamente alla prima parte dell'intervento...
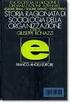 ANALISI DELLA STRUTTURA FINANZIARIA a cura Giuseppe Polli SECONDA PARTE clicca QUI per accedere direttamente alla prima parte dell'intervento... 4 GLI INDICI DI LIQUIDITA L analisi procede con la costruzione
ANALISI DELLA STRUTTURA FINANZIARIA a cura Giuseppe Polli SECONDA PARTE clicca QUI per accedere direttamente alla prima parte dell'intervento... 4 GLI INDICI DI LIQUIDITA L analisi procede con la costruzione
CAPACITÀ DI PROCESSO (PROCESS CAPABILITY)
 CICLO DI LEZIONI per Progetto e Gestione della Qualità Facoltà di Ingegneria CAPACITÀ DI PROCESSO (PROCESS CAPABILITY) Carlo Noè Università Carlo Cattaneo e-mail: cnoe@liuc.it 1 CAPACITÀ DI PROCESSO Il
CICLO DI LEZIONI per Progetto e Gestione della Qualità Facoltà di Ingegneria CAPACITÀ DI PROCESSO (PROCESS CAPABILITY) Carlo Noè Università Carlo Cattaneo e-mail: cnoe@liuc.it 1 CAPACITÀ DI PROCESSO Il
Tabella iniziale con i dati. Malattia Malati Non malati Totale Test Positivo 183 Negativo 280 Totale 199 512. Calcolo i valori mancanti per differenza
 ESERCIZIO DI STATISTICA D.U. / simulazione di esame Esercizio 1: Per una malattia particolarmente grave viene sperimentato l utilizzo di una nuova tecnica radiologica allo scopo di identificare correttamente
ESERCIZIO DI STATISTICA D.U. / simulazione di esame Esercizio 1: Per una malattia particolarmente grave viene sperimentato l utilizzo di una nuova tecnica radiologica allo scopo di identificare correttamente
US SECURITY AND EXCHANGE COMMISSION, Division of Investment Management, Report on Mutual Fund Fees and Expenses, December 2000.
 Recensione US SECURITY AND EXCHANGE COMMISSION, Division of Investment Management, Report on Mutual Fund Fees and Expenses, December 2000. Si tratta di un rapporto sui fondi statunitensi riferito al periodo
Recensione US SECURITY AND EXCHANGE COMMISSION, Division of Investment Management, Report on Mutual Fund Fees and Expenses, December 2000. Si tratta di un rapporto sui fondi statunitensi riferito al periodo
PRINCIPALI ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DEI BILANCI CONSUNTIVI RELATIVI ALL ANNO 2003
 NOTA METODOLOGICA I dati elaborati per la presente pubblicazione sono quelli riportati nell allegato D ed F al rendiconto finanziario, rilevati dall Istat non più con un suo proprio modello ma a partire
NOTA METODOLOGICA I dati elaborati per la presente pubblicazione sono quelli riportati nell allegato D ed F al rendiconto finanziario, rilevati dall Istat non più con un suo proprio modello ma a partire
Università del Piemonte Orientale. Corso di laurea in biotecnologia. Corso di Statistica Medica. Intervalli di confidenza
 Università del Piemonte Orientale Corso di laurea in biotecnologia Corso di Statistica Medica Intervalli di confidenza Università del Piemonte Orientale Corso di laurea in biotecnologia Corso di Statistica
Università del Piemonte Orientale Corso di laurea in biotecnologia Corso di Statistica Medica Intervalli di confidenza Università del Piemonte Orientale Corso di laurea in biotecnologia Corso di Statistica
Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica
 Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica Rapporto di monitoraggio semestrale II semestre 2013 Pubblicato in data 30 gennaio 2014 1 INDICE 1. Introduzione... 3 2. Situazione Operatori... 3 3. TEE emessi...
Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica Rapporto di monitoraggio semestrale II semestre 2013 Pubblicato in data 30 gennaio 2014 1 INDICE 1. Introduzione... 3 2. Situazione Operatori... 3 3. TEE emessi...
LA DISTRIBUZIONE DI PROBABILITÀ DEI RITORNI AZIONARI FUTURI SARÀ LA MEDESIMA DEL PASSATO?
 LA DISTRIBUZIONE DI PROBABILITÀ DEI RITORNI AZIONARI FUTURI SARÀ LA MEDESIMA DEL PASSATO? Versione preliminare: 25 Settembre 2008 Nicola Zanella E-Mail: n.zanella@yahoo.it ABSTRACT In questa ricerca ho
LA DISTRIBUZIONE DI PROBABILITÀ DEI RITORNI AZIONARI FUTURI SARÀ LA MEDESIMA DEL PASSATO? Versione preliminare: 25 Settembre 2008 Nicola Zanella E-Mail: n.zanella@yahoo.it ABSTRACT In questa ricerca ho
SCHEDA FARMACO. Principio attivo (nome commerciale) Forma farmaceutica e dosaggio, posologia, prezzo, regime di rimborsabilità, ditta
 Principio attivo (nome commerciale) Forma farmaceutica e dosaggio, posologia, prezzo, regime di rimborsabilità, ditta Indicazione terapeutica Classificazione: Spesa per paziente trattato (euro, posologia/durata)
Principio attivo (nome commerciale) Forma farmaceutica e dosaggio, posologia, prezzo, regime di rimborsabilità, ditta Indicazione terapeutica Classificazione: Spesa per paziente trattato (euro, posologia/durata)
Le malattie cardiovascolari (MCV) sono la principale causa di morte nelle donne, responsabili del 54% dei decessi femminili in Europa
 Red Alert for Women s Heart Compendio DONNE E RICERCA CARDIOVASCOLARE Le malattie cardiovascolari (MCV) sono la principale causa di morte nelle donne, responsabili del 54% dei decessi femminili in Europa
Red Alert for Women s Heart Compendio DONNE E RICERCA CARDIOVASCOLARE Le malattie cardiovascolari (MCV) sono la principale causa di morte nelle donne, responsabili del 54% dei decessi femminili in Europa
Quando i sintomi vengono interpretati
 Quando i sintomi vengono interpretati Ricordo quando il mio Professore di Semeiotica Medica parlandoci delle cause che determinano la fibrillazione atriale disse: rammentate che la fibrillazione atriale
Quando i sintomi vengono interpretati Ricordo quando il mio Professore di Semeiotica Medica parlandoci delle cause che determinano la fibrillazione atriale disse: rammentate che la fibrillazione atriale
Infezione da HIV e AIDS in Piemonte
 Infezione da HIV e AIDS in Piemonte anno 212 a cura di Chiara Pasqualini, Vittorio Demicheli si ringraziano i medici referenti del Sistema di Sorveglianza HIV/AIDS del Piemonte: O. Bargiacchi, S. Bonora,
Infezione da HIV e AIDS in Piemonte anno 212 a cura di Chiara Pasqualini, Vittorio Demicheli si ringraziano i medici referenti del Sistema di Sorveglianza HIV/AIDS del Piemonte: O. Bargiacchi, S. Bonora,
IL CONTRIBUTO DEGLI INFERMIERI ALLA IDEAZIONE DEL PSS REGIONALE
 IL CONTRIBUTO DEGLI INFERMIERI ALLA IDEAZIONE DEL PSS REGIONALE Il presente documento, presentato in V commissione in occasione dell audizione del 23 settembre, si compone di due parti: Introduzione e
IL CONTRIBUTO DEGLI INFERMIERI ALLA IDEAZIONE DEL PSS REGIONALE Il presente documento, presentato in V commissione in occasione dell audizione del 23 settembre, si compone di due parti: Introduzione e
LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La comprensione
 LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La comprensione dell impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi Ottobre 2013 Indice 1. La comprensione dell impresa e del suo contesto
LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La comprensione dell impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi Ottobre 2013 Indice 1. La comprensione dell impresa e del suo contesto
Statistiche campionarie
 Statistiche campionarie Sul campione si possono calcolare le statistiche campionarie (come media campionaria, mediana campionaria, varianza campionaria,.) Le statistiche campionarie sono stimatori delle
Statistiche campionarie Sul campione si possono calcolare le statistiche campionarie (come media campionaria, mediana campionaria, varianza campionaria,.) Le statistiche campionarie sono stimatori delle
Tratto dal libro Come vivere 150 anni Dr. Dimitris Tsoukalas
 1 Tratto dal libro Come vivere 150 anni Dr. Dimitris Tsoukalas Capitolo 7 Enzimi, le macchine della vita Piccole macchine regolano la funzione del corpo umano in un orchestrazione perfetta e a velocità
1 Tratto dal libro Come vivere 150 anni Dr. Dimitris Tsoukalas Capitolo 7 Enzimi, le macchine della vita Piccole macchine regolano la funzione del corpo umano in un orchestrazione perfetta e a velocità
Capitolo 25: Lo scambio nel mercato delle assicurazioni
 Capitolo 25: Lo scambio nel mercato delle assicurazioni 25.1: Introduzione In questo capitolo la teoria economica discussa nei capitoli 23 e 24 viene applicata all analisi dello scambio del rischio nel
Capitolo 25: Lo scambio nel mercato delle assicurazioni 25.1: Introduzione In questo capitolo la teoria economica discussa nei capitoli 23 e 24 viene applicata all analisi dello scambio del rischio nel
Orientamenti sul sottomodulo del rischio di catastrofe per l assicurazione malattia
 EIOPA-BoS-14/176 IT Orientamenti sul sottomodulo del rischio di catastrofe per l assicurazione malattia EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +
EIOPA-BoS-14/176 IT Orientamenti sul sottomodulo del rischio di catastrofe per l assicurazione malattia EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +
