Ai miei genitori, per il sostegno sia economico che morale di questo mio percorso
|
|
|
- Arnoldo Toscano
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ai miei genitori, per il sostegno sia economico che morale di questo mio percorso 1
2 LA TRADUZIONE AUDIOVISIVA E LA SOTTOTITOLAZIONE PER PERSONE CON DISABILITÀ SENSORIALI 2
3 3
4 SOMMARIO SOMMARIO... 4 SEZIONE IN ITALIANO... 7 INTRODUZIONE LA TRADUZIONE AUDIOVISIVA a CHE COS È? b TECNICHE DI TRASFERIMENTO E TRASPOSIZIONE LINGUISTICA c IL TRADUTTORE AUDIOVISIVO INTRODUZIONE AL SOTTOTITOLAGGIO a IL PASSAGGIO DALLE DIDASCALIE AI SOTTOTITOLI b SOTTOTITOLAGGIO E TRADUZIONE c TRATTI CARATTERISTICI DEL SOTTOTITOLAGGIO d ASPETTI SALIENTI DEL SOTTOTITOLAGGIO ACCESSIBILITÀ E USABILITÀ NELLA TRADUZIONE AUDIOVISIVA a STORIA DELL EDUCAZIONE DELLA COMUNITÀ SORDA b LA SORDITÀ c INTRODUZIONE ALLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI d LA COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE DEL BAMBINO SORDO IN ITALIA e LA SOTTOTITOLAZIONE INTRALINGUISTICA PER SORDI ANALISI DEL CONTESTO VISSUTO DALLE PERSONE NON VEDENTI IN ITALIA E L IMPORTANZA DELL AUDIO DESCRIZIONE a COS È L AUDIO DESCRIZIONE? CONCLUSIONI ENGLISH SECTION INTRODUCTION AUDIOVISUAL TRANSLATION a WHAT IT IS? b TRANSFER AND LINGUISTIC TRANSPOSITION TECHNIQUES c AUDIOVISUAL TRANSLATOR INTRODUCTION TO SUBTITLING a THE TRANSITION FROM CAPTIONS TO SUBTITLES b SUBTITLING AND TRANSLATION
5 6.c SUBTITLING CHARACTERISTIC FEATURES d SUBTITLING CONSIDERABLE ASPECTS ACCESSIBILITY AND USABILITY IN AUDIOVISUAL TRANSLATION a HISTORY OF THE DEAF COMMUNITY EDUCATION CONCLUSIONS SECCIÓN EN ESPAÑOL INTRODUCCIÓN LA SORDERA a INTRODUCCIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS b LA COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL NIÑO SORDO EN ITALIA c LA SUBTITULACIÓN INTRALINGÜĺSTICA PARA SORDOS ANÁLISIS DEL CONTEXTO VIVIDO POR LAS PERSONAS CIEGAS EN ITALIA Y LA IMPORTANCIA DE LA AUDIODESCRIPCIÓN a QUÉ ES LA AUDIODESCRIPCIÓN? CONCLUSIONES Ringraziamenti Bibliografia e sitografia
6 6
7 SEZIONE IN ITALIANO INTRODUZIONE La scelta dell argomento deriva da un particolare interesse per il tema della traduzione audiovisiva e in particolar modo per la traduzione dei sottotitoli per non udenti e non vedenti. Il presente lavoro quindi tratterà le tematiche della traduzione audiovisiva in generale e del sottotitolaggio, focalizzandosi sul sottotitolaggio intralinguistico per non udenti e sull audio descrizione per non vedenti, cioè il processo che trasforma le informazioni visive di un film in parole, dando completezza alla traccia sonora e ai dialoghi del film stesso a beneficio del pubblico cieco e ipovedente. Per motivi di chiarezza e semplificazione ho deciso di strutturare il lavoro in tre parti: la prima parte è un quadro generale sulla traduzione audiovisiva; si esamineranno pertanto le tecniche di trasposizione, si analizzeranno i protagonisti della traduzione audiovisiva e le varie soluzioni e forme di traduzione audiovisive. La seconda parte si concentrerà sul tema del sottotitolaggio, in cui verranno esaminate le caratteristiche principali, lo scopo dell utilizzo dei sottotitoli, cioè l apprendimento di una lingua straniera o l ausilio per disabili. Si farà riferimento anche alla storia della comunità sorda e alla sordità in generale, a come hanno vissuto le persone sorde fino ad oggi e come hanno imparato a comunicare. Si passerà poi ad una breve introduzione alla lingua dei segni italiana, alla 7
8 sottotitolazione per non udenti e infine all audio descrizione, la tecnica di sottotitolazione intralinguistica per non vedenti. Nonostante le tecniche dell audio descrizione e della sottotitolazione per non udenti siano, purtroppo, ancora poco utilizzate oggi, ho deciso di concentrare il mio lavoro su questo argomento perché negli ultimi tempi sta diventando comunque argomento di discussione sempre più popolare e si sta affermando in molti Paesi europei e non. Il fenomeno della globalizzazione ha avuto un impatto piuttosto forte e diretto su tutti noi, soprattutto per ciò che riguarda la dimensione linguistica e culturale. Il rapido sviluppo delle tecnologie dell informazione e della comunicazione ha modificato profondamente alcuni aspetti della nostra vita quotidiana e, grazie alla diffusione dei mezzi di comunicazione di massa e al rapido sviluppo tecnologico avvenuto negli ultimi decenni, abbiamo assistito ad una massiccia produzione e distribuzione su scala mondiale di prodotti audiovisivi di ogni genere. Infatti non è un esagerazione affermare che al giorno d oggi siamo costantemente circondati da dispositivi e strumenti tecnologici di ogni forma e dimensione, i quali ci permettono di lavorare, apprendere e tenerci sempre informati. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una vera e propria rivoluzione audiovisiva, con la creazione di canali televisivi satellitari, internet, la telefonia mobile, prodotti cinematografici, dunque si ha accesso ad una grande varietà di materiali audiovisivi provenienti da ogni parte del mondo; parallelamente, la comunicazione ha assunto un ruolo sempre più importante della nostra società, tanto da diventare un vero e proprio prodotto sul mercato internazionale. 8
9 Per queste ragioni il ruolo delle lingue e, in particolare, le attività legate al trasferimento linguistico hanno acquisito un importanza crescente negli ultimi anni perché divenute essenziali per diffondere informazioni e veicolare conoscenze a livello internazionale. La competenza linguistica svolge quindi un ruolo di primaria importanza, in quanto indispensabile per usufruire dei prodotti audiovisivi di ogni nazionalità e per comprendere il significato dei testi che questi nuovi prodotti incorporano. È sorta così una nuova esigenza, ovvero quella di abbattere qualsiasi tipo di barriera (linguistica, culturale, ma anche sensoriale) che impedisca una piena accessibilità e fruibilità dei prodotti distribuiti per mezzo delle tecnologie audiovisive e multimediali ad un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo in termini di età, sesso, livello di istruzione, capacità ricettive, lingua e cultura. In conseguenza di tale fenomeno, ha assunto un importanza cruciale la dimensione culturale, linguistica e traduttologica. Non è difficile immaginare, quindi, quanto sia ampia la varietà di metodologie traduttive ed ambiti applicativi che possono essere ascritti al settore della traduzione audiovisiva. Lo scopo dei capitoli che seguono, dunque, è quello di offrire un quadro teorico di riferimento che permetta di comprendere e analizzare nel dettaglio le caratteristiche e le peculiarità che contraddistinguono la traduzione audiovisiva, elencare le principali tecniche traduttive in uso oggi e differenziare questo tipo di traduzione da altre forme di trasposizione linguistica che per tradizione sono al centro degli studi sulla traduzione. 9
10 1. LA TRADUZIONE AUDIOVISIVA 1.a CHE COS È? Prima di dare una definizione e spiegare cos è la traduzione audiovisiva è bene precisare che essa è un mondo vivo ed elastico, in continua espansione e ridefinizione. Quando parliamo di traduzione di un prodotto audiovisivo non ci riferiamo solo ad una metodologia in particolare, bensì a diverse forme di traduzione che non comportano necessariamente il passaggio da una lingua all altra, ma che operano da e verso la stessa lingua o da un codice a un altro. In questi ultimi casi ci riferiamo alla sottotitolazione per sordi, che implica un attenta attività di riscrittura e di adattamento del dialogo originale all interno dello stesso codice linguistico, e all audio descrizione per non vedenti, un attività che rende verbale il visivo e che non opera all interno dello stesso codice. Ma di questo parleremo nella seconda parte della tesi. Attualmente viviamo, ma possiamo dire che siamo sempre vissuti, in un mondo multimodale. La multimodalità si riferisce a come si comunica il significato attraverso la combinazione di modalità (o canali semiotici) diverse. Oltre allo scritto e al parlato, esistono altre fonti in grado di trasmettere il significato come ad esempio i gesti, la postura, lo sguardo, i rumori, la musica i simboli. In un testo multimodale, il significato è trasmesso attraverso la forza integrata di diverse modalità semiotiche. Oggi, la tecnologia a nostra disposizione e la possibilità di 10
11 comunicare istantaneamente a livello globale hanno creato orizzonti senza precedenti per l espansione multimodale. Le modalità semiotiche diverse dalla lingua (gesti, sguardo, postura, suoni ) trasmettono il significato in molti modi diversi. La gestualità dell uomo utilizza tutte le parti del corpo, dai cenni di assenso fatti con la testa, all indicare con le dita, alla scrollata di spalle. Alcuni di questi gesti sono universali, altri sono tipici di determinate culture, altri ancora cambiano di significato da una cultura all altra, mentre alcuni hanno usi diversi, ma tutti hanno un significato. Nel contesto multimediale, comunque, la lingua costituisce il fattore più importante. Il dialogo di un film tradotto, se tradotto in modo adeguato, interagirà con le stesse modalità semiotiche per ricreare lo stesso effetto nel pubblico di arrivo come aveva fatto l originale con il pubblico di partenza. Quello che può incrinare questa situazione ideale è la presenza di vincoli di tempo che non permettono una traduzione completa, o quella degli squilibri sintattici tra lingue (l inglese, per esempio, è generalmente più breve dell italiano), oppure la mancanza di un tempo sufficiente per consentirne la lettura da parte del pubblico. In questi casi il traduttore audiovisivo può cercare aiuto tra le altre risorse semiotiche in gioco e può quindi operare delle scelte che riguardano la versione tradotta del prodotto. Tra le varie scelte non è da escludere il non tradurre. Infatti, se un gesto ha un significato inequivocabile, il traduttore potrebbe anche scegliere di non tradurre, oppure può scegliere anche di abbreviare la traduzione, cioè di tradurre solo gli elementi più importanti. In una situazione marcata dal punto di vista culturale, 11
12 invece, la decisione potrebbe essere di espandere il testo di partenza, aggiungendo informazioni, per facilitarne la comprensione. Dopo questa breve introduzione, con il termine traduzione audiovisiva, dunque, si fa riferimento a tutte le modalità di trasferimento linguistico che si propongono di tradurre i dialoghi originali di prodotti audiovisivi, al fine di renderli accessibili ad un pubblico più ampio. Mantenere un alto livello di aderenza con specifici aspetti dell originale è un operazione sempre complessa, che fa del traduttore (audiovisivo e non) una figura di grande responsabilità. Oggetto della traduzione audiovisiva sono testi che non contengono solo l elemento verbale, ma che includono sistemi semiotici differenti, di cui i principali sono quello verbale e visivo, ma anche quello sonoro, grafico, cinetico e gestuale. Ogni modalità semiotica è portatrice di un significato fondamentale ai fini della comprensione del testo nella sua totalità, perciò non deve essere trascurata dal traduttore. In altre parole, il destinatario di un testo audiovisivo può cogliere appieno il messaggio e percepirne ogni sfumatura solo se può usufruire di tutti i segnali simultaneamente. La maggiore difficoltà della traduzione audiovisiva risiede quindi nel fatto che essa deve restituire parallelamente al senso degli elementi verbali quello degli elementi non verbali. 12
13 Ogni tecnica traduttiva è costituita da due processi focali: Processo: attività tramite l esecuzione della quale si ottiene il testo di arrivo (TA) a partire da un testo sorgente (TS), comprendente i percorsi operativi e psico-cognitivi del traduttore. Prodotto (=TA): risultato conseguito mediante il processo traduttivo, dato in fruizione all utenza finale. Inoltre, per ogni tecnica traduttiva devono essere definiti il mezzo (orale, scritto o entrambi), il canale (acustico, visivo, audio-visivo, simbolico-tattile), la modalità del processo (in tempo reale, in differita, consecutiva, simultanea, a vista), la lingua (linguaggio di TS e TA) e la localizzazione del prodotto (cartacea, nastro, web, software). In sintesi, possiamo distinguere due tipi di traduzione: la traduzione interlinguistica (il testo sorgente TS e il testo di arrivo TA sono in due lingue differenti), la traduzione intralinguistica (TS e TA condividono la medesima lingua). Mentre tra le tipologie dei processi traduttivi distinguiamo l interpretazione, che può essere simultanea, consecutiva o a trattativa, la traduzione propria, che può essere letteraria o tecnico-scientifica e la traduzione audiovisiva, di cui fanno parte il doppiaggio e la sottotitolazione. La traduzione audiovisiva, che è di nostro interesse nel presente lavoro, possiede un TS a due canali, quello audio e quello visivo (verbale e non) e l obiettivo è quello di rendere disponibili a un utenza più ampia prodotti audiovisivi che altrimenti risulterebbero non fruibili per motivi sensoriali o linguistici. Si 13
14 può riferire quindi a prodotti eterogenei come il materiale televisivo o cinematografico, prodotti derivanti dall Opera e dal teatro, materiale prodotto in seminari e conferenze ecc. La componente audio verbale nella traduzione audiovisiva comprende i dialoghi, i monologhi, eventuali brani musicali cantati dagli attori e qualsiasi altra componente verbale o dialogica significativa per il prodotto finale; mentre la componente audio non verbale è costituita da effetti speciali, rumori di fondo, musiche di sottofondo, altri effetti sonori non voluti o non significativi per il prodotto finale. Per quanto riguarda la componente video verbale, essa annovera qualsiasi dato scritto visibile durante la fruizione del prodotto come didascalie, sottotitoli, sottopancia, scritte interne derivanti da inquadratura, mentre la componente video non verbale è costituita da elementi di fotografia, prossemica (l ambiente di svolgimento della comunicazione) e cinesica (gestualità e linguaggio del corpo degli attori). Negli anni 80 e 90 in Europa si assiste ad una riconsiderazione delle minoranze linguistiche e ai media è riconosciuto il ruolo di strumenti utili per agevolare la comunicazione e per promuovere e rinforzare l identità linguistico-culturale. Si hanno quindi i primi studi di traduzione filmica (film translation) e traduzione per lo schermo (screen translation), ancora oggi molto utilizzate. Mentre il trasferimento linguistico (language transfer) subentra in un secondo momento, e mette in evidenza la componente verbale del prodotto audiovisivo. Da qui nasce l esigenza di introdurre la designazione più precisa ed esauriente di traduzione audiovisiva, oggi utilizzata per fare riferimento alla dimensione semiotica di tutte le opere 14
15 cinematografiche e televisive i cui dialoghi subiscono una traduzione. Nel testo audiovisivo la sfera sonora e quella visiva si combinano creando un complesso testo multicolore la cui traduzione può essere problematica. Fin dalla nascita del cinema sonoro si è manifestato il bisogno di tradurre i film importati e, di conseguenza, si sono sviluppati numerosi metodi di traduzione audiovisiva e strategie di trasferimento linguistico molto differenti tra loro. 1.b TECNICHE DI TRASFERIMENTO E TRASPOSIZIONE LINGUISTICA A seconda del trattamento che subiscono i dialoghi originali e di come la loro versione tradotta e adattata è presentata al pubblico, si distinguono diverse forme di traduzione audiovisiva che vanno dal doppiaggio alla descrizione audiovisiva per non vedenti. Esistono tredici tipi di trasferimento linguistico, ma otto sono quelli dominanti: Sottotitolazione interlinguistica Doppiaggio Interpretazione consecutiva Interpretazione simultanea Voice-over 15
16 Commento libero Traduzione simultanea I challenging (traduzione degli script, la sottotitolazione simultanea o in tempo reale, la sopratitolazione, la descrizione audiovisiva e la sottotitolazione intralinguistica per sordi). La tecnica della sottotitolazione è il procedimento grazie al quale una traduzione viene resa, grazie ad un testo scritto, collocato nella parte inferiore dello schermo, e che riporta un testo tradotto condensato risultante da un forte lavoro di riduzione testuale. Poiché la traduzione è offerta simultaneamente alla versione originale e poiché lo spettatore ha accesso contemporaneamente a entrambe, la sottotitolazione ha acquisito l etichetta di modalità di traduzione trasparente. Esistono vari tipi di sottotitolazione, come ad esempio la sottotitolazione simultanea, che è una procedura che si esegue i tempo reale, nel momento stesso della trasmissione di un programma. Si tratta di una sorta di interpretariato scritto, in cui un interprete-traduttore riferisce un messaggio tradotto e ridotto rispetto al testo originale, mentre un tecnico è incaricato di scrivere velocemente ciò che lo spettatore riceverà sotto forma di sottotitolo. Un esempio di questo tipo di traduzione è il respeaking, l utima nata tra le tecniche di sottotitolazione. Il respeaking è una tecnica di sottotitolazione simultanea tramite software di riconoscimento del parlato; un testo orale viene simultaneamente tradotto in un testo scritto. Questa forma di traduzione è utilizzata soprattutto per trasmettere in diretta interviste o notizie all ultimo minuto ed è particolarmente impegnativa. 16
17 La sopratitolazione è una modalità di traduzione adottata negli anni 80 per tradurre il teatro in prosa e l opera lirica, ma è marginale nell ambito cinematografico. Questa tecnica consiste nel riportare una traduzione scritta del testo originale dell opera teatrale, proiettata su appositi schermi al lato del palcoscenico oppure sopra o al di sotto della scena. Questa idea non è affatto nuova, ma ha raggiunto visibilità solo nel ventesimo secolo, mentre prima la maggior parte delle opere liriche veniva recitata in lingua tradotta. Il doppiaggio è la procedura di traduzione audiovisiva più nota e diffusa in Italia che consiste nel sostituire per post-sincronizzazione la colonna sonora originale di un film con una nuova colonna sonora provvista di dialoghi tradotti nella lingua dei fruitori. Nel caso del doppiaggio, la traduzione sostituisce del tutto il testo originale, mentre per la sottotitolazione possiamo parlare di modalità di traduzione trasparente perché il testo tradotto affianca quello originale, senza eliminarlo affatto. Questo sistema richiede grande precisione nella sincronizzazione, cioè nell adattare i nuovi dialoghi in modo che il testo udito nella lingua della traduzione e i movimenti labiali degli attori coincidano il più possibile per dare l impressione al nuovo spettatore che gli attori stiano parlando nella sua lingua. Ovviamente la difficoltà del dialoghista non è solo questa, ma a livello linguistico deve affrontare e risolvere altre situazioni difficili: tradurre giochi di parole, adattare la traduzione all immagine, tradurre termini culturalmente connotati, trasporre, usando formule opportune, il turpiloquio o forme allocutive, mantenere, se presente, l umorismo del testo originale. 17
18 Il voice-over è usato per mandare in onda notizie, documentari o interviste provvisti di una traduzione simultanea al dialogo originale. Ciò permette di accedere solo in maniera parziale alla versione originale, che non è mai udita nella sua integrità. Questa tecnica consiste nell aggiungere una nuova colonna sonora sul filmato da tradurre, ma consentendo contemporaneamente di lasciare inalterata la pista audio originale. L unica variazione che il testo di partenza subisce consiste in un abbassamento di volume, così da far risaltare la versione audio tradotta e lasciare il sottofondo sonoro originale. La coincidenza tra i dialoghi letti e dialoghi originali è tuttavia approssimativa e non così puntuale. Il voice-over non richiede sincronia labiale e quindi facilita e velocizza la traduzione. Nella narrazione il testo rielaborato presenta un maggior numero di riduzioni e adattamenti rispetto al voice-over. Il testo di partenza, già tradotto anticipatamente, è alleggerito dalle parti ritenute superflue. Il testo viene poi letto da un unica voce ed è presentato in sincronia con il testo originale. Rispetto al voice-over, la tecnica della narrazione ammette un maggiore distacco dal testo originale sia a livello contenutistico, sia a livello stilistico; quindi il testo sarà più formale e curato nei particolari stilistici, e i discorsi diretti sono trasformati in indiretti perché la voce del narratore racconta in modo distaccato ciò che accade. Il commento è spesso utilizzato per rendere fruibili documentari o cortometraggi. Una delle caratteristiche principali di questa tecnica sta nella libertà d interpretazione del testo originale; in molti casi, infatti, il 18
19 prodotto di arrivo rappresenta una vera e propria versione nuova rispetto all originale. La scarsa fedeltà al testo di partenza è implementata dalla possibilità di aggiungere o eliminare informazioni ogni volta che lo si ritiene opportuno grazie all elasticità dei vincoli spazio-temporali. Il commento è particolarmente efficace per rendere accessibili programmi culturalmente distanti; i contenuti possono essere attualizzati o sostituiti da informazioni ritenute più facilmente accessibili; interi brani relativi ad argomenti specifici della cultura emittente possono essere rimossi o espansi in base alle esigenze del pubblico di destinazione. La lingua del commento presenta strutture sintattiche semplici in cui vi è la predilezione per frasi coordinate e proposizioni brevi. La descrizione audiovisiva, o audio descrizione, è quella forma di traduzione audiovisiva indirizzata a un pubblico di non vedenti. Consiste in una voce fuori campo che descrive ciò che si vede sullo schermo, dà informazioni più o meno dettagliate riguardanti la scena, permettendo allo spettatore cieco o ipovedente di integrare le informazioni percepibili attraverso la banda sonora del film o del programma scelto con una versione sonora delle informazioni visive più significative. La difficoltà della descrizione audiovisiva risiede nell eterogeneità del pubblico cui si rivolge: il traduttore che deve operare con questa tecnica deve tenere in considerazione le diverse difficoltà di ricezione degli utenti. La ricerca del messaggio udito verrà infatti rielaborata in modo diverso dai ciechi dalla nascita, assolutamente privi di memoria visiva, e da chi, avendo perso la vista in una fase successiva della propria vita, è provvisto di un maggiore o un minore grado di memoria visiva. 19
20 La traduzione filmica costituisce in ogni caso un campo di ricerca complesso a causa delle diverse metodologie utilizzate nei vari campi. Inoltre i copioni dei testi audiovisivi nelle lingue di partenza e di arrivo non sono sempre disponibili e quindi qualche volta è necessario un lavoro di trascrizione che richiede molto tempo. 1.c IL TRADUTTORE AUDIOVISIVO L attenzione riservata in misura sempre maggiore da parte della comunità scientifica ha fatto sì che la figura del traduttore si sviluppasse ulteriormente, in maniera professionale anche in nuovi ambiti lavorativi. Questo esito si è avvertito soprattutto in campo cinematografico, dove nel corso degli ultimi vent anni, con l aumento esponenziale della circolazione di prodotti audiovisivi, è cresciuta di pari passo la necessità di una qualsiasi forma di traduzione adatta al mondo del cinema. Grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie in campo informatico, come ad esempio internet, ma anche grazie alla comparsa di supporti ottici come CD o DVD, oppure quelle piattaforme satellitari per la televisione, la traduzione in questo campo ha raggiunto un importanza cruciale per i futuri esiti della comunicazione audiovisiva. In questo nuovo scenario mondiale, come abbiamo già detto, ha trovato 20
21 spazio una nuova figura professionale e specializzata, il traduttore audiovisivo. Laddove un tempo la traduzione era principalmente gestita da traduttori indipendenti o da persone con inadeguate abilità linguistiche, talvolta favorite da un retroterra professionale legato al mondo del cinema o della televisione, adesso questo non è più accettabile. Comunque oggi è sempre più forte la consapevolezza da parte di produttori e distributori che un efficace ricezione di un film non dipende solo dalla qualità dei meccanismi di sincronizzazione del doppiaggio, o dalla sottotitolazione, ma anche dalla qualità della traduzione del testo. Il traduttore audiovisivo ha un ruolo molto importante durante il processo di sottotitolazione. Innanzi tutto, all arrivo di un prodotto audiovisivo, il traduttore ha il compito di trascrivere tutti i dialoghi, ascoltando la colonna sonora originale. Inoltre, si occuperà di tradurre, nella lingua in cui dovranno apparire i sottotitoli, il testo originale, adattandolo alla lingua di arrivo. Una volta effettuato il lavoro di traduzione, ci sarà bisogno di un accurata revisione, che può essere effettuata sia dal traduttore stesso, sia da un altro traduttore, per un diverso punto di vista. Un buon traduttore dovrà prendere nota ogni volta che si presentano punti critici nel testo di partenza, come parole o espressioni ambigue, frasi idiomatiche e colloquiali, uso e omissione di deittici (questo/questi, quello/quelli), esclamazioni che non sono direttamente traducibili da una lingua all altra, che potrebbero causare problemi linguistici o di traduzione nelle fasi successive del lavoro. Dopo queste operazioni può procede alla traduzione vera e propria. 21
22 2. INTRODUZIONE AL SOTTOTITOLAGGIO 2.a IL PASSAGGIO DALLE DIDASCALIE AI SOTTOTITOLI Dopo l avvento del cinema muto (1895) in Europa vengono usati per la prima volta gli intertitoli (generalmente bianchi su sfondo nero), che costituivano delle didascalie complementari. Questi brevi testi scritti, che sono brevi sequenze di commenti descrittivo-esplicativi o brevi dialoghi, apparivano su tutto lo schermo su fondo nero per veicolare informazioni utili alla comprensione della scena, o per riportare brevi dialoghi dei personaggi nei film. Questa tecnica può essere considerata come un precedente dei sottotitoli odierni, anche se con sostanziali differenze. Infatti gli intertitoli occupano un fotogramma ad essi destinato e quindi si posizionano tra due fotogrammi del film originale, mentre il sottotitolo viene proiettato direttamente sull immagine del film. A partire dal 1927 le didascalie incominciano ad essere sovrapposte e non più interposte alle immagini, finché spariscono definitivamente, permettendo agli spettatori di ascoltare la versione originale dei dialoghi e di comprenderla, se necessario, anche 22
23 attraverso il sottotitolo. Con l avvento del sonoro lo scenario cinematografico cambia totalmente; in un primo momento si tentò di favorire la fruizione di una stessa pellicola in diverse culture e lingue del mondo tramite le edizioni multilingue. Questo procedimento consisteva nel girare lo stesso film in più versioni linguistiche, spesso con attori e registi diversi, ma questa tecnica chiaramente risultava molto costosa e per questo fu abbandonata. Così si è cominciato a consolidare l utilizzo della sottotitolazione. Sin dalla nascita, il processo di sottotitolazione ha subito molte trasformazioni in maniera graduale, si è evoluto, è migliorato e si è affinato grazie alla modernizzazione delle tecniche coinvolte e anche grazie ai media, i quali, ideati inizialmente per il cinema, sono stati poi usati anche per la televisione. In seguito, però, ci si è resi conto che i sottotitoli preparati per il cinema non erano adatti per essere trasmessi anche in televisione. Nemmeno la ricezione del pubblico è rimasta la stessa: è stato infatti dimostrato che la velocità di lettura degli spettatori dipende anche dal mezzo che trasmette i sottotitoli (per leggere i sottotitoli al cinema si necessita il 30% di tempo in meno rispetto al tempo necessario per leggere gli stessi sottotitoli sul piccolo schermo). Risulta chiaro, quindi, che non esiste un sottotitolo universale adatto a tutti i contesti, ma esso deve essere costruito in base al media specifico per cui viene preparato. Il 1927 segna il punto di partenza di un secolo di cambiamenti e di evoluzione: dai sottotitoli costituiti da brevi frasi di dialogo si arriva ai sottotitoli di oggi che, insieme al doppiaggio, costituiscono il principale veicolo di internazionalizzazione del cinema come della televisione. In quest ottica, quindi, i sottotitoli sono da considerarsi i garanti 23
24 dell esportazione dell industria cinematografica e televisiva, soprattutto laddove la tecnica della sottotitolazione è preferita a quella del doppiaggio. Non è il caso dell Italia, in cui nelle sale cinematografiche risulta quasi impossibile trovare un film straniero nella sua versione originale. Ciò è dovuto essenzialmente a ragioni di natura politica (in Italia il governo fascista privilegiava il doppiaggio dei film in lingua straniera perché questo dava la possibilità di variare o addirittura capovolgere il significato di un discorso o l assunto di un film, se questo non era conforme alle idee del regime) e culturale (in un paese come l Italia in cui il tasso di analfabetismo nazionale dell epoca era molto basso, il doppiaggio era considerato come veicolo di uniformazione dell Italia a livello linguistico). Al contrario, paesi come Danimarca e Norvegia sono stati i primi ad utilizzare la tecnica del sottotitolaggio. Oggi anche in Francia la maggior parte dei film di produzione straniera viene proposta nelle sale cinematografiche in versione originale sottotitolata. Un produttore canadese di film documentari e autore di diverse opere sul cinema, Lucien Marleau, in un suo saggio sul sottotitolaggio pubblicato sulla rivista online traduttologica Meta, nel 1982 affermò Les sous-titres un mal nècessaire 1 (i sottotitoli un male necessario). L autore, già dal titolo, fornisce al lettore una visione complessa e antitetica; in poche parole egli ha saputo riassumere l essenza stessa del sottotitolo, sottolineandone da un lato la sua necessità di esistere e dall altro il suo carattere nocivo per chi ne fa uso, lo spettatore. 1 L. Marleau, Meta,
25 Questa breve parentesi ha permesso di dare un perché all essenzialità del sottotitolaggio. Dunque, per guardare un film in lingua straniera, a meno che non si abbia un ottima conoscenza della lingua originale, il sottotitolaggio rimane uno dei principali veicoli di fruizione di una pellicola cinematografica in versione originale. 2.b SOTTOTITOLAGGIO E TRADUZIONE Nell ambito della traduzione la sottotitolazione è stata finora considerata come una delle numerose forme di traduzione di prodotti audiovisivi. L attività di sottotitolazione è un attività che necessita di una specifica inquadratura metodologica e terminologica. Fra i numerosi esempi, si possono citare le attività di sottotitolazione per il materiale cinematografico da rendere in lingua differente dall originale, il materiale cinematografico da rendere in lingua originale per non udenti, i contributi filmati a conferenze, meeting e incontri da rendere nelle varie lingue di appartenenza alla composizione dell uditorio e il materiale audiovisivo di animazione in lingua differente dall originale. Nel tentativo di definire la sottotitolazione, gli studiosi mettono in evidenza i tratti più caratteristici e cioè quelli relativi alla riduzione testuale e alla semplificazione. Il sottotitolo non viene considerato come un riassunto dell originale, bensì una sua riduzione selettiva, volta ad adattare la lingua alle circostanze e a permetterle di rappresentare ciò che il parlante intendeva comunicare. Ovviamente di 25
26 rado è possibile tradurre ciò che si dice nell originale. La sottotitolazione è un tipo di traduzione che implica modi di rielaborazione testuale piuttosto complessi, poiché il passaggio da una lingua di partenza a una di arrivo deve essere in consonanza con la contemporaneità delle immagini e dei suoni a esse attinenti. Quindi il traduttore di sottotitoli deve saper trasferire le intenzioni comunicative veicolate dal codice della lingua di partenza al codice della lingua di arrivo, dal codice orale al codice scritto, il quale deve essere in sincronia con tutte le realtà paralinguistiche presenti nel film, come le distanze e i movimenti degli attori. Inoltre il traduttore di sottotitoli deve anche saper far corrispondere il testo sovraimpresso del sottotitolo al testo parlato, calibrando la inevitabili riduzioni per non ostacolare il flusso della comprensione da parte degli spettatori. La componente traduttiva della sottotitolazione include quindi alcuni concetti fondamentali riguardo la teoria della traduzione quali l equivalenza, l adeguatezza, la fedeltà e la traducibilità, nozioni molto importanti a cui un traduttore deve tener conto. L equivalenza fa riferimento alla descrizione della natura e il tipo di relazioni che si instaurano tra testo originale e testo tradotto. Ricorrere a espressioni equivalenti significa fare uso, nel metatesto (testo di arrivo), di espressioni che si adattano alla situazione, che sono appropriate al contesto inserite nell originale. L obiettivo, quindi, è quello di presentare una stessa situazione dell originale usando parole diverse per tradurre frasi idiomatiche fisse, proverbi ecc. Anche l adeguatezza fa riferimento alla relazione tra testo e lingua di partenza e testo e lingua di destinazione, ma è più debole, meno 26
27 rigida. La produzione di una traduzione adeguata riflette la risposta del traduttore a una situazione comunicativa che non può essere trasferita in modo completo e assoluto, ma che esige una sorta di compromesso e sacrificio, inteso come perdita necessaria per poter veicolare gli aspetti principali ed essenziali del testo fonte. In presenza di un elemento dominante nel testo, verranno sacrificati altri elementi ritenuti secondari e meno importanti e si cercheranno tutti i mezzi possibili per tradurre l elemento dominante; gli elementi secondari saranno poi ripristinati in varie forme attraverso adeguate strategie di compensazione. Più precisamente, quindi, con il concetto di adeguatezza ci si riferisce ad una traduzione che guarda il testo di arrivo ed è pienamente consapevole delle esigenze di quest ultimo. Infine, l impego di una soluzione adeguata deve essere per necessità e non per decisione del traduttore. Il termine fedeltà invece viene usato per dire quanto una traduzione possa considerarsi una rappresentazione ragionevole e leale all originale, e questo presuppone che il traduttore comprenda appieno il significato e il messaggio del prototesto. Facendo riferimento alla questione tanto discussa del traduttore-traditore, il rischio e la possibilità di tradire è presente soprattutto nel momento in cui si traducono opere filmiche. Quindi, il fatto che il traduttore deve conoscere bene la lingua e la cultura straniera da cui traduce è un fattore molto importante per assicurare una buona traduzione. Il primo compito del traduttore è quello di capire e analizzare il testo di partenza, in modo da poter scegliere il metodo traduttivo più adeguato, poi deve riuscire a mantenere quanto più possibile l originalità 27
28 grammaticale e semantica del testo, capire quindi qual è l intenzione dell autore e il linguaggio che usa per persuadere lo spettatore, quindi deve acquisire la tecnica per muoversi con più sicurezza e svolgere un buon lavoro. Il fattore traducibilità è molto importante per sapere fino a che punto è possibile tradurre da una lingua all altra. Dove non è possibile tradurre per motivi lessicali o culturali, possono essere adottate strategie traduttive particolari come l esplicitazione, aggiunte di glosse, commenti esplicativi, parafrasi o riformulazione di termini originali per chiarificare un significato. Quando parliamo, invece, di problemi di trasferimento linguistico, facciamo riferimento alle difficoltà di traduzione che risiedono nell asimmetria linguistica, che implica numerosi procedimenti linguistici per adattare il testo tradotto agli standard del pubblico per cui si traduce. Gli elementi linguistici trattati sono giochi di parole, e, in particolar modo, quelle parole o espressioni che non hanno un corrispettivo nella lingua verso cui si sta traducendo. I giochi di parole presentano un ambiguità lessicale basata sull omonimia o sull omofonia delle parole utilizzate. Per espressioni che non hanno un corrispettivo nella lingua verso cui si traduce si intendono quelle frasi per cui non esiste nessun equivalente codificato. Queste si oppongono ai modi di dire o frasi fatte, come ad esempio i proverbi, che invece possono avere un equivalente in diverse lingue. Ma oltre alle problematiche di natura linguistica, in un testo audiovisivo è molto probabile imbattersi in problemi di trasferimento culturale, poiché ad essere tradotta non è 28
29 solo la lingua, ma anche elementi culturali, e ogni paese possiede culture e tradizioni differenti. Come comportarci in questo caso? Bisogna ricorrere a delle strategie. Il traduttore e storico americano Lawrence Venuti propone il modello addomesticamentostraniamento 2 : il primo consiste nella sostituzione di un dato elemento culturale, cancellando l estraneità da esso rappresentata e sostituendolo con un elemento familiare nella cultura di arrivo. Lo straniamento, invece, è la strategia opposta, cioè rappresenta l elemento culturale esattamente come appare nel testo originale. Altre strategie presentate da altri studiosi sono: l omissione (dell elemento culturale nel testo tradotto), traduzione letterale, prestito (il termine viene presentato nella traduzione nella sua forma originale), equivalenza (uso del corrispettivo dell espressione originale all interno del testo tradotto), adattamento (la traduzione è conformata alla cultura del pubblico per cui si traduce), sostituzione del termine culturale con un deittico, generalizzazione (il termine culturale viene sostituito con un termine più generale di facile comprensione), spiegazione del termine culturale attraverso una parafrasi. Ma vediamo nel dettaglio quali sono tutte le strategie traduttive utilizzate nella sottotitolazione: 1. Espansione (Expansion): aggiunta di spiegazioni 2. Parafrasi (Paraphrase): cambiamento di qualche elemento della frase, necessario nel passaggio della lingua di partenza alla lingua obiettivo 2 Venuti, L., Strategies of Translation, 1998:
30 3. Trasposizione (Transfer): traduzione letterale 4. Imitazione (Imitation): riproduzione di alcuni tratti della lingua di partenza 5. Trascrizione (Transcription): tentativo di riprodurre suoni che sono insoliti per entrambe le lingue, come le voci di animali 6. Slittamento (Dislocation): uso di mezzi linguistici diversi per mantenere lo stesso effetto 7. Restrizione (Condensation): riassunto del testo originale senza perdite di significato 8. Riduzione (Decimation): eliminazione di una parte del testo originale contenente significati non essenziali 9. Cancellazione (Deletion): eliminazione totale di una parte del testo con perdita di significati 10. Rinuncia (Resignation): soluzione che non soddisfa le esigenze linguistiche o semantiche del testo di partenza Roman Jakobson, nel suo saggio del 1959 Aspetti linguistici della traduzione 3, ha dato una svolta alla teoria della traduzione. Egli intende la traduzione come un problema di interpretazione e non di semplice trasposizione di un segno in un altro e individua tre tipi di interpretazione di un segno linguistico, dai quali nascono tre tipi di traduzione: la traduzione endolinguistica (intralinguistica), che consiste 3 R. Jakobson, Aspetti linguistici della traduzione, 1959, Milano, Edizione Strumenti Bompiani,
31 nell interpretare dei segni linguistici per mezzo di altri segni della stessa lingua, la traduzione interlinguistica o traduzione propriamente detta, quando opera su testi appartenenti a due sistemi linguistici differenti, e la traduzione intersemiotica, che si serve di segni non linguistici per interpretare segni linguistici. Più precisamente quando si incontra una lacuna linguistica la terminologia sarà modificata e ampliata da prestiti, calchi o trasposizioni semantiche. 2.c TRATTI CARATTERISTICI DEL SOTTOTITOLAGGIO Abbiamo già detto che il sottotitolaggio è una tipologia di traduzione audiovisiva che ha delle proprie tecniche, regole e criteri; viene definita traduzione subordinata, poiché ha delle restrizioni di tempo e spazio che influenzano in modo diretto il risultato finale. La traduzione dipende quindi da questi parametri, e consiste non solo nel tradurre il contenuto testuale, ma si basa anche sull immagine e sull audio, contando su un tempo e uno spazio determinati. Per questo motivo la traduzione del sottotitolo è definita sincronica e traduzione trasparente, poiché rispetta totalmente l integrità del dialogo originale, che nella sua forma orale convive con la traduzione scritta. Il film sottotitolato non può permettersi di manipolare il 31
32 messaggio originale perché mette lo spettatore nelle condizioni di confrontarlo costantemente con la traduzione. L unica manipolazione possibile, e necessaria, riguarda la riduzione del testo tradotto rispetto a quello originale. La sottotitolazione deve infatti essere selettiva ed economica rispetto alle informazioni da veicolare: poiché lo spettatore non può leggere un testo troppo lungo in tempi troppo brevi, è importante che si selezionino solo le informazioni rilevanti, eliminando ciò che è ridondante o poco utile per la comprensione globale del film. Anche se vi è, tra le altre caratteristiche, l impossibilità di rendere in forma scritta tutte le sfumature e le caratteristiche della lingua parlata, la sottotitolazione rappresenta una procedura vantaggiosa per una larga fetta di utenti che comprende sordi, immigrati e apprendenti di lingue straniere. Lo spazio che si dispone per la traduzione in sottotitoli si limita a due linee, di solito collocati nella parte inferiore dello schermo; ogni linea non può contenere più di 35 caratteri, il che significa che il numero di caratteri che può contenere un sottotitolo intero è di 70 caratteri. In termini di tempo, un sottotitolo ha una durata minima di un secondo e una durata massima di sei secondi nello schermo. Per quanto riguarda infatti la struttura del sottotitolo, bisogna adottare linee di testo più corte dell intera larghezza dell area visuale, suddividendole laddove necessario in stringhe multi-linea (linea superiore solitamente più corta); soprattutto nelle traduzioni bisogna adottare laddove consentito una sintassi lineare per consentire una lettura veloce e intuitiva; bisogna utilizzare colori, sfondi, dimensioni dei 32
33 font adeguati al contesto e non invasivi da un punto di vista grafico e cromatico. Infine è importante rispettare la punteggiatura e utilizzarla come vettore di elementi para-linguistici (stati d animo, toni, emozioni manifestate dal parlante). La sottotitolazione comprende anche una parte tecnica chiamata modello, spotting in inglese, vale a dire calcolare il momento nel quale i sottotitoli appaiono e scompaiono dallo schermo, in modo che esista una sincronizzazione con l audio. Si deve inoltre tener conto della durata dei sottotitoli e dei cambi di inquadratura che vengono fatti nell immagine. Infatti, quando si produce un cambio di inquadratura, lo spettatore tende ad abbassare lo sguardo per rileggere il sottotitolo. È molto importante che il canale visivo (testo scritto e immagini) e il canale uditivo (colonna sonora e testo orale) siano perfettamente integrati per ricostruire in modo chiaro ed efficace il messaggio originale. L eccessiva concentrazione su una sola delle due coordinate informative può comportare la perdita di parte del contenuto veicolato da quella trascurata. Quindi, la riduzione, la trasformazione diamesica (passaggio dal codice orale a quello scritto) e la traduzione sono le fasi principali ed essenziali che costituiscono il processo di sottotitolazione. La riduzione del testo originale è quasi necessaria poiché i sottotitoli non possono essere una trasformazione integrale e dettagliata dei dialoghi della versione originale, per motivi di tempo e spazio sia del sottotitolatore, sia dei tempi di lettura del pubblico. La trasformazione diamesica riguarda invece la trascrizione del dialogo sotto forma di sottotitolo. In generale, la lingua scritta non rappresenta una trascrizione del parlato; i due codici hanno una diversa funzione, un 33
34 target diverso, che non sempre si possono far coincidere. È bene che il sottotitolo raggiunga il giusto equilibrio tra il polo della rigidità, del controllo, della pianificazione, della chiarezza e della concisione tipiche dello scritto e il polo della flessibilità, della libertà, della ridondanza e dell implicitezza tipiche del parlato. La realizzazione dei sottotitoli può essere effettuata tramite un agenzia di sottotitolazione, che mette a disposizione un team di esperti del settore, insieme ad apparecchiature per la sottotitolazione. La creazione di sottotitoli tramite agenzia prevede quindi un lavoro di squadra e vede coinvolta ogni singola persona in maniera diretta o indiretta al processo di realizzazione. Ognuno degli stadi di esecuzione prevede, da parte dei soggetti che ne prendono parte, accuratezza e precisione e si spazia dal momento in cui il lavoro viene commissionato, fino al momento in cui i destinatari finali, ovvero gli spettatori, possono usufruire di un prodotto sottotitolato. Di solito è sempre presente un traduttore, che si occupa di trasporre il testo dalla lingua originale a quella del sottotitolatore, che crea sottotitoli, dividendoli e sincronizzandoli al video e, se non dovesse essere presente un traduttore, il sottotitolatore si occuperà di tradurre la colonna sonora originale prima di dedicarsi all adattamento e allo spotting; infine, possono essere presenti dei tecnici, che si dedicano al controllo dell audiovisivo prima di iniziare il lavoro di sottotitolazione e che imprimono il file dei sottotitoli sulla traccia video. Al giorno d oggi, le operazioni di sottotitolazione possono essere eseguite anche da una singola persona, purché abbia dimestichezza con le lingue straniere in cui decide di creare i sottotitoli e con i programmi per sottotitolare materiali audiovisivi. È possibile creare dei sottotitoli anche senza 34
35 l ausilio di alcuna agenzia, grazie ai software disponibili su internet. In questo caso, la singola persona che decide di affrontare questo lavoro diventerà traduttore, sottotitolatore e tecnico. È possibile suddividere, quindi, il processo di sottotitolatura in diverse fasi: 1. Arrivo del prodotto da sottotitolare; 2. Il tecnico controlla che il prodotto non sia danneggiato; 3. Il traduttore annota i punti critici del testo originale e poi inizia la traduzione vera e propria; 4. Il sottotitolatore revisiona e divide il testo tradotto; 5. Si esegue lo spotting (viene deciso il preciso istante in cui compariranno i sottotitoli e quando dovranno sparire; 6. Si esegue una prova cartacea della sottotitolatura e si fa un altra revisione per eventuali errori; 7. Viene eseguita l incisione dei sottotitoli sulla pellicola. Prima di essere presentata al pubblico, la pellicola verrà poi visionata da un cliente e da un tecnico. Possiamo, pertanto, riassumere così il processo di sottotitolazione: Modello: localizzazione dei tempi di entrata e uscita dei sottotitoli, sincronizzati con l audio, calcolando i tempi minimo e massimo di durata e rispettando i cambi id inquadratura e di scena. 35
36 Traduzione (adattamento): traduzione dell originale, adattandola e aggiustandola ai caratteri permessi secondo la durata del sottotitolo. Simulazione: rappresentazione dei sottotitoli tradotti con l immagine audio per verificare che si rispettino tutti i criteri e che si possano leggere in modo naturale. Correzione: correggere eventuali errori e riallineare il testo. Per quanto riguarda invece la parte di adattamento, esistono una serie di criteri basici che si eseguono nella sottotitolazione. Il testo che contiene i sottotitoli deve essere un testo naturale, con la stessa punteggiatura, regole ortografiche e convenzioni della lingua naturale. Non si deve convertire in un telegramma per cercare di adattarlo al numero dei caratteri, ma si deve arrivare ad un adattamento che risulti naturale e corretto. Ecco quali sono alcuni criteri basici principali: Il taglio del sottotitolo, la separazione delle due linee, non deve mai interrompere in nessun modo l unità del significato. Non si deve separare un sostantivo e il suo aggettivo in due linee differenti, o un sostantivo e un verbo, ma deve essere un taglio naturale. Si utilizza il trattino breve nelle conversazioni per indicare che parlano due persone, con un trattino e un intervento per linea di sottotitolo. 36
37 Si utilizza il corsivo per voci in off, canzoni e audio provenienti da fuori della scena degli apparati elettronici. Si utilizzano virgolette, abbreviature, cifre, e si evitano per quanto possibile le lettere maiuscole. Possiamo inoltre distinguere due tipi di sottotitolazione: quella tecnica e quella generalistica. Nel primo caso è importante trasmettere fedelmente il messaggio essenziale per trattare un argomento rivolto ad un pubblico ristretto ma conoscitore della materia trattata, mentre nel secondo è importante fare leva su ogni mezzo linguistico a disposizione per rappresentare le più sottili sfumature colloquiali. Si fa inoltre distinzione tra sottotitolaggio per ausilio fisico e quello per ausilio linguistico (per gli utenti che non conoscono la lingua originale del testo audiovisivo). 37
38 2.d ASPETTI SALIENTI DEL SOTTOTITOLAGGIO Il film o il programma televisivo sottotitolato svolge una funzione comunicativa con molteplici finalità. Inizialmente lo scopo era quello di rendere accessibile a un pubblico internazionale la fruizione della produzione cinematografica multilingue servendo interessi economici e favorendo il superamento di barriere linguistiche e culturali. In seguito emerge un ulteriore funzione comunicativa del sottotitolo, che si rivolge a un numero inferiore di fruitori, ma con uno scopo socioculturale più elevato. Stiamo parlando della sottotitolazione per soggetti sordi, di cui parleremo più approfonditamente nella seconda parte della tesi. Questa multifunzionalità del sottotitolo è legata ai diversi tipi di sottotitoli esistenti ed è finalizzata a soddisfare le esigenze di un eterogeneo numero di fruitori. In base ai criteri di carattere linguistico si possono distinguere due tipi di sottotitoli: quelli interlinguistici e quelli intralinguistici, riassunti in una tabella di questo tipo da Elisa Perego 4 : 4 Elisa Perego, La Traduzione Audiovisiva, Carocci,
Programmazione annuale a. s
 Programmazione annuale a. s. 2016-2017 MATERIA: CLASSE: ITALIANO SECONDA LIBRO/I DI TESTO: AUTORE: TITOLO: EDITORE: AUTORE: TITOLO: EDITORE: MARCELLO SENSINI L ITALIANO DA SAPERE IN TEORIA E IN PRATICA
Programmazione annuale a. s. 2016-2017 MATERIA: CLASSE: ITALIANO SECONDA LIBRO/I DI TESTO: AUTORE: TITOLO: EDITORE: AUTORE: TITOLO: EDITORE: MARCELLO SENSINI L ITALIANO DA SAPERE IN TEORIA E IN PRATICA
TESTO/I ADOTTATO/I: B.Panebianco A.Varani, METODI E FANTASIA, Narrativa e Poesia e Teatro, Zanichelli ed COMPETENZE
 Anno scolastico 2013/2014 PRIMO BIENNIO Corso Diurno Classe :2 As RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE di: ITALIANO PROF./SSA CAIOLO RITA TESTO/I ADOTTATO/I: B.Panebianco A.Varani, METODI E FANTASIA, Narrativa
Anno scolastico 2013/2014 PRIMO BIENNIO Corso Diurno Classe :2 As RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE di: ITALIANO PROF./SSA CAIOLO RITA TESTO/I ADOTTATO/I: B.Panebianco A.Varani, METODI E FANTASIA, Narrativa
COMPETENZA CHIAVE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
 COMPETENZA ITALIANO COMPETENZA CHIAVE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA Definizione: è la capacità di esprimere e interpretare pensieri,sentimenti e fatti in forma sia in forma orale che scritta (comprensione
COMPETENZA ITALIANO COMPETENZA CHIAVE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA Definizione: è la capacità di esprimere e interpretare pensieri,sentimenti e fatti in forma sia in forma orale che scritta (comprensione
Istituto Comprensivo Francesco D'Assisi TEZZE SUL BRENTA Scuola Primaria CLASSE 2 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE ITALIANO
 Istituto Comprensivo Francesco D'Assisi TEZZE SUL BRENTA Scuola Primaria CLASSE 2 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE ITALIANO OBIETTIVI ASCOLTO E PARLATO Prestare attenzione in varie situazioni comunicative
Istituto Comprensivo Francesco D'Assisi TEZZE SUL BRENTA Scuola Primaria CLASSE 2 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE ITALIANO OBIETTIVI ASCOLTO E PARLATO Prestare attenzione in varie situazioni comunicative
DIREZIONE DIDATTICA DI RACCONIGI CURRICOLO DI LINGUA INGLESE
 DIREZIONE DIDATTICA DI RACCONIGI CURRICOLO DI LINGUA INGLESE PREMESSA Il Curricolo di lingua straniera attualmente in uso nel nostro circolo è stato elaborato tenendo presenti le indicazioni del Progetto
DIREZIONE DIDATTICA DI RACCONIGI CURRICOLO DI LINGUA INGLESE PREMESSA Il Curricolo di lingua straniera attualmente in uso nel nostro circolo è stato elaborato tenendo presenti le indicazioni del Progetto
Modulo I: Fiaba in musica e sonorizzazione Discipline: Musica e Italiano Competenze
 Curricolo indirizzo musicale classe prima Modulo I: Fiaba in musica e sonorizzazione Discipline: Musica e Italiano Conoscere la vita dell autore Conoscere attraverso la musica le caratteristiche descrittive
Curricolo indirizzo musicale classe prima Modulo I: Fiaba in musica e sonorizzazione Discipline: Musica e Italiano Conoscere la vita dell autore Conoscere attraverso la musica le caratteristiche descrittive
Educazione Linguistica (lingua come codice) ortografia e punteggiatura morfologia sintassi della frase semplice e complessa
 Liceo B. Russell VIA IV NOVEMBRE 35, 38023 CLES Tutti gli indirizzi Anno scolastico Disciplina: Lingua e letteratura italiana CLASSE 1 1. comunicare e interagire verbalmente in contesti di varia natura
Liceo B. Russell VIA IV NOVEMBRE 35, 38023 CLES Tutti gli indirizzi Anno scolastico Disciplina: Lingua e letteratura italiana CLASSE 1 1. comunicare e interagire verbalmente in contesti di varia natura
Università degli Studi di Messina
 Università degli Studi di Messina Traduzione e sottotitolazione di un episodio della serie televisiva '' Aquì no hay quien viva: Erase una de miedo'' di Fabiana Alecci Relatore: Giovanni Brandimonte A.A
Università degli Studi di Messina Traduzione e sottotitolazione di un episodio della serie televisiva '' Aquì no hay quien viva: Erase una de miedo'' di Fabiana Alecci Relatore: Giovanni Brandimonte A.A
ITALIANO classe quarta
 NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CONOSCENZE ASCOLTO E PARLATO - SA ESPRIMERE LA PROPRIA OPINIONE SU UN ARGOMENTO TRATTATO - SA PORRE DOMANDE PERTINENTI ALL ARGOMENTO E AL CONTESTO DURANTE O DOPO L ASCOLTO -
NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CONOSCENZE ASCOLTO E PARLATO - SA ESPRIMERE LA PROPRIA OPINIONE SU UN ARGOMENTO TRATTATO - SA PORRE DOMANDE PERTINENTI ALL ARGOMENTO E AL CONTESTO DURANTE O DOPO L ASCOLTO -
Riassumere significa ridurre la lunghezza di un testo mantenendone il senso globale.
 Riassumere Riassumere significa ridurre la lunghezza di un testo mantenendone il senso globale. Non esistono regole fisse per il riassunto, che può variare a seconda del tipo di testo da riassumere, dello
Riassumere Riassumere significa ridurre la lunghezza di un testo mantenendone il senso globale. Non esistono regole fisse per il riassunto, che può variare a seconda del tipo di testo da riassumere, dello
SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA LINGUA CLASSE SECONDA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO. Micro- obiettivi
 SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA LINGUA CLASSE SECONDA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Nuclei Macro- obiettivi al termine della classe terza Ascolto e parlato Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA LINGUA CLASSE SECONDA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Nuclei Macro- obiettivi al termine della classe terza Ascolto e parlato Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
CURRICOLO VERTICALE LINGUA INGLESE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SCUOLA DELL INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 CURRICOLO VERTICALE LINGUA INGLESE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SCUOLA DELL INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Il bambino: ascolta e comprende brevi messaggi orali;
CURRICOLO VERTICALE LINGUA INGLESE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SCUOLA DELL INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Il bambino: ascolta e comprende brevi messaggi orali;
PIANO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO
 PIANO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO Scuola Primaria di BELLANO Classi 4^A e4^b a.s. 2014/2015 Insegnante: Busi Mara DISCIPLINA: ITALIANO TITOLO ATTIVITA MODALITA DI VERIFICA E UN MONDO DI CODICI Comunicare
PIANO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO Scuola Primaria di BELLANO Classi 4^A e4^b a.s. 2014/2015 Insegnante: Busi Mara DISCIPLINA: ITALIANO TITOLO ATTIVITA MODALITA DI VERIFICA E UN MONDO DI CODICI Comunicare
CURRICOLO ITALIANO - CLASSE SECONDA -
 CURRICOLO ITALIANO - CLASSE SECONDA - ASCOLTO E PARLATO - Ascoltare con attenzione le Collaborare e comunicazioni dei compagni. partecipare - Comprendere messaggi orali e lo scopo per cui sono attivati.
CURRICOLO ITALIANO - CLASSE SECONDA - ASCOLTO E PARLATO - Ascoltare con attenzione le Collaborare e comunicazioni dei compagni. partecipare - Comprendere messaggi orali e lo scopo per cui sono attivati.
PIANO DI LAVORO ANNUALE
 MONOENNIO - ITALIANO OBIETTIVI MINIMI 1.PARLARE/ASCOLTARE: usare il codice verbale orale in modo significativo. a. Mantenere l attenzione sul messaggio orale avvalendosi dei diversi linguaggi verbali e
MONOENNIO - ITALIANO OBIETTIVI MINIMI 1.PARLARE/ASCOLTARE: usare il codice verbale orale in modo significativo. a. Mantenere l attenzione sul messaggio orale avvalendosi dei diversi linguaggi verbali e
EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE. Multimedia Video Editing. Syllabus
 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE Multimedia Video Editing Syllabus Scopo Questo documento presenta il syllabus di ECDL Multimedia Modulo 2 Video Editing. Il syllabus descrive, attraverso i risultati del
EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE Multimedia Video Editing Syllabus Scopo Questo documento presenta il syllabus di ECDL Multimedia Modulo 2 Video Editing. Il syllabus descrive, attraverso i risultati del
ITALIANO CLASSE 1 1. ASCOLTARE E COMPRENDERE TESTI NARRATIVI.
 ITALIANO OB. FORMATIVI COMPETENZE CLASSE 1 1. ASCOLTARE E COMPRENDERE TESTI 1.1 Ascoltare una semplice narrazione individuando personaggi, luoghi, successione temporale. 1.2 Ascoltare una semplice descrizione
ITALIANO OB. FORMATIVI COMPETENZE CLASSE 1 1. ASCOLTARE E COMPRENDERE TESTI 1.1 Ascoltare una semplice narrazione individuando personaggi, luoghi, successione temporale. 1.2 Ascoltare una semplice descrizione
SCRIVERE Costruire l interesse per la scrittura autonoma. Scrivere autonomamente un breve testo su un esperienza motivante.
 CURRICOLO DI LINGUA CLASSI 1 Ascoltare e parlare Avvio alla costruzione del Sé e alla percezione delle emozioni Ascoltare e comprendere una semplice consegna organizzativa e didattica Narrare un esperienza
CURRICOLO DI LINGUA CLASSI 1 Ascoltare e parlare Avvio alla costruzione del Sé e alla percezione delle emozioni Ascoltare e comprendere una semplice consegna organizzativa e didattica Narrare un esperienza
SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA ITALIANO CLASSE PRIMA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO. Micro- obiettivi
 SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA ITALIANO CLASSE PRIMA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Nuclei Macro- obiettivi al termine della classe terza Ascolto e parlato Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA ITALIANO CLASSE PRIMA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Nuclei Macro- obiettivi al termine della classe terza Ascolto e parlato Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
UNITA DI APPRENDIMENTO
 UNITA DI APPRENDIMENTO NOI E LA FESTA DATI IDENTIFICATIVI TITOLO: Noi e la festa ANNO SCOLASTICO:.. DESTINATARI: alunni della classe prima DOCENTI IMPEGNATI NELL UA: ARTICOLAZIONE DELL UNITA DI APPRENDIMENTO
UNITA DI APPRENDIMENTO NOI E LA FESTA DATI IDENTIFICATIVI TITOLO: Noi e la festa ANNO SCOLASTICO:.. DESTINATARI: alunni della classe prima DOCENTI IMPEGNATI NELL UA: ARTICOLAZIONE DELL UNITA DI APPRENDIMENTO
TRAGUARDI PER LO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE TRASVERSALI ASCOLTO E PARLATO ESSERE AUTONOMI E RESPONSABILI COMUNICARE
 CURRICOLO D ISTITUTO a. s. 2012 / 2013 CLASSE I SCUOLA SECONDARIA I GRADO COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA FONTI DI SVILUPPO DELLE OBIETTIVI DI ASCOLTO E PARLATO 1. L allievo interagisce in diverse situazioni
CURRICOLO D ISTITUTO a. s. 2012 / 2013 CLASSE I SCUOLA SECONDARIA I GRADO COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA FONTI DI SVILUPPO DELLE OBIETTIVI DI ASCOLTO E PARLATO 1. L allievo interagisce in diverse situazioni
CLASSE PRIMA OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ITALIANO A) ASCOLTARE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 BIMESTRE
 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA ITALIANO A) ASCOLTARE 1 1) Ascoltare e comprendere un comando 1. Prestare attenzione a messaggi orali di vario tipo 2. Comprendere ed eseguire semplici
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA ITALIANO A) ASCOLTARE 1 1) Ascoltare e comprendere un comando 1. Prestare attenzione a messaggi orali di vario tipo 2. Comprendere ed eseguire semplici
parole Classificare e ordinare Comprensione Anticipazione Applicazione Reversibilità del pensiero
 Tabella generale: ASCOLTO, COMPRENSIONE E COMUNICAZIONE OBIETTIVI SPECIFICI DI Avvalersi di tutte le anticipazioni del testo per mantenere l attenzione, orientarsi nella comprensione, porsi in modo attivo
Tabella generale: ASCOLTO, COMPRENSIONE E COMUNICAZIONE OBIETTIVI SPECIFICI DI Avvalersi di tutte le anticipazioni del testo per mantenere l attenzione, orientarsi nella comprensione, porsi in modo attivo
CLASSI SECONDE LA PROGRAMMAZIONE. - Potenziare il possesso di una lingua sempre più ricca lessicalmente nella molteplicità delle sue espressioni
 CLASSI SECONDE LA PROGRAMMAZIONE ITALIANO - Potenziare il possesso di una lingua sempre più ricca lessicalmente nella molteplicità delle sue espressioni - Potenziare l ascolto reciproco, il rispetto e
CLASSI SECONDE LA PROGRAMMAZIONE ITALIANO - Potenziare il possesso di una lingua sempre più ricca lessicalmente nella molteplicità delle sue espressioni - Potenziare l ascolto reciproco, il rispetto e
L ITALIANO COME LINGUA SECONDA
 L ITALIANO COME LINGUA SECONDA L'apprendimento e lo sviluppo della seconda lingua negli allievi stranieri deve essere al centro dell'azione didattica prevedere modificazioni nelle modalità organizzative
L ITALIANO COME LINGUA SECONDA L'apprendimento e lo sviluppo della seconda lingua negli allievi stranieri deve essere al centro dell'azione didattica prevedere modificazioni nelle modalità organizzative
FRANCESE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Classe 1 a
 FRANCESE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Classe 1 a Competenze Conoscenze Abilità Tecniche di lettura espressiva: intonazione, pause, punteggiatura. Applicare diverse strategie di lettura: lettura espressiva
FRANCESE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Classe 1 a Competenze Conoscenze Abilità Tecniche di lettura espressiva: intonazione, pause, punteggiatura. Applicare diverse strategie di lettura: lettura espressiva
IL NUOVO GATTI Revisione didattica e metodologica a cura di Renato Soglia
 IL NUOVO GATTI Revisione didattica e metodologica a cura di Renato Soglia IL NUOVO GATTI Metodo teorico e pratico per tromba e congeneri a cura di Renato Soglia Pagine VI+97 + CD Testo italiano e inglese
IL NUOVO GATTI Revisione didattica e metodologica a cura di Renato Soglia IL NUOVO GATTI Metodo teorico e pratico per tromba e congeneri a cura di Renato Soglia Pagine VI+97 + CD Testo italiano e inglese
CLASSE PRIMA LINGUA INGLESE COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE 18/12/2006) LA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
 COMPETENZE SPECIFICHE DELLA CLASSE PRIMA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE * (Indicazioni per il curricolo 2012) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Comprendere il significato di semplici istruzioni e
COMPETENZE SPECIFICHE DELLA CLASSE PRIMA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE * (Indicazioni per il curricolo 2012) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Comprendere il significato di semplici istruzioni e
AMBITO LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVO
 AMBITO LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVO Area disciplinare: LINGUA ITALIANA LEGGERE E COMPRENDERE TESTI DI VARIO TIPO 1, 2 e 3 anno della Scuola Primaria l'alunno è in grado di leggere in modo scorrevole;
AMBITO LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVO Area disciplinare: LINGUA ITALIANA LEGGERE E COMPRENDERE TESTI DI VARIO TIPO 1, 2 e 3 anno della Scuola Primaria l'alunno è in grado di leggere in modo scorrevole;
UNITÀ DIDATTICA N. 1
 DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIGONZA UNITÀ DIDATTICA N. 1 LEGGERE Leggere in modo chiaro, scorrevole e corretto. Avvalersi di tutte le anticipazioni del testo per mantenere l attenzione, orientarsi nella
DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIGONZA UNITÀ DIDATTICA N. 1 LEGGERE Leggere in modo chiaro, scorrevole e corretto. Avvalersi di tutte le anticipazioni del testo per mantenere l attenzione, orientarsi nella
Classe Prima Scuola Secondaria di Primo Grado
 FRANCESE Classe Prima Scuola Secondaria di Primo Grado NUCLEI TEMATICI CONOSCENZE ABILITA Ascolto Suoni, ritmo ed intonazione della Ascoltare e capire lingua globalmente brevi (Ricezione orale) conversazioni
FRANCESE Classe Prima Scuola Secondaria di Primo Grado NUCLEI TEMATICI CONOSCENZE ABILITA Ascolto Suoni, ritmo ed intonazione della Ascoltare e capire lingua globalmente brevi (Ricezione orale) conversazioni
ITALIANO UNITÀ DIDATTICA N. 1 ASCOLTARE E PARLARE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ABILITÀ
 UNITÀ DIDATTICA N. 1 ASCOLTARE E PARLARE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ABILITÀ 1. Adeguare la comunicazione, prestando attenzione all interlocutore, alla situazione,all argomento. 2. Esprimersi
UNITÀ DIDATTICA N. 1 ASCOLTARE E PARLARE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ABILITÀ 1. Adeguare la comunicazione, prestando attenzione all interlocutore, alla situazione,all argomento. 2. Esprimersi
CLASSE SECONDA OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ITALIANO A) ASCOLTARE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 BIMESTRE
 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA ITALIANO A) ASCOLTARE 1 1. Ascoltare e comprendere vari messaggi 1. Ascoltare messaggi orali di vario genere e individuare l'argomento centrale 2. Ascoltare
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA ITALIANO A) ASCOLTARE 1 1. Ascoltare e comprendere vari messaggi 1. Ascoltare messaggi orali di vario genere e individuare l'argomento centrale 2. Ascoltare
Istituto Comprensivo di Pralboino Curricolo Verticale
 ITALIANO CLASSE 2 a PRIMARIA ASCOLTO E PARLATO -L allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando
ITALIANO CLASSE 2 a PRIMARIA ASCOLTO E PARLATO -L allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando
ITALIANO TRAGUARDI SCRITTURA
 Proposta di lettura e di interpretazione delle Indicazioni 2012, secondo nodi concettuali ITALIANO. Traguardi di SCRITTURA, obiettivi, nodi. Roberta Rigo ITALIANO TRAGUARDI SCRITTURA Piste di lavoro Traguardi
Proposta di lettura e di interpretazione delle Indicazioni 2012, secondo nodi concettuali ITALIANO. Traguardi di SCRITTURA, obiettivi, nodi. Roberta Rigo ITALIANO TRAGUARDI SCRITTURA Piste di lavoro Traguardi
Psicologia della comunicazione Fondamenti. Psicologia della comunicazione I. Riccioni 1
 Psicologia della comunicazione Fondamenti Psicologia della comunicazione I. Riccioni 1 Psicologia della comunicazione Settore scientifico-disciplinare: Psicologia generale Campo di ricerca interdisciplinare
Psicologia della comunicazione Fondamenti Psicologia della comunicazione I. Riccioni 1 Psicologia della comunicazione Settore scientifico-disciplinare: Psicologia generale Campo di ricerca interdisciplinare
LIVE LLO 9-10/1 07-8/10. 6/10 Partecipa sufficientemente a scambi comunicativi semplici. Comprende globalmente le istruzioni verbali e
 LIVE LLO 9-10/1 0 07-8/10 EFFICACIA COMUNICATIVA Partecipa in modo efficace a scambi comunicativi semplici e chiari. Comprende in modo completo le istruzioni orali e sa rispondere alle richieste in maniera
LIVE LLO 9-10/1 0 07-8/10 EFFICACIA COMUNICATIVA Partecipa in modo efficace a scambi comunicativi semplici e chiari. Comprende in modo completo le istruzioni orali e sa rispondere alle richieste in maniera
PROGETTAZIONE ANNUALE - ITALIANO
 PROGETTAZIONE ANNUALE - ITALIANO classe I Finalità educative. Capacità di comunicare ed esprimere l esperienza di sé e della realtà naturale e culturale attraverso la padronanza delle abilità linguistiche
PROGETTAZIONE ANNUALE - ITALIANO classe I Finalità educative. Capacità di comunicare ed esprimere l esperienza di sé e della realtà naturale e culturale attraverso la padronanza delle abilità linguistiche
OBIETTIVI MINIMI DI ITALIANO
 OBIETTIVI MINIMI DI ITALIANO TERZA NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI SPECIFICI COMPETENZE VERIFICHE ASCOLTARE Ascoltare e comprendere comandi, istruzioni, regole. Seguire una conversazione e comprendere ciò di
OBIETTIVI MINIMI DI ITALIANO TERZA NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI SPECIFICI COMPETENZE VERIFICHE ASCOLTARE Ascoltare e comprendere comandi, istruzioni, regole. Seguire una conversazione e comprendere ciò di
RIM RELAZIONI IINTERNAZIONALI PER IL MARKETING
 RIM RELAZIONI IINTERNAZIONALI PER IL MARKETING CLASSE TERZA RIM CONOSCENZE ABILITA' ECONOMIA AZIENDALE GEOPOLITICA Organizzazione aziendale e analisi del fabbisogno finanziario. Regole e tecniche di contabilità
RIM RELAZIONI IINTERNAZIONALI PER IL MARKETING CLASSE TERZA RIM CONOSCENZE ABILITA' ECONOMIA AZIENDALE GEOPOLITICA Organizzazione aziendale e analisi del fabbisogno finanziario. Regole e tecniche di contabilità
SCUOLA PRIMARIA ITALIANO (Classe 1ª)
 SCUOLA PRIMARIA ITALIANO (Classe 1ª) Leggere testi brevi e rispondere a semplici domande di comprensione. Ricostruire cronologicamente un semplice testo ascoltato. Eseguire semplici istruzioni, consegne
SCUOLA PRIMARIA ITALIANO (Classe 1ª) Leggere testi brevi e rispondere a semplici domande di comprensione. Ricostruire cronologicamente un semplice testo ascoltato. Eseguire semplici istruzioni, consegne
SAPER ASCOLTARE CON ATTENZIONE SAPER ANALIZZARE/CONFRONTARE I SUONI IN RELAZIONE AI PRINCIPALI PARAMETRI
 UAD N. 1 SAPER ASCOLTARE CON ATTENZIONE SAPER ANALIZZARE/CONFRONTARE I SUONI IN RELAZIONE AI PRINCIPALI PARAMETRI Riferimento OSA: 2-4(conoscenza) e D E F- G (abilità) Il silenzio e il suono. Suono e rumore
UAD N. 1 SAPER ASCOLTARE CON ATTENZIONE SAPER ANALIZZARE/CONFRONTARE I SUONI IN RELAZIONE AI PRINCIPALI PARAMETRI Riferimento OSA: 2-4(conoscenza) e D E F- G (abilità) Il silenzio e il suono. Suono e rumore
Si può fare un riassunto in matematica?
 Si può fare un riassunto in matematica? Livello scolare: 1 biennio Abilità Esprimersi nel linguaggio naturale con coerenza e proprietà. Usare, in varie situazioni, linguaggi simbolici. Analizzare semplici
Si può fare un riassunto in matematica? Livello scolare: 1 biennio Abilità Esprimersi nel linguaggio naturale con coerenza e proprietà. Usare, in varie situazioni, linguaggi simbolici. Analizzare semplici
FARE COMUNICAZIONE PUBBLICA
 FARE COMUNICAZIONE PUBBLICA 1 ADVERTISING LEZIONE 8 2 IL LINGUAGGIO DELLA CREATIVITA 3 IL LINGUAGGIO PUBBLICITARIO Segue il linguaggio sancito dallo sviluppo dei media, da quelli di settore a quelli di
FARE COMUNICAZIONE PUBBLICA 1 ADVERTISING LEZIONE 8 2 IL LINGUAGGIO DELLA CREATIVITA 3 IL LINGUAGGIO PUBBLICITARIO Segue il linguaggio sancito dallo sviluppo dei media, da quelli di settore a quelli di
UNITÀ DIDATTICA N. 1 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ABILITÀ
 UNITÀ DIDATTICA N. 1 LEGGERE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ABILITÀ Leggere in modo chiaro scorrevole e corretto. Avvalersi di tutte le anticipazioni del testo per mantenere l attenzione, orientarsi
UNITÀ DIDATTICA N. 1 LEGGERE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ABILITÀ Leggere in modo chiaro scorrevole e corretto. Avvalersi di tutte le anticipazioni del testo per mantenere l attenzione, orientarsi
ISTITUTO COMPRENSIVO DI RASTIGNANO CURRICOLO VERTICALE DI MUSICA
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI RASTIGNANO CURRICOLO VERTICALE DI MUSICA 1. SAPER COMUNICARE 1.1 Acquisire il lessico specifico Percepire la velocità di un brano Confrontare suoni secondo le qualità di intensità
ISTITUTO COMPRENSIVO DI RASTIGNANO CURRICOLO VERTICALE DI MUSICA 1. SAPER COMUNICARE 1.1 Acquisire il lessico specifico Percepire la velocità di un brano Confrontare suoni secondo le qualità di intensità
FRANCESE. Classe SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. SEZIONE A: Traguardi formativi e percorsi didattici
 FRANCESE Classe SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE SPECIFICHE LINGUA Saper raccontare un fatto passato. Ascoltare linguistiche riprodotte con materiale audio e audiovisivo. Ascoltare ritmi
FRANCESE Classe SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE SPECIFICHE LINGUA Saper raccontare un fatto passato. Ascoltare linguistiche riprodotte con materiale audio e audiovisivo. Ascoltare ritmi
Seconda Lingua Comunitaria (Francese Spagnolo) Classe seconda secondaria
 CURRICOLO DISCIPLINARE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE Seconda Lingua Comunitaria (Francese Spagnolo) Classe seconda secondaria Traguardi per lo sviluppo delle competenze Conoscenze Obiettivi di apprendimento
CURRICOLO DISCIPLINARE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE Seconda Lingua Comunitaria (Francese Spagnolo) Classe seconda secondaria Traguardi per lo sviluppo delle competenze Conoscenze Obiettivi di apprendimento
SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 SCUOLA PRIMARIA ARTE E IMMAGINE CLASSE 1^ relative al linguaggio visivo per produrre varie comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi,
SCUOLA PRIMARIA ARTE E IMMAGINE CLASSE 1^ relative al linguaggio visivo per produrre varie comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi,
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA OTTIMO DISTINTO BUONO NON IN Conosce in modo ottimale i documenti e i contenuti della materia Conosce i documenti e i contenuti in modo efficace Conosce
GRIGLIA DI VALUTAZIONE Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA OTTIMO DISTINTO BUONO NON IN Conosce in modo ottimale i documenti e i contenuti della materia Conosce i documenti e i contenuti in modo efficace Conosce
CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE QUARTA
 CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE QUARTA CONTENUTI ABILITA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI LINGUA PER NARRARE Testo fantastico fiaba favola mito leggenda racconto di fantasia Testo realistico
CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE QUARTA CONTENUTI ABILITA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI LINGUA PER NARRARE Testo fantastico fiaba favola mito leggenda racconto di fantasia Testo realistico
Comprende il testo proposto - comprende il lessico di base - comprende i termini tecnicospecialistici
 COMUNICAZIONE COMPETENZE ABILITÀ EVIDENZE TIPOLOGIA ESERCIZI Comunicare adeguandosi al con sociale e professionale di Comprende il proposto - comprende il lessico di base - comprende i termini tecnicospecialistici
COMUNICAZIONE COMPETENZE ABILITÀ EVIDENZE TIPOLOGIA ESERCIZI Comunicare adeguandosi al con sociale e professionale di Comprende il proposto - comprende il lessico di base - comprende i termini tecnicospecialistici
INDICATORI PER IL REGISTRO CLASSI PRIME 2015 2016
 INDICATORI PER IL REGISTRO CLASSI PRIME 2015 2016 Nell ordine: Italiano, Matematica, Scienze, Tecnologia, Storia, Geografia, Inglese, Arte ed Immagine, Musica e Motoria. ITALIANO ASCOLTO E PARLATO 1)a
INDICATORI PER IL REGISTRO CLASSI PRIME 2015 2016 Nell ordine: Italiano, Matematica, Scienze, Tecnologia, Storia, Geografia, Inglese, Arte ed Immagine, Musica e Motoria. ITALIANO ASCOLTO E PARLATO 1)a
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO
 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO CLASSE PRIMA OBIETTIVI 1. PRODUZIONE E COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE: ASCOLTARE, COMPRENDERE, PARLARE 1.1 Ascoltare e comprendere semplici messaggi 1.2 Ascoltare
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO CLASSE PRIMA OBIETTIVI 1. PRODUZIONE E COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE: ASCOLTARE, COMPRENDERE, PARLARE 1.1 Ascoltare e comprendere semplici messaggi 1.2 Ascoltare
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA DI BISUSCHIO
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA DI BISUSCHIO Anno scolastico 2010/2011 CURRICULUM DI D ISTITUTO SCUOLA DELL INFANZIA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Utilizzare criteri e relazioni
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA DI BISUSCHIO Anno scolastico 2010/2011 CURRICULUM DI D ISTITUTO SCUOLA DELL INFANZIA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Utilizzare criteri e relazioni
CONOSCENZE ABILITA COMPETENZE ATTIVITA CONTENUTI METODI. Mantiene un attenzione gradualmente più costante su messaggi orali di tipo diverso
 ITALIANO Docente: Maria Cava Balistreri Anno scolastico 2016/17 PROGRAMMAZIONE LINGUA ITALIANA / ASCOLTO E PARLATO NUCLEI TEMATICI CONOSCENZE ABILITA COMPETENZE ATTIVITA CONTENUTI METODI Saper ascoltare
ITALIANO Docente: Maria Cava Balistreri Anno scolastico 2016/17 PROGRAMMAZIONE LINGUA ITALIANA / ASCOLTO E PARLATO NUCLEI TEMATICI CONOSCENZE ABILITA COMPETENZE ATTIVITA CONTENUTI METODI Saper ascoltare
CURRICOLO TRASVERSALE SCUOLA PRIMARIA a.s. 2015-16
 CURRICOLO TRASVERSALE SCUOLA PRIMARIA a.s. 2015-16 Competenza n 1: Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. Utilizza la lingua italiana per comprendere semplici enunciati e raccontare esperienze
CURRICOLO TRASVERSALE SCUOLA PRIMARIA a.s. 2015-16 Competenza n 1: Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. Utilizza la lingua italiana per comprendere semplici enunciati e raccontare esperienze
LINGUA COMUNITARIA INGLESE SCUOLA SECONDARIA CLASSE TERZA
 LINGUA COMUNITARIA INGLESE SCUOLA SECONDARIA CLASSE TERZA Livello A2 Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio d Europa D ASCOLTO ( COMPRENSIONE ORALE ) L alunno comprende oralmente
LINGUA COMUNITARIA INGLESE SCUOLA SECONDARIA CLASSE TERZA Livello A2 Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio d Europa D ASCOLTO ( COMPRENSIONE ORALE ) L alunno comprende oralmente
ITALIANO GRIGLIE DI VALUTAZIONE. Indicatore di competenza chiave europea CLASSE PRIMA
 GRIGLIE DI VALUTAZIONE ITALIANO CLASSE PRIMA Indicatore di competenza chiave europea La comunicazione della madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e
GRIGLIE DI VALUTAZIONE ITALIANO CLASSE PRIMA Indicatore di competenza chiave europea La comunicazione della madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e
MUSICA COMPETENZE CHIAVE:
 MUSICA COMPETENZE CHIAVE: comunicazione nella madrelingua, competenza digitale, imparare a imparare, competenze sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale Traguardi per lo sviluppo delle
MUSICA COMPETENZE CHIAVE: comunicazione nella madrelingua, competenza digitale, imparare a imparare, competenze sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale Traguardi per lo sviluppo delle
SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ITALIANO Griglia per la valutazione della comprensione di un testo Classi 1 a 2 a 3 a
 19 ISTITUTO COMPRENSIVO EVEMERO DA MESSINA Cod.Mecc: MEIC872002 GANZIRRI C. F. : 97062190836 via Francesco Denaro 98165 GANZIRRI MESSINA e-mail: meic872002@istruzione.it Segreteria via F. Denaro, n 15
19 ISTITUTO COMPRENSIVO EVEMERO DA MESSINA Cod.Mecc: MEIC872002 GANZIRRI C. F. : 97062190836 via Francesco Denaro 98165 GANZIRRI MESSINA e-mail: meic872002@istruzione.it Segreteria via F. Denaro, n 15
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ITALIANO PRIMA. OBIETTIVI GENERALI (secondo l Asse dei Linguaggi) MATERIA: CLASSE: LIBRI DI TESTO: A.S.
 PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE A.S.2016/17 MATERIA: CLASSE: ITALIANO PRIMA LIBRI DI : AUTORE: TITOLO: EDITORE: AUTORE: TITOLO: EDITORE: MARCELLO SENSINI DATEMI LE PAROLE A. MONDADORI SCUOLA MARIA ZIONI E.MOROSINI
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE A.S.2016/17 MATERIA: CLASSE: ITALIANO PRIMA LIBRI DI : AUTORE: TITOLO: EDITORE: AUTORE: TITOLO: EDITORE: MARCELLO SENSINI DATEMI LE PAROLE A. MONDADORI SCUOLA MARIA ZIONI E.MOROSINI
OBIETTIVI MINIMI PRIMARIA ITALIANO
 OBIETTIVI MINIMI PRIMARIA ITALIANO Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Ascoltare e parlare Ascoltare e comprendere semplici consegne operative. Comprendere l essenziale di una semplice spiegazione. Riferire
OBIETTIVI MINIMI PRIMARIA ITALIANO Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Ascoltare e parlare Ascoltare e comprendere semplici consegne operative. Comprendere l essenziale di una semplice spiegazione. Riferire
PERCORSO DI TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTIVA IeFP - ISIS MAMOLI BERGAMO
 PERCORSO DI TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTIVA IeFP - ISIS MAMOLI BERGAMO AMBITO COMPETENZE DI BASE N. Abilità del triennio 1A Comprendere testi di diversa tipologia e complessità N.1
PERCORSO DI TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTIVA IeFP - ISIS MAMOLI BERGAMO AMBITO COMPETENZE DI BASE N. Abilità del triennio 1A Comprendere testi di diversa tipologia e complessità N.1
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO AREE DA SVILUPPARE. Riflettere sulla lingua
 Riflettere sulla lingua 1. Consolidare ed approfondire la conoscenza degli obiettivi affrontati in prima classe. 2. Conoscere l'alfabeto e le lettere straniere. 3. Affrontare le seguenti difficoltà: -
Riflettere sulla lingua 1. Consolidare ed approfondire la conoscenza degli obiettivi affrontati in prima classe. 2. Conoscere l'alfabeto e le lettere straniere. 3. Affrontare le seguenti difficoltà: -
Istituto Comprensivo di Sissa Trecasali Allegato 2.E al Piano Triennale dell Offerta Formativa 2016/19 CURRICOLO DI SCIENZE SCUOLA DELL INFANZIA
 CURRICOLO DI SCIENZE SCUOLA DELL INFANZIA OBIETTIVI FORMATIVI TRAGUARDI Obiettivi riferiti all intero percorso della scuola dell infanzia OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE Osservare con attenzione
CURRICOLO DI SCIENZE SCUOLA DELL INFANZIA OBIETTIVI FORMATIVI TRAGUARDI Obiettivi riferiti all intero percorso della scuola dell infanzia OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE Osservare con attenzione
LE ESPRESSIONI. Espressioni
 VI LE ESPRESSIONI Le difficoltà di alcuni bambini nel leggere derivano dalla scarsa confidenza col fare ipotesi su quanto è implicito in ciò che leggono. Insegnare ai bambini a contare sulla propria conoscenza
VI LE ESPRESSIONI Le difficoltà di alcuni bambini nel leggere derivano dalla scarsa confidenza col fare ipotesi su quanto è implicito in ciò che leggono. Insegnare ai bambini a contare sulla propria conoscenza
ASCOLTARE E PARLARE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI
 ASCOLTARE E PARLARE - Cogliere l argomento principale dei discorsi altrui; - Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione) rispettando i turni di parola, ponendo domande pertinenti
ASCOLTARE E PARLARE - Cogliere l argomento principale dei discorsi altrui; - Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione) rispettando i turni di parola, ponendo domande pertinenti
ARTE E IMMAGINE - CLASSE PRIMA Traguardi Obiettivi di apprendimento Contenuti
 ARTE E IMMAGINE - CLASSE PRIMA Traguardi Obiettivi di apprendimento Contenuti del linguaggio visuale per osservare immagini statiche (fotografie, manifesti) e in movimento(brevi filmati). produrre le immagini
ARTE E IMMAGINE - CLASSE PRIMA Traguardi Obiettivi di apprendimento Contenuti del linguaggio visuale per osservare immagini statiche (fotografie, manifesti) e in movimento(brevi filmati). produrre le immagini
La competenza in Lettura
 La competenza in Lettura Dipartimento di Lettere- Buone pratiche 1 Aspetti della competenza di lettura 1 Riconoscere e comprendere il significato letterale e figurato di parole ed espressioni; riconoscere
La competenza in Lettura Dipartimento di Lettere- Buone pratiche 1 Aspetti della competenza di lettura 1 Riconoscere e comprendere il significato letterale e figurato di parole ed espressioni; riconoscere
Il processo di comprensione del testo scritto
 ALLEGATO 1 testo di partenza Il processo di comprensione del testo scritto Gli studi dedicati alla lettura, soprattutto in ambito psicolinguistico e neurolinguistico, pur collocandosi su livelli diversi,
ALLEGATO 1 testo di partenza Il processo di comprensione del testo scritto Gli studi dedicati alla lettura, soprattutto in ambito psicolinguistico e neurolinguistico, pur collocandosi su livelli diversi,
FRANCESE. Classe TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. SEZIONE A: Traguardi formativi e percorsi didattici
 FRANCESE Classe TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE SPECIFICHE LINGUA ORALE Ascoltare e comprendere un linguaggio di classe sempre più articolato Ascoltare, comprendere ed eseguire istruzioni
FRANCESE Classe TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE SPECIFICHE LINGUA ORALE Ascoltare e comprendere un linguaggio di classe sempre più articolato Ascoltare, comprendere ed eseguire istruzioni
III Circolo di Rho. Programmazione annuale. Lingua Italiana. Classe II
 III Circolo di Rho Programmazione annuale Lingua Italiana Classe II ASCOLTARE E PARLARE Interagisce nello scambio comunicativo rispettando le regole. Interagisce nello scambio comunicativo in modo adeguato
III Circolo di Rho Programmazione annuale Lingua Italiana Classe II ASCOLTARE E PARLARE Interagisce nello scambio comunicativo rispettando le regole. Interagisce nello scambio comunicativo in modo adeguato
PROGETTAZIONE ANNUALE - CLASSE II
 PROGETTAZIONE ANNUALE - CLASSE II ITALIANO 1. Prerequisiti: 1 - Saper leggere e decodificare un testo 2 - Saper ricodificare secondo modalità e tempi stabiliti 3 - Saper leggere e manipolare un testo 4
PROGETTAZIONE ANNUALE - CLASSE II ITALIANO 1. Prerequisiti: 1 - Saper leggere e decodificare un testo 2 - Saper ricodificare secondo modalità e tempi stabiliti 3 - Saper leggere e manipolare un testo 4
Competenza: 1. Comunicazione efficace Indicatore: 1.1 Comprensione
 SCUOLA PRIMARIA INGLESE Competenza: 1. Comunicazione efficace Indicatore: 1.1 Comprensione Descrittori Classe 1 Descrittori Classe 2 Descrittori Classe 3 Descrittori Classe 4 Descrittori Classe 5 comprendere
SCUOLA PRIMARIA INGLESE Competenza: 1. Comunicazione efficace Indicatore: 1.1 Comprensione Descrittori Classe 1 Descrittori Classe 2 Descrittori Classe 3 Descrittori Classe 4 Descrittori Classe 5 comprendere
La prova scritta di italiano nell esame conclusivo del primo ciclo
 La prova scritta di italiano nell esame conclusivo del primo ciclo La prova d esame come esito di una didattica efficace Un ambiente di apprendimento funzionale allo sviluppo delle competenze di scrittura
La prova scritta di italiano nell esame conclusivo del primo ciclo La prova d esame come esito di una didattica efficace Un ambiente di apprendimento funzionale allo sviluppo delle competenze di scrittura
Curricolo Inglese a.s
 Curricolo Inglese a.s. 2015-2016 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria (I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Curricolo Inglese a.s. 2015-2016 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria (I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Riprodurre visi e corpi con varie tecniche. Usare creativamente e/o in modo pertinente il colore.
 ARTE E IMMAGINE Esprimersi e comunicare; osservare e leggere le immagini; comprendere e apprezzare le opere d arte CLASSE PRIMA _Scuola Primaria L alunno si esprime attraverso il linguaggio visivo per
ARTE E IMMAGINE Esprimersi e comunicare; osservare e leggere le immagini; comprendere e apprezzare le opere d arte CLASSE PRIMA _Scuola Primaria L alunno si esprime attraverso il linguaggio visivo per
Competenza : 1. Comunicazione efficace Indicatore: 1.1 Comprensione
 SCUOLA DELL INFANZIA LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE Gestualità, arte, musica, multimedialità Competenza : 1. Comunicazione efficace Indicatore: 1.1 Comprensione Descrittori Descrittori Descrittori
SCUOLA DELL INFANZIA LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE Gestualità, arte, musica, multimedialità Competenza : 1. Comunicazione efficace Indicatore: 1.1 Comprensione Descrittori Descrittori Descrittori
Lingua Straniera. Sviluppare curiosità nei confronti di documenti sonori. Identificare parole note in L 2. Usare semplici espressioni di interazione.
 Lingua Straniera Classe Prima e Seconda Per far familiarizzare il bambino con una nuova realtà fonologica si darà ampio spazio ad attività di ascolto/ricezione. pertanto saranno privilegiate le attività
Lingua Straniera Classe Prima e Seconda Per far familiarizzare il bambino con una nuova realtà fonologica si darà ampio spazio ad attività di ascolto/ricezione. pertanto saranno privilegiate le attività
LICEO SCIENTIFICO GIORDANO BRUNO MESTRE - VENEZIA
 LICEO SCIENTIFICO GIORDANO BRUNO MESTRE - VENEZIA Anno scolastico 2010-2011 Classe 2^ C Materie: ITALIANO Docente: ONGARO GIANPIETRO Oggetto: PROGRAMMAZIONE ANNUALE La classe è composta di 24 alunni, palesa
LICEO SCIENTIFICO GIORDANO BRUNO MESTRE - VENEZIA Anno scolastico 2010-2011 Classe 2^ C Materie: ITALIANO Docente: ONGARO GIANPIETRO Oggetto: PROGRAMMAZIONE ANNUALE La classe è composta di 24 alunni, palesa
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico Indirizzo: Grafica e comunicazione
 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca I.I.S. CATERINA CANIANA Via Polaresco 19 24129 Bergamo Tel: 035 250547 035 253492 Fax: 035 4328401 http://www.istitutocaniana.it email: canianaipssc@istitutocaniana.it
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca I.I.S. CATERINA CANIANA Via Polaresco 19 24129 Bergamo Tel: 035 250547 035 253492 Fax: 035 4328401 http://www.istitutocaniana.it email: canianaipssc@istitutocaniana.it
III Circolo di Rho. Programmazione annuale. Lingua Italiana. Classe III
 III Circolo di Rho Programmazione annuale Lingua Italiana Classe III ASCOLTARE E PARLARE Ascolta e comprende le informazioni principali di un messaggio Interviene nel dialogo e nella conversazione in modo
III Circolo di Rho Programmazione annuale Lingua Italiana Classe III ASCOLTARE E PARLARE Ascolta e comprende le informazioni principali di un messaggio Interviene nel dialogo e nella conversazione in modo
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA MONGINEVRO ARCORE
 CURRICOLO MUSICA SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA A.1. Discriminare ed interpretare eventi sonori A.2. Attribuire significati a segnali sonori e musicali, a semplici sonorità quotidiane ed eventi naturali
CURRICOLO MUSICA SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA A.1. Discriminare ed interpretare eventi sonori A.2. Attribuire significati a segnali sonori e musicali, a semplici sonorità quotidiane ed eventi naturali
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO a. s. / Residenza Via CAP Recapito Telefonico PRESENZA A SCUOLA DI UNA A. E. C. SI NO
 MINISTERO dell ISTRUZIONE, dell UNIVERSITA e della RICERCA Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LARGO ORIANI SCUOLA STATALE INFANZIA - PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO Largo
MINISTERO dell ISTRUZIONE, dell UNIVERSITA e della RICERCA Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LARGO ORIANI SCUOLA STATALE INFANZIA - PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO Largo
CURRICOLO DEL PRIMO CICLO
 CURRICOLO DEL PRIMO CICLO MUSICA CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in Eseguire collettivamente e individualmente semplici brani vocali/strumentali curando
CURRICOLO DEL PRIMO CICLO MUSICA CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in Eseguire collettivamente e individualmente semplici brani vocali/strumentali curando
Progetto DSA: Guida al metodo di studio
 Progetto DSA: Guida al metodo di studio CESPD - Centro Studi e Ricerche per la Disabilità Scuola di Psicologia Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia Scuola di Ingegneria Dipartimento di
Progetto DSA: Guida al metodo di studio CESPD - Centro Studi e Ricerche per la Disabilità Scuola di Psicologia Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia Scuola di Ingegneria Dipartimento di
Voto Conoscenze Abilità Competenze Livelli. Abilità per svolgere compiti/mansioni in modo impreciso e disorganizzato
 Griglia di corrispondenza tra i voti e i livelli di competenza Voto Conoscenze Abilità Competenze Livelli 1-5 Conoscenze generali di base approssimate 6 7-8 9-10 Conoscenza teorica e pratica indispensabile
Griglia di corrispondenza tra i voti e i livelli di competenza Voto Conoscenze Abilità Competenze Livelli 1-5 Conoscenze generali di base approssimate 6 7-8 9-10 Conoscenza teorica e pratica indispensabile
U. A. 1 ITALIANO settembre-ottobre-novembre
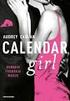 U. A. 1 ITALIANO settembre-ottobre-novembre ABILITÀ a. Ascoltare attivamente e comprendere vari tipi di testo. b. Intervenire appropriatamente ed esprimere attraverso il parlato pensieri e stati d animo.
U. A. 1 ITALIANO settembre-ottobre-novembre ABILITÀ a. Ascoltare attivamente e comprendere vari tipi di testo. b. Intervenire appropriatamente ed esprimere attraverso il parlato pensieri e stati d animo.
ITALIANO TRAGUARDI ASCOLTO-PARLATO.
 Proposta di lettura e di interpretazione delle Indicazioni 2012, secondo nodi concettuali ITALIANO. Traguardi di interazione, ascolto e parlato, obiettivi, nodi. Nella Cazzador e Roberta Rigo Ascolto-Parlato
Proposta di lettura e di interpretazione delle Indicazioni 2012, secondo nodi concettuali ITALIANO. Traguardi di interazione, ascolto e parlato, obiettivi, nodi. Nella Cazzador e Roberta Rigo Ascolto-Parlato
CURRICOLO DI EDUCAZIONE MUSICALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 CURRICOLO DI EDUCAZIONE MUSICALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Nucleo tematico Comprensione e uso dei linguaggi specifici Traguardi per lo sviluppo delle competenze Comprendere ed utilizzare gli elementi
CURRICOLO DI EDUCAZIONE MUSICALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Nucleo tematico Comprensione e uso dei linguaggi specifici Traguardi per lo sviluppo delle competenze Comprendere ed utilizzare gli elementi
L elasticità e le sue applicazioni in economia Introduzione
 L elasticità e le sue applicazioni in economia Introduzione Fino ad ora l analisi su domanda, offerta ed equilibrio di mercato è stata di tipo qualitativo. Se vogliamo avere una misura quantitativa degli
L elasticità e le sue applicazioni in economia Introduzione Fino ad ora l analisi su domanda, offerta ed equilibrio di mercato è stata di tipo qualitativo. Se vogliamo avere una misura quantitativa degli
La personalità del sordo
 La personalità del sordo La struttura psicologica del sordo è legata ad alcune variabili -ambiente familiare -grado di sordità -età di insorgenza della stessa -contesto socio-culturale di riferimento -presenza
La personalità del sordo La struttura psicologica del sordo è legata ad alcune variabili -ambiente familiare -grado di sordità -età di insorgenza della stessa -contesto socio-culturale di riferimento -presenza
Scuola statale italiana di Madrid Anno scolastico 2016/17 LINGUA ITALIANA Classe 2C Insegnante: Cristina Contri. ABILITÀ Obiettivi di apprendimento
 Scuola statale italiana di Madrid Anno scolastico 2016/17 LINGUA ITALIANA Classe 2C Insegnante: Cristina Contri NUCLEI FONDANTI ASCOLTO E PARLATO COMPETENZE Ascoltare e comprendere messaggi in contesti
Scuola statale italiana di Madrid Anno scolastico 2016/17 LINGUA ITALIANA Classe 2C Insegnante: Cristina Contri NUCLEI FONDANTI ASCOLTO E PARLATO COMPETENZE Ascoltare e comprendere messaggi in contesti
SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMO ANNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE
 SCUOLA ELEMENTARE STATALE DI RACCONIGI CURRICOLO DI MUSICA SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMO ANNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE INDICATORE I Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali
SCUOLA ELEMENTARE STATALE DI RACCONIGI CURRICOLO DI MUSICA SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMO ANNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE INDICATORE I Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali
CLASSI TERZE LA PROGRAMMAZIONE
 Obiettivi generali del processo formativo CLASSI TERZE LA PROGRAMMAZIONE La comunicazione nella madrelingua: la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in
Obiettivi generali del processo formativo CLASSI TERZE LA PROGRAMMAZIONE La comunicazione nella madrelingua: la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in
CURRICOLO VERTICALE DI ARTE E IMMAGINE. Istituto comprensivo di Castell Arquato
 CURRICOLO VERTICALE DI ARTE E IMMAGINE Istituto comprensivo di Castell Arquato Scuola dell infanzia Campi di esperienza Il sé e l altro Il bambino: comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le
CURRICOLO VERTICALE DI ARTE E IMMAGINE Istituto comprensivo di Castell Arquato Scuola dell infanzia Campi di esperienza Il sé e l altro Il bambino: comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE MODELLO SPERIMENTALE
 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE MODELLO SPERIMENTALE Dall analisi sul modello di certificazione per la scuola primaria, sono emerse le seguenti osservazioni: Struttura tabella - Spostare la colonna delle
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE MODELLO SPERIMENTALE Dall analisi sul modello di certificazione per la scuola primaria, sono emerse le seguenti osservazioni: Struttura tabella - Spostare la colonna delle
Istituto Comprensivo
 CURRICOLO DELLA SECONDA LINGUA COMUNITARIA CLASSE I - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RICEZIONE ORALE (ASCOLTO) Comprendere frasi semplici, brevi registrazioni trattanti argomenti con significati molto
CURRICOLO DELLA SECONDA LINGUA COMUNITARIA CLASSE I - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RICEZIONE ORALE (ASCOLTO) Comprendere frasi semplici, brevi registrazioni trattanti argomenti con significati molto
ISTITUTO COMPRENSIVO G.PASCOLI -SILVI. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI Sezione POF
 ISTITUTO COMPRENSIVO G.PASCOLI -SILVI OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI Sezione POF 2014-2015 OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI SCUOLA DELL INFANZIA Accoglienza della diversità, delle persone e delle culture Rafforzamento
ISTITUTO COMPRENSIVO G.PASCOLI -SILVI OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI Sezione POF 2014-2015 OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI SCUOLA DELL INFANZIA Accoglienza della diversità, delle persone e delle culture Rafforzamento
