STAZIONI VIRTUALI DI CODICE
|
|
|
- Norberto Capasso
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 STAZIONI VIRTUALI DI CODICE Alberto Cina (*), Ambrogio Maria Manzino (*), Marco Roggero (*) (*) Politecnico di Torino C.so Duca degli Abruzzi 24, Torino Mail: Riassunto Il lavoro si inquadra nel progetto nazionale del MURST cofinanziato nel 1999 e riguarda la simulazione eseguita, con l uso dei dati giornalieri di alcune stazioni permanenti EUREF per verificarne il possibile impiego per il posizionamento in tempo reale. Questo articolo, relativo alla prima parte della ricerca MURST si limita a studiare le correzioni differenziali di codice, il segnale contenuto, ed una loro modellazione spaziale. Abstract The paper reports on the simulation of a virtual reference station network, to test in in a real time applications. Differential corrections were calculated from pseudorange absolute positioning, and were modelled in space interpolating signal in data. This study is a part of a national research project financed by MURST in Introduzione Le stazioni permanenti GPS in Italia sono potenzialmente in grado di fornire correzioni differenziali a ricevitori mobili, tuttavia le precisioni sono limitate da errori sistematici, fra i quali quelli spazialmente correlati di troposfera, ionosfera, di effemeridi, che possono essere in parte resi funzione della posizione delle stazioni. Le distanze fra queste, possono raggiungere anche le centinaia di chilometri, rendendo inaccettabili le precisioni delle correzioni differenziali. Per limitare i bias, le stazioni della rete possono modellare opportunamente l effetto dei sistematismi nella posizione approssimata del ricevitore mobile, ovvero in una stazione virtuale (VRS) molto prossima alla sua posizione reale. Questo lavoro riguarda la parte di simulazione, nella quale le correzioni differenziali sono state ricavate a posteriori, utilizzando i file delle osservazioni delle più vicine stazioni permanenti. Allo scopo si è sviluppato un software col quale è possibile, compatibilmente con problemi di latenza e ricezione in rete dei dati, calcolare e fornire correzioni differenziali in tempo reale. Il software, compilato in visual fortran, risponde alle esigenze specifiche del problema esaminato: calcola le orbite dei satelliti ed esegue il posizionamento assoluto con misure di pseudorange di codice. Nel caso di posizionamento differenziale, esclude dal calcolo le osservazioni relative ai satelliti non osservati da tutte le stazioni della rete. Il programma è compatibile con diversi formati di input: File delle osservazioni in formato RINEX. File delle effemeridi broadcast in formato RINEX o precise in formato SP3. In tempo reale effemeridi broadcast e osservazioni grezze dal ricevitore tramite porta seriale. Include anche alcune interessanti funzioni per il controllo di qualità sui dati: Tracciamento di elevazione e azimut dei satelliti. Stima del bias dell orologio del ricevitore.
2 Stima del ritardo ionosferico e troposferico. Stima reale delle ambiguità. fig. 1 - la rete di stazioni permanenti utilizzata Normalmente si usa il concetto di stazione virtuale per il posizionamento differenziale con misure di fase; per il momento abbiamo esteso e applicato questo concetto esclusivamente al posizionamento differenziale con misure di codice, modellando nello spazio e nel tempo, direttamente gli errori plano-altimetrici della stazione di misura. Ciò semplifica per ora il problema ed è ugualmente utile in termini applicativi per utenze non professionali. Può essere inoltre considerato un buon posizionamento di partenza per fissare in seguito le ambiguità di fase. Il lavoro mostra applicazioni sulle correzioni alle coordinate. Abbiamo utilizzato nei test le osservazioni delle stazioni permanenti di Novara, Genova, Grasse, Zimmerwald e Torino (fig. 1), prima in modo indipendente, poi mettendo in relazione le correzioni delle prime quattro stazioni, al fine di ottenere il miglior posizionamento differenziale della stazione baricentrica di Torino. Le distanze coinvolte sono centinaia di km; dieci volte superiori a quelle usate per il posizionamento RTK. 2. Le correzioni differenziali Vediamo di che ordine di grandezza sono queste correzioni e come variano nel tempo. Il confronto è tra coordinate note e quelle ricavate dal posizionamento pseudorange di codice fatto con effemeridi broadcast. Requisiti del posizionamento differenziale sono: la stazione base e la stazione mobile devono calcolare la loro posizione nello stesso modo, utilizzando solo i satelliti osservati da entrambe; in questo caso si sono usati quelli comuni alle cinque stazioni. La fig. 2 rappresenta gli errori di posizionamento in longitudine delle cinque stazioni in esame, e si riferisce alle 24 ore del 20/9/2000. Le osservazioni sono ad intervalli di 30 secondi. Notiamo subito dalla fig. 2 che gli errori, al massimo circa 20m, sono molto simili, anche per stazioni che sono molto lontane tra loro. Si osservi anche che le misure variano improvvisamente in certe epoche, che corrispondono ad un cambiamento della costellazione, ovvero al sorgere o al tramontare di un satellite. Gli errori del posizionamento sono di maggiore entità per l altezza ellissoidica: i massimi arrivano a 50 m.
3 fig. 2 correzioni differenziali λ in metri delle 5 stazioni della rete: in ascissa il tempo (tow) La tab. 1 riporta (in metri) i valori di media e sqm degli errori di posizione per le quattro stazioni attorno a Torino. Sono molto simili; con un errore medio di 2 5 m per la planimetria, con sqm di 5 6 m, e un errore medio per l altimetria di 10 m, con sqm pure di 10 m. Grasse Genova Novara Zimmerwald (m) ϕ λ h ϕ λ h ϕ λ h ϕ λ h Media Sqm Tab. 1- errori di posizione di varie stazioni attorno a Torino Nell invio di correzioni differenziali esiste il problema della latenza, ovvero del ritardo dovuto ai tempi di calcolo e di trasmissione delle informazioni dalla stazione base al ricevitore mobile. Ne consegue che una correzione differenziale calcolata per un dato istante nella base, verrà invece applicata in un istante successivo nel ricevitore mobile. Quale latenza può essere tollerata? Per quanto tempo è possibile applicare la stessa correzione senza introdurre degli errori? fig. 3- errori di posizione nella stazione di Torino nel tempo: epoche di 1s 3
4 Per rispondere a queste domande osserviamo ingrandito il diagramma degli errori di posizionamento della stazione di Torino ad intervalli di un secondo (fig. 3), riferentesi ad un ora di misure. Notiamo ancora, come le misure cambiano marcatamente al variare della costellazione. In questo grafico è però importante osservare come sia presente un segnale che, per periodi non troppo lunghi, può essere facilmente interpolato e una componente dovuta al rumore. Questo ci consente di rispondere alle domande che ci siamo posti: sino a quando il segnale presente nelle misure non diventa più grande del rumore, è possibile non solo ricevere il dato, ma anche utilizzarne la sua tendenza per predirlo ad epoche successive. Nel caso specifico ciò avviene anche per più di un minuto a parità di costellazione. La figura mostra anche che il rumore è più grande nelle misure di quota che in planimetria. Vediamo finalmente i risultati del posizionamento differenziale della stazione di Torino, riassunti in tabella 2. È evidente un maggiore scostamento degli errori residui ottenuti utilizzando le correzioni differenziali calcolate con la stazione di Grasse. Grasse Genova Novara Zimmerwald (m) ϕ λ h ϕ λ h ϕ λ h ϕ λ h Media Sqm Tab. 2- errori residui su Torino, calcolati con le correzioni differenziali di varie stazioni Sia per quanto riguarda la planimetria che l altimetria otteniamo ottimi risultati con le correzioni calcolate dalla stazione di Novara, la più vicina a Torino. In altimetria, com era prevedibile, precisione ed accuratezza sono inferiori. Prestiamo attenzione all altimetria: mentre Grasse e Zimmerwald restituiscono un h in media negativo, Genova e Novara forniscono valori h positivi. Non a caso le prime due stazioni sono situate in quota (a circa 1300m e 950 m rispettivamente). Un modello fisico di troposfera, anche grossolano, come una semplice dipendenza dell errore troposferico dalla quota, potrebbe migliorare il risultato finale. 3. Il segnale nei dati e la stazionarietà delle correzioni Prima di proporre qualunque modello interpolativo ci domandiamo: ha senso interpolare le correzioni in una posizione definita stazione virtuale? La risposta è affermativa se sussistono queste due condizioni: nei dati sia presente un segnale e l interpolazione eseguita in qualche modo lo estragga ed aumenti la precisione e l accuratezza che si avrebbe in un posizionamento tradizionale. La prima verifica è stata eseguita cercando la presenza di un segnale con una funzione di autocorrelazione, la seconda cercando la migliore stima lineare della correzione di Torino in funzione delle correzioni degli altri siti. È evidente che l ultima operazione non serve dal punto di vista pratico in quanto la correzione su un punto interno ad una maglia è proprio la quantità incognita, ma serve ugualmente a comprendere e giustificare una stima interpolativa. I grafici seguenti mostrano le funzioni di autocorrelazione delle correzioni di quota di Torino calcolate da Grasse (fig. 4a) e da Zimmerwald (fig. 4b). Si nota la presenza di un segnale di potenza compresa tra 0.8 e 0.3, valori che giustificano un filtraggio. Le ascisse sono il numero di epoche a 30s. È anche evidente una lunghezza di correlazione di circa un centinaio di epoche e un andamento oscillatorio che si ripete circa ogni 300 epoche (due ore e mezza) che potremmo attribuire agli aspetti troposferici. I grafici delle altre due stazioni sono simili.
5 a b Figg. 4 - Autocorrelazioni delle correzioni h di Torino calcolate da Grasse: a) e Zimmerwald: b) Le figure 5a e 5b descrivono le autocorrelazioni delle correzioni ϕ e λ della stazione di Torino calcolate da Novara. In questi casi invece si nota la presenza di un segnale molto più debole, (di potenza da 0.03 a 0.2) con lunghezze di correlazione un poco più ampie e con periodicità di almeno quattro ore. L interpolazione di queste quantità non potrà fornire grandi miglioramenti a Figg. 5 - Autocorrelazioni delle correzioni di Torino calcolate da Novara in ϕ : a) e λ : b) b Cerchiamo allora un segnale nei dati attraverso una funzione lineare del tipo x T = a1 x1 + a2x anxn (1) dove x T è la correzione (in ϕ, λ o h) della stazione test di Torino e x 1,.. x n sono le correzioni delle quattro stazioni che la circondano, a i sono i coefficienti da stimare. Nel nostro caso i coefficienti sono 4: è necessario allora utilizzare almeno 4 epoche nell ipotesi che in quattro o più epoche questi valori siano stazionari. Nella ricerca di un possibile periodo di stazionarietà il risultato è stato sorprendente: non solo si ha stazionarietà dopo diverse epoche, ma in tutta la giornata di misura. Risultati simili, per intervalli di tempo prossimi o superiori alle 24 ore, si sono ottenuti utilizzando anche altre giornate di misura. A tale proposito lo strumento che si è ritenuto più adatto è quello dei minimi quadrati sequenziali. A partire dalla quinta epoca si sono stimati i parametri e le loro precisioni e ne sono stati graficati gli andamenti. Per verifica sono stati calcolati all indietro, come avviene ad esempio nel filtro di Kalman, ottenendo una seconda conferma (figure 6b e 6d). I grafici seguenti indicano l andamento di questi parametri per la correzione di quota, ma gli stessi risultati, con valori dei parametri diversi, si ottengono per latitudine e longitudine. 5
6 Figg. 6a e 6b (in alto): stazionarietà delle correzioni di quota (valori dei parametri a i per le quote). Figg 6c e 6d (in basso): sqm dei parametri a i nel tempo. Tutti indicano poi come le correzioni meno importanti quelle derivanti dalla stazione di Genova. La somma dei parametri è sempre molto prossima all unità: ad esempio, per le quote, i valori di a i della (1) sono: a GRAS = 0.31; a GENO =0.22; a NOVA =0.25; a ZIMM =0.22. Ciò ha un evidente motivo fisico. I coefficienti trovati non sono tuttavia spiegabili completamente con la distanza tra le stazioni, ma permettono ugualmente di determinarne l importanza. La controprova è stata l applicazione di questi parametri per i dati di tutta la giornata. Le correzioni interpolate di Torino, rispetto alla posizione nota hanno fornito i risultati di tabella 3, decisamente migliori, principalmente sul valore medio, di quelli calcolati dalla stazione più vicina di Novara. Migliore interpolazione Con correzioni di Novara (m) ϕ λ h ϕ λ h Media sqm Tab. 3 - risultati dell applicazione dei coefficienti giornalieri per determinare le correzioni di Torino 4. L interpolazione delle correzioni Le prove precedenti hanno dimostrato che la correzione di una stazione interna alla rete può essere ricavata come combinazione lineare delle correzioni delle altre stazioni e che i coefficienti sono stazionari anche per una intera giornata. Il risultato tuttavia non serve a predire le correzioni in relazione alla posizione del punto. È necessario un algoritmo di interpolazione funzione della posizione geografica della stazione rover. La scelta del miglior algoritmo di interpolazione è un problema di non facile soluzione che dipende sia dal dominio spaziale che dalle caratteristiche del segnale.
7 Per comprendere quali risultati possono attendersi da metodi classici di interpolazione e solo come metodo di prima approssimazione, abbiamo utilizzato le correzioni di tutte le stazioni con una combinazione lineare di pesi dipendenti dall inverso del quadrato della distanza dai punti della rete. Abbiamo così simulato il posizionamento differenziale della stazione permanente di Torino, utilizzando correzioni calcolate dalle stazioni di Genova, Grass, Novara e Zimmerwald. I risultati sono riassunti in tab. 4. Notiamo i buoni valori di media, inoltre i valori di sqm dell'errore altimetrico sono diminuiti mediamente di più del 20%, rispetto ai risultati della stazione più vicina. Correzioni interpolate: 1/d 2 Con correzioni da Novara (m) ϕ λ h ϕ λ h Media sqm Tab. 4 - risultati dell interpolazione con pesi= 1/d 2 per determinare le correzioni di Torino Una seconda prova di interpolazione è stata eseguita con un modello linearmente dipendente dalla coordinate della stazione del tipo: C = a 0 + a 1 ϕ + a 2 λ + a 3 h (2) Tale modello è indipendente dalle correzioni stesse, dipende da queste solo indirettamente in quanto i coefficienti sono stati ricavati ai minimi quadrati imponendo il ritorno delle correzioni differenziali C in ϕ, λ, h sulle quattro stazioni attorno a Torino. Per ricavare questi quattro coefficienti ad ogni epoca sono necessarie perlomeno quattro stazioni I coefficienti sono stati ricavati in due modi: sfruttando i soli dati dell epoca di misura od utilizzando i dati di un certo numero n di epoche precedenti la misura. Nel primo caso i risultati ottenuti sono stati peggiori di quanto ricavabile con l interpolazione precedente: i valori di sqm in quota sono superiori ad 1m. Fig 7 - medie e sqm in ϕ nel posizionamento differenziale a Torino al variare della finestra. Il secondo metodo va attentamente considerato: è vero che l utilizzo proposto è il tempo reale ma, per scopi statici non è operativamente gravoso rimanere sul punto di misura per un numero limitato di epoche. Per scopi cinematici, se fosse improponibile conoscere la posizione dopo 10 o 20 epoche di misura, è possibile predire questi coefficienti all epoca di misura per mezzo del filtro di Kalman. Ai fini della simulazione abbiamo esaminato una finestra temporale di n epoche nella quale sono state usate tutte le correzioni per calcolare, per ogni coordinata, i quattro parametri della (2). Questi parametri sono poi stati usati per stimare le correzioni di Torino. Il confronto è avvenuto con le corrispondenti medie mobili, operate sulle stesse finestre, delle correzioni note di Torino. La fig. 7 riporta i risultati del confronto ottenuti per la latitudine. Aumentando la finestra a 40 e più epoche si ottengono errori residui di posizionamento con sqm paragonabili ai metodi di interpo- 7
8 lazione sinora descritti, anche se non migliori. Le medie sono abbastanza prossime a zero. La tab. 5 indica i parametri di errore per una finestra di 40 epoche. Errori sul tipo di correzione (2) (m) ϕ λ h Media sqm Tab. 5 statistiche su residui del posizionamento differenziale di Torino usando l interpolazione (2) All esperimento sono possibili due critiche: i risultati ottenuti sono pessimistici in quanto i dati utilizzati riguardano epoche di 30s. In questi dati, dopo poche epoche, le correzioni differenziali non sono fra loro più correlate. Ha senso invece filtrare i dati di codice per epoche di un secondo, per le quali è anche ragionevole attendere una o due decine di epoche. Purtroppo molte stazioni permanenti non forniscono dati ad un secondo. L equazione (2) ha lo svantaggio, utilizzata ai minimi quadrati, non utilizzare direttamente, come la (1) le correzioni ed il segnale ad alta frequenza in queste contenuto, ma anzi di lisciare questi segnali, anche se ha ovviamente il vantaggio di rimuovere un poco il rumore. Conclusioni Anche per le correzioni differenziali di codice ha senso parlare di stazioni virtuali. Anche per distanze elevate tipiche dell attuale rete EUREF l interpolazione delle correzioni rimuove gran parte dei sistematismi e aumenta la precisione sulla posizione. Il fenomeno della latenza è in tal caso di scarso rilievo. Le correzioni sono ben modellabili con coefficienti simili a pesi che sono stazionari per lunghi periodi. È auspicabile che le stazioni permanenti si attrezzino a fornire dati con rate di un secondo. Bibliografia Borre K.,G. Strang, Linear Algebra, Geodesy, and GPS, Wellesley-Cambridge Press, Cina A., GPS, principi, modalità e tecniche di posizionamento, Celid, maggio Hofmann Wellenhof B.,-, Lichtenegger H., Collins J, GPS Theory and Practice, Springer Wien New York, Leick A., GPS Satellite Surveying, Wiley Interscience Publication, Press W. H., Teukolsky S. A., Vetterling W. T., Flannery B. P., Numerical Recipes in Fortran 77, Cambridge University Press, Riguzzi F. Istituto Nazionale di Geofisica, La trasformazione delle osservazioni GPS nel formato internazionale di scambio RINEX in Bollettino di Geodesia pp n Vollath U., Buecherl A., Landau H., Pagels C., Wagner B.: Multi-base RTK positioning using virtual refeence stations. ION GPS 2000, september 2000 pagg Vollath U., Buecherel A., Landau H.: Long-range RTK positioning using virtual refeence stations. ION GPS 2000, september 2000 pagg
Strumentazione GPS e Reti di Stazioni Permanenti. M. Grazia Visconti
 Strumentazione GPS e Reti di Stazioni Permanenti Eugenio Realini eugenio.realini@polimi.it M. Grazia Visconti grazia@geomatica.como.polimi.it Modalità di posizionamento Posizionamento assoluto Posizionamento
Strumentazione GPS e Reti di Stazioni Permanenti Eugenio Realini eugenio.realini@polimi.it M. Grazia Visconti grazia@geomatica.como.polimi.it Modalità di posizionamento Posizionamento assoluto Posizionamento
Contributi geomatici al progetto MEP (Map for Easy Paths)
 XIX Conferenza ASITA 29-30 Settembre - 1 ottobre 2015 Politecnico di Milano Polo di Lecco Como Campus Laboratorio di Geomatica Contributi geomatici al progetto MEP (Map for Easy Paths) L. Biagi, M. Negretti,
XIX Conferenza ASITA 29-30 Settembre - 1 ottobre 2015 Politecnico di Milano Polo di Lecco Como Campus Laboratorio di Geomatica Contributi geomatici al progetto MEP (Map for Easy Paths) L. Biagi, M. Negretti,
Il sistema di posizionamento GPS
 Il sistema di posizionamento GPS Introduzione Il sistema di posizionamento GNSS (Global Navigation Satellite System) è un sistema di navigazione basato sulla ricezione di segnali radio emessi da una costellazione
Il sistema di posizionamento GPS Introduzione Il sistema di posizionamento GNSS (Global Navigation Satellite System) è un sistema di navigazione basato sulla ricezione di segnali radio emessi da una costellazione
Laboratorio di restauro Topografia e rilevamento
 Laboratorio di restauro Topografia e rilevamento Dott. Andrea Piccin andrea_piccin@regione.lombardia.it ESERCITAZIONE GPS ELABORAZIONE DEI DATI Dott. Geol.Silvia Rosselli Il GPS Il posizionamento di un
Laboratorio di restauro Topografia e rilevamento Dott. Andrea Piccin andrea_piccin@regione.lombardia.it ESERCITAZIONE GPS ELABORAZIONE DEI DATI Dott. Geol.Silvia Rosselli Il GPS Il posizionamento di un
Facoltà di Ingegneria. Corso di Laurea in Ingegneria per l Ambiente ed il Territorio Anno accademico: Tesi di Laurea
 Metodologia per la validazione geometrica del catasto della segnaletica verticale della provincia di Frosinone tramite una rete di stazioni permanenti GNSS Relatore: Correlatore: Prof. Ing. Mattia G. Crespi
Metodologia per la validazione geometrica del catasto della segnaletica verticale della provincia di Frosinone tramite una rete di stazioni permanenti GNSS Relatore: Correlatore: Prof. Ing. Mattia G. Crespi
Confronto stime-misure
 Confronto stime-misure L approccio modellistico adottato per la stima del campo di vento ha previsto, nella fase di configurazione del modello CALMET utilizzato per il downscaling, una verifica delle stime
Confronto stime-misure L approccio modellistico adottato per la stima del campo di vento ha previsto, nella fase di configurazione del modello CALMET utilizzato per il downscaling, una verifica delle stime
I. Foglio di esercizi su vettori linearmente dipendenti e linearmente indipendenti. , v 2 = α v 1 + β v 2 + γ v 3. α v 1 + β v 2 + γ v 3 = 0. + γ.
 ESERCIZI SVOLTI DI ALGEBRA LINEARE (Sono svolti alcune degli esercizi proposti nei fogli di esercizi su vettori linearmente dipendenti e vettori linearmente indipendenti e su sistemi lineari ) I. Foglio
ESERCIZI SVOLTI DI ALGEBRA LINEARE (Sono svolti alcune degli esercizi proposti nei fogli di esercizi su vettori linearmente dipendenti e vettori linearmente indipendenti e su sistemi lineari ) I. Foglio
TOPOGRAFIA 2013/2014. Prof. Francesco-Gaspare Caputo
 TOPOGRAFIA 2013/2014 L operazione di misura di una grandezza produce un numero reale che esprime il rapporto della grandezza stessa rispetto a un altra, a essa omogenea, assunta come unità di misura. L
TOPOGRAFIA 2013/2014 L operazione di misura di una grandezza produce un numero reale che esprime il rapporto della grandezza stessa rispetto a un altra, a essa omogenea, assunta come unità di misura. L
Struttura del sistema GPS. Introduzione
 Introduzione Il sistema di posizionamento GNSS (Global Navigation Satellite System) è un sistema di navigazione basato sulla ricezione di segnali radio emessi da una costellazione di satelliti artificiali
Introduzione Il sistema di posizionamento GNSS (Global Navigation Satellite System) è un sistema di navigazione basato sulla ricezione di segnali radio emessi da una costellazione di satelliti artificiali
Il sistema GPS IL SISTEMA GPS. Università di Pavia
 IL SISTEMA GPS Argomenti della lezione Navstar GPS Utilizzazione del sistema GPS a fini geodetici e topografici Problemi di passaggio di datum NAVSTAR GPS (NAVigation Satellite Timing And Ranging Global
IL SISTEMA GPS Argomenti della lezione Navstar GPS Utilizzazione del sistema GPS a fini geodetici e topografici Problemi di passaggio di datum NAVSTAR GPS (NAVigation Satellite Timing And Ranging Global
GNSS DAL GPS AL PER LA
 Alberto Cina DAL GPS AL GNSS (Global Navigation Satellite System) PER LA GEOMATICAA I siti internet citati sono stati visitati nel febbraio 2014 In copertina: misure GNSS su ghiacciaio, in Valle d Aosta
Alberto Cina DAL GPS AL GNSS (Global Navigation Satellite System) PER LA GEOMATICAA I siti internet citati sono stati visitati nel febbraio 2014 In copertina: misure GNSS su ghiacciaio, in Valle d Aosta
Sistemi di Posizionamento Satellitare
 Sistemi di Posizionamento Satellitare GNSS Global Navigation Satellite System indica il complesso di tutti i sistemi di navigazione satellitare GPS GLONASS GALILEO COMPASS Global Positioning System (U.S.A.)
Sistemi di Posizionamento Satellitare GNSS Global Navigation Satellite System indica il complesso di tutti i sistemi di navigazione satellitare GPS GLONASS GALILEO COMPASS Global Positioning System (U.S.A.)
Metodologia di implementazione del sistema per la spazializzazione dei dati meteo
 Metodologia di implementazione del sistema per la spazializzazione dei dati meteo Metodologia di implementazione del sistema per la spazializzazione dei dati meteo . Metodologia Le reti di monitoraggio
Metodologia di implementazione del sistema per la spazializzazione dei dati meteo Metodologia di implementazione del sistema per la spazializzazione dei dati meteo . Metodologia Le reti di monitoraggio
La Rete SPIN GNSS di Piemonte e Lombardia: modalità di utilizzo
 La Rete SPIN GNSS di Piemonte e Lombardia: modalità di utilizzo A che cosa serve una rete GNSS? Applicazioni «topografiche» Rilievi topografici / geodetici terrestri e stradali Produzione e aggiornamento
La Rete SPIN GNSS di Piemonte e Lombardia: modalità di utilizzo A che cosa serve una rete GNSS? Applicazioni «topografiche» Rilievi topografici / geodetici terrestri e stradali Produzione e aggiornamento
LA GEOMATICA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO. A. Albertella (DICA Sezione di Geodesia e Geomatica)
 LA GEOMATICA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO A. Albertella (DICA Sezione di Geodesia e Geomatica) Cosa è la GEOMATICA? 2 GEOMATICA per il controllo del territorio 3 Conoscere il territorio significa anche
LA GEOMATICA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO A. Albertella (DICA Sezione di Geodesia e Geomatica) Cosa è la GEOMATICA? 2 GEOMATICA per il controllo del territorio 3 Conoscere il territorio significa anche
Il processo inferenziale consente di generalizzare, con un certo grado di sicurezza, i risultati ottenuti osservando uno o più campioni
 La statistica inferenziale Il processo inferenziale consente di generalizzare, con un certo grado di sicurezza, i risultati ottenuti osservando uno o più campioni E necessario però anche aggiungere con
La statistica inferenziale Il processo inferenziale consente di generalizzare, con un certo grado di sicurezza, i risultati ottenuti osservando uno o più campioni E necessario però anche aggiungere con
Interpolazione Statistica
 Interpolazione Statistica Come determinare una funzione che rappresenti la relazione tra due grandezze x e y a cura di Roberto Rossi novembre 2008 Si parla di INTERPOLAZIONE quando: Note alcune coppie
Interpolazione Statistica Come determinare una funzione che rappresenti la relazione tra due grandezze x e y a cura di Roberto Rossi novembre 2008 Si parla di INTERPOLAZIONE quando: Note alcune coppie
( t) NR( t) NR( t) ( t)
 prof Valerio CURCIO Simulazione del prezzo del petrolio 1 1. Processi stocastici stazionari e non stazionari dall analisi del prezzo del petrolio Quello che vogliamo fare in questo articolo è un analisi
prof Valerio CURCIO Simulazione del prezzo del petrolio 1 1. Processi stocastici stazionari e non stazionari dall analisi del prezzo del petrolio Quello che vogliamo fare in questo articolo è un analisi
Statistica Descrittiva Soluzioni 7. Interpolazione: minimi quadrati
 ISTITUZIONI DI STATISTICA A. A. 2007/2008 Marco Minozzo e Annamaria Guolo Laurea in Economia del Commercio Internazionale Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese Università degli Studi di Verona
ISTITUZIONI DI STATISTICA A. A. 2007/2008 Marco Minozzo e Annamaria Guolo Laurea in Economia del Commercio Internazionale Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese Università degli Studi di Verona
Raccolta di esercizi di Calcolo Numerico Prof. Michela Redivo Zaglia
 Raccolta di esercizi di Calcolo Numerico Prof. Michela Redivo Zaglia Nota Bene: Gli esercizi di questa raccolta sono solo degli esempi. Non sono stati svolti né verificati e servono unicamente da spunto
Raccolta di esercizi di Calcolo Numerico Prof. Michela Redivo Zaglia Nota Bene: Gli esercizi di questa raccolta sono solo degli esempi. Non sono stati svolti né verificati e servono unicamente da spunto
"Match analysis, GPS, potenza metabolica: le bugie della verità"
 www.k-sport.it "Match analysis, GPS, potenza metabolica: le bugie della verità" Mirko Marcolini Il carico esterno Cos è Ogni grandezza fisica viene definita mediante il metodo che si usa per misurarla.
www.k-sport.it "Match analysis, GPS, potenza metabolica: le bugie della verità" Mirko Marcolini Il carico esterno Cos è Ogni grandezza fisica viene definita mediante il metodo che si usa per misurarla.
Le reti GNSS nella ricerca accademica. Ludovico Biagi, Politecnico di Milano, DICA.
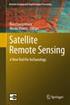 Le reti GNSS nella ricerca accademica Ludovico Biagi, Politecnico di Milano, DICA ludovico.biagi@polimi.it www.geoinformatics.polimi.it Le reti permanenti GNSS Una rete di stazioni GNSS continuamente operante
Le reti GNSS nella ricerca accademica Ludovico Biagi, Politecnico di Milano, DICA ludovico.biagi@polimi.it www.geoinformatics.polimi.it Le reti permanenti GNSS Una rete di stazioni GNSS continuamente operante
PROBABILITÀ - SCHEDA N. 3 VARIABILI ALEATORIE CONTINUE E SIMULAZIONE
 PROBABILITÀ - SCHEDA N. 3 VARIABILI ALEATORIE CONTINUE E SIMULAZIONE (da un idea di M. Impedovo Variabili aleatorie continue e simulazione Progetto Alice n. 15, ) 1. La simulazione Nelle schede precedenti
PROBABILITÀ - SCHEDA N. 3 VARIABILI ALEATORIE CONTINUE E SIMULAZIONE (da un idea di M. Impedovo Variabili aleatorie continue e simulazione Progetto Alice n. 15, ) 1. La simulazione Nelle schede precedenti
B02 - GNSS ARGOMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX I sistemi di posizionamento satellitare. Tratto dalle dispense D02
 B02 - GNSS X I sistemi di posizionamento satellitare Tratto dalle dispense D02 1 11/05/2011 I sistemi GNSS X GNSS: Global Navigation Satellite Systems GPS Stati Uniti GLONASS Russia GALILEO Europa COMPASS
B02 - GNSS X I sistemi di posizionamento satellitare Tratto dalle dispense D02 1 11/05/2011 I sistemi GNSS X GNSS: Global Navigation Satellite Systems GPS Stati Uniti GLONASS Russia GALILEO Europa COMPASS
Sommario RILIEVO TOPOGRAFICO DELLO STATO DI FATTO... 2 METODI... 2 RISULTATI... 5
 Sommario RILIEVO TOPOGRAFICO DELLO STATO DI FATTO... 2 METODI... 2 RISULTATI... 5 RILIEVO TOPOGRAFICO DELLO STATO DI FATTO METODI Nel tratto interessato dall attraversamento della nuova strada è stato
Sommario RILIEVO TOPOGRAFICO DELLO STATO DI FATTO... 2 METODI... 2 RISULTATI... 5 RILIEVO TOPOGRAFICO DELLO STATO DI FATTO METODI Nel tratto interessato dall attraversamento della nuova strada è stato
Anno 3 Equazione dell'ellisse
 Anno Equazione dell'ellisse 1 Introduzione In questa lezione affronteremo una serie di problemi che ci chiederanno di determinare l equazione di un ellisse sotto certe condizioni. Al termine della lezione
Anno Equazione dell'ellisse 1 Introduzione In questa lezione affronteremo una serie di problemi che ci chiederanno di determinare l equazione di un ellisse sotto certe condizioni. Al termine della lezione
PAROLE CHIAVE Accuratezza, Accuracy, Esattezza, PRECISIONE, Precision, Ripetibilità, Affidabilità, Reliability, Scarto quadratico medio (sqm), Errore
 PAROLE CHIAVE Accuratezza, Accuracy, Esattezza, PRECISIONE, Precision, Ripetibilità, Affidabilità, Reliability, Scarto quadratico medio (sqm), Errore medio, Errore quadratico medio (eqm), Deviazione standard,
PAROLE CHIAVE Accuratezza, Accuracy, Esattezza, PRECISIONE, Precision, Ripetibilità, Affidabilità, Reliability, Scarto quadratico medio (sqm), Errore medio, Errore quadratico medio (eqm), Deviazione standard,
Tipi di servizi offerti
 Tipi di servizi offerti Tiziano Cosso tiziano.cosso@unige.it Laboratorio di Geodesia, Geomatica e GIS DICAT Università degli Studi di Genova Seminario Formativo REALIZZAZIONE DELLA RETE REGIONALE GNSS
Tipi di servizi offerti Tiziano Cosso tiziano.cosso@unige.it Laboratorio di Geodesia, Geomatica e GIS DICAT Università degli Studi di Genova Seminario Formativo REALIZZAZIONE DELLA RETE REGIONALE GNSS
Le esperienze di reti GNSS nella Regione Abruzzo
 Università dell Aquila Facoltà di Ingegneria Le esperienze di reti GNSS nella Regione Abruzzo Donatella Dominici TECNICHE GPS DIFFERENZIALI DGPS (Differential GPS) Misure di codice Precisione metrica
Università dell Aquila Facoltà di Ingegneria Le esperienze di reti GNSS nella Regione Abruzzo Donatella Dominici TECNICHE GPS DIFFERENZIALI DGPS (Differential GPS) Misure di codice Precisione metrica
APPENDICE 4.A2 RILEVAMENTI IN TEMPO REALE IN PROSSIMITÀ DEI CONFINI DI RETI DI STAZIONI PERMANENTI GPS
 PRIN 2004: I Servizi di posizionamento satellitare per l e-government APPENDICE 4.A2 RILEVAMENTI IN TEMPO REALE IN PROSSIMITÀ DEI CONFINI DI RETI DI STAZIONI PERMANENTI GPS Tiziano Cosso, Bianca Federici,
PRIN 2004: I Servizi di posizionamento satellitare per l e-government APPENDICE 4.A2 RILEVAMENTI IN TEMPO REALE IN PROSSIMITÀ DEI CONFINI DI RETI DI STAZIONI PERMANENTI GPS Tiziano Cosso, Bianca Federici,
INTERPOLAZIONE. Introduzione
 Introduzione INTERPOLAZIONE Quando ci si propone di indagare sperimentalmente la legge di un fenomeno, nel quale intervengono due grandezze x, y simultaneamente variabili, e una dipendente dall altra,
Introduzione INTERPOLAZIONE Quando ci si propone di indagare sperimentalmente la legge di un fenomeno, nel quale intervengono due grandezze x, y simultaneamente variabili, e una dipendente dall altra,
La Rete Dinamica Nazionale (RDN)
 La Rete Dinamica Nazionale (RDN) Renzo Maseroli Servizio Geodetico - IGM Bologna, 15 gennaio 2009 1 Profonda rivoluzione delle scienze del rilievo in tempi brevi con l avvento della geodesia satellitare
La Rete Dinamica Nazionale (RDN) Renzo Maseroli Servizio Geodetico - IGM Bologna, 15 gennaio 2009 1 Profonda rivoluzione delle scienze del rilievo in tempi brevi con l avvento della geodesia satellitare
GPS. nuove tecnologie di posizionamento
 GPS nuove tecnologie di posizionamento Sistemi GNSS Esistono attualmente due sistemi di posizionamento via satellite: - il sistema USA Navstar GPS (sistema rif. WGS84) - il sistema Russo Glonass (sistema
GPS nuove tecnologie di posizionamento Sistemi GNSS Esistono attualmente due sistemi di posizionamento via satellite: - il sistema USA Navstar GPS (sistema rif. WGS84) - il sistema Russo Glonass (sistema
Global Positioning System Lavoro di maturità. Sandro Mani
 Global Positioning System Lavoro di maturità Sandro Mani Struttura del sistema Global Positioning System 1 Space segment: User segment: Control segment: 24 satelliti orbitanti attorno alla Terra a circa
Global Positioning System Lavoro di maturità Sandro Mani Struttura del sistema Global Positioning System 1 Space segment: User segment: Control segment: 24 satelliti orbitanti attorno alla Terra a circa
Una Libreria di Algebra Lineare per il Calcolo Scientifico
 Una Libreria di Algebra Lineare per il Calcolo Scientifico Introduzione Il Lavoro di Tesi Introduzione al Metodo Ridurre l Occupazione di Memoria Metodo di Memorizzazione degli Elementi Risultati Attesi
Una Libreria di Algebra Lineare per il Calcolo Scientifico Introduzione Il Lavoro di Tesi Introduzione al Metodo Ridurre l Occupazione di Memoria Metodo di Memorizzazione degli Elementi Risultati Attesi
Derivazione numerica. Introduzione al calcolo numerico. Derivazione numerica (II) Derivazione numerica (III)
 Derivazione numerica Introduzione al calcolo numerico Il calcolo della derivata di una funzione in un punto implica un processo al limite che può solo essere approssimato da un calcolatore. Supponiamo
Derivazione numerica Introduzione al calcolo numerico Il calcolo della derivata di una funzione in un punto implica un processo al limite che può solo essere approssimato da un calcolatore. Supponiamo
[ ] L incremento di invaso in un intervallo di tempo t è dato da:
![[ ] L incremento di invaso in un intervallo di tempo t è dato da: [ ] L incremento di invaso in un intervallo di tempo t è dato da:](/thumbs/71/65149015.jpg) METODO DI MUSKINGUM-CUNGE E un modello del 1938 che prende il nome dal fiume in cui è stato applicato la prima volta. Alla base del modello ci sono le ipotesi che il volume d acqua invasato nel tronco
METODO DI MUSKINGUM-CUNGE E un modello del 1938 che prende il nome dal fiume in cui è stato applicato la prima volta. Alla base del modello ci sono le ipotesi che il volume d acqua invasato nel tronco
TEMI D ESAME DI ANALISI MATEMATICA I
 TEMI D ESAME DI ANALISI MATEMATICA I Corso di laurea quadriennale) in Fisica a.a. 003/04 Prova scritta del 3 aprile 003 ] Siano a, c parametri reali. Studiare l esistenza e, in caso affermativo, calcolare
TEMI D ESAME DI ANALISI MATEMATICA I Corso di laurea quadriennale) in Fisica a.a. 003/04 Prova scritta del 3 aprile 003 ] Siano a, c parametri reali. Studiare l esistenza e, in caso affermativo, calcolare
CAPITOLO 2: RILIEVO GEODETICO E NAVIGAZIONE 2.1 OBIETTIVI DELLA RICERCA PERIODO DI LAVORO, PERSONALE E ATTREZZATURE... 1
 CAPITOLO 2: RILIEVO GEODETICO E NAVIGAZIONE 2.1 OBIETTIVI DELLA RICERCA... 1 2.2 PERIODO DI LAVORO, PERSONALE E ATTREZZATURE... 1 2.3 METODOLOGIE OPERATIVE E STRUMENTAZIONI... 1 2.3.1 Sistema di posizionamento
CAPITOLO 2: RILIEVO GEODETICO E NAVIGAZIONE 2.1 OBIETTIVI DELLA RICERCA... 1 2.2 PERIODO DI LAVORO, PERSONALE E ATTREZZATURE... 1 2.3 METODOLOGIE OPERATIVE E STRUMENTAZIONI... 1 2.3.1 Sistema di posizionamento
Creazione e pubblicazione del DTM HELI-DEM Presentazione di Laura Carcano, Politecnico di Milano, Laboratorio di Geomatica del Polo Territoriale di
 Creazione e pubblicazione del DTM HELI-DEM Presentazione di Laura Carcano, Politecnico di Milano, Laboratorio di Geomatica del Polo Territoriale di Como A nome di tutto il gruppo di lavoro HELI-DEM Obiettivo
Creazione e pubblicazione del DTM HELI-DEM Presentazione di Laura Carcano, Politecnico di Milano, Laboratorio di Geomatica del Polo Territoriale di Como A nome di tutto il gruppo di lavoro HELI-DEM Obiettivo
Metodi di riduzione del modello dinamico Dott. Lotti Nevio
 1. Metodi di riduzione del modello dinamico Nel mettere insieme modelli dinamici di elementi diversi di una struttura (come avviene nel caso di un velivolo e del suo carico utile, ma anche per i diversi
1. Metodi di riduzione del modello dinamico Nel mettere insieme modelli dinamici di elementi diversi di una struttura (come avviene nel caso di un velivolo e del suo carico utile, ma anche per i diversi
Tecnologia e rilievo del carico esterno nel calcio
 www.k-sport.it Tecnologia e rilievo del carico esterno nel calcio Una mela cade dall albero. Qualcuno ci vede un frutto andato a male. Qualcun altro la legge di gravità. Mirko Marcolini 1 Cos è Ogni grandezza
www.k-sport.it Tecnologia e rilievo del carico esterno nel calcio Una mela cade dall albero. Qualcuno ci vede un frutto andato a male. Qualcun altro la legge di gravità. Mirko Marcolini 1 Cos è Ogni grandezza
RILIEVI GPS-RTK E STAZIONI PERMANENTI GPS: SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA RIR
 RILIEVI GPS-RTK E STAZIONI PERMANENTI GPS: SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA RIR R. Barzaghi*, B. Betti*, L. Biagi**, V. Casella***, M. Crespi****, M. Franzini***, A. M. Manzino*****, A. Mazzoni****, M. Piras******,
RILIEVI GPS-RTK E STAZIONI PERMANENTI GPS: SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA RIR R. Barzaghi*, B. Betti*, L. Biagi**, V. Casella***, M. Crespi****, M. Franzini***, A. M. Manzino*****, A. Mazzoni****, M. Piras******,
CAPITOLO 11 ANALISI DI REGRESSIONE
 VERO FALSO CAPITOLO 11 ANALISI DI REGRESSIONE 1. V F Se c è una relazione deterministica tra due variabili,x e y, ogni valore dato di x,determinerà un unico valore di y. 2. V F Quando si cerca di scoprire
VERO FALSO CAPITOLO 11 ANALISI DI REGRESSIONE 1. V F Se c è una relazione deterministica tra due variabili,x e y, ogni valore dato di x,determinerà un unico valore di y. 2. V F Quando si cerca di scoprire
SIMULAZIONE - 29 APRILE QUESITI
 www.matefilia.it SIMULAZIONE - 29 APRILE 206 - QUESITI Q Determinare il volume del solido generato dalla rotazione attorno alla retta di equazione y= della regione di piano delimitata dalla curva di equazione
www.matefilia.it SIMULAZIONE - 29 APRILE 206 - QUESITI Q Determinare il volume del solido generato dalla rotazione attorno alla retta di equazione y= della regione di piano delimitata dalla curva di equazione
La ionosfera è una parte dell'atmosfera terrestre, che si estende da circa km di altitudine.
 Effetti ionosferici su Posizionamento GNSS Ionosferica ritardo del segnale - Trimble - La ionosfera è una parte dell'atmosfera terrestre, che si estende da circa 50-1000 km di altitudine. Ultravioletti
Effetti ionosferici su Posizionamento GNSS Ionosferica ritardo del segnale - Trimble - La ionosfera è una parte dell'atmosfera terrestre, che si estende da circa 50-1000 km di altitudine. Ultravioletti
IL CRITERIO DELLA MASSIMA VEROSIMIGLIANZA
 Metodi per l Analisi dei Dati Sperimentali AA009/010 IL CRITERIO DELLA MASSIMA VEROSIMIGLIANZA Sommario Massima Verosimiglianza Introduzione La Massima Verosimiglianza Esempio 1: una sola misura sperimentale
Metodi per l Analisi dei Dati Sperimentali AA009/010 IL CRITERIO DELLA MASSIMA VEROSIMIGLIANZA Sommario Massima Verosimiglianza Introduzione La Massima Verosimiglianza Esempio 1: una sola misura sperimentale
3.2. Individuazione dell area di interesse ai fini della modellistica diffusionale
 Capitolo 3 Caratterizzazione delle sorgenti pag. 53 3.2. Individuazione dell area di interesse ai fini della modellistica diffusionale 3.2.1. Metodologia di individuazione dell area Ai fini dell individuazione
Capitolo 3 Caratterizzazione delle sorgenti pag. 53 3.2. Individuazione dell area di interesse ai fini della modellistica diffusionale 3.2.1. Metodologia di individuazione dell area Ai fini dell individuazione
L A B C di R. Stefano Leonardi c Dipartimento di Scienze Ambientali Università di Parma Parma, 9 febbraio 2010
 L A B C di R 0 20 40 60 80 100 2 3 4 5 6 7 8 Stefano Leonardi c Dipartimento di Scienze Ambientali Università di Parma Parma, 9 febbraio 2010 La scelta del test statistico giusto La scelta della analisi
L A B C di R 0 20 40 60 80 100 2 3 4 5 6 7 8 Stefano Leonardi c Dipartimento di Scienze Ambientali Università di Parma Parma, 9 febbraio 2010 La scelta del test statistico giusto La scelta della analisi
CORSO DI TOPOGRAFIA A A.A
 CORSO DI TOPOGRAFIA A A.A. 2006-2007 APPUNTI LEZIONI GPS PARTE I Documento didattico ad uso interno - www.rilevamento.it 1 1. Principi base del GPS Il sistema di posizionamento globale NAVSTAR GPS (NAVigation
CORSO DI TOPOGRAFIA A A.A. 2006-2007 APPUNTI LEZIONI GPS PARTE I Documento didattico ad uso interno - www.rilevamento.it 1 1. Principi base del GPS Il sistema di posizionamento globale NAVSTAR GPS (NAVigation
RETI TOPOGRAFICHE. 1. Premessa
 RETI TOPOGRAFICHE 1. Premessa Una rete topografica è costituita da un insieme di punti, detti vertici della rete, connessi fra di loro da un insieme di misure di distanze e di angoli azimutali e zenitali;
RETI TOPOGRAFICHE 1. Premessa Una rete topografica è costituita da un insieme di punti, detti vertici della rete, connessi fra di loro da un insieme di misure di distanze e di angoli azimutali e zenitali;
TRACCIA DI STUDIO. Indici di dispersione assoluta per misure quantitative
 TRACCIA DI STUDIO Un indice di tendenza centrale non è sufficiente a descrivere completamente un fenomeno. Gli indici di dispersione assolvono il compito di rappresentare la capacità di un fenomeno a manifestarsi
TRACCIA DI STUDIO Un indice di tendenza centrale non è sufficiente a descrivere completamente un fenomeno. Gli indici di dispersione assolvono il compito di rappresentare la capacità di un fenomeno a manifestarsi
Il modello di regressione (VEDI CAP 12 VOLUME IEZZI, 2009)
 Il modello di regressione (VEDI CAP 12 VOLUME IEZZI, 2009) Quesito: Posso stimare il numero di ore passate a studiare statistica sul voto conseguito all esame? Potrei calcolare il coefficiente di correlazione.
Il modello di regressione (VEDI CAP 12 VOLUME IEZZI, 2009) Quesito: Posso stimare il numero di ore passate a studiare statistica sul voto conseguito all esame? Potrei calcolare il coefficiente di correlazione.
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
 Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni METODO PER IL RENDERING DEI DIAGRAMMI DI IRRADIAZIONE VERTICALI BASATO SUI DATI PREVISTI DALLE SPECIFICHE DI FORMATO DEL CATASTO AGCOM 1. Premessa Per calcolare
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni METODO PER IL RENDERING DEI DIAGRAMMI DI IRRADIAZIONE VERTICALI BASATO SUI DATI PREVISTI DALLE SPECIFICHE DI FORMATO DEL CATASTO AGCOM 1. Premessa Per calcolare
Regressione e Correlazione (cap. 11) Importazione dati da file di testo
 Regressione e Correlazione (cap. 11) Importazione dati da file di testo Introduzione Nella statistica applicata si osserva la relazione (dipendenza) tra due o più grandezze. Esigenza: determinare una funzione
Regressione e Correlazione (cap. 11) Importazione dati da file di testo Introduzione Nella statistica applicata si osserva la relazione (dipendenza) tra due o più grandezze. Esigenza: determinare una funzione
Distribuzione Gaussiana - Facciamo un riassunto -
 Distribuzione Gaussiana - Facciamo un riassunto - Nell ipotesi che i dati si distribuiscano seguendo una curva Gaussiana è possibile dare un carattere predittivo alla deviazione standard La prossima misura
Distribuzione Gaussiana - Facciamo un riassunto - Nell ipotesi che i dati si distribuiscano seguendo una curva Gaussiana è possibile dare un carattere predittivo alla deviazione standard La prossima misura
RENDITE. Ricerca del tasso di una rendita
 RENDITE Ricerca del tasso di una rendita Un problema che si presenta spesso nelle applicazioni è quello di calcolare il tasso di interesse associato a una rendita quando siano note le altre grandezze 1
RENDITE Ricerca del tasso di una rendita Un problema che si presenta spesso nelle applicazioni è quello di calcolare il tasso di interesse associato a una rendita quando siano note le altre grandezze 1
L integrazione di GPS con altri strumenti topografici
 Scuola Regionale Servizi GPS di posizionamento per il territorio o e il catasto 16 Febbraio 2006 L integrazione di GPS con altri strumenti topografici Ing.. Marco Scaioni Politecnico di Milano D.I.I.A.R.
Scuola Regionale Servizi GPS di posizionamento per il territorio o e il catasto 16 Febbraio 2006 L integrazione di GPS con altri strumenti topografici Ing.. Marco Scaioni Politecnico di Milano D.I.I.A.R.
Sistemi di riferimento
 Sistemi di riferimento Cos è un sistema di riferimento? Un sistema di riferimento (SR) è un insieme di regole e misure per la determinazione delle posizioni spazio temporale di un qualsiasi punto sulla
Sistemi di riferimento Cos è un sistema di riferimento? Un sistema di riferimento (SR) è un insieme di regole e misure per la determinazione delle posizioni spazio temporale di un qualsiasi punto sulla
Posizionamento e Navigazione: attività del Laboratorio di Topografia
 Posizionamento e Navigazione: attività del Laboratorio di Topografia Fabio Radicioni Università degli Studi di Perugia EPN 1997 L Università di Perugia ha installato la prima stazione permanente in Umbria
Posizionamento e Navigazione: attività del Laboratorio di Topografia Fabio Radicioni Università degli Studi di Perugia EPN 1997 L Università di Perugia ha installato la prima stazione permanente in Umbria
STATISTICA esercizi svolti su: INTERPOLAZIONE PONDERATA, REGRESSIONE E CORRELAZIONE
 STATISTICA esercizi svolti su: INTERPOLAZIONE PONDERATA, REGRESSIONE E CORRELAZIONE 1 1 INTERPOLAZIONE PONDERATA, REGRESSIONE E CORRELAZIONE 2 1 INTERPOLAZIONE PONDERATA, REGRESSIONE E CORRELAZIONE 1.1
STATISTICA esercizi svolti su: INTERPOLAZIONE PONDERATA, REGRESSIONE E CORRELAZIONE 1 1 INTERPOLAZIONE PONDERATA, REGRESSIONE E CORRELAZIONE 2 1 INTERPOLAZIONE PONDERATA, REGRESSIONE E CORRELAZIONE 1.1
La regressione lineare. Rappresentazione analitica delle distribuzioni
 La regressione lineare Rappresentazione analitica delle distribuzioni Richiamiamo il concetto di dipendenza tra le distribuzioni di due caratteri X e Y. Ricordiamo che abbiamo definito dipendenza perfetta
La regressione lineare Rappresentazione analitica delle distribuzioni Richiamiamo il concetto di dipendenza tra le distribuzioni di due caratteri X e Y. Ricordiamo che abbiamo definito dipendenza perfetta
INDICE PREMESSA... 2 IL SOFTWARE NFTP ISO SIMULAZIONI... 4 REPORTS DELLE SIMULAZIONI. La norma ISO
 INDICE PREMESSA... 2 IL SOFTWARE NFTP ISO 9613... 2 La norma ISO 9613-2...2 SIMULAZIONI... 4 REPORTS DELLE SIMULAZIONI PREMESSA Conoscendo i valori di emissione della sorgente si è proceduto ad una stima
INDICE PREMESSA... 2 IL SOFTWARE NFTP ISO 9613... 2 La norma ISO 9613-2...2 SIMULAZIONI... 4 REPORTS DELLE SIMULAZIONI PREMESSA Conoscendo i valori di emissione della sorgente si è proceduto ad una stima
Risoluzioni di alcuni esercizi
 Risoluzioni di alcuni esercizi Reti topografiche, trasformazioni di coordinate piane In una poligonale piana il punto è nell origine delle coordinate, l angolo (in verso orario fra il semiasse positivo
Risoluzioni di alcuni esercizi Reti topografiche, trasformazioni di coordinate piane In una poligonale piana il punto è nell origine delle coordinate, l angolo (in verso orario fra il semiasse positivo
CAPITOLO 5. Stima della frequenza dei segnali dovuta al 40 K
 CAPITOLO 5 Stima della frequenza dei segnali dovuta al 40 K 5.1 Simulazione dei segnali registrabili con i fotomoltiplicatori. Nei capitoli precedenti, dopo aver illustrato brevemente la motivazione per
CAPITOLO 5 Stima della frequenza dei segnali dovuta al 40 K 5.1 Simulazione dei segnali registrabili con i fotomoltiplicatori. Nei capitoli precedenti, dopo aver illustrato brevemente la motivazione per
CALCOLO DEI VOLUMI DI STERRO E RIPORTO
 CALCOLO DEI VOLUMI DI STERRO E RIPORTO http://www.geodis-ale.com/ita/ 1. Premessa Il programma software ALE Advanced Land Editor esegue il calcolo dei volumi di scavo e rinterro su un'area circoscritta
CALCOLO DEI VOLUMI DI STERRO E RIPORTO http://www.geodis-ale.com/ita/ 1. Premessa Il programma software ALE Advanced Land Editor esegue il calcolo dei volumi di scavo e rinterro su un'area circoscritta
Corso di Calcolo Numerico
 Prof. L. Brandolini Corso di Calcolo Numerico Dott.ssa N. Franchina Laboratorio 6 Equazioni differenziali ordinarie: metodi impliciti 3 Novembre 26 Esercizi di implementazione Un equazione differenziale
Prof. L. Brandolini Corso di Calcolo Numerico Dott.ssa N. Franchina Laboratorio 6 Equazioni differenziali ordinarie: metodi impliciti 3 Novembre 26 Esercizi di implementazione Un equazione differenziale
Appunti su Indipendenza Lineare di Vettori
 Appunti su Indipendenza Lineare di Vettori Claudia Fassino a.a. Queste dispense, relative a una parte del corso di Matematica Computazionale (Laurea in Informatica), rappresentano solo un aiuto per lo
Appunti su Indipendenza Lineare di Vettori Claudia Fassino a.a. Queste dispense, relative a una parte del corso di Matematica Computazionale (Laurea in Informatica), rappresentano solo un aiuto per lo
La correzione dell amplitudine per il lembo superiore del Sole
 La correzione dell amplitudine per il lembo superiore del Sole di Antonio Adduci docente di Scienze della navigazione presso l ITTL C. Colombo di Camogli anno 2016 Generalità Com è noto l osservazione
La correzione dell amplitudine per il lembo superiore del Sole di Antonio Adduci docente di Scienze della navigazione presso l ITTL C. Colombo di Camogli anno 2016 Generalità Com è noto l osservazione
L uso del GPS in montagna
 Tiziano Cosso 1, Roberto Marzocchi 1, Domenico Sguerso 1,2 1 Gter s.r.l. Innovazione in Geomatica, Gnss e Gis 2 Dicca - Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale Scuola Politecnica dell Università
Tiziano Cosso 1, Roberto Marzocchi 1, Domenico Sguerso 1,2 1 Gter s.r.l. Innovazione in Geomatica, Gnss e Gis 2 Dicca - Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale Scuola Politecnica dell Università
Ancora sulla distribuzione in longitudine dei flocculi di calcio
 Ancora sulla distribuzione in longitudine dei flocculi di calcio G. GODOLI - F. MAZZUCCONI - B. C. MONSIGNORI FOSSI Ricevuto il 17 Aprile 1967 RIASSUNTO. Viene estesa ai numeri caratteristici definitivi
Ancora sulla distribuzione in longitudine dei flocculi di calcio G. GODOLI - F. MAZZUCCONI - B. C. MONSIGNORI FOSSI Ricevuto il 17 Aprile 1967 RIASSUNTO. Viene estesa ai numeri caratteristici definitivi
ANALISI DELLE SERIE STORICHE
 ANALISI DELLE SERIE STORICHE De Iaco S. s.deiaco@economia.unile.it UNIVERSITÀ del SALENTO DIP.TO DI SCIENZE ECONOMICHE E MATEMATICO-STATISTICHE FACOLTÀ DI ECONOMIA 24 settembre 2012 Indice 1 Funzione di
ANALISI DELLE SERIE STORICHE De Iaco S. s.deiaco@economia.unile.it UNIVERSITÀ del SALENTO DIP.TO DI SCIENZE ECONOMICHE E MATEMATICO-STATISTICHE FACOLTÀ DI ECONOMIA 24 settembre 2012 Indice 1 Funzione di
Modelli e Metodi per il Supporto alle Decisioni II A.A. 2016/2017
 Modelli e Metodi per il Supporto alle Decisioni II A.A. 2016/2017 Macroprogetto MCDA: argomenti, obiettivi, risultati attesi Metodi di base individuare fenomeni di rank reversal (tra i problemi a 6 e a
Modelli e Metodi per il Supporto alle Decisioni II A.A. 2016/2017 Macroprogetto MCDA: argomenti, obiettivi, risultati attesi Metodi di base individuare fenomeni di rank reversal (tra i problemi a 6 e a
ISTITUTO SUPERIORE PIERO CALAMANDREI < GEOMETRI > LA STAZIONE PERMANENTE GNSS NELLA RETE DI POSIZIONAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE
 ISTITUTO SUPERIORE PIERO CALAMANDREI < GEOMETRI > LA STAZIONE PERMANENTE GNSS NELLA RETE DI POSIZIONAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE fig. 1: La MONOGRAFIA del sito al 16 giugno 2011 da http://gnss.regione.piemonte.it
ISTITUTO SUPERIORE PIERO CALAMANDREI < GEOMETRI > LA STAZIONE PERMANENTE GNSS NELLA RETE DI POSIZIONAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE fig. 1: La MONOGRAFIA del sito al 16 giugno 2011 da http://gnss.regione.piemonte.it
Tecnica GPS RTK Multi-Reference Station: Sperimentazione sulla rete test Campania GPS Network
 Tecnica GPS RTK Multi-Reference Station: Sperimentazione sulla rete test Campania GPS Network Giovanni PUGLIANO (*), M. Elizabeth CANNON (**), Gérard LACHAPELLE (**) (*) Università degli Studi di Napoli
Tecnica GPS RTK Multi-Reference Station: Sperimentazione sulla rete test Campania GPS Network Giovanni PUGLIANO (*), M. Elizabeth CANNON (**), Gérard LACHAPELLE (**) (*) Università degli Studi di Napoli
CALCOLO DEI VOLUMI DI STERRO E RIPORTO
 CALCOLO DEI VOLUMI DI STERRO E RIPORTO www.geodis.it Silvia Tutone 1. Premessa Il programma software Ale Advanced Land Editor esegue il calcolo dei volumi di scavo e rinterro su un'area circoscritta in
CALCOLO DEI VOLUMI DI STERRO E RIPORTO www.geodis.it Silvia Tutone 1. Premessa Il programma software Ale Advanced Land Editor esegue il calcolo dei volumi di scavo e rinterro su un'area circoscritta in
Cartografia IGM in formato digitale
 Cartografia IGM in formato digitale E formata da dati: - in formato vettoriale acquisiti da cartografia esistente mediante digitalizzazione; - in formato raster acquisiti da cartografia esistente mediante
Cartografia IGM in formato digitale E formata da dati: - in formato vettoriale acquisiti da cartografia esistente mediante digitalizzazione; - in formato raster acquisiti da cartografia esistente mediante
SISTEMI LINEARI. x y + 2t = 0 2x + y + z t = 0 x z t = 0 ; S 3 : ; S 5x 2y z = 1 4x 7y = 3
 SISTEMI LINEARI. Esercizi Esercizio. Verificare se (,, ) è soluzione del sistema x y + z = x + y z = 3. Trovare poi tutte le soluzioni del sistema. Esercizio. Scrivere un sistema lineare di 3 equazioni
SISTEMI LINEARI. Esercizi Esercizio. Verificare se (,, ) è soluzione del sistema x y + z = x + y z = 3. Trovare poi tutte le soluzioni del sistema. Esercizio. Scrivere un sistema lineare di 3 equazioni
Sperimentazioni di Fisica I mod. A Statistica - Lezione 2
 Sperimentazioni di Fisica I mod. A Statistica - Lezione 2 A. Garfagnini M. Mazzocco C. Sada Dipartimento di Fisica G. Galilei, Università di Padova AA 2014/2015 Elementi di Statistica Lezione 2: 1. Istogrammi
Sperimentazioni di Fisica I mod. A Statistica - Lezione 2 A. Garfagnini M. Mazzocco C. Sada Dipartimento di Fisica G. Galilei, Università di Padova AA 2014/2015 Elementi di Statistica Lezione 2: 1. Istogrammi
C I R C O N F E R E N Z A...
 C I R C O N F E R E N Z A... ESERCITAZIONI SVOLTE 3 Equazione della circonferenza di noto centro C e raggio r... 3 Equazione della circonferenza di centro C passante per un punto A... 3 Equazione della
C I R C O N F E R E N Z A... ESERCITAZIONI SVOLTE 3 Equazione della circonferenza di noto centro C e raggio r... 3 Equazione della circonferenza di centro C passante per un punto A... 3 Equazione della
Funzioni elementari: funzioni potenza
 Funzioni elementari: funzioni potenza Lezione per Studenti di Agraria Università di Bologna (Università di Bologna) Funzioni elementari: funzioni potenza 1 / 36 Funzioni lineari Come abbiamo già visto,
Funzioni elementari: funzioni potenza Lezione per Studenti di Agraria Università di Bologna (Università di Bologna) Funzioni elementari: funzioni potenza 1 / 36 Funzioni lineari Come abbiamo già visto,
Statistica multivariata Donata Rodi 17/10/2016
 Statistica multivariata Donata Rodi 17/10/2016 Quale analisi? Variabile Dipendente Categoriale Continua Variabile Indipendente Categoriale Chi Quadro ANOVA Continua Regressione Logistica Regressione Lineare
Statistica multivariata Donata Rodi 17/10/2016 Quale analisi? Variabile Dipendente Categoriale Continua Variabile Indipendente Categoriale Chi Quadro ANOVA Continua Regressione Logistica Regressione Lineare
Modelli Digitali del Terreno (DTM)
 Modelli Digitali del Terreno (DTM) Rappresentazione digitale del terreno, adatta all elaborazione automatica con il calcolatore Descrizione numerica dell andamento altimetrico del terreno Insieme di coordinate
Modelli Digitali del Terreno (DTM) Rappresentazione digitale del terreno, adatta all elaborazione automatica con il calcolatore Descrizione numerica dell andamento altimetrico del terreno Insieme di coordinate
GENETICA QUANTITATIVA
 GENETICA QUANTITATIVA Caratteri quantitativi e qualitativi I caratteri discontinui o qualitativi esibiscono un numero ridotto di fenotipi e mostrano una relazione genotipo-fenotipo semplice I caratteri
GENETICA QUANTITATIVA Caratteri quantitativi e qualitativi I caratteri discontinui o qualitativi esibiscono un numero ridotto di fenotipi e mostrano una relazione genotipo-fenotipo semplice I caratteri
CALCOLO DEL VALORE GENETICO DI UN RIPRODUTTORE
 CALCOLO DEL VALORE GENETICO DI UN RIPRODUTTORE Lo strumento adatto per misurare la qualità genetica di un individuo è il valore genetico (o riproduttivo), che fornisce informazioni sulla bontà di un determinato
CALCOLO DEL VALORE GENETICO DI UN RIPRODUTTORE Lo strumento adatto per misurare la qualità genetica di un individuo è il valore genetico (o riproduttivo), che fornisce informazioni sulla bontà di un determinato
Reti Geodetiche e Stazioni Permanenti GPS - GNSS
 Reti Geodetiche e Stazioni Permanenti GPS - GNSS Ludovico Biagi, Fernando Sansò Politecnico di Milano, DIIAR c/o Polo Regionale di Como ludovico.biagi@polimi.it fernando.sanso@polimi.it Perugia, 13 Dicembre
Reti Geodetiche e Stazioni Permanenti GPS - GNSS Ludovico Biagi, Fernando Sansò Politecnico di Milano, DIIAR c/o Polo Regionale di Como ludovico.biagi@polimi.it fernando.sanso@polimi.it Perugia, 13 Dicembre
ECONOMIA APPLICATA ALL INGEGNERIA (Docente: Prof. Ing. Donato Morea) Microeconomia Esercitazione n. 1 - I FONDAMENTI DI DOMANDA E DI OFFERTA
 ESERCIZIO n. 1 - Equilibrio di mercato e spostamenti delle curve di domanda e di offerta La quantità domandata di un certo bene è descritta dalla seguente funzione: p (D) mentre la quantità offerta è descritta
ESERCIZIO n. 1 - Equilibrio di mercato e spostamenti delle curve di domanda e di offerta La quantità domandata di un certo bene è descritta dalla seguente funzione: p (D) mentre la quantità offerta è descritta
GPS e sistemi di riferimento
 GPS e sistemi di riferimento Sistemi di riferimento e reti geodetiche Il posizionamento satellitare ha reso necessario l istituzione di sistemi di riferimento mondiali, la cui definizione è stata possibile
GPS e sistemi di riferimento Sistemi di riferimento e reti geodetiche Il posizionamento satellitare ha reso necessario l istituzione di sistemi di riferimento mondiali, la cui definizione è stata possibile
Distribuzione Normale
 Distribuzione Normale istogramma delle frequenze di un insieme di misure di una grandezza che può variare con continuità popolazione molto numerosa, costituita da una quantità praticamente illimitata di
Distribuzione Normale istogramma delle frequenze di un insieme di misure di una grandezza che può variare con continuità popolazione molto numerosa, costituita da una quantità praticamente illimitata di
CONTROLLI SUGLI ELETTRODOTTI DI ALTA TENSIONE TRANSITANTI SUL TERRITORIO DELLA VALLE D AOSTA
 CONTROLLI SUGLI ELETTRODOTTI DI ALTA TENSIONE TRANSITANTI SUL TERRITORIO DELLA VALLE D AOSTA Valeria Bottura, C. Desandré, E. Imperial, Leo Cerise ARPA Valle d Aosta, Loc. Grande Charrière 44, 11020 St.
CONTROLLI SUGLI ELETTRODOTTI DI ALTA TENSIONE TRANSITANTI SUL TERRITORIO DELLA VALLE D AOSTA Valeria Bottura, C. Desandré, E. Imperial, Leo Cerise ARPA Valle d Aosta, Loc. Grande Charrière 44, 11020 St.
Il metodo dei minimi quadrati. Molto spesso due grandezze fisiche x e y, misurabili direttamente, sono legate tra loro da una legge del tipo:
 Il metodo dei minimi quadrati Molto spesso due grandezze fisiche x e y, misurabili direttamente, sono legate tra loro da una legge del tipo: Dove A e B sono costanti y = A + Bx (ad esempio in un moto uniformemente
Il metodo dei minimi quadrati Molto spesso due grandezze fisiche x e y, misurabili direttamente, sono legate tra loro da una legge del tipo: Dove A e B sono costanti y = A + Bx (ad esempio in un moto uniformemente
AERONAUTICA MILITARE CENTRO OPERATIVO PER LA METEOROLOGIA EFFEMERIDI AERONAUTICHE
 AERONAUTICA MILITARE CENTRO OPERATIVO PER LA METEOROLOGIA EFFEMERIDI AERONAUTICHE 2 0 1 6 AERONAUTICA MILITARE CENTRO OPERATIVO PER LA METEOROLOGIA EFFEMERIDI AERONAUTICHE 2 0 1 6 INDICE Pag. Descrizione
AERONAUTICA MILITARE CENTRO OPERATIVO PER LA METEOROLOGIA EFFEMERIDI AERONAUTICHE 2 0 1 6 AERONAUTICA MILITARE CENTRO OPERATIVO PER LA METEOROLOGIA EFFEMERIDI AERONAUTICHE 2 0 1 6 INDICE Pag. Descrizione
N. 120 Rapporti OM 07/1. Franco Stravisi Nicolò Purga. Stazione mareografica di Trieste - Porto Lido DATI 2006
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA O M OCEANOGRAFIA e METEOROLOGIA N. 12 Rapporti OM 7/1 Franco Stravisi Nicolò Purga Stazione mareografica di Trieste - Porto Lido DATI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA O M OCEANOGRAFIA e METEOROLOGIA N. 12 Rapporti OM 7/1 Franco Stravisi Nicolò Purga Stazione mareografica di Trieste - Porto Lido DATI
Elementi di Epidemiologia per la Valutazione Comparativa di Esito
 Elementi di Epidemiologia per la Valutazione Comparativa di Esito La valutazione della qualità dell assistenza: quali domande? L incidenza di alcuni esiti negativi dell assistenza ospedaliera (come la
Elementi di Epidemiologia per la Valutazione Comparativa di Esito La valutazione della qualità dell assistenza: quali domande? L incidenza di alcuni esiti negativi dell assistenza ospedaliera (come la
Esercizi su algebra lineare, fattorizzazione LU e risoluzione di sistemi lineari
 Esercizi su algebra lineare, fattorizzazione LU e risoluzione di sistemi lineari 4 maggio Nota: gli esercizi più impegnativi sono contrassegnati dal simbolo ( ) Esercizio Siano 3 6 8 6 4 3 3 ) determinare
Esercizi su algebra lineare, fattorizzazione LU e risoluzione di sistemi lineari 4 maggio Nota: gli esercizi più impegnativi sono contrassegnati dal simbolo ( ) Esercizio Siano 3 6 8 6 4 3 3 ) determinare
REGRESSIONE E CORRELAZIONE
 REGRESSIONE E CORRELAZIONE Nella Statistica, per studio della connessione si intende la ricerca di eventuali relazioni, di dipendenza ed interdipendenza, intercorrenti tra due variabili statistiche 1.
REGRESSIONE E CORRELAZIONE Nella Statistica, per studio della connessione si intende la ricerca di eventuali relazioni, di dipendenza ed interdipendenza, intercorrenti tra due variabili statistiche 1.
i dati escludono vi sia una relazione tra variabile indipendente e variabile dipendente (rispettivamente
 TEST DI AUTOVALUTAZIONE - SETTIMANA 6 I diritti d autore sono riservati. Ogni sfruttamento commerciale non autorizzato sarà perseguito. Metodi statistici per la biologia Parte A. La retta di regressione.2
TEST DI AUTOVALUTAZIONE - SETTIMANA 6 I diritti d autore sono riservati. Ogni sfruttamento commerciale non autorizzato sarà perseguito. Metodi statistici per la biologia Parte A. La retta di regressione.2
Integrazione Numerica. Teoria ed Esempi
 Integrazione Numerica Teoria ed Esempi Sommario Analisi del problema Teoria dell integrazione numerica Metodo dei rettangoli Metodo dei trapezi Metodo delle parabole Esempi di calcolo Funzione integrabile
Integrazione Numerica Teoria ed Esempi Sommario Analisi del problema Teoria dell integrazione numerica Metodo dei rettangoli Metodo dei trapezi Metodo delle parabole Esempi di calcolo Funzione integrabile
TEORIA DEI SISTEMI E DEL CONTROLLO LM in Ingegneria Informatica e Ingegneria Elettronica
 TEORIA DEI SISTEMI E DEL CONTROLLO LM in Ingegneria Informatica e Ingegneria Elettronica http://www.dii.unimore.it/~lbiagiotti/teoriasistemicontrollo.html Stima dello stato in presenza di disturbi: il
TEORIA DEI SISTEMI E DEL CONTROLLO LM in Ingegneria Informatica e Ingegneria Elettronica http://www.dii.unimore.it/~lbiagiotti/teoriasistemicontrollo.html Stima dello stato in presenza di disturbi: il
Il teorema di Rouché-Capelli
 Luciano Battaia Questi appunti (1), ad uso degli studenti del corso di Matematica (A-La) del corso di laurea in Commercio Estero dell Università Ca Foscari di Venezia, campus di Treviso, contengono un
Luciano Battaia Questi appunti (1), ad uso degli studenti del corso di Matematica (A-La) del corso di laurea in Commercio Estero dell Università Ca Foscari di Venezia, campus di Treviso, contengono un
