4 MODELLI E PRATICHE DI VALUTAZIONE: DALLA VALUTAZIONE AL MONITORAGGIO
|
|
|
- Brigida Belloni
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 4 MODELLI E PRATICHE DI VALUTAZIONE: DALLA VALUTAZIONE AL MONITORAGGIO (mod. 4 on line) I CONCETTI FONDAMENTALI DEL 3 MODULO: Le prove di verifica possono essere classificate: o Stimolo aperto - risposta aperta o Stimolo chiuso - risposta aperta o Stimolo aperto - risposta chiusa o Stimolo chiuso - risposta chiusa I criteri di riferimento con cui vengono confrontati i risultati possono essere: assoluto, relativo e a progresso individuale. Le prove strutturate sono costituite da una serie di stimoli (domande) chiusi ciascuno dei quali è corredato da due o più risposte chiuse; le risposte "errate", note con il termine di distrattori, hanno la funzione di disturbo. Validità degli item. Il problema dell oggettività. La tipologia dei quesiti varia col variare delle modalità con cui vengono strutturate sia le domande sia le risposte. I più importanti tipi di items sono vero-falso, completamento, corrispondenza, scelta multipla ad una o più soluzioni. Funzione cognitiva delle prove. Numero ideale di item. Item discriminanti e non. Azioni per progettare una prova di verifica. Azioni per l organizzazione degli item in un test. Finalità e strutture dei diversi quesiti. Vantaggi delle prove oggettive Limiti delle prove oggettive Validità delle rilevazioni Attendibilità delle misurazioni Gli studenti rispondono bene fornendo risposte a caso Gli studenti copiano le risposte Dopo aver analizzato nel modulo 2 le prime attività valutative (l accertamento, il controllo e la verifica) ed aver approfondito nel modulo 3 la costruzione delle prove strutturate di conoscenza, proseguiamo, ora, il discorso con le altre attività: la valutazione (vera e propria), la metavalutazione e il monitoraggio. 4.1 LA VALUTAZIONE E IL PROBLEMA DEL VALORE FORMATIVO Come abbiamo precedentemente indicato, intendiamo ribadire il senso profondo della valutazione: valutare significa attribuire valore a qualche cosa o riconoscere il valore di qualche cosa. Attribuire o riconoscere? Una differenza non di poco conto tra il primo significato (in cui tutto il valore sta nell'occhio e nella mente del valutatore) e il secondo (in cui tutto il valore sta in ciò che viene valutato), considerato che essi si rifanno a due concezioni filosofiche che per millenni si sono altalenate nel proporre soluzioni ad un problema nel contempo gnoseologico ed etico. Per ciò che ci riguarda, è difficile immaginare la valutazione di qualche cosa senza un riferimento valoriale su ciò che quel qualche cosa
2 rappresenta "in sé" per il valutatore. Il problema non risiede nella scelta tra l oggettivazione di una scala di valori e la sua frammentazione nelle individualità delle persone, quanto piuttosto nella piena consapevolezza del multiverso valoriale che, nella sua duttilità e nella sua mutevolezza, impregna di relatività ogni atto valutativo. Come il concetto di "vero" nella verifica, così anche il concetto di "valore" nella valutazione comporta connotazioni estremamente diversificate che vanno dai costi dell investimento formativo (valore economico) al merito sulle competenze per ciascuna componente del sistema (giudizio di valore), dalla spendibilità di tali competenze (valore professionale) alla loro certificazione (valore documentale). Ma il nostro interesse si restringe a quella valutazione che primariamente restituisce il valore formativo dei processi attivati, ossia quella che mira a interpretare e comprendere il senso e il significato delle trasformazioni progettate e accadute. I risultati e le indicazioni provenienti dall accertamento, dal controllo e dalla verifica rappresentano la base concreta, i dati di fatto, analitici e prevalentemente quantitativi, non ancora interpretati in chiave formativa. Due insegnanti possono dare due significati diversi ai medesimi risultati o alle medesime osservazioni. La valutazione non è un semplice aggregato di accertamenti e di verifiche, non è la somma delle misure emerse (che conduce alle note classifiche di merito) e neppure la loro media (che conduce alle tradizionali votazioni, con numeri, con lettere o con aggettivi). Con la verifica si punta a separare il vero dal falso, ciò che conferma da ciò che smentisce le ipotesi formulate. Con la valutazione si cambia il registro di letturainterpretazione e si allarga il contesto di riferimento: il nuovo registro non è designato dalla confermabilità o dalla falsificabilità delle ipotesi progettuali, ma dalla loro efficacia nell innestare significativi processi di trasformazione. La valutazione deve cercare risposte a domande di questo tipo: Che senso hanno questi risultati per la maturazione dell allievo? È stato efficace il progetto messo in atto? Quale è la qualità degli apprendimenti? Perché ci sono state queste difficoltà? Quando si valuta non ci si limita all analisi dei risultati, ma si punta a comprendere tutto il sistema dei processi individuali (intellettuali, affettivi, comportamentali) e collettivi (sociali, relazionali, comunicativi) che qualificano e rendono unica ogni esperienza formativa. Attribuire valore a qualcosa non può che condurre ad un prodotto soggettivo, personale. La soggettività della valutazione sta a significare che: - le interpretazioni non possono che essere personali sulla base dei giudizi pregressi, dei vissuti e delle esperienze individuali (H.G. Gadamer), - la riflessione valutativa deve essere promossa non solo da parte dell insegnante ma anche dallo studente, e deve condurre alla consapevolezza della sua relatività, - ciascuno valuta i processi ai quali partecipa e quindi non esistono separazioni nette tra auto ed eterovalutazione, - non si valutano le persone ma i processi, le azioni, i comportamenti e gli atteggiamenti delle persone Per equilibrare la soggettività valutativa Soggettività non vuol dire individualismo o anarchia valutativa del docente. La soggettività non deve costituire un alibi alla mancata ricerca del massimo grado possibile di obiettività. L individualismo si supera con la consapevolezza dei vincoli e dei limiti personali, professionali e culturali, ma anche con il
3 riconoscimento dei preconcetti e delle stereotipie presenti in ciascuno. In pratica l unica strada percorribile sta: - nella trasparenza e nella comunicazione delle valutazioni, - nella condivisione dei criteri per la valutazione (Lakatos), - nella triangolazione dei punti di vista e delle metodologie (Huberman, Stake). Trasparenza, condivisione e triangolazione sono regole che chiamano direttamente in causa la collegialità dei docenti; i consigli di classe, i gruppi di insegnanti per discipline o aree (dipartimenti), le commissioni di studio o di progetto: siano essi équipe, team o staff, tutti hanno il compito di progettare e di valutare in gruppo, nell applicazione e nel rispetto dei principi indicati. Poiché abbiamo già preso in considerazione il principio della triangolazione dei punti di vista, analizziamo gli altri due. Il principio della trasparenza sostiene che se il valutatore è consapevole che il risultato della sua valutazione sarà comunicato, allora procederà in modo da farsi comprendere dal lettore o dall ascoltatore; e in tal modo ridurrà il grado di soggettività autoreferenziale. Questo principio risulta ancora più determinante quando la comunicazione non è rivolta ad un solo utente o ad una sola tipologia, ma riguarda molteplici lettori-ascoltatori: basti pensare alla pagella (indirizzata sì agli allievi, ma anche alle famiglie, e in un ottica collegialità formativa anche ai colleghi del consiglio di classe) o al rapporto finale di un azione di autoanalisi scolastica. Il principio della condivisione dei criteri asserisce che la valutazione sarà tanto più oggettiva quanto più precisi e condivisi saranno i criteri fissati in sede di progettazione. Tutto ciò chiama in causa le azioni collegiali dei consigli di classe: una progettazione condivisa all inizio dell anno scolastico non sarà sterile esercizio tassonomico se il gruppo dei docenti fonderà il lavoro basandosi su una semplice domanda: che cosa valuteremo in itinere e alla fine del percorso?. La valutazione è un processo di sintesi nella complessità: punta a comprendere la varietà e la diversità qualitativa dei processi formativi interpretandoli alla luce dei valori e dei significati individualmente e collettivamente attribuiti. Interpretare i valori significa riconoscere la profondità delle esperienze, delle competenze e delle potenzialità di ciascuno; significa personalizzare i percorsi formativi nell ambito del progetto disegnato; significa rintracciare la coerenza globale delle finalità perseguite dal sistema e dai singoli operatori; significa governare in modo flessibile competenze e talenti. In sintesi, la valutazione si configura come un'azione interpretativa che dà senso ai processi formativi vissuti e riconduce a sintesi sistemica le qualità, i valori e le significatività personali (esperienze, atteggiamenti, motivazioni, bisogni, ecc.) da essi veicolati. 4.2 LA METAVALUTAZIONE E IL PROBLEMA DELLA DISTANZA VALUTATIVA In campo sperimentale, una ricerca non si conclude con la raccolta delle informazioni (accertamento), né con il controllo della correttezza procedurale, né con la conferma delle ipotesi (verifica) e neppure con l interpretazione dei risultati e dei processi (valutazione), si conclude invece con la validazione. Nei laboratori la validazione si effettua con l esperimento cruciale, nella ricerca applicata si effettua con la riflessione critica sui percorsi e sugli strumenti attivati. Anche la valutazione scolastica si dovrebbe concludere con la medesima riflessione critica: in altre parole sarà la valutazione stessa a farsi valutare.
4 Così come la metacognizione è consapevolezza dei saperi, apice riflessivo e garanzia dell apprendimento significativo, la metavalutazione è consapevolezza del valutare, apice e garanzia della pertinenza e della coerenza delle attività di valutazione. In pratica, ci si chiederà: i criteri di valutazione rispondono coerentemente agli scopi formativi concordati nel progetto? le procedure di verifica tengono conto delle differenze individuali nelle esperienze, negli stili, nelle competenze, nelle reazioni al cambiamento, ecc.? le operazioni e gli strumenti per l accertamento sono tarati e calibrati alle caratteristiche specifiche degli allievi? le metodologie utilizzate per valutare sono le stesse adottate per formare? le competenze e i contenuti sottoposti a valutazione sono coerenti con quelli effettivamente processati nell intervento? Perché valutare la valutazione? È necessario? Non si rischia, così facendo, di enfatizzare la portata delle attività valutative a discapito di quelle più costruttive della formazione? La valutazione non è separata dalla formazione e non rappresenta neppure il suo ultimo atto: formare e valutare sono attività che convenzionalmente separiamo per ragioni di opportunità di studio e di progettazione, ma nella realtà si presentano coesistenti e integrate. Il processo valutativo rientra a tutti gli effetti tra i processi formativi e intrecciandosi con gli altri concorre a determinare l unitarietà dell esperienza formativa. Cercando di individuare quali sono le attività che compongono la metavalutazione abbiamo ritrovato in essa una varietà di funzioni raggruppabili nelle seguenti quattro tipologie: supervisione tecnica, equilibrazione metodologica, coordinamento integrativo, regolazione sistemica. a) Supervisione tecnica. Con i compiti di supervisione la metavalutazione indaga: - rispetto all accertamento: la correttezza nel rilevamento dei dati, la validità, l attendibilità e l efficienza degli strumenti adottati (mediante le usuali tecniche utilizzate nelle indagini statistiche); - rispetto al controllo: l adeguatezza degli standard procedurali, la distribuzione dei tempi e delle fasi di controllo (mediante analisi di pianificazione); - rispetto alla verifica: la pertinenza degli strumenti alle ipotesi progettuali, la coerenza delle procedure di verifica con le proprietà dei processi formativi effettuati (con l uso delle metodologie della pedagogia sperimentale); - rispetto alla valutazione: la significatività delle indagini qualitative, la rispondenza alla comprensione dei processi e l utilità delle informazioni prodotte (con l analisi delle convergenze-divergenze e con lo sviluppo di triangolazioni valutative). b) Equilibrazione metodologica. Considerata l insufficienza di una metavalutazione che utilizza gli stessi strumenti adottati nelle specifiche attività valutative (rispettivamente statistici, sperimentali e descrittivi) si rendono necessarie attività che metodologicamente possano riequilibrare le valenze eccessivamente quantitative o per contro eccessivamente qualitative. Il compito della metavalutazione in questo caso è quello di porre interrogativi "qualitativi" e di iniettare metodologie descrittive là dove dominano i numeri e viceversa di porre interrogativi "quantitativi" e di iniettare il rigore sperimentale là dove dominano le descrizioni e le narrazioni. c) Coordinamento integrativo. I compiti della metavalutazione indicati nei punti precedenti si consumano all interno delle singole attività valutative, questi invece intendono fungere da raccordo interno al sistema. La regia metavalutativa consiste essenzialmente nel far sì che tutte le attività valutative siano orientate verso un unico scopo, che nei travasi di input-output tra
5 accertamento, controllo, verifica e valutazione si adottino i medesimi protocolli comunicativi, che tali attività forniscano puntualmente le informazioni richieste onde garantire un coordinamento progettuale coerente. d) Regolazione sistemica tra il sistema formativo e il contesto esterno ad esso. Tutte le attività valutative rispondono a criteri di coerenza logica interna e fondamentalmente si "misurano" in termini di significatività rispetto ai processi attivati entro il sistema formativo (significatività qualitativa per la valutazione, progettuale per la verifica, procedurale per il controllo, statistica per l accertamento). La metavalutazione, invece, risponde a criteri di coerenza esterna, in quanto comporta un disegno di consenso e di concertazione tra i diversi attori che concorrono allo sviluppo complessivo. Per esempio: se dall analisi dell efficacia della formazione ricevuta (effettuata alla conclusione gli studi secondari) emergessero dati contraddittori rispetto ai risultati nell'esame finale, nessuna delle attività valutative "interne" potrebbe essere in grado di spiegare-comprendere le cause di tale discrasia. La metavalutazione si propone quindi come elemento di feedback regolatore tra il sistema formativo e quel contesto allargato che aveva esplicitato la domanda di formazione. Operativamente, in questo caso la procedura migliore sembra essere quella di ripercorrere, in modo sistematico, tutte le tappe della valutazione, della progettazione e della gestione formativa. Per esempio, ci si chiederà: - i criteri di valutazione rispondono coerentemente agli scopi formativi concordati nel programma? - le procedure di verifica tengono conto delle differenze individuali nelle esperienze, negli stili, nelle competenze, nelle reazioni al cambiamento, ecc.? - le operazioni e gli strumenti per l accertamento sono tarati e calibrati alle caratteristiche specifiche delle diverse componenti indagate? - le metodologie utilizzate per valutare sono le stesse adottate per formare? - le competenze e i contenuti sottoposti a valutazione sono coerenti con quelli effettivamente "processati" nell intervento? Gli errori di chi valuta Nella consuetudine della pratica valutativa la maggior parte delle attività si concentra nell individuazione, nella spiegazione e nel comprensione dell errore. La riflessione critica della metavalutazione capovolge la prospettiva: al posto della valutazione dell errore si prendono in considerazione gli errori di valutazione, ossia tutti quei fattori soggettivi e personali che a diverso titolo possono inficiare la correttezza valutativa. Ecco, in sequenza, gli errori in cui può incorrere colui che valuta. L errore sistematico consiste nella tendenza spontanea a sopravvalutare o a sottovalutare coloro che si devono giudicare. L errore sistematico può, quindi, manifestarsi in due modi antitetici: nell effetto di indulgenza o, all inverso, nell effetto di severità. L effetto di indulgenza riguarda prevalentemente coloro che tendono a sopravvalutare sistematicamente le prestazioni da valutare, ossia coloro che manifestano marcati bisogni di popolarità e di accettazione, e che, nel contempo, presentano difficoltà ad affrontare i doveri sociali (D. Izzo, 1976, p. 50). L effetto di severità, invece, riguarda coloro che sistematicamente sottovalutano l operato da valutare, ossia coloro che
6 manifestano comportamenti reattivi improntati alla rigidità e all eccessivo rigore. L errore di contrasto si può osservare nella tendenza a valutare gli altri in modo diametralmente opposto al proprio modo di essere: il timido é portato a giudicare gli altri più sicuri di quanto essi realmente siano, il depresso più euforici e vivaci, l introverso più socievoli e così via. L effetto di alone, secondo la classica definizione di Thorndike, si configura come l espansione indebita di giudizio: essa si verifica quando un aspetto noto e conosciuto condiziona la valutazione nei confronti di altri aspetti non dipendenti da esso. Per esempio, un linguaggio forbito usato dallo studente può influenzare la valutazione circa la preparazione, lo studio o la reale competenza; così come un compito scritto, preciso e ordinato, può condizionare la valutazione nelle successive interrogazioni orali. L errore logico, descritto da Newcomb e così definito da Guilford, può essere considerato come una particolare forma dell effetto di alone e consiste nello stabilire arbitrari legami logici tra eventi indipendenti o autonomi. Tra gli esempi di errori logici ritroviamo note espressioni come: "non ha saputo rispondere perché non si è impegnato nello studio"; se non ce la fa in latino, non ce la fa neppure in matematica"; "non leggono perché c'è la televisione", e così via. L errore di aspettativa si ha dinanzi da un pregiudizio sulle capacità di colui che si deve valutare e ci si attende che le sue prestazioni vi corrispondano. In tal modo si selezionano le prestazioni estrapolando quelle che si adattano al giudizio precostituito. Rosenthal e Jacobson hanno, a questo proposito, dimostrato come l aspettativa, indipendentemente dalla sua origine, può funzionare come preveggenza che si autorealizza (effetto Pigmalione). L errore di aspettativa nel colloquio o nell interrogazione orale, può tradursi in pregiudizio contagioso (Ancona) il quale non solo comporta interpretazioni soggettive delle risposte, ma addirittura spinge a scegliere e a formulare le domande così da ottenere le risposte desiderate. L errore di tendenza centrale, derivata dal linguaggio statistico, indica il raggrupparsi verso il centro di determinati valori, punteggi o giudizi. Chi valuta tende frequentemente ad utilizzare i valori mediani evitando compromissioni rischiose dando giudizi estremi, molto bassi o molto alti. Nel sistema di valutazione in decimali é netta la tendenza a raggruppare i voti tra il quattro e il sette; nelle check list o nelle scale di valutazione, in cui viene richiesto un giudizio scelto all interno di una scala di valori superiori a tre, siano essi quantitativi (da 1 a 5 oppure da 1 a 7, ecc.) o descrittivi (da nullo a ottimo oppure da sempre a mai, ecc.) si può facilmente riconoscere come la maggior parte delle scelte cada nei valori centrali.
7 In sintesi, la meta-valutazione si configura come un insieme di attività criticamente riflesso su tutti i processi valutativi intrapresi e il suo scopo è quello di convalidarli contestualmente ai progetti, ai prodotti e ai processi formativi. 4.3 IL MONITORAGGIO E IL PROBLEMA DELLE SOGLIE CRITICHE Negli anni più recenti, una nuova modalità valutativa si è prepotentemente insediata nelle attività e nei progetti scolastici; tale modalità comporta un impianto valutativo basato su serie storiche di dati, noto come monitoraggio dei percorsi formativi. La storicità della valutazione è quella che meglio precisa il senso del monitoraggio. Ma, che cosa è il monitoraggio? Che cosa avvicina il monitoraggio alla valutazione e in che cosa si differenzia da essa. È possibile monitorare gli apprendimenti? Quali sono i limiti del monitoraggio? Possiamo definire il monitoraggio come un insieme organizzato di attività di reperimento informativo mediante l osservazione sistematica dello sviluppo di un fenomeno complesso (= processo) entro un determinato sistema. Il monitoraggio è un operazione valutativa intenzionale e finalizzata che comporta la visualizzazione (monitor) dell andamento delle regolarità e delle turbolenze di un processo nel tempo. Il monitoraggio non cerca di semplificare la realtà, ma di comprenderla: dovrà essere quindi, nel contempo, flessibile e rigoroso. Lo scopo del monitoraggio è di analizzare le condizioni di sviluppo dei processi formativi in chiave sistemica e dinamica, per garantirne la governabilità e l ottimizzazione verso il risultato. Come tutte le attività valutative, anche il monitoraggio restituisce il risultato a seguito di un confronto; in questo caso il confronto si effettua tra un dato osservato e un indicatore determinato. Ma il monitoraggio si differenzia da tutte le altre attività valutative perché il confronto non avviene ex post (dopo aver osservato, rilevato, registrato, ecc.) ma avviene ex ante, quando si definiscono a priori le soglie di accettabilità dell indicatore considerato. Ed è questo il punto più delicato del monitoraggio: chi definisce gli indicatori migliori o quelli più opportuni per rappresentare l intero sistema? E, dopo aver individuato gli indicatori, chi determina le soglie critiche, ossia quelle che definiscono lo stato di crisi del sistema? 1 La definizione degli indicatori e delle relative soglie dovrà essere il risultato di opportune azioni sperimentali in fase d avvio, e da periodiche revisioni riguardo la loro pertinenza in fase di sviluppo. Dal punto di vista operativo, il monitoraggio si effettua con la rilevazione di dati e informazioni, con la descrizione di caratteristiche e di proprietà, con la narrazione di eventi e di vissuti, nell integrazione di tecniche quantitative e qualitative. Ciò che va rilevato, descritto e narrato (ossia gli indicatori) non è l intero (sia esso sistema, progetto, processo o prodotto) ma le parti, ovvero gli elementi, le relazioni, i tratti, le caratteristiche, le componenti, le proprietà, le situazioni, ecc., purché: 1 Supponiamo che i professori di una scuola intendano monitorare i voti assegnati in una determinata classe nei tre precedenti anni di corso. L'indicatore (trend del profitto) può essere analizzato in termini statistici avendone o meno definito a priori le soglie di accettabilità e di criticità. La soglia di accettabilità potrebbe essere così definita: comparando due anni, per ciascun allievo, la media dei risultati del secondo anno deve essere superiore di almeno mezzo punto rispetto alla media dei risultati dell anno precedente. La soglia di criticità potrebbe essere così definita: tra un anno e l altro non si riscontrano differenze migliorative (detto altrimenti: gli studenti, man mano che frequentano la scuola, peggiorano il loro profitto). Ebbene, se tali soglie non vengono definite a priori ciascuno è autorizzato a valutare i risultati dell'analisi statistica a proprio modo; se invece le soglie sono state precedentemente definite, appena i dati sono conosciuti, l'interpretazione si presenterà omogenea e coerente.
8 a) rappresentino significativamente i focus cruciali dello sviluppo del processo e b) siano suscettibili di cambiamento, di rottura, di evoluzione o di presenza/assenza. Il monitoraggio effettuato in ambito scolastico risponde a diverse funzioni; esso serve: per conoscere in qualsiasi momento lo stato del sistema nella sua complessità e nei singoli elementi, nella proiezione e nello sviluppo degli indicatori (diagnosi); per prefigurare lo sviluppo del sistema lasciando inalterato il progetto oppure modificandolo (prognosi e analisi della qualità degli interventi); per documentare e rendicontare (accountability) sia storicamente, sia in senso sincronico che diacronico, le discrepanze tra le situazioni particolari e la generalità dei processi; per prendere decisioni (strategiche, metodologiche e operative) inerenti l incremento, l orientamento e la modifica del progetto formativo o di sue fasi particolari; per promuovere trasparenza e partecipazione degli attori ai risultati in itinere e finali del processo, riducendo la discrepanza tra lo stato reale e quello desiderato. A differenza dello studio dei fenomeni fisici, il monitoraggio degli interventi formativi (come, per altro, di qualsiasi processo sociale) si caratterizza: per l imprevedibilità delle variabili intervenienti (non ipotizzabili a priori) che determina un grado più o meno elevato di incertezza predittiva; per la singolarità delle reazioni individuali, delle dinamiche di gruppo, delle attitudini al cambiamento o alla conservazione, e delle resistenze al cambiamento Metodologie per il monitoraggio Tra le diverse metodologie che il monitoraggio utilizza e integra in ambito formativo, sono queste le più rappresentative: 1) L analisi statistica (metodo quantitativo) che: - opera in ambiti ampi e generali, - è nomotetica e quindi necessita di grandi numeri e di campioni significativi, - studia l uniformità e le regolarità nel succedersi dei fenomeni, - parte da ipotesi sperimentali da confermare o smentire tramite i risultati acquisiti, - rileva e analizza dati numerici o ad essi equiparabili. L analisi statistica presenta i seguenti vantaggi: rigore metodologico e strumentale, dati oggettivi, strumenti di misura standardizzati; e i seguenti limiti: l ambiente formativo non presenta le condizioni del laboratorio; nel progetto sperimentale le persone devono adeguarsi agli obiettivi (nella realtà avviene l opposto); non permette decisioni in itinere e riduce la validità di quelle terminali. 2) L analisi descrittiva (metodo qualitativo statico) che: - opera in ambiti specifici ma comparabili, - è idiografica, punta alla profondità analitica e qualitativa degli elementi, - è soggettiva nell analisi e intersoggettiva nella definizione degli indicatori e nella comparazione, - opera sulla variabilità dei descrittori. L analisi descrittiva presenta i seguenti vantaggi: coerenza metodologica e strumentale, dati comparabili, strumenti di analisi condivisi; e i seguenti limiti: lo sviluppo del processo viene interpretato sulla base di analisi dei passi cruciali (step procedurali) e/o dei risultati; analisi frammentata con debole comprensione sistemica, possibili inferenze indebite.
9 3) L analisi fenomenologica (metodo qualitativo-narrativo) che: - opera in situazioni particolari (casi), - punta al controllo qualitativo del processo durante il suo svolgersi per modificarne l evoluzione o l orientamento, - non dà interpretazioni, ma le raccoglie, - studia le difformità e gli imprevisti che provocano i mutamenti, - non parte da ipotesi sperimentali precostituite ma da obiettivi di cambiamento flessibili e contingentemente adattabili. L analisi fenomenologica presenta i seguenti vantaggi: comprensione approfondita dei fenomeni; consente decisioni immediate e partecipate, nonché la valutazione della loro efficacia; e i seguenti limiti: debolezza metodologica; soggettività interpretativa, scarsa generalizzazione dei risultati. In conclusione, il monitoraggio non è mai occasionale o fortuito, è sempre sistematico: le proprietà controllate devono essere sempre le stesse e vengono considerate "indicative" di un intero processo. Nel monitoraggio le ipotesi preventive non vengono comparate con i risultati conclusivi, riguardano, invece, gli indicatori prescelti e ciò che si ipotizza è la loro precisa corrispondenza alle proprietà dei processi indagati. Ciò significa che gli strumenti di monitoraggio devono essere tarati sulla fedeltà dell indicatore e non sui risultati temporanei che all interno dell indicatore possono liberamente oscillare LE MOLTEPLICI FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE La valutazione: serva o padrona? Abbiamo rappresentato il senso fondamentale della valutazione nella capacità di leggere e di interpretare la realtà entro quadri valoriali personali e secondo misure e schemi convenzionalmente determinati. Ma la valutazione, come abbiamo visto, si manifesta in una molteplicità di attività e per ciascuna di esse generalmente si assume come prioritaria una specifica funzione. L accertamento serve per spiegare, il controllo viene tendenzialmente utilizzato per rilevare gli scostamenti dai punti nodali di una procedura, la verifica serve per ridefinire la progettazione, la valutazione per comprendere i tanti sensi della complessità, la metavalutazione per assumere le decisioni e le successive azioni, il monitoraggio per determinare lo stato di un sistema sulla base di precisi indicatori. Orbene queste funzioni, che unitariamente contribuiscono alla "vera" funzione valutativa (interpretazione valoriale), se prese singolarmente, rappresentano soltanto ruoli di sostegno e di aiuto allo studio dei processi formativi (spiegazione / comprensione) o alle attività ad essa conseguenti (progettazione / decisione). Funzione esplicativa. La valutazione aiuta a spiegare il mutamento dei fenomeni, infatti non produce mai certezze, ma estrae congetture e le riveste di senso. "Spiegare vuol dire, in effetti, rendere conto dei fenomeni a partire da qualcosa di altro da loro, con cui li associamo secondo relazioni considerate come necessarie, o 2 La corrispondenza biunivoca tra gli indicatori e i processi, che tali indicatori rappresentano, non è data di per sé, ma al contrario va sempre conferita in dubbio: la presenza di muschio è un indicatore del nord se si ritrova sulla corteccia di un albero, ma non all interno di una grotta. Cosi, in ambito didattico, un indicatore sistematico di coinvolgimento degli allievi alle attività formative può essere rappresentato dal numero di interventi spontanei. Certamente l indicatore (numero di interventi spontanei) corrisponde al processo (coinvolgimento degli allievi) ma non in modo bidirezionale: ci possono essere interventi senza coinvolgimento e viceversa coinvolgimento senza interventi. Questo indicatore, pertanto, risulta necessario ma non sufficiente per rappresentare il processo richiesto.
10 almeno sufficienti. A tale scopo facciamo appello a entità o a processi elementari che si pensa siano all origine dei fenomeni osservati, o che permettono di ricostituire questi ultimi attraverso combinazioni o raggruppamenti. La spiegazione implica dunque sempre l intervento di parti costitutive e di fattori interni o esterni rispetto al campo studiato, nonché di interazioni cui partecipano queste diverse entità" (Delattre, 1984, p. 33). Si spiega, quindi, per diagnosticare i fenomeni, ossia per conoscere (gnosis) la realtà attraverso (dià) alcuni segni. Saranno pertanto i segni ritenuti significativi a "dare senso" alle conoscenze. Funzione progettuale. La valutazione convalida o smentisce, in tutto o in parte, le ipotesi formulate nell ambito di piani sperimentali o di progetti operativi. La funzione progettuale della valutazione garantisce continue retroazioni tra il disegno formativo e le azioni formative attivate. Tutto ciò comporta la capacità previsionale (prognostica) connaturata alla valutazione: la valutazione non serve soltanto per fotografare la realtà ma anche per rilevarne le continuità e le discontinuità tra cause, fenomeni e conseguenze, e quindi prognosticarne lo sviluppo. Funzione comprendente. La valutazione aiuta a comprendere i processi, ossia a farli propri, entro il personale vissuto esperienziale. Con la comprensione si assumono sia la capacità diagnostica che quella prognostica, ma in questo caso la conoscenza e la previsione vengono filtrate e commisurate all esperienza personale. Questa funzione mette in risalto le caratteristiche soggettive e personali, piuttosto che quelle strumentali o progettuali. Funzioni decisionale e orientativa. La valutazione promuove decisioni orientate, con l assunzione della responsabilità delle scelte effettuale mediante l attivazione di opportune strategie d intervento. La funzione decisionale della valutazione è quella che maggiormente le imprime il carattere di formatività: la valutazione è formativa quando permette di modificare e di adattare percorsi differenziati. Ciò significa che la valutazione deve valorizzare la "positività" nelle persone, nelle situazioni e nei processi se vuole garantirsi decisioni orientate, costruttive e generative. In altre parole, individuando soltanto ciò che una persona non sa o non sa fare, o anche la carenza di risorse, si arriva tutt al più ad una parziale diagnosi; se si vuole decidere sul "che fare" è necessario partire da quello che la persona realmente sa fare, dalle risorse effettive, dai processi accaduti o in atto. La valutazione "in negativo" non indica come superare l errore, quella "in positivo" comprende l errore mettendone in evidenza la dissonanza dal contesto valorizzato. Nella scuola secondaria, la funzione orientativa è prioritaria: essa aiuta lo studente ad indirizzarsi nello sviluppo delle proprie competenze, a riconoscere interessi e valori, ad assumere scelte ponderate per la costruzione personalizzata del curricolo formativo (piano di studi), proiettato verso il proprio futuro. Orientamento e decisione si presentano molto intrecciati: nel caso dell orientamento dell allievo circa il proprio piano di studi, sarà determinante precisare chi ha il potere di decidere: l allievo stesso o la sua famiglia, un insegnante tutor o il consiglio di classe? E sulla base di quali criteri lo studente potrà (o dovrà) transitare da un indirizzo di studi ad un altro? Funzioni formativa e sommativa. Rappresentano due tipologie di valutazione, i cui termini, coniati da M. Scriven (1967), sono stati tradotti in italiano in modo apparentemente letterale, ma applicati con valenze e significati talvolta distanti da quelli originari. Spesso la valutazione formativa viene associata a tecniche qualitative nell analisi in itinere dei risultati degli studenti; per contro la valutazione sommativa viene associata a tecniche quantitative, alla docimologia, o interpretata in funzione certificativa. Così non è. La valutazione formativa (sarebbe opportuno denominarla costruttiva ) è la valutazione di un programma di intervento durante la sua fase di attuazione, allo scopo di apporvi parziali adattamenti e verificare il reale contributo delle attività messe in opera. La valutazione sommativa (sarebbe opportuno denominarla riepilogativa ) è la valutazione di un programma di
11 intervento giunto alla sua fase matura, dopo gli eventuali aggiustamenti introdotti con la valutazione formativa, in cui si valuta la totalità del programma e degli effetti ottenuti. In modo suggestivo, R. Stake esemplifica: La valutazione del cuoco che assaggia la zuppa è formativa, quella dell ospite che degusta la zuppa è sommativa. Funzione certificativa. La funzione certificativa della valutazione comprende la documentazione inerente il superamento di esami, di prove, di interrogazioni, o concernente il profitto nelle tappe intermedie e finali di un corso di studi. Negli anni più recenti, la valutazione certificativa, uniformandosi alle linee di tendenza europee, ha iniziato a documentare i crediti formativi, perlopiù interpretati non come accertamento di competenze acquisite da parte degli studenti, ma come durata e frequenza a corsi o a moduli formativi. Va precisato, infine, che la funzione certificativa della valutazione non va confusa con la certificazione di qualità. I risultati della valutazione, infatti, possono essere utilizzati per scopi certificativi, ma la certificazione, intesa come dichiarazione dello stato di sistema, è più funzionale all affermazione della produttività del sistema scuola che alla formatività dei processi in essa attivati. Fine del mod. 4.
Gli errori di valutazione
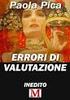 CORSO ITC TOSI Quando l insegnante sbaglia Gli errori di valutazione prof. Fiorino Tessaro Che cosa sono gli errori di valutazione? Sono i fattori soggettivi e personali che inficiano la correttezza valutativa.
CORSO ITC TOSI Quando l insegnante sbaglia Gli errori di valutazione prof. Fiorino Tessaro Che cosa sono gli errori di valutazione? Sono i fattori soggettivi e personali che inficiano la correttezza valutativa.
CRITERI GENERALI. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari:
 CRITERI GENERALI Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai componenti
CRITERI GENERALI Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai componenti
Quadro di certificazione delle competenze
 Quadro di certificazione delle competenze Alla fine del primo ciclo di istruzione Circolare ministeriale 10.11.2005, n.84 Linguistiche Lingue comunitarie Scientifiche Matematiche Tecniche informatiche
Quadro di certificazione delle competenze Alla fine del primo ciclo di istruzione Circolare ministeriale 10.11.2005, n.84 Linguistiche Lingue comunitarie Scientifiche Matematiche Tecniche informatiche
Criteri di verifica e di valutazione
 Criteri di verifica e di valutazione Osservazione iniziale Questo momento è volto alla conoscenza degli alunni e del loro ambiente socioculturale di appartenenza al fine di poter programmare interventi
Criteri di verifica e di valutazione Osservazione iniziale Questo momento è volto alla conoscenza degli alunni e del loro ambiente socioculturale di appartenenza al fine di poter programmare interventi
Selezione del disegno di ricerca. Quantitativo e qualitativo
 Selezione del disegno di ricerca Quantitativo e qualitativo Principali differenze tra ricerca quantitativa e qualitativa Quantitativa Natura della realtà Qualitativa Realtà indagabile con modalità obiettive
Selezione del disegno di ricerca Quantitativo e qualitativo Principali differenze tra ricerca quantitativa e qualitativa Quantitativa Natura della realtà Qualitativa Realtà indagabile con modalità obiettive
PARTE V Monitoraggio. Verifica e valutazione
 PARTE V Monitoraggio Verifica e valutazione Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri
PARTE V Monitoraggio Verifica e valutazione Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri
VALUTAZIONE RELAZIONALE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI ACCREDITATI
 VALUTAZIONE RELAZIONALE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI ACCREDITATI Diversi modi di intendere la valutazione Controllo dei processi e degli esiti con netta separazione tra chi valuta e chi è oggetto della valutazione.
VALUTAZIONE RELAZIONALE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI ACCREDITATI Diversi modi di intendere la valutazione Controllo dei processi e degli esiti con netta separazione tra chi valuta e chi è oggetto della valutazione.
SINTESI DELL INDAGINE INVALSI 2016 (II classe delle superiori, riformata)
 SINTESI DELL INDAGINE INVALSI 2016 (II classe delle superiori, riformata) L indagine INVALSI del 2016 ha coinvolto undici classi del Liceo Fermi, compresa la sede associata; nessuna classe è stata scelta
SINTESI DELL INDAGINE INVALSI 2016 (II classe delle superiori, riformata) L indagine INVALSI del 2016 ha coinvolto undici classi del Liceo Fermi, compresa la sede associata; nessuna classe è stata scelta
DOCIMOLOGIA FRANCESCO AGRUSTI. anno accademico CdL Scienze dell Educazione 9 (6+3) CFU
 1 DOCIMOLOGIA FRANCESCO AGRUSTI Testi consigliati testi consigliati per l esame 2 B. Vertecchi, Manuale della valutazione. Analisi degli apprendimenti e dei contesti, Milano, Franco Angeli, 2003. B. Vertecchi,
1 DOCIMOLOGIA FRANCESCO AGRUSTI Testi consigliati testi consigliati per l esame 2 B. Vertecchi, Manuale della valutazione. Analisi degli apprendimenti e dei contesti, Milano, Franco Angeli, 2003. B. Vertecchi,
DALL AUTOVALUTAZIONE AI PIANI DI MIGLIORAMENTO
 IRRE Toscana 28-29 ottobre 2004 Seminario di studi La qualità nei sistemi educativi DALL AUTOVALUTAZIONE AI PIANI DI MIGLIORAMENTO Mario Castoldi DALL AUTOVALUTAZIONE AI PIANI DI MIGLIORAMENTO QUALE IDEA
IRRE Toscana 28-29 ottobre 2004 Seminario di studi La qualità nei sistemi educativi DALL AUTOVALUTAZIONE AI PIANI DI MIGLIORAMENTO Mario Castoldi DALL AUTOVALUTAZIONE AI PIANI DI MIGLIORAMENTO QUALE IDEA
La valutazione individualizzata
 CTI Acqualagna 19.01.10 La valutazione individualizzata A cura di Definizione di valutazione La parola valutare deriva dal latino valitus = avere prezzo, stimare, attribuire un prezzo È il processo attraverso
CTI Acqualagna 19.01.10 La valutazione individualizzata A cura di Definizione di valutazione La parola valutare deriva dal latino valitus = avere prezzo, stimare, attribuire un prezzo È il processo attraverso
DOMANDA DI RICERCA TIPI DI RICERCA
 DOMANDA DI conoscenza esistente del problema: letteratura, esperienze relative al problema oggetto di studio, teorie già note, osservazione dirette di fenomeni/comportamenti nelle organizzazioni TIPI DI
DOMANDA DI conoscenza esistente del problema: letteratura, esperienze relative al problema oggetto di studio, teorie già note, osservazione dirette di fenomeni/comportamenti nelle organizzazioni TIPI DI
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
 MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni, secondo quanto disposto dall art.2 comma 1 e 3 del D.L.gs 62/17, si esprime in decimi ed è integrata
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni, secondo quanto disposto dall art.2 comma 1 e 3 del D.L.gs 62/17, si esprime in decimi ed è integrata
Servizi Socio sanitari Espressioni grafiche ed elementi di storia dell arte
 Servizi Socio sanitari Espressioni grafiche ed elementi di storia dell arte METODI e STRUMENTI Si premette che, compatibilmente con i dispositivi e gli strumenti messi a disposizione dalla scuola, si utilizzeranno
Servizi Socio sanitari Espressioni grafiche ed elementi di storia dell arte METODI e STRUMENTI Si premette che, compatibilmente con i dispositivi e gli strumenti messi a disposizione dalla scuola, si utilizzeranno
SINTESI DELL INDAGINE INVALSI 2017 (II classe delle superiori, riformata)
 SINTESI DELL INDAGINE INVALSI 2017 (II classe delle superiori, riformata) L indagine INVALSI del 2016/2017 ha coinvolto quattordici classi del, compresa la sede associata; nessuna classe è stata scelta
SINTESI DELL INDAGINE INVALSI 2017 (II classe delle superiori, riformata) L indagine INVALSI del 2016/2017 ha coinvolto quattordici classi del, compresa la sede associata; nessuna classe è stata scelta
Prof. Roberto Melchiori
 CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE CORSO DI LAUREA IN SCIENZE PSICOLOGICHE DEL LAVORO E DELLE Anno Accademico2013/2014 PROGRAMMA DEL CORSO DI Pedagogia sperimentale Prof. Roberto
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE CORSO DI LAUREA IN SCIENZE PSICOLOGICHE DEL LAVORO E DELLE Anno Accademico2013/2014 PROGRAMMA DEL CORSO DI Pedagogia sperimentale Prof. Roberto
Scheda di autoriflessione del docente
 Scheda di autoriflessione del docente Presentazione L autoriflessività del docente è intesa sia come acquisizione di consapevolezza dei propri processi conoscitivi e delle relative strategie che mette
Scheda di autoriflessione del docente Presentazione L autoriflessività del docente è intesa sia come acquisizione di consapevolezza dei propri processi conoscitivi e delle relative strategie che mette
Le attività laboratoriali: progettazione, organizzazione e valutazione. 10 marzo 2017 Prof. Giuseppe Elia
 Le attività laboratoriali: progettazione, organizzazione e valutazione 10 marzo 2017 Prof. Giuseppe Elia Nella metodologia della didattica laboratoriale abbiamo affermato che il docente non è più colui
Le attività laboratoriali: progettazione, organizzazione e valutazione 10 marzo 2017 Prof. Giuseppe Elia Nella metodologia della didattica laboratoriale abbiamo affermato che il docente non è più colui
LA VALUTAZIONE. Valutazione degli alunni (Cfr Indicazioni nazionali per il Curricolo del Settembre 2012) Traguardi per lo sviluppo delle competenze
 LA VALUTAZIONE Valutazione degli alunni (Cfr Indicazioni nazionali per il Curricolo del Settembre 2012) Traguardi per lo sviluppo delle competenze Al termine della Scuola Primaria vengono individuati traguardi
LA VALUTAZIONE Valutazione degli alunni (Cfr Indicazioni nazionali per il Curricolo del Settembre 2012) Traguardi per lo sviluppo delle competenze Al termine della Scuola Primaria vengono individuati traguardi
La Scuola Primaria e Secondaria di 1º Grado devono pertanto:
 5. METODOLOGIA Insegnamento e apprendimento: centralità dell alunno Le Indicazioni Nazionali, emanate dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (M.I.U.R.) nel novembre 2012, sottolineano
5. METODOLOGIA Insegnamento e apprendimento: centralità dell alunno Le Indicazioni Nazionali, emanate dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (M.I.U.R.) nel novembre 2012, sottolineano
Università Milano Bicocca Corso di Metodi e tecniche del servizio sociale Teresa Bertotti. La valutazione nel servizio sociale
 Università Milano Bicocca Corso di Metodi e tecniche del servizio sociale Teresa Bertotti La valutazione nel servizio sociale Perché si valuta? Accountability - Necessità di rendicontazione Learning La
Università Milano Bicocca Corso di Metodi e tecniche del servizio sociale Teresa Bertotti La valutazione nel servizio sociale Perché si valuta? Accountability - Necessità di rendicontazione Learning La
Il ruolo della scuola in una corretta prassi valutativa dei bisogni dei bambini
 Il ruolo della scuola in una corretta prassi valutativa dei bisogni dei bambini Milano, 6 marzo 2009 Isp. Mario Maviglia Dirigente Ufficio VIII Formazione e Aggiornamento - USR Lombardia mario.maviglia.bs@istruzione.it
Il ruolo della scuola in una corretta prassi valutativa dei bisogni dei bambini Milano, 6 marzo 2009 Isp. Mario Maviglia Dirigente Ufficio VIII Formazione e Aggiornamento - USR Lombardia mario.maviglia.bs@istruzione.it
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA DELL INFANZIA Stabilire dei traguardi di sviluppo e raccogliere i dati in modo sistematico costituisce una
 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA DELL INFANZIA Stabilire dei traguardi di sviluppo e raccogliere i dati in modo sistematico costituisce una modalità per conoscere meglio il bambino e le sue effettive
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA DELL INFANZIA Stabilire dei traguardi di sviluppo e raccogliere i dati in modo sistematico costituisce una modalità per conoscere meglio il bambino e le sue effettive
Indice. 1 Le fasi della ricerca osservativa Le tecniche e gli strumenti L analisi del comportamento docente...7
 INSEGNAMENTO DI PEDAGOGIA SPERIMENTALE LEZIONE III LA RICERCA EMPIRICA PARTE II PROF. LUCIANO GALLIANI Indice 1 Le fasi della ricerca osservativa...3 2 Le tecniche e gli strumenti...5 3 L analisi del comportamento
INSEGNAMENTO DI PEDAGOGIA SPERIMENTALE LEZIONE III LA RICERCA EMPIRICA PARTE II PROF. LUCIANO GALLIANI Indice 1 Le fasi della ricerca osservativa...3 2 Le tecniche e gli strumenti...5 3 L analisi del comportamento
CLASSE PRIMA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA
 CLASSE PRIMA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO SCIENZE DISCIPLINE TRASVERSALI SCIENZE TRAGUARDI FORMATIVI COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE
CLASSE PRIMA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO SCIENZE DISCIPLINE TRASVERSALI SCIENZE TRAGUARDI FORMATIVI COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE
AUTOVALUTAZIONE PROVE D INGRESSO
 AUTOVALUTAZIONE PROVE D INGRESSO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 Funzione Strumentale Riga Maria Angela PREMESSA Di seguito si riportano i dati relativi alle somministrazioni delle prove d ingresso delle classi
AUTOVALUTAZIONE PROVE D INGRESSO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 Funzione Strumentale Riga Maria Angela PREMESSA Di seguito si riportano i dati relativi alle somministrazioni delle prove d ingresso delle classi
La valutazione nell organizzazione modulare della didattica. Dott.ssa Anna Maria Ciraci Cosenza 5-6 marzo 2003
 La valutazione nell organizzazione modulare della didattica Dott.ssa Anna Maria Ciraci Cosenza 5-6 marzo 2003 La valutazione nell attuale quadro normativo e operativo Regolamento dell autonomia delle istituzioni
La valutazione nell organizzazione modulare della didattica Dott.ssa Anna Maria Ciraci Cosenza 5-6 marzo 2003 La valutazione nell attuale quadro normativo e operativo Regolamento dell autonomia delle istituzioni
SINTESI DELL INDAGINE INVALSI 2013 (II classe delle superiori, riformata)
 SINTESI DELL INDAGINE INVALSI 2013 (II classe delle superiori, riformata) L indagine INVALSI del 2013 ha coinvolto dodici classi del Liceo Fermi, compresa la sede associata; per le classi II D e II P,
SINTESI DELL INDAGINE INVALSI 2013 (II classe delle superiori, riformata) L indagine INVALSI del 2013 ha coinvolto dodici classi del Liceo Fermi, compresa la sede associata; per le classi II D e II P,
Donatella Poliandri. Responsabile area Valutazione delle scuole INVALSI
 Donatella Poliandri Responsabile area Valutazione delle scuole INVALSI Valutare per migliorare: le sperimentazioni INVALSI verso la valutazione delle scuole Schema di Regolamento del Sistema Nazionale
Donatella Poliandri Responsabile area Valutazione delle scuole INVALSI Valutare per migliorare: le sperimentazioni INVALSI verso la valutazione delle scuole Schema di Regolamento del Sistema Nazionale
VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
 CAPITOLO 4 4.9 Con l emanazione del DPR 80/2013 e della legge 107/2015 si sta delineando un compiuto sistema di valutazione finalizzato alla qualificazione del servizio scolastico, alla valorizzazione
CAPITOLO 4 4.9 Con l emanazione del DPR 80/2013 e della legge 107/2015 si sta delineando un compiuto sistema di valutazione finalizzato alla qualificazione del servizio scolastico, alla valorizzazione
REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
 REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE 1 Servizi di educazione, formazione e lavoro Processo Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione
REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE 1 Servizi di educazione, formazione e lavoro Processo Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione
Osservare per riflettere sulle azioni didattiche Osservare per analizzare gli strumenti
 Osservare per riflettere sulle azioni didattiche Osservare per analizzare gli strumenti Rossella D Ugo Dipartimento di Studi Umanistici Università di Urbino Il significato di osservare Osservare significa
Osservare per riflettere sulle azioni didattiche Osservare per analizzare gli strumenti Rossella D Ugo Dipartimento di Studi Umanistici Università di Urbino Il significato di osservare Osservare significa
La valutazione dell // per l alunno La valutazione del // per il sistema
 Istituto Comprensivo Statale CALITRI - a. sc. 2014-2015 La valutazione dell // per l alunno La valutazione del // per il sistema Non ci sono venti favorevoli per coloro che non sanno dove andare Seneca
Istituto Comprensivo Statale CALITRI - a. sc. 2014-2015 La valutazione dell // per l alunno La valutazione del // per il sistema Non ci sono venti favorevoli per coloro che non sanno dove andare Seneca
Rilevazione precoce dei disturbi specifici di apprendimento nelle scuole
 Rilevazione precoce dei disturbi specifici di apprendimento nelle scuole Modena 17 dicembre 2018 Prof.ssa Cristina Monzani Ufficio Scolastico Provinciale Modena Linee guida per la rilevazione precoce dei
Rilevazione precoce dei disturbi specifici di apprendimento nelle scuole Modena 17 dicembre 2018 Prof.ssa Cristina Monzani Ufficio Scolastico Provinciale Modena Linee guida per la rilevazione precoce dei
Insieme per una scuola di successo
 Insieme per una scuola di successo rete di Apricena Lesina San Severo 20 aprile 2015 2 anno San Paolo Civitate M.C. Escher Relativity, 1953 Il tempo La ricerca Da Montaigne a Edgar Morin: la testa ben
Insieme per una scuola di successo rete di Apricena Lesina San Severo 20 aprile 2015 2 anno San Paolo Civitate M.C. Escher Relativity, 1953 Il tempo La ricerca Da Montaigne a Edgar Morin: la testa ben
Dalla valutazione degli apprendimenti al RAV. Maria Carmela Termini
 Dalla valutazione degli apprendimenti al RAV Maria Carmela Termini Verifica e valutazione Differenza concettuale e operativa Verifica ci riferiamo alle operazioni di rilevazione e misurazione dell apprendimento
Dalla valutazione degli apprendimenti al RAV Maria Carmela Termini Verifica e valutazione Differenza concettuale e operativa Verifica ci riferiamo alle operazioni di rilevazione e misurazione dell apprendimento
I modulo di formazione : ASPETTI PEDAGOGICI DIDATTICI ED ORGANIZZATIVI Prima parte
 PROGETTO MARCHIGIANO DI EDUCAZIONE COOPERATIVA I modulo di formazione : ASPETTI PEDAGOGICI DIDATTICI ED ORGANIZZATIVI Prima parte 22.10.2013 Il sistema valoriale e le finalità educative del progetto Le
PROGETTO MARCHIGIANO DI EDUCAZIONE COOPERATIVA I modulo di formazione : ASPETTI PEDAGOGICI DIDATTICI ED ORGANIZZATIVI Prima parte 22.10.2013 Il sistema valoriale e le finalità educative del progetto Le
Maurizio Muraglia Marsala 4 dicembre 2014
 Valutare e certificare le competenze Maurizio Muraglia Marsala 4 dicembre 2014 Apriori sulla valutazione scolastica Valutare non è mettere il voto Non si fa media tra atti valutativi Non si può rinunciare
Valutare e certificare le competenze Maurizio Muraglia Marsala 4 dicembre 2014 Apriori sulla valutazione scolastica Valutare non è mettere il voto Non si fa media tra atti valutativi Non si può rinunciare
VALUTAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE DI SISTEMA
 VALUTAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE DI SISTEMA ( AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO) MASSIMO MORSELLI LABORATORI FORMATIVI PER DOCENTI NEOASSUNTI POLO FORMATIVO LAS A. MODIGLIANI GIUSSANO VALUTAZIONE DEGLI
VALUTAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE DI SISTEMA ( AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO) MASSIMO MORSELLI LABORATORI FORMATIVI PER DOCENTI NEOASSUNTI POLO FORMATIVO LAS A. MODIGLIANI GIUSSANO VALUTAZIONE DEGLI
Progettare e valutare l intervento sociale
 Progettare e valutare l intervento sociale Una precisazione semantica Piano - Programma Progetto I tre termini, spesso utilizzati come sinonimi, hanno in realtà una precisa connotazione che ne indica :
Progettare e valutare l intervento sociale Una precisazione semantica Piano - Programma Progetto I tre termini, spesso utilizzati come sinonimi, hanno in realtà una precisa connotazione che ne indica :
PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE ESTERNA DELLE SCUOLE
 Comitato Provinciale di Valutazione del Sistema Scolastico e Formativo con il supporto tecnico scientifico di IPRASE del Trentino Area di Supporto alla Valutazione Dipartimento Istruzione PROTOCOLLO PER
Comitato Provinciale di Valutazione del Sistema Scolastico e Formativo con il supporto tecnico scientifico di IPRASE del Trentino Area di Supporto alla Valutazione Dipartimento Istruzione PROTOCOLLO PER
LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI - PESCARA POF PROCESSI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
 La è per l apprendimento PROCESSI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE Il processo di è necessario per accertare la qualità delle competenze, delle abilità e delle conoscenze degli allievi; è in grado di raccogliere
La è per l apprendimento PROCESSI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE Il processo di è necessario per accertare la qualità delle competenze, delle abilità e delle conoscenze degli allievi; è in grado di raccogliere
PROTOCOLLO PROVE COMUNI TABULATE
 Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MARSALA Via Marsala 13 27058 Voghera (Pv) Tel. 0383-41371 Fax 0383 41598 C.F. 95032770182 Email: PVIC826009@istruzione.it
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MARSALA Via Marsala 13 27058 Voghera (Pv) Tel. 0383-41371 Fax 0383 41598 C.F. 95032770182 Email: PVIC826009@istruzione.it
prestazione autentica
 prestazione autentica E.Fazi UCIIM nazionale 2 DIFFERENZE tra RUBRICHE e PROVE OGGETTIVE DI VERIFICA Prova oggettiva Verifica obiettivi specifici Verifica una prestazione formale,non contestualizzata Rubrica
prestazione autentica E.Fazi UCIIM nazionale 2 DIFFERENZE tra RUBRICHE e PROVE OGGETTIVE DI VERIFICA Prova oggettiva Verifica obiettivi specifici Verifica una prestazione formale,non contestualizzata Rubrica
Alcune indicazioni dai progetti sperimentali per supportare le scuole
 Seminario di formazione e informazione Il Rapporto di autovalutazione Roma 28 novembre 2014 Alcune indicazioni dai progetti sperimentali per supportare le scuole Donatella Poliandri Responsabile area Valutazione
Seminario di formazione e informazione Il Rapporto di autovalutazione Roma 28 novembre 2014 Alcune indicazioni dai progetti sperimentali per supportare le scuole Donatella Poliandri Responsabile area Valutazione
VALUTAZIONE DEGLI ESITI FORMATIVI
 VALUTAZIONE DEGLI ESITI FORMATIVI Valutazione interna La valutazione degli alunni è parte integrante della programmazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento
VALUTAZIONE DEGLI ESITI FORMATIVI Valutazione interna La valutazione degli alunni è parte integrante della programmazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento
LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 1 Premessa
 LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 1 Premessa La scuola, vista come sistema organizzato, è caratterizzata da complessità. Il Sistema deve essere tenuto sotto continuo monitoraggio e controllo
LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 1 Premessa La scuola, vista come sistema organizzato, è caratterizzata da complessità. Il Sistema deve essere tenuto sotto continuo monitoraggio e controllo
MONITORAGGIO SU PROGETTO PILOTA
 MONITORAGGIO SU PROGETTO PILOTA Progetto DSA: creare una buona scuola per un apprendimento facilitato degli allievi DSA Prof. Antonio Augenti, Dott.ssa Maria A. Geraci Dott.ssa M. Filomena Casale PREMESSA
MONITORAGGIO SU PROGETTO PILOTA Progetto DSA: creare una buona scuola per un apprendimento facilitato degli allievi DSA Prof. Antonio Augenti, Dott.ssa Maria A. Geraci Dott.ssa M. Filomena Casale PREMESSA
SCHEMA DELLA RELAZIONE FINALE DI TIROCINIO
 SCHEMA DELLA RELAZIONE FINALE DI TIROCINIO La relazione deve consistere in un elaborato originale, non limitato a una semplice esposizione delle attività svolte. Esso deve evidenziare la capacità del tirocinante
SCHEMA DELLA RELAZIONE FINALE DI TIROCINIO La relazione deve consistere in un elaborato originale, non limitato a una semplice esposizione delle attività svolte. Esso deve evidenziare la capacità del tirocinante
Metodologia per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione della formazione nelle PPAA
 Metodologia per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione della formazione nelle PPAA Prof. Guido CAPALDO Roma, 21 maggio 2013 Sala Polifunzionale PCM Come è stata costruita la metodologia Messa
Metodologia per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione della formazione nelle PPAA Prof. Guido CAPALDO Roma, 21 maggio 2013 Sala Polifunzionale PCM Come è stata costruita la metodologia Messa
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: DE-COSTRUIRE SIGNIFICATI E PRASSI VALUTATIVE
 Liceo «Galilei» - Trento VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: DE-COSTRUIRE SIGNIFICATI E PRASSI VALUTATIVE Mario Castoldi settembre 2012 LUOGHI COMUNI DELLA VALUTAZIONE SCOLASTICA LA VALUTAZIONE DEVE ESSERE
Liceo «Galilei» - Trento VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: DE-COSTRUIRE SIGNIFICATI E PRASSI VALUTATIVE Mario Castoldi settembre 2012 LUOGHI COMUNI DELLA VALUTAZIONE SCOLASTICA LA VALUTAZIONE DEVE ESSERE
Questioni culturali e pedagogiche che il Miur sottopone all attenzione delle scuole per riceverne osservazioni
 1 CM 3/15: domande di ricerca, monitoraggio e restituzione esiti Questioni culturali e pedagogiche che il Miur sottopone all attenzione delle scuole per riceverne osservazioni 2 Osservazioni:1 Struttura
1 CM 3/15: domande di ricerca, monitoraggio e restituzione esiti Questioni culturali e pedagogiche che il Miur sottopone all attenzione delle scuole per riceverne osservazioni 2 Osservazioni:1 Struttura
ANALISI ESITI PROVE INVALSI
 ANALISI ESITI PROVE INVALSI Anno Scolastico 2015/2016 Dirigente Scolastico Prof. Trunfio Nicola Commissione NIV La valutazione, nell Istituto Comprensivo «Criscuoli», è il processo centrale di tutta l
ANALISI ESITI PROVE INVALSI Anno Scolastico 2015/2016 Dirigente Scolastico Prof. Trunfio Nicola Commissione NIV La valutazione, nell Istituto Comprensivo «Criscuoli», è il processo centrale di tutta l
Indicatori di qualità dell integrazione Fattori di inclusione
 Verso un Osservatorio Territoriale Integrato sulla disabilità nella Scuola 1di 5 Indicatori di qualità dell integrazione Fattori di inclusione Fiorino Tessaro Prof. Ass. di Didattica generale e Pedagogia
Verso un Osservatorio Territoriale Integrato sulla disabilità nella Scuola 1di 5 Indicatori di qualità dell integrazione Fattori di inclusione Fiorino Tessaro Prof. Ass. di Didattica generale e Pedagogia
Ref. Prof.ri TIC e Informatica e Laboratorio A PRESENTAZIONE. Tecnologia dell informazione e della comunicazione ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
 UNITÀ DI APPRENDIMENTO TECNOLOGIE DELL INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE Ref. Prof.ri TIC e Informatica e Laboratorio A.S. 2015-2016 TITOLO PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI (POWERPOINT) COD 01/02 A PRESENTAZIONE
UNITÀ DI APPRENDIMENTO TECNOLOGIE DELL INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE Ref. Prof.ri TIC e Informatica e Laboratorio A.S. 2015-2016 TITOLO PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI (POWERPOINT) COD 01/02 A PRESENTAZIONE
L efficacia della formazione e il monitoraggio dell apprendimento
 Convegno gratuito L efficacia della formazione e il monitoraggio dell apprendimento Relatore: Giovanna Alvaro BOLOGNA, 20 ottobre 2016 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 La valutazione, ultimo anello del processo
Convegno gratuito L efficacia della formazione e il monitoraggio dell apprendimento Relatore: Giovanna Alvaro BOLOGNA, 20 ottobre 2016 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 La valutazione, ultimo anello del processo
ANNO DI FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI Anno scolastico 20-20
 ANNO DI FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI Anno scolastico 20-20 SCHEDA DI RILEVAZIONE PER L INSEGNANTE ESPERTO (Da riempire al termine dell anno scolastico) Ambito o disciplina di insegnamento 1. Attività
ANNO DI FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI Anno scolastico 20-20 SCHEDA DI RILEVAZIONE PER L INSEGNANTE ESPERTO (Da riempire al termine dell anno scolastico) Ambito o disciplina di insegnamento 1. Attività
MONITORAGGIO PDM ANNO SCOLASTICO AREA DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e valutazione
 Istituto Comprensivo di Scuola dell Infanzia Primaria e Secondaria di Primo Grado Via Enrico Dalfino, 1 - Sammichele di Bari 70010 (Ba) e-mail BAIC80500V@ISTRUZIONE.IT pec BAIC80500V@PEC.ISTRUZIONE.IT
Istituto Comprensivo di Scuola dell Infanzia Primaria e Secondaria di Primo Grado Via Enrico Dalfino, 1 - Sammichele di Bari 70010 (Ba) e-mail BAIC80500V@ISTRUZIONE.IT pec BAIC80500V@PEC.ISTRUZIONE.IT
CLASSE SECONDA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA
 CLASSE SECONDA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO SCIENZE DISCIPLINE TRASVERSALI TUTTE TRAGUARDI FORMATIVI COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE
CLASSE SECONDA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO SCIENZE DISCIPLINE TRASVERSALI TUTTE TRAGUARDI FORMATIVI COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE
ISTITUTO COMPRENSIVO G.PASCOLI -SILVI. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI Sezione POF
 ISTITUTO COMPRENSIVO G.PASCOLI -SILVI OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI Sezione POF 2014-2015 OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI SCUOLA DELL INFANZIA Accoglienza della diversità, delle persone e delle culture Rafforzamento
ISTITUTO COMPRENSIVO G.PASCOLI -SILVI OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI Sezione POF 2014-2015 OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI SCUOLA DELL INFANZIA Accoglienza della diversità, delle persone e delle culture Rafforzamento
PROGETTO AUTOVALUTAZIONE D ISTITUTO FUNZIONE STRUMENTALE AREA 5 A. S. 2014/2015. DOCENTI REFERENTI: Maria Rosaria Basta ( scuola primaria )
 MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL UNIVERSITA E RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo Via F. BORROMEO VIA F. BORROMEO 53/57 00168 ROMA TEL./FAX 066281239 / 066145764 PROGETTO
MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL UNIVERSITA E RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo Via F. BORROMEO VIA F. BORROMEO 53/57 00168 ROMA TEL./FAX 066281239 / 066145764 PROGETTO
IL SENSO DELLA PSICOLOGIA
 INSEGNAMENTO DI: PSICOLOGIA GENERALE IL SENSO DELLA PSICOLOGIA PROF.SSA ANNAMARIA SCHIANO Indice 1 IL SENSO DELLA PSICOLOGIA -----------------------------------------------------------------------------------------
INSEGNAMENTO DI: PSICOLOGIA GENERALE IL SENSO DELLA PSICOLOGIA PROF.SSA ANNAMARIA SCHIANO Indice 1 IL SENSO DELLA PSICOLOGIA -----------------------------------------------------------------------------------------
Ruolo e funzioni del tutor alla luce delle indicazioni normative
 Ruolo e funzioni del tutor alla luce delle indicazioni normative Guido Garlati - Monza, 11 gennaio 2017 S Tutor accogliente Il percorso Legge 107/2015 S Legge 107/2015 4. Il comitato esprime altresì il
Ruolo e funzioni del tutor alla luce delle indicazioni normative Guido Garlati - Monza, 11 gennaio 2017 S Tutor accogliente Il percorso Legge 107/2015 S Legge 107/2015 4. Il comitato esprime altresì il
SUPERIORE DI SAN DANIELE DEL FRIULI VINCENZO MANZINI CORSI DI STUDIO:
 ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE DI SAN DANIELE DEL FRIULI VINCENZO MANZINI CORSI DI STUDIO: Amministrazione, Finanza e Marketing/IGEA Costruzioni, Ambiente e Territorio/Geometri Liceo Linguistico/Linguistico
ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE DI SAN DANIELE DEL FRIULI VINCENZO MANZINI CORSI DI STUDIO: Amministrazione, Finanza e Marketing/IGEA Costruzioni, Ambiente e Territorio/Geometri Liceo Linguistico/Linguistico
UNA PROPOSTA PER LAVORARE IN GRUPPO CON EFFICIENZA *
 UNA PROPOSTA PER LAVORARE IN GRUPPO CON EFFICIENZA * di Maria Luisa Peretti e Marina Russo La proposta di due schede di lavoro per i docenti, relative al Consiglio di classe e al Dipartimento per materie,
UNA PROPOSTA PER LAVORARE IN GRUPPO CON EFFICIENZA * di Maria Luisa Peretti e Marina Russo La proposta di due schede di lavoro per i docenti, relative al Consiglio di classe e al Dipartimento per materie,
L INVALSI e il Sistema Nazionale di Valutazione
 L INVALSI e il Sistema Nazionale di Valutazione N O D I E S F I D E D E L L A V A L U T A Z I O N E E D E L L I N N O V A Z I O N E I I C O N V E G N O N A Z I O N A L E R E T E L I. S A. C A. S A L E
L INVALSI e il Sistema Nazionale di Valutazione N O D I E S F I D E D E L L A V A L U T A Z I O N E E D E L L I N N O V A Z I O N E I I C O N V E G N O N A Z I O N A L E R E T E L I. S A. C A. S A L E
VERIFICA e VALUTAZIONE
 VERIFICA e I criteri della valutazione Modalità di verifica La valutazione disciplinare La valutazione del comportamento La certificazione delle competenze Le prove del sistema nazionale di valutazione
VERIFICA e I criteri della valutazione Modalità di verifica La valutazione disciplinare La valutazione del comportamento La certificazione delle competenze Le prove del sistema nazionale di valutazione
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA. Docente: Anna Aliberti. Classe 1^E EL. a.s: 20018/2019
 PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Docente: Anna Aliberti Classe 1^E EL. a.s: 20018/2019 FINALITA SPECIFICHE DEL BIENNIO Nel settore delle abilità linguistiche: - acquisizione della
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Docente: Anna Aliberti Classe 1^E EL. a.s: 20018/2019 FINALITA SPECIFICHE DEL BIENNIO Nel settore delle abilità linguistiche: - acquisizione della
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE Guglielmo Marconi Via Atzori, Nocera Inferiore (SA) - Tel.Fax:
 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE Guglielmo Marconi Via Atzori, 174-84014 Nocera Inferiore (SA) - Tel.Fax: 081 5174171 081 927918 D D PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI 2007-2013 Obiettivo "Convergenza"
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE Guglielmo Marconi Via Atzori, 174-84014 Nocera Inferiore (SA) - Tel.Fax: 081 5174171 081 927918 D D PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI 2007-2013 Obiettivo "Convergenza"
Lezione Le prestazioni autentiche
 Lezione Le prestazioni autentiche Le Prestazioni Autentiche: Permettono allo studente di dimostrare ciò che sa fare con ciò che sa, utilizzando conoscenze, abilità e disposizioni in situazioni contestualizzate,
Lezione Le prestazioni autentiche Le Prestazioni Autentiche: Permettono allo studente di dimostrare ciò che sa fare con ciò che sa, utilizzando conoscenze, abilità e disposizioni in situazioni contestualizzate,
SCUOLA MEDIA STATALE G. ROSSI SS. COSMA E DAMIANO A.S. 2016/2017 Area 1
 SCUOLA MEDIA STATALE G. ROSSI SS. COSMA E DAMIANO A.S. 2016/2017 Area 1 PROVE COMUNI COMPETENZE INIZIALI Il valore pedagogico/didattico E importante esplorare, all inizio dell anno scolastico, le conoscenze
SCUOLA MEDIA STATALE G. ROSSI SS. COSMA E DAMIANO A.S. 2016/2017 Area 1 PROVE COMUNI COMPETENZE INIZIALI Il valore pedagogico/didattico E importante esplorare, all inizio dell anno scolastico, le conoscenze
VALUTAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE DI SISTEMA 2
 VALUTAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE DI SISTEMA 2 LEGGE 53/2003 ART. 3 INValSI: Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione «ai fini del progressivo miglioramento e dell armonizzazione
VALUTAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE DI SISTEMA 2 LEGGE 53/2003 ART. 3 INValSI: Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione «ai fini del progressivo miglioramento e dell armonizzazione
PIANO ANNUALE PER L INCLUSIONE
 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia Via S.Antonio, 14-25133 Brescia - Codice Ipa: m_pi PIANO
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia Via S.Antonio, 14-25133 Brescia - Codice Ipa: m_pi PIANO
I. C. Piaget - Majorana. Valutazione ed autovalutazione
 I. C. Piaget - Majorana Valutazione ed autovalutazione La Valutazione nel processo di apprendimento La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico
I. C. Piaget - Majorana Valutazione ed autovalutazione La Valutazione nel processo di apprendimento La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico
ANNO SCOLASTICO: 2017/2018 MATERIA: DIRITTO-ECONOMIA INSEGNANTE: MARIA INSERO CLASSE: I F SERVIZI COMMERCIALI OPERATORE GRAFICO
 ANNO SCOLASTICO: 2017/2018 MATERIA: DIRITTO-ECONOMIA INSEGNANTE: MARIA INSERO CLASSE: I F SERVIZI COMMERCIALI OPERATORE GRAFICO FINALITA DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la disciplina):
ANNO SCOLASTICO: 2017/2018 MATERIA: DIRITTO-ECONOMIA INSEGNANTE: MARIA INSERO CLASSE: I F SERVIZI COMMERCIALI OPERATORE GRAFICO FINALITA DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la disciplina):
ANNO SCOLASTICO: 2017/2018 MATERIA: DIRITTO-ECONOMIA INSEGNANTE: MARIA INSERO CLASSE: I A SERVIZI COMMERCIALI
 ANNO SCOLASTICO: 2017/2018 MATERIA: DIRITTO-ECONOMIA INSEGNANTE: MARIA INSERO CLASSE: I A SERVIZI COMMERCIALI FINALITA DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la disciplina): COMPETENZE
ANNO SCOLASTICO: 2017/2018 MATERIA: DIRITTO-ECONOMIA INSEGNANTE: MARIA INSERO CLASSE: I A SERVIZI COMMERCIALI FINALITA DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la disciplina): COMPETENZE
Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri E. Fermi Pontedera (Pi)
 Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri E. Fermi Pontedera (Pi) Via Firenze, 51 - Tel. 0587/213400 - Fax 0587/52742 http://www.itcgfermi.it E-mail: mail@itcgfermi.it PIANO DI LAVORO Prof.ssa
Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri E. Fermi Pontedera (Pi) Via Firenze, 51 - Tel. 0587/213400 - Fax 0587/52742 http://www.itcgfermi.it E-mail: mail@itcgfermi.it PIANO DI LAVORO Prof.ssa
Bari, marzo 2015
 Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale UFFICIO V Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni
Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale UFFICIO V Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni
Programma del corso di STATISTICA ECONOMICA
 Programma del corso di STATISTICA ECONOMICA Insegnamento Corso di laurea Settore Scientifico STATISTICA ECONOMICA L18 - GESTIONE DI IMPRESA SECSS03 CFU 10 Obiettivi formativi per il raggiungimento dei
Programma del corso di STATISTICA ECONOMICA Insegnamento Corso di laurea Settore Scientifico STATISTICA ECONOMICA L18 - GESTIONE DI IMPRESA SECSS03 CFU 10 Obiettivi formativi per il raggiungimento dei
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALENA-TORRICELLA ISTRUZIONE INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO. Dir. Scolastico: Prof.ssa VIZZARRI IRENE FRIDA
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALENA-TORRICELLA ISTRUZIONE INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 2016-1-IT02-KA219-024192 Dir. Scolastico: Prof.ssa VIZZARRI IRENE FRIDA REPORT DATI A.S 2017/2018 a cura della
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALENA-TORRICELLA ISTRUZIONE INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 2016-1-IT02-KA219-024192 Dir. Scolastico: Prof.ssa VIZZARRI IRENE FRIDA REPORT DATI A.S 2017/2018 a cura della
La ricerca valutativa
 Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione La ricerca valutativa Daniele Morciano daniele.morciano@uniba.it La ricerca valutativa ricerca sociale al servizio dell interesse pubblico
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione La ricerca valutativa Daniele Morciano daniele.morciano@uniba.it La ricerca valutativa ricerca sociale al servizio dell interesse pubblico
PERCORSO FORMATIVO BIENNIO
 Modulo di lavoro Pagina 1 di 7 PERCORSO FORMATIVO BIENNIO Il dipartimento disciplinare chimico-biologico si pone come obiettivo quello di far acquisire agli studenti del biennio, al termine dell azione
Modulo di lavoro Pagina 1 di 7 PERCORSO FORMATIVO BIENNIO Il dipartimento disciplinare chimico-biologico si pone come obiettivo quello di far acquisire agli studenti del biennio, al termine dell azione
Criteri per l organizzazione del POF
 Criteri per l organizzazione del POF Proponiamo una serie di materiali che possono orientare a leggere e comprendere struttura e i criteri sottesi ad un POF. la Scheda 1 Analisi leggibilità del POF La
Criteri per l organizzazione del POF Proponiamo una serie di materiali che possono orientare a leggere e comprendere struttura e i criteri sottesi ad un POF. la Scheda 1 Analisi leggibilità del POF La
LA METRICA DI VALUTAZIONE CAF. La metrica di valutazione CAF
 1 LA METRICA DI VALUTAZIONE CAF LA METRICA CAF 2006 2 Sistema di punteggio - Premessa per una corretta comprensione dei sistemi di punteggio e loro uso (1) Il sistema di punteggio consente di quantificare
1 LA METRICA DI VALUTAZIONE CAF LA METRICA CAF 2006 2 Sistema di punteggio - Premessa per una corretta comprensione dei sistemi di punteggio e loro uso (1) Il sistema di punteggio consente di quantificare
Adattare i programmi di insegnamento. E la valutazione? Elio Gilberto Bettinelli Vignola,, 20 novembre 2008
 Adattare i programmi di insegnamento. E la valutazione? Elio Gilberto Bettinelli Vignola,, 20 novembre 2008 La domanda E giusto mandare avanti uno studente che, per le sue pur giustificate difficoltà linguistiche,
Adattare i programmi di insegnamento. E la valutazione? Elio Gilberto Bettinelli Vignola,, 20 novembre 2008 La domanda E giusto mandare avanti uno studente che, per le sue pur giustificate difficoltà linguistiche,
Curricolo verticale d'istituto e co-progettazione: integrazione tra le competenze dell'esperto e le esigenze della scuola
 Curricolo verticale d'istituto e co-progettazione: integrazione tra le competenze dell'esperto e le esigenze della scuola Paolo Seclì Università di Modena e Reggio Emilia Dip. di Educazione e Scienze Umane
Curricolo verticale d'istituto e co-progettazione: integrazione tra le competenze dell'esperto e le esigenze della scuola Paolo Seclì Università di Modena e Reggio Emilia Dip. di Educazione e Scienze Umane
IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI PARMA PRINCIPI
 Appendice al Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI PARMA PRINCIPI Approvato con deliberazione della Giunta comunale
Appendice al Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI PARMA PRINCIPI Approvato con deliberazione della Giunta comunale
VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI APPRENDIMENTI: TEST D INGRESSO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO SCOLASTICO 2015/16
 Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO ERODOTO CORIGLIANO CALABRO VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI APPRENDIMENTI: TEST D INGRESSO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO ERODOTO CORIGLIANO CALABRO VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI APPRENDIMENTI: TEST D INGRESSO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO
La valutazione degli alunni
 La valutazione degli alunni La valutazione degli studenti, è comprensiva del voto di comportamento, in base all articolo 2 della legge 169/2008. La valutazione degli apprendimenti per le varie discipline
La valutazione degli alunni La valutazione degli studenti, è comprensiva del voto di comportamento, in base all articolo 2 della legge 169/2008. La valutazione degli apprendimenti per le varie discipline
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ALIGHIERI - TANZI MOLA DI BARI ANNO SCOLASTICO 2011/1012
 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ALIGHIERI - TANZI MOLA DI BARI ANNO SCOLASTICO 2011/1012 ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (Scienze, Geografia, Tecnologia, Scienze Motorie) L asse scientifico-tecnologico ha l
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ALIGHIERI - TANZI MOLA DI BARI ANNO SCOLASTICO 2011/1012 ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (Scienze, Geografia, Tecnologia, Scienze Motorie) L asse scientifico-tecnologico ha l
LICEO STATALE V. LINARES. Relazione sugli esiti delle prove INVALSI a.s. 2015/2016 A cura della Prof.ssa Maria Di Franco
 LICEO STATALE V. LINARES Liceo Classico / Liceo Scientifico / Liceo delle Scienze Umane Via Prof. S. Malfitano n. 2-92027 Licata (AG) Tel. 0922-772266 Fax 0922-775234 Cod. Fiscale: 81000470849 - Cod. Mecc.:
LICEO STATALE V. LINARES Liceo Classico / Liceo Scientifico / Liceo delle Scienze Umane Via Prof. S. Malfitano n. 2-92027 Licata (AG) Tel. 0922-772266 Fax 0922-775234 Cod. Fiscale: 81000470849 - Cod. Mecc.:
Primo bimestre 2017/2018 REPORT MONITORAGGI
 Primo bimestre 2017/2018 REPORT MONITORAGGI OBIETTIVI INDICATORI E METRICHE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO TROVA ATTUAZIONE NELLE AZIONI DI OGNUNO Processi /Area RAV Punteggio RAV 16-17 PUNTI DI DEBOLEZZA
Primo bimestre 2017/2018 REPORT MONITORAGGI OBIETTIVI INDICATORI E METRICHE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO TROVA ATTUAZIONE NELLE AZIONI DI OGNUNO Processi /Area RAV Punteggio RAV 16-17 PUNTI DI DEBOLEZZA
La ricerca scientifica in educazione
 Analisi Qualitativa nei processi di insegnamento apprendimento G. Cappuccio La ricerca scientifica in educazione La ricerca scientifica in educazione tiene conto delle istanze che sono alla base della
Analisi Qualitativa nei processi di insegnamento apprendimento G. Cappuccio La ricerca scientifica in educazione La ricerca scientifica in educazione tiene conto delle istanze che sono alla base della
Liceo Antonio Rosmini -Rovereto
 PERCORSO DIDATTICO PERSONALIZZATO PER STUDENTI STRANIERI CLASSE FREQUENTATA: DATI ANAGRAFICI ANNO SCOLASTICO 2012-2013 Cognome e nome:. Data di nascita e Paese di provenienza: Mese e anno di arrivo in
PERCORSO DIDATTICO PERSONALIZZATO PER STUDENTI STRANIERI CLASSE FREQUENTATA: DATI ANAGRAFICI ANNO SCOLASTICO 2012-2013 Cognome e nome:. Data di nascita e Paese di provenienza: Mese e anno di arrivo in
Gli strumenti per la valutazione della scuola dell infanzia. Fossano, 2009
 Gli strumenti per la valutazione della scuola dell infanzia Fossano, 2009 Gli strumenti per la scuola dell infanzia l ACEI-ASEI Darder P., Mestres J. (1994), Autovalutazione dei servizi educativi per l
Gli strumenti per la valutazione della scuola dell infanzia Fossano, 2009 Gli strumenti per la scuola dell infanzia l ACEI-ASEI Darder P., Mestres J. (1994), Autovalutazione dei servizi educativi per l
La vocazione professionale e la carriera accademica. Report della prima fase di ricerca
 La vocazione professionale e la carriera accademica Report della prima fase di ricerca 1 Obiettivi dell indagine Il focus della nostra ricerca è la vocazione professionale: l esperienza di una passione
La vocazione professionale e la carriera accademica Report della prima fase di ricerca 1 Obiettivi dell indagine Il focus della nostra ricerca è la vocazione professionale: l esperienza di una passione
