La Chiesa di Santo Spirito in Agrigento
|
|
|
- Arnoldo Savino
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Marcella La Monica La Chiesa di Santo Spirito in Agrigento Stucchi di Serpotta e illusionismo pittorico-architettonico Contributi di Salvatore Alfano, Antonella Chiazza e Simona Sanzo E D I Z I O N I P A L E R M O
2 Printed in Italy 2009 Editrice Pitti Edizioni Palermo ISBN
3 INDICE Pag. 7 Premessa di Marcella La Monica» 9 Simona Sanzo 1. Cenni sull architettura della Chiesa di Santo Spirito.» Ingresso-Cantoria.» Aula liturgica.» Presbiterio.» 23 Marcella La Monica 2. Le opere scultoree e pittoriche nella Chiesa di Santo Spirito.» La scultura in stucco tra Barocco e Rococò: Giacomo Serpotta.» La committenza della decorazione.» Le componenti materiche dello stucco serpottiano.» Stile, iconografia e attribuzioni probabilistiche.» Confronti iconografici e implicazioni iconologiche.» La scultura in marmo: la Madonna di Domenico Gagini.» a. Materiali e tecniche.» b. Lo stile e la forma.» Cenni iconografici ed iconologici.» La scultura in marmo: l Altare maggiore di Vincenzo Mosca e gli altari minori di autori ignoti.» La scultura in marmo: l acquasantiera di autore ignoto.» La scultura in legno: il Crocifisso con il Reliquiario e la Madonna del Rosario.» a. Il Crocifisso con il Reliquiario: G. Cardilicchia, Moscato ed Avocato. Materiale e tecnica.» b. Brevi note stilistico-formali e iconografiche. 5
4 Pag La Madonna del Rosario di autore ignoto. Materiali e tecniche.» La porta: Domenico Provenzani.» Il tetto a cassettoni e la tela dello Spirito Santo: autori ignoti.» La Strage degli Innocenti: Antonio Napolitano.» La Madonna con San Benedetto e san Bernardo: Apelle Politi.» Gli affreschi parietali: autore ignoto.» La finta cupola: Giacomo Di Stefano.» a. Materiale e tecnica.» b. Aspetti formali.» c. Iconografia.» d. Spunti iconologici.» Riflessioni conclusive.» 151 Appendici» 153 Marcella La Monica 1. Profili di Giuseppe Serpotta, Procopio Serpotta e Domenico Provenzani.» a. Giuseppe Serpotta.» b. Procopio Serpotta.» c. Domenico Provenzani.» 159 Antonella Chiazza 2. «Presentazione di Gesù al tempio»: proporzioni e prospettiva.» 169 Simona Sanzo 3. Cenni sullo stato di conservazione.» a. Degrado degli stucchi.» b. Degrado della finta cupola.» c. Degrado del soffitto ligneo cassettonato.» d. Degrado della porta lignea di Domenico Provenzani.» 189 Elenco delle foto 6
5 Antonella Chiazza 2. «Presentazione di Gesù al tempio»: proporzioni e prospettiva. Il quadrone in stucco raffigurante La presentazione di Gesù al tempio, situato nella chiesa di Santo Spirito entrando a sinistra lungo la navata, è racchiuso all interno di un perimetro regolare di forma rettangolare le cui misure sono: 2,134 ml di larghezza per 2,70 ml di altezza, escludendo la cornice esterna che lo delimita. Si trova a 2,071 ml di altezza dal piano di calpestio e l altezza totale da quest ultimo è di circa 5 ml. Il testo di riferimento della rappresentazione scultorea realizzata da Giacomo Serpotta agli inizi del XVIII secolo, è il racconto descritto nel Vangelo di Luca (2,22-38) (v. quanto scritto precedentemente nel saggio di M. La Monica). Un dettagliato rilievo metrico e fotografico ha permesso di individuare i sistemi proporzionali e compositivi del quadrone serpottesco, all interno del quale si alternano sia figure a tuttotondo, sia altorilievi che bassorilievi. La statua a tuttotondo, raffigurante la figura maschile di Simeone (Fig. 136), la cui altezza complessiva è di 1,31 ml, è proporzionata secondo le proporzioni medie dello scheletro dell uomo: la testa, la cui misura è di 0,175 ml, è compresa sette volte e mezzo. Non viene pienamente rispettato (anche se di pochissimo) il canone classico policleteo che individua la misura della testa pari ad 1/8 dell altezza totale del corpo; si tratta, in realtà, di una lieve imprecisione probabilmente verificatasi durante la fase esecutiva dei lavori. Il canone proporzionale da unico che era nel Rinascimento, si moltiplicherà in diverse 1 ipotesi di rapporto tra testa e corpo. La presenza dell ampio panneggio che avvolge interamente la figura non ha consentito di poter effettuare un analisi dettagliata delle proporzioni anatomiche del corpo umano. Si è quindi analizzato il rapporto proporzionale tra la misura della testa e l altezza dell intera figura. Esaminando dettagliatamente il volto (Fig. 137) sono state individuate alcune proporzioni auree basate sul numero irrazionale detto Φ = 1+ 5/2 = 1, che è noto con il nome di numero aureo, e definito come il rapporto della sezione aurea, o proporzione aurea. 159
6 160 Fig Proporzionamento della statua di Simeone secondo il canone classico: testa = 1/8 dell altezza totale. Il canone non è pienamente rispettato: testa = 7½ circa. h tot. = ml 1,31; testa = ml 0,175; modulo = 7½ circa; Scala 1:10.
7 Fig Particolare della testa della statua con le relative proporzioni auree individuate: la distanza fra il margine inferiore del mento e l occhio, e dall occhio sino all apice della fronte; la distanza tra la fronte e la bocca rispetto alla distanza tra la bocca e il mento. Sono uguali le distanze tra la fronte e l occhio e tra la bocca e il mento. Si individua una figura quadrata che misura la distanza tra l arcata sopraccigliare e il mento. (Scala 1:3) 161
8 La sezione aurea è considerata come legge universale dell armonia, la giusta proporzione tra due elementi, perché essi appaiano armoniosi all occhio umano. Nel XVIII secolo, periodo al quale risale l opera del Serpotta, si scoprì che i rapporti tra i numeri della sequenza di Fibonacci (matematico pisano del XIII secolo) convergono proprio sul numero irrazionale phi. Questo significa che ogni numero della sequenza è circa 1, volte più grande del numero che lo precede. Il numero aureo, conosciuto presso gli antichi Greci e ripreso nel Rinascimento, troverà applicazione anche nei secoli successivi nella pittura, nell architettura, nella botanica e nella musica suscitando sempre molto interesse ed ammirazione. Gli studi sulle proporzioni del corpo umano, dal Rinascimento in poi, si amplieranno legandosi a moduli sempre più complessi come quelli che, per l appunto, definiscono le regole della sezione aurea. Ritornando al volto della statua di Simeone, le proporzioni governate da numeri irrazionali infinitesimali regolano la distanza tra il mento e il margine inferiore dell occhio e da quest ultimo sino all apice della fronte. Inoltre, la distanza tra la fronte e la bocca si pone come segmento aureo rispetto alla distanza tra la bocca e il mento. Risultano uguali le distanze tra la fronte e l occhio e tra la bocca e il mento. Nel volto si individua, infine, una figura quadrata che verticalmente misura la distanza tra l arcata sopraccigliare e il mento. Oltre lo studio delle proporzioni si sono analizzati alcuni elementi della grammatica visiva come la composizione e lo spazio. La Fig. 138 evidenzia come nel quadrone, dove fa da sfondo un ambientazione architettonica, la prospettiva centrale non è applicata in modo rigoroso. Tutte le linee parallele tra loro e perpendicolari al quadro prospettico non convergono in un punto posto di fronte l osservatore (punto di fuga). La molteplicità dei punti di fuga (ne sono stati individuati tre) comporta un continuo movimento dell occhio, facendo così percepire uno spazio dinamico. La prospettiva diventa, pertanto, non più uno strumento di conoscenza razionale dello spazio ma, al contrario, una realtà immaginaria, uno spazio più ampio del reale, quasi infinito, grazie all utilizzo di elaboratissimi artifici visivi. Un artificio visivo, per esempio, è costituito dalla presenza della concavità (un po forzata) del colonnato di ordine composito e della trabeazione che sembra dilatare lo spazio dando origine ad un effetto avvolgente. Il colonnato, inoltre, sembra scandire la sequenza ritmica e temporale dell episodio evangelico; l ultima colonna a destra è perfettamente in corrispondenza di Simeone e del Bambino Gesù. 162
9 Fig Analisi della rappresentazione prospettica dello spazio: la prospettiva centrale viene stravolta per la presenza di molteplici punti di fuga (F1, F2, F3); si percepisce uno spazio dinamico ed illusionistico grazie all utilizzo di artifici visivi. 163
10 Tale sfondo architettonico (un esplicito richiamo al classicismo romano), si rifà alle nicchie borrominiane di Casa Professa a Pa- 2 lermo. L inclinazione, secondo un angolo di circa 30, del piano orizzontale inferiore del quadrone (la cui profondità è di circa 0,54 ml), sembra realizzata in modo da creare un palcoscenico inclinato che proietta le immagini scultoree in avanti verso l osservatore, il quale viene invitato ad entrare a far parte della scena; la figura di Simeone, grazie a questo artificio, sembra leggermente sovradimensionata. In realtà, come già detto, essa rispetta il canone proporzionale dello scheletro dell uomo (Fig. 137). Attraverso un analitico esame geometrico del quadrone è plausibile affermare che l inclinazione del piano geometrale abbia contribuito non poco ad alterare la rappresentazione centrale dello spazio, facendo convergere alcune rette perpendicolari al quadro prospettico nel punto di fuga F1 situato su una linea d orizzonte (luogo dei punti di fuga degli infiniti fasci di rette orizzontali e non parallele al quadro) più alta rispetto alle altre individuate (Fig. 139). L altezza della linea d orizzonte corrisponde anche all altezza del punto di vista e viceversa. Avendo individuato più punti di vista separati tra loro, si può ragionevolmente supporre che la rappresentazione sia stata creata su un accurato ed artificioso montaggio di più prospettive. L opera, pertanto, presenta una impostazione visiva centrica, anche se tale veduta preferenziale non viene mantenuta a causa della presenza della molteplicità dei punti di fuga, creando una serie di rimandi visivi che si concludono nella figura in posizione asimmetrica di Simeone e del Bambino Gesù. La geometria e la prospettiva perdono l originaria funzione di porre con scientificità gli oggetti nello spazio, lasciando il posto allo stupore, grazie alla grande forza comunicativa che esse impongono, coinvolgendo l osservatore sia sul piano percettivo che su quello affettivo: egli «entra» e partecipa alla storia del racconto evangelico raffigurato davanti ai suoi occhi. Le aberrazioni o espedienti applicati alla prospettiva fanno si che la rappresentazione venga osservata non dal corretto punto di vista o con il giusto angolo visuale. In tal modo tale il ciclo della restituzione visiva, ripetendosi più volte, costringe l osservatore ad una percezione più attenta e ad una analisi più approfondita dell opera scultorea. Un espediente prospettico usato dal Serpotta anche nei teatrini degli oratori palermitani consiste nel collocare le figure a bassorilievo dietro le sculture a tuttotondo e tra gli elementi architettonici. Questa differenziazione del rilievo, che diventa minimo in alcuni punti, pone lo spetta- 164
11 Fig Proporzioni auree nell architettura del quadrone: s individua un rettangolo aureo tra la larghezza compresa dalla prima colonna a destra alla base della prima colonna a sinistra e l altezza del colonnato e della trabeazione. La larghezza e l altezza dell apertura ad arco a sesto ribassato sono proporzionati secondo un rapporto aureo. La finestra rettangolare sopra la trabeazione è anch essa un rettangolo aureo. 165
12 tore su un piano percettivo nel quale la profondità spaziale sembra più estesa di quanto non lo sia in realtà; così pure le gambe del putto seduto, che debordano dalla cornice delimitante il quadrone, invadendo lo spazio reale, generano una falsa percezione della profondità spaziale e suggeriscono una continuità fra spazio reale e spazio rappresentato. Mentre nei teatrini serpotteschi la prospettiva viene affrontata con un certo rigore scientifico desunto dall influente libro di Paolo Amato «La nuova pratica di prospetti- 3 va» (pubblicato in parte a Palermo nel 1714) nelle opere della maturità, in particolare nei fastosi stucchi della chiesa di S. Spirito, sembra che venga a mancare il grande rigore dello scultore palermitano, forse a causa dell intromissione durante l esecuzione dei lavori di aiutanti o del fratello Giuseppe. Da questa produzione di équipe probabilmente «derivano gli scompensi qualitativi riscontrabili in alcune parti delle decorazioni»..., ma, comunque, «la qualità plastica dei rilievi agrigentini è sufficientemente alta per dare per 4 certo l intervento di Giacomo nel lavoro». La rappresentazione illusoria dello spazio di cui Giacomo Serpotta era un interprete eccezionale come infinita e molteplice continuità spaziale, nasce da una nuova concezione dello spazio maturata dalla crisi della cultura umanistica e rinascimentale, in seguito alla lunga serie di sconvolgenti scoperte scientifiche succedutesi lungo l intero arco del 500 e precisate poi dai risultati delle indagini successive: scoperte che sovvertirono la tradizionale concezione geocentrica e antropocentrica del mondo. Le scoperte di Copernico fecero crollare la convinzione della centralità della terra e, quindi, venne infranta anche la tradizionale concezione dell uomo come centro della terra e dell Universo. Ma furono soprattutto le scoperte di Keplero sulla rotazione dei pianeti intorno al sole secondo ellissi, e di Galilei sull estensione e sulla consistenza materica dell Universo celeste che generarono effetti riconoscibili soprattutto sulla concezione visiva della natura e dello spazio nella cultura barocca. La «perdita del centro», la disgregazione della concezione antropocentrica dell Universo, il rinnovato legame dell uomo «nuovo» col divino identificato e compenetrato con il continuo divenire della natura, delle emozioni, delle sensazioni e dell esistenza umana, si concretizzano nella rappresentazione illusiva dello spazio che si estende al di là dei limiti reali implicando anche un illusiva traduzione visiva di tempo infinito. In alcuni dei putti presenti nel quadrone si evidenziano delle incertezze anatomiche: gli arti superiori, in particolare, presentano una muscolatura sviluppata in maniera esagerata rispetto al resto del corpo; le teste, al contrario, appaiono sottodimensionate rispetto all altezza e alla corporatura. 166
13 I putti del Serpotta, infatti, non hanno corpi infantili «ma sono adulti in miniatura, 6 con muscolature pronunciate e titaniche». La mano della donna genuflessa protesa in avanti è troppo grande rispetto al corpo. Altre imperfezioni compositive si osservano al di là del colonnato nelle aperture ad arco a sesto ribassato, scolpite a bassorilievo, che non sono sempre precise da un punto di vista geometrico e sembrano illusoriamente archi a tutto sesto. Inoltre, la prima colonna a sinistra presenta un anomalia nel fusto. La rastremazione di quest ultimo inizia a 1/3 circa della sua altezza (mentre le altre colonne hanno il fusto interamente rastremato); visivamente la colonna risulta instabile ed insufficiente a «sorreggere» il peso della struttura sovrastante. Tale instabilità ricomposta ai limiti dell equilibrio, è tipica del linguaggio barocco, così come il virtuosismo tecnico che contribuisce a ricreare tale equilibrio producendo esiti stupefacenti. L equilibrio compositivo viene ricomposto grazie alla presenza di alcuni rapporti proporzionali basati sul numero aureo che regolano l architettura presente nell opera (Fig. 140). In particolare la larghezza tra la prima colonna a destra e la base della prima colonna a sinistra e l altezza del colonnato e della trabeazione delineano un rettangolo aureo. La larghezza e l altezza dell apertura ad arco a sesto ribassato sono proporzionati secondo un rapporto aureo. Così come la finestra di forma rettangolare sopra la trabeazione non è altro che un rettangolo aureo. Equilibrio ed instabilità, spiritualità e materialità, infinito e finito, divinità e natura, coesistono e si identificano continuamente, così come coesiste nell osservatore la sua duplice identità di attore e spettatore privilegiato della «rappresentazione teatrale» voluta e diretta dalla Divina Provvidenza. 167
14 NOTE 1 Marco Bussagli, Il corpo umano. Anatomia e significati simbolici, Electa, Milano, 2005, pag. 93. Per la proporzione e la sezione aurea si vedano: Erwin Panofsky, Il significato nelle arti visive, Einaudi, Torino, 1962; Cesare Bairati, La simmetria dinamica. Scienza ed arte nell architettura classica, Electa, Milano, 1993; Antonella Chiazza, Proporzioni delle statue. Analisi e cenni storici, in Marcella La Monica, Il monumento a Filippo V, Palermo, 2007, pagg Donald Garstang, Giacomo Serpotta e i serpottiani, Flaccovio, Palermo, 2006, pag Donald Garstang, op. cit., pag Giovanni Carandente, Giacomo Serpotta, Torino, 1967, pag Aa.Vv., La storia dell arte, vol. 12, Electa, Milano, 2006, pag Donald Garstang, op. cit., pag
 Antonella Chiazza Geometria e proporzioni nelle sculture di Valerio Villareale. Lo studio e l analisi della geometria e delle proporzioni si sono effettuati su due mezzi-busti marmorei a tuttotondo intitolati
Antonella Chiazza Geometria e proporzioni nelle sculture di Valerio Villareale. Lo studio e l analisi della geometria e delle proporzioni si sono effettuati su due mezzi-busti marmorei a tuttotondo intitolati
La sezione aurea nelle sue molteplici
 La sezione aurea nelle sue molteplici applicazioni Nella geometria piana il rapporto aureo trova molteplici applicazioni. Se prendiamo un segmento AB =, la sua parte aurea AD vale circa 0,68 (Figura ).
La sezione aurea nelle sue molteplici applicazioni Nella geometria piana il rapporto aureo trova molteplici applicazioni. Se prendiamo un segmento AB =, la sua parte aurea AD vale circa 0,68 (Figura ).
Associazione Italiana Amici del Presepio Sezione di Cinisello Balsamo. incontro formativo. La Tecnica della Prospettiva
 incontro formativo Definizione di prospettiva Cosa significa prospettiva Rappresentazione degli oggetti nello spazio, nel disegno, nella pittura ma anche nella scultura in bassorilievo o altorilievo, in
incontro formativo Definizione di prospettiva Cosa significa prospettiva Rappresentazione degli oggetti nello spazio, nel disegno, nella pittura ma anche nella scultura in bassorilievo o altorilievo, in
Tre finestre rettangolari, decorate con vetri multicolore raffiguranti S. Pietro, S. Paolo e Gesù Cristo, illuminano la cantoria e la navata centrale
 Descrizione Oggetto Esterno La Chiesa dei S.S. Pietro e Paolo presenta una tipica facciata a capanna (fotografia 1). Il portale principale (fotografia 2), recante il simbolo del Giubileo del 2000 (fotografia
Descrizione Oggetto Esterno La Chiesa dei S.S. Pietro e Paolo presenta una tipica facciata a capanna (fotografia 1). Il portale principale (fotografia 2), recante il simbolo del Giubileo del 2000 (fotografia
Onzo, un affresco perduto ritrovato nella cappella di San Giuseppe a Varavo
 1 Onzo, un affresco perduto ritrovato nella cappella di San Giuseppe a Varavo Domenica 7 maggio 2017 Onzo. Un affresco perduto e risalente probabilmente al XVIII secolo è stato recentemente ritrovato in
1 Onzo, un affresco perduto ritrovato nella cappella di San Giuseppe a Varavo Domenica 7 maggio 2017 Onzo. Un affresco perduto e risalente probabilmente al XVIII secolo è stato recentemente ritrovato in
Lettura di un opera d arte. Lettura formale di un opera d arte
 Lettura di un opera d arte Per leggere un opera d arte, 1) si analizzano i materiali e la tecnica con cui è stata creata; 2) si effettua la LETTURA FORMALE, analizzando gli elementi fondamentali di quella
Lettura di un opera d arte Per leggere un opera d arte, 1) si analizzano i materiali e la tecnica con cui è stata creata; 2) si effettua la LETTURA FORMALE, analizzando gli elementi fondamentali di quella
CORSO DI FONDAMENTI DI DISEGNO TECNICO LEZIONE 4 PROSPETTIVA
 PERCORSI ABILITANTI SPECIALI (PAS) - A.A. 2013-2014 UNIVERSITÀ DI PISA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE (DICI) CORSO DI FONDAMENTI DI DISEGNO TECNICO LEZIONE 4 PROSPETTIVA 1 Raffaello (1483
PERCORSI ABILITANTI SPECIALI (PAS) - A.A. 2013-2014 UNIVERSITÀ DI PISA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE (DICI) CORSO DI FONDAMENTI DI DISEGNO TECNICO LEZIONE 4 PROSPETTIVA 1 Raffaello (1483
Corso di Laurea in Scienze dell Architettura
 Università degli Studi di Roma Facoltà di Architettura AA 2013 2014 Corso di Laurea in Scienze dell Architettura Corso di Disegno Riccardo Migliari 1, Marta Salvatore 2, Jessica Romor 3 1 Professore ordinario
Università degli Studi di Roma Facoltà di Architettura AA 2013 2014 Corso di Laurea in Scienze dell Architettura Corso di Disegno Riccardo Migliari 1, Marta Salvatore 2, Jessica Romor 3 1 Professore ordinario
Protocollo dei saperi imprescindibili
 DISCIPLINA: Discipline Plastiche e scultoree CLASSE: I^ A /B Le tecniche e i metodi di base del disegno funzionali ad una corretta rappresentazione grafica del volume. I materiali, le tecniche e gli strumenti
DISCIPLINA: Discipline Plastiche e scultoree CLASSE: I^ A /B Le tecniche e i metodi di base del disegno funzionali ad una corretta rappresentazione grafica del volume. I materiali, le tecniche e gli strumenti
Il monumento a Filippo V a Palermo
 Marcella La Monica Il monumento a Filippo V a Palermo Stile e iconografia Contributo di Antonella Chiazza EDIZIONI MARCELLA LA MONICA IL MONUMENTO A FILIPPO V A PALERMO STILE E ICONOGRAFIA CONTRIBUTO DI
Marcella La Monica Il monumento a Filippo V a Palermo Stile e iconografia Contributo di Antonella Chiazza EDIZIONI MARCELLA LA MONICA IL MONUMENTO A FILIPPO V A PALERMO STILE E ICONOGRAFIA CONTRIBUTO DI
modulo a SEZIONE 1 LA PROSPETTIVA
 IV INDICE SEZIONE 1 LA PROSPETTIVA modulo a PRoSPETTIVE CENTRalI E accidentali: metodi E TECNICHE 1 Proiezioni prospettiche 2 1.1 la prospettiva nel mondo moderno 2 1.2 Elementi necessari per eseguire
IV INDICE SEZIONE 1 LA PROSPETTIVA modulo a PRoSPETTIVE CENTRalI E accidentali: metodi E TECNICHE 1 Proiezioni prospettiche 2 1.1 la prospettiva nel mondo moderno 2 1.2 Elementi necessari per eseguire
Programmazione finale della classe IIA Discipline Geometriche a.s
 Programmazione finale della classe IIA Discipline Geometriche a.s. 2012-13 Il programma di Disegno Geometrico è stato svolto in due ambiti: quello teorico che - dall analisi dei segni convenzionali, degli
Programmazione finale della classe IIA Discipline Geometriche a.s. 2012-13 Il programma di Disegno Geometrico è stato svolto in due ambiti: quello teorico che - dall analisi dei segni convenzionali, degli
Applicazioni - Prospettiva, arte e architettura
 Applicazioni - Prospettiva, arte e architettura - Fino al Rinascimento, pittori ed architetti non furono in grado di attrezzarsi di risorse tecniche per rappresentare gli oggetti tridimensionali e la prospettiva.
Applicazioni - Prospettiva, arte e architettura - Fino al Rinascimento, pittori ed architetti non furono in grado di attrezzarsi di risorse tecniche per rappresentare gli oggetti tridimensionali e la prospettiva.
ANAT ANA O T MIA G ENERALE GENERALE U MANA UMANA
 CORSO DI FORMAZIONE TECNICO EDUCATORE REGIONALE LA MACCHINA DELL UOMO: CENNI DI FISIOLOGIA, ANATOMIA DELL APPARATO LOCOMOTORE TERMINOLOGIA ANATOMICA Relatore: Dott.Michele Bisogni Medico chirurgo Specializzando
CORSO DI FORMAZIONE TECNICO EDUCATORE REGIONALE LA MACCHINA DELL UOMO: CENNI DI FISIOLOGIA, ANATOMIA DELL APPARATO LOCOMOTORE TERMINOLOGIA ANATOMICA Relatore: Dott.Michele Bisogni Medico chirurgo Specializzando
COMUNICAZIONE N.17 DEL
 COMUNICAZIONE N.17 DEL 03.04.20131 1- SECONDO MODULO - APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (16): ESEMPI 134-143 2 - QUARTO MODULO - CLASSICI MODERNI E CONTEMPORANEI (15): REM KOOLHAAS, VILLA DALL'AVA,
COMUNICAZIONE N.17 DEL 03.04.20131 1- SECONDO MODULO - APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (16): ESEMPI 134-143 2 - QUARTO MODULO - CLASSICI MODERNI E CONTEMPORANEI (15): REM KOOLHAAS, VILLA DALL'AVA,
LINGUAGGI, CREATIVITA, ESPRESSIONE
 CURRICOLO VERTICALE DI ARTE E IMMAGINE. LINGUAGGI, CREATIVITA, ESPRESSIONE INDICATORI DI COMPETENZA Esplorare i materiali a disposizione per utilizzarli con creatività. Comunicare, raccontare, esprimere
CURRICOLO VERTICALE DI ARTE E IMMAGINE. LINGUAGGI, CREATIVITA, ESPRESSIONE INDICATORI DI COMPETENZA Esplorare i materiali a disposizione per utilizzarli con creatività. Comunicare, raccontare, esprimere
LICEO ARTISTICO STATALE Giacomo e Pio Manzù BERGAMO TABELLA DEI MINIMI DISCIPLINARI TRIENNIO RIFORMA DISCIPLINE PROGETTUALI
 DISCIPLINE PROGETTUALI CLASSE TERZA MODULO ARGOMENTO/CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI Riepilogo dei metodi proiettivi del disegno tecnico: - Proiezioni cilindriche proiezioni ortogonali (metodo di Monge) assonometrie
DISCIPLINE PROGETTUALI CLASSE TERZA MODULO ARGOMENTO/CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI Riepilogo dei metodi proiettivi del disegno tecnico: - Proiezioni cilindriche proiezioni ortogonali (metodo di Monge) assonometrie
AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA
 AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA Campo d'esperienza: Linguaggi, creatività, espressione TRAGUAR TRAGUAR TRAGUAR 1, 2, 3 anno della Scuola dell'infanzia l'alunno segue con attenzione e con piacere
AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA Campo d'esperienza: Linguaggi, creatività, espressione TRAGUAR TRAGUAR TRAGUAR 1, 2, 3 anno della Scuola dell'infanzia l'alunno segue con attenzione e con piacere
Arte e Immagine Classe Prima
 Arte e Immagine Classe Prima Traguardi Obiettivi di apprendimento Contenuti Attività Competenze chiave e di cittadinanza L alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre
Arte e Immagine Classe Prima Traguardi Obiettivi di apprendimento Contenuti Attività Competenze chiave e di cittadinanza L alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre
COMUNICAZIONE N.10 DEL
 COMUNICAZIONE N.10 DEL 16.01.20131 1 - IL PROSPETTO E LA SEZIONE Per il testo e le immagini, si rimanda al testo: Daniele Colistra, Il disegno dell'architettura e della città, Reggio Calabria 2003 disponibile
COMUNICAZIONE N.10 DEL 16.01.20131 1 - IL PROSPETTO E LA SEZIONE Per il testo e le immagini, si rimanda al testo: Daniele Colistra, Il disegno dell'architettura e della città, Reggio Calabria 2003 disponibile
I.C. Francesco Cilea via Cilea 269 Roma. Esprimersi e comunicare. Osservare e leggere le immagini. Comprendere e apprezzare le opere d arte
 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (al termine della Scuola Secondaria di 1 grado) ABILITA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARTE E IMMAGINE CONOSCENZE/ESPERIENZE L alunno padroneggia gli elementi della
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (al termine della Scuola Secondaria di 1 grado) ABILITA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARTE E IMMAGINE CONOSCENZE/ESPERIENZE L alunno padroneggia gli elementi della
ARTE E IMMAGINE NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA. riconoscere ed usare i linguaggi visivi. Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi.
 ARTE E IMMAGINE NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA Capacità di vedere osservare e comprendere riconoscere ed usare i linguaggi visivi. Conoscenza ed uso delle tecniche espressive. Produzione e rielaborazione
ARTE E IMMAGINE NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA Capacità di vedere osservare e comprendere riconoscere ed usare i linguaggi visivi. Conoscenza ed uso delle tecniche espressive. Produzione e rielaborazione
Procedimento di progettazione e realizzazione del bassorilievo prospettico
 Procedimento di progettazione e realizzazione del bassorilievo prospettico Il bassorilievo prospettico ha origini nel Rinascimento fiorentino e la sua caratteristica peculiare è la presenza del sottosquadro,
Procedimento di progettazione e realizzazione del bassorilievo prospettico Il bassorilievo prospettico ha origini nel Rinascimento fiorentino e la sua caratteristica peculiare è la presenza del sottosquadro,
La percezione visiva:
 La percezione visiva: le sue leggi e le illusioni ottiche. Forma, colore, spazio, sono i principali componenti delle immagini. Entro i sei anni di vita, si formano alcuni meccanismi percettivi molto sofisticati
La percezione visiva: le sue leggi e le illusioni ottiche. Forma, colore, spazio, sono i principali componenti delle immagini. Entro i sei anni di vita, si formano alcuni meccanismi percettivi molto sofisticati
Presso la nuova civiltà così delineatasi, l arte assunse significati e finalità prima sconosciuti configurandosi come LIBERA ESPRESSIONE DELL
 Quadro di sintesi L origine della civiltà greca si fa risalire ai fenomeni migratori dell XI secolo a.c., quando la popolazione dei Dori calò sulle civiltà già insediatesi nel territorio greco La popolazione
Quadro di sintesi L origine della civiltà greca si fa risalire ai fenomeni migratori dell XI secolo a.c., quando la popolazione dei Dori calò sulle civiltà già insediatesi nel territorio greco La popolazione
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
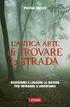 OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI WWW.ARTEIMMAGINECOSSATO.IT Osservare le immagini Noi conosciamo il mondo che ci circonda grazie ai messaggi che esso ci trasmette e che i nostri sensi percepiscono. Gli
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI WWW.ARTEIMMAGINECOSSATO.IT Osservare le immagini Noi conosciamo il mondo che ci circonda grazie ai messaggi che esso ci trasmette e che i nostri sensi percepiscono. Gli
Bassorilievi e pitture nell antico Egitto
 Bassorilievi e pitture nell antico Egitto 1. Paletta di Narmer. Circa 3100 a.c. Particolare. La rappresentazione figurativa egizia è sostanzialmente legata alla struttura della scrittura geroglifica. Questa
Bassorilievi e pitture nell antico Egitto 1. Paletta di Narmer. Circa 3100 a.c. Particolare. La rappresentazione figurativa egizia è sostanzialmente legata alla struttura della scrittura geroglifica. Questa
APPENDICE. 74 Nella prospettiva seguente due dei quattro solidi hanno uguale altezza, quali?
 T07_PPNII_UNIO -0-009 7:0 Pagina 7 Nella prospettiva seguente due dei quattro solidi hanno uguale altezza, quali? 77 L assonometria rappresenta un gruppo di parallelepipedi. Quale delle viste dall alto
T07_PPNII_UNIO -0-009 7:0 Pagina 7 Nella prospettiva seguente due dei quattro solidi hanno uguale altezza, quali? 77 L assonometria rappresenta un gruppo di parallelepipedi. Quale delle viste dall alto
Lo studio della pittura parietale pompeiana fu affrontato per la prima volta da August Mau
 LA PITTURA Il primo tipo di pittura che Roma ebbe fu quella trionfale, destinata ad illustrare le gesta vittoriose dei condottieri. Si tratta di dipinti che non sono arrivati sino a noi, cosi come perduti
LA PITTURA Il primo tipo di pittura che Roma ebbe fu quella trionfale, destinata ad illustrare le gesta vittoriose dei condottieri. Si tratta di dipinti che non sono arrivati sino a noi, cosi come perduti
ISTITUTO COMPRENSIVO G.PASCOLI DI GERMIGNAGA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA MATERIA OGGETTO DELLA PROGRAMMAZIONE ARTE E IMMAGINE
 SCUOLA PRIMARIA Anno scolastico 2016/2017 Responsabile programmazione Insegnanti Destinatari (Classe/Gruppo) Durata (dal-al) Ore settimanali CL. V Anno scolastico MATERIA OGGETTO DELLA PROGRAMMAZIONE ARTE
SCUOLA PRIMARIA Anno scolastico 2016/2017 Responsabile programmazione Insegnanti Destinatari (Classe/Gruppo) Durata (dal-al) Ore settimanali CL. V Anno scolastico MATERIA OGGETTO DELLA PROGRAMMAZIONE ARTE
La Galleria Spada. Università degli studi di Verona Laurea magistrale in Discipline artistiche e archeologiche Corso di Storia dell architettura
 Università degli studi di Verona Laurea magistrale in Discipline artistiche e archeologiche Corso di Storia dell architettura La Galleria Spada Federica Franchetto 1 LA GALLERIA DI PALAZZO SPADA L interesse
Università degli studi di Verona Laurea magistrale in Discipline artistiche e archeologiche Corso di Storia dell architettura La Galleria Spada Federica Franchetto 1 LA GALLERIA DI PALAZZO SPADA L interesse
Piano di Studio di Istituto ARTE E IMMAGINE
 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 Piano di Studio di Istituto ARTE E IMMAGINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZA
ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 Piano di Studio di Istituto ARTE E IMMAGINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZA
ANNO: MARMO BIANCO E LEGNO DORATO DIMENSIONE: 160 X 120 CON LETTO DI 192 COLLOCAZIONE: ROMA. GALLERIA BORGHESE. LUOGO DI ESECUZIONE:
 ANTONIO CANOVA. NASCE A TREVISO NEL 1757.POCO PIU CHE ADOLESCENTE SI TRASFERISCE A VENEZIA PER FREQUENTARE L ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI. L ARTE VENETA ERA ANCORA IMPREGNATA DEL ROCOCO E CANOVA NON NE E
ANTONIO CANOVA. NASCE A TREVISO NEL 1757.POCO PIU CHE ADOLESCENTE SI TRASFERISCE A VENEZIA PER FREQUENTARE L ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI. L ARTE VENETA ERA ANCORA IMPREGNATA DEL ROCOCO E CANOVA NON NE E
ARTE E IMMAGINE. Classe prima. Produrre messaggi attraverso l uso di linguaggi, tecniche e materiali diversi
 ARTE E IMMAGINE Classe prima NUCLEI ESSENZIALI Traguardi di SVILUPPO di COMPETENZA CONOSCENZE (i saperi) ABILITA (saper fare) ELEMENTI DEL LINGUAGGIO VISIVO Produrre messaggi attraverso l uso di linguaggi,
ARTE E IMMAGINE Classe prima NUCLEI ESSENZIALI Traguardi di SVILUPPO di COMPETENZA CONOSCENZE (i saperi) ABILITA (saper fare) ELEMENTI DEL LINGUAGGIO VISIVO Produrre messaggi attraverso l uso di linguaggi,
Progettazione Multimediale REGOLE DI COMPOSIZIONE GRAFICA. Parte 3. Lo spazio. Prof. Gianfranco Ciaschetti
 Progettazione Multimediale REGOLE DI COMPOSIZIONE GRAFICA Parte 3 Lo spazio Prof. Gianfranco Ciaschetti Solitamente, per spazio intendiamo un volume in tre dimensioni di estensione illimitata. In grafica,
Progettazione Multimediale REGOLE DI COMPOSIZIONE GRAFICA Parte 3 Lo spazio Prof. Gianfranco Ciaschetti Solitamente, per spazio intendiamo un volume in tre dimensioni di estensione illimitata. In grafica,
SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 SCUOLA PRIMARIA ARTE E IMMAGINE CLASSE 1^ relative al linguaggio visivo per produrre varie comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi,
SCUOLA PRIMARIA ARTE E IMMAGINE CLASSE 1^ relative al linguaggio visivo per produrre varie comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi,
Verifica finale MODULO D. Esercizio 16. fig. 5
 l l h III PRESENTAZIONE Questa quarta edizione ampliata di Spazio Immagini condivide i tratti essenziali del progetto originario, conservati nelle diverse edizioni dell opera: la concezione della geometria
l l h III PRESENTAZIONE Questa quarta edizione ampliata di Spazio Immagini condivide i tratti essenziali del progetto originario, conservati nelle diverse edizioni dell opera: la concezione della geometria
Programmazione finale classe II L A a.s. 2015/2016 Materia: Discipline Geometriche Docente: Antonio Caputo
 1. MODULI DISCIPLINARI PERIODO / DURATA Modulo n. 1 Proiezioni Ortogonali - Approfondimento U.D. Introduttiva - Il ripasso del sistema di rappresentazione studiato nell anno scolastico precedente: le proiezioni
1. MODULI DISCIPLINARI PERIODO / DURATA Modulo n. 1 Proiezioni Ortogonali - Approfondimento U.D. Introduttiva - Il ripasso del sistema di rappresentazione studiato nell anno scolastico precedente: le proiezioni
Prodo3o realizzato con il contributo della Regione Toscana nell'ambito dell'azione regionale di sistema. Laboratori del Sapere Scien0fico
 Prodo3o realizzato con il contributo della Regione Toscana nell'ambito dell'azione regionale di sistema Laboratori del Sapere Scien0fico LA SEZIONE AUREA IN CLASSE I numeri e la geometria CLASSI 3 - Scuola
Prodo3o realizzato con il contributo della Regione Toscana nell'ambito dell'azione regionale di sistema Laboratori del Sapere Scien0fico LA SEZIONE AUREA IN CLASSE I numeri e la geometria CLASSI 3 - Scuola
PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE DEL GRUPPO DI DISCIPLINE PITTORICHE
 PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE DEL GRUPPO DI DISCIPLINE PITTORICHE 1) OBIETTIVI CONCORDATI IN TERMINI CONOSCENZE COMPETENZE E CAPACITÀ Classe PRIMA Parametri Obiettivi Livelli (*= STANDARD MINIMO
PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE DEL GRUPPO DI DISCIPLINE PITTORICHE 1) OBIETTIVI CONCORDATI IN TERMINI CONOSCENZE COMPETENZE E CAPACITÀ Classe PRIMA Parametri Obiettivi Livelli (*= STANDARD MINIMO
Istituto di Istruzione Superiore Virgilio Empoli
 1 21 Ed. 1 del 19/06/2012 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILIO Data 24/09/2013 LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO Istituto di Istruzione Superiore Virgilio Empoli LICEO ARTISTICO Indirizzi di studio
1 21 Ed. 1 del 19/06/2012 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILIO Data 24/09/2013 LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO Istituto di Istruzione Superiore Virgilio Empoli LICEO ARTISTICO Indirizzi di studio
TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE NEL PIANO. Parte 2
 TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE NEL PIANO Parte 2 La simmetria L'etimologia della parola simmetria è greca. = stessa misura Per estensione, se ne amplia il significato ad espressioni del tipo 'equilibrio fra
TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE NEL PIANO Parte 2 La simmetria L'etimologia della parola simmetria è greca. = stessa misura Per estensione, se ne amplia il significato ad espressioni del tipo 'equilibrio fra
Il Rinascimento: approfondimenti sul rapporto aureo
 Il Rinascimento: approfondimenti sul rapporto aureo Lo studio degli antichi da parte dei nuovi artisti rinascimentali si sviluppa e si approfondisce notevolmente. Essi infatti sono particolarmente affascinati
Il Rinascimento: approfondimenti sul rapporto aureo Lo studio degli antichi da parte dei nuovi artisti rinascimentali si sviluppa e si approfondisce notevolmente. Essi infatti sono particolarmente affascinati
la restituzione prospettica - schemi 14corso tecniche di rappresentazione dello spazio docente Arch. Emilio Di Gristina
 la restituzione prospettica - schemi 14corso tecniche di rappresentazione dello spazio docente rch. Emilio Di Gristina la restituzione prospettica - ricerca della Linea d Orizzonte Le rette parallele al
la restituzione prospettica - schemi 14corso tecniche di rappresentazione dello spazio docente rch. Emilio Di Gristina la restituzione prospettica - ricerca della Linea d Orizzonte Le rette parallele al
Il Foglio Parrocchiale La Via Crucis per i ragazzi Jesus - Il Film
 Il Foglio Parrocchiale La Via Crucis per i ragazzi Jesus - Il Film La Chiesa Matrice Madre di tutte le Chiese Costruzione del 1795, con facciata in granito locale progettata dall architetto serrese Biagio
Il Foglio Parrocchiale La Via Crucis per i ragazzi Jesus - Il Film La Chiesa Matrice Madre di tutte le Chiese Costruzione del 1795, con facciata in granito locale progettata dall architetto serrese Biagio
LA SIMMETRIA DELLA VITA
 LA SIMMETRIA DELLA VITA Studente: Carlo Falco, Cl. IV B, a. s. 2013-2014, Liceo Scientifico E. Siciliano, Bisignano CS Referente: prof.ssa Franca Tortorella 1 Il mondo è un posto asimmetrico pieno di esseri
LA SIMMETRIA DELLA VITA Studente: Carlo Falco, Cl. IV B, a. s. 2013-2014, Liceo Scientifico E. Siciliano, Bisignano CS Referente: prof.ssa Franca Tortorella 1 Il mondo è un posto asimmetrico pieno di esseri
Metodi di Proiezione
 Metodi di Proiezione A cosa servono le proiezioni? I mondo reale è 3D, ma i supporti (carta, schermo, etc.. ) sono bi-dimensionali! La storia Il problema della rappresentazione su un piano di oggetti tridimensionali
Metodi di Proiezione A cosa servono le proiezioni? I mondo reale è 3D, ma i supporti (carta, schermo, etc.. ) sono bi-dimensionali! La storia Il problema della rappresentazione su un piano di oggetti tridimensionali
IL RINASCIMENTO. Il 400
 IL RINASCIMENTO Il 400 apr 11 21.02 IL RINASCIMENTO Introduzione: da dove deriva il termine "Rinascimento" A partire dal Quattrocento nasce in Italia, a Firenze, il Rinascimento. Il termine venne coniato
IL RINASCIMENTO Il 400 apr 11 21.02 IL RINASCIMENTO Introduzione: da dove deriva il termine "Rinascimento" A partire dal Quattrocento nasce in Italia, a Firenze, il Rinascimento. Il termine venne coniato
Spazi di ri-significazione
 architettura di interni 20 21 Spazi di ri-significazione Il percorso creativo di Simone Subissati Nel percorso creativo dell architetto Simone Subissati alcune opere possono essere lette come componenti
architettura di interni 20 21 Spazi di ri-significazione Il percorso creativo di Simone Subissati Nel percorso creativo dell architetto Simone Subissati alcune opere possono essere lette come componenti
DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL ARTE
 LICEO SCIENTIFICO KEPLERO - ROMA DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL ARTE PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE A025 ANNO SCOLASTICO 2015/2016 DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL ARTE PRIMO BIENNIO Primo anno
LICEO SCIENTIFICO KEPLERO - ROMA DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL ARTE PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE A025 ANNO SCOLASTICO 2015/2016 DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL ARTE PRIMO BIENNIO Primo anno
TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE NEL PIANO. Parte 3
 TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE NEL PIANO Parte 3 Le Isometrie trasformazioni geometriche che lasciano invariate la forma e le dimensioni delle figure I movimenti Traslazioni Rotazioni Ribaltamenti Principali
TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE NEL PIANO Parte 3 Le Isometrie trasformazioni geometriche che lasciano invariate la forma e le dimensioni delle figure I movimenti Traslazioni Rotazioni Ribaltamenti Principali
CURRICOLO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DISCIPLINA: MATEMATICA CLASSE 1^
 CURRICOLO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DISCIPLINA: MATEMATICA CLASSE 1^ Nucleo fondante 1: IL NUMERO Argomento 1: Sistemi di numerazione Sa rappresentare graficamente numeri, ordinarli e confrontarli.
CURRICOLO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DISCIPLINA: MATEMATICA CLASSE 1^ Nucleo fondante 1: IL NUMERO Argomento 1: Sistemi di numerazione Sa rappresentare graficamente numeri, ordinarli e confrontarli.
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Roma. Servizio Educativo
 Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Roma Servizio Educativo PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2012-2013 GALLERIA BORGHESE Scuole
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Roma Servizio Educativo PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2012-2013 GALLERIA BORGHESE Scuole
COMPETENZA GEOMETRICA. Descrittori Classe I - Scuola Primaria.
 COMPETENZA GEOMETRICA Macroindicatori di conoscenze/abilità Esplorazione, descrizione e rappresentazione dello spazio Descrittori dei traguardi per lo sviluppo della competenza geometrica Uscita scuola
COMPETENZA GEOMETRICA Macroindicatori di conoscenze/abilità Esplorazione, descrizione e rappresentazione dello spazio Descrittori dei traguardi per lo sviluppo della competenza geometrica Uscita scuola
CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA
 CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE DELLA CLASSE PRIMA Competenza 1 - Osservare, descrivere e leggere immagini di diverso tipo. Competenza 2 - Produrre messaggi e forme con l uso di linguaggi, tecniche e materiali
CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE DELLA CLASSE PRIMA Competenza 1 - Osservare, descrivere e leggere immagini di diverso tipo. Competenza 2 - Produrre messaggi e forme con l uso di linguaggi, tecniche e materiali
Istituto d Istruzione Superiore Francesco Algarotti
 Classe: 1 M Docente: Antonio M. Povelato CAPITOLO 1 - Insiemi e numeri naturali Concetti primitivi di insieme e di elemento. Relazioni di appartenenza, inclusione e eguaglianza tra insiemi. Rappresentazione
Classe: 1 M Docente: Antonio M. Povelato CAPITOLO 1 - Insiemi e numeri naturali Concetti primitivi di insieme e di elemento. Relazioni di appartenenza, inclusione e eguaglianza tra insiemi. Rappresentazione
LA PERCEZIONE VISIVA (3)
 LA PERCEZIONE VISIVA (3) 1 - ASPETTI FISIOLOGICI E PSICOLOGICI 2 - ARTICOLAZIONE FIGURA SFONDO 3 - PERCEZIONE DELLA PROFONDITA 4 - PERCEZIONE DEL MOVIMENTO 6 - REALTA ED ILLUSIONE 6.1 - Realtà fenomeniche
LA PERCEZIONE VISIVA (3) 1 - ASPETTI FISIOLOGICI E PSICOLOGICI 2 - ARTICOLAZIONE FIGURA SFONDO 3 - PERCEZIONE DELLA PROFONDITA 4 - PERCEZIONE DEL MOVIMENTO 6 - REALTA ED ILLUSIONE 6.1 - Realtà fenomeniche
Leon Battista Alberti
 Ausilioteca del Comune di Firenze - Piattaforma didattica "Facilefacile" - www.ausiliotecafirenze.org/facilefacile Leon Battista Alberti 1. La vita Leon Battista Alberti nasce a Genova nel 1404, figlio
Ausilioteca del Comune di Firenze - Piattaforma didattica "Facilefacile" - www.ausiliotecafirenze.org/facilefacile Leon Battista Alberti 1. La vita Leon Battista Alberti nasce a Genova nel 1404, figlio
PROSPETTIVA CENTRALE A2 B2 A2 A B A LT PV AB
 PROSPETTIVA CENTRALE immaginiamo di fare scorrere un segmento AB lungo 2 binari (allonandolo sempre di più dall osservatore). la dimensione del segmento diminuisce seguendo l andamento delle due rette
PROSPETTIVA CENTRALE immaginiamo di fare scorrere un segmento AB lungo 2 binari (allonandolo sempre di più dall osservatore). la dimensione del segmento diminuisce seguendo l andamento delle due rette
DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE
 29. Osservando la sezione longitudinale dell Auditorium di Ibirapuera costruito da Oscar Niemeyer a San Paolo nel 2005, qual è la corretta disposizione dei piani verticali per ottenere le sezioni trasversali
29. Osservando la sezione longitudinale dell Auditorium di Ibirapuera costruito da Oscar Niemeyer a San Paolo nel 2005, qual è la corretta disposizione dei piani verticali per ottenere le sezioni trasversali
Ad una ad una annoverar le stelle (5/7 anni)
 Ad una ad una annoverar le stelle (5/7 anni) di Ana Millán Gasca La contemplazione delle stelle, un infinità di punti che brillano sulla volta celeste 1, ci appare come una delle sorgenti, nell esperienza
Ad una ad una annoverar le stelle (5/7 anni) di Ana Millán Gasca La contemplazione delle stelle, un infinità di punti che brillano sulla volta celeste 1, ci appare come una delle sorgenti, nell esperienza
Brand manual. Linee guida per l uso
 Linee guida per l uso dell identità visiva del marchio Indice Concept del simbolo 4 Declinazioni del marchio 6 Struttura del logo e carattere 7 Proporzioni e distanze minime di rispetto 8 Codici cromatici
Linee guida per l uso dell identità visiva del marchio Indice Concept del simbolo 4 Declinazioni del marchio 6 Struttura del logo e carattere 7 Proporzioni e distanze minime di rispetto 8 Codici cromatici
TAPPE (OBIETTIVI) ANNUALI
 CURRICOLO DI ARTE Istituto Comprensivo di Castrezzato TAPPE (OBIETTIVI) ANNUALI Percettivo visivi Classe prima Percepire punti, linee, forme geometriche semplici,colori presenti nell ambiente e nelle immagini.
CURRICOLO DI ARTE Istituto Comprensivo di Castrezzato TAPPE (OBIETTIVI) ANNUALI Percettivo visivi Classe prima Percepire punti, linee, forme geometriche semplici,colori presenti nell ambiente e nelle immagini.
Bramante ( ) Lo studiolo di Federico nel palazzo ducale di Urbino
 Bramante si forma in ambiente urbinate alla scuola di frà Carnevale. Le idee che caratterizzano questo centro umanistico prendono spunto dalle idee e dall opera di Alberti e di Piero della Francesca. Nella
Bramante si forma in ambiente urbinate alla scuola di frà Carnevale. Le idee che caratterizzano questo centro umanistico prendono spunto dalle idee e dall opera di Alberti e di Piero della Francesca. Nella
COS E L ARTE???? COS E UN IMMAGINE???
 ARTE E IMMAGINE COS E L ARTE???? COS E UN IMMAGINE??? LA PERCEZIONE VISIVA Le immagini che noi vediamo con gli occhi vengono percepite e rielaborate con la mente. Dipinti, disegni, fotografie, film,
ARTE E IMMAGINE COS E L ARTE???? COS E UN IMMAGINE??? LA PERCEZIONE VISIVA Le immagini che noi vediamo con gli occhi vengono percepite e rielaborate con la mente. Dipinti, disegni, fotografie, film,
L educazione estetica per l integrazione
 L educazione estetica per l integrazione Percorsi di lettura ottica e tattile delle immagini artistiche Loretta Secchi Museo Tattile di pittura antica e moderna Anteros Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza
L educazione estetica per l integrazione Percorsi di lettura ottica e tattile delle immagini artistiche Loretta Secchi Museo Tattile di pittura antica e moderna Anteros Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza
SCUOLA DELL INFANZIA. Scuola dell infanzia: 5 ANNI
 ISTITUTO COMPRENSIVO REGGIO CALABRIA PROFILO di MATEMATICA SCUOLA DELL INFANZIA Scuola dell infanzia: 5 ANNI Il bambino è in grado di comprendere con precisione e coerenza l appartenenza di un oggetto
ISTITUTO COMPRENSIVO REGGIO CALABRIA PROFILO di MATEMATICA SCUOLA DELL INFANZIA Scuola dell infanzia: 5 ANNI Il bambino è in grado di comprendere con precisione e coerenza l appartenenza di un oggetto
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO. Storia dell'arte e del territorio
 PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO Storia dell'arte e del territorio CLASSE TERZA 1. 1. Competenze: le specifiche competenze di base disciplinari previste
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO Storia dell'arte e del territorio CLASSE TERZA 1. 1. Competenze: le specifiche competenze di base disciplinari previste
LICEO G.B. BENEDETTI
 LICEO G.B. BENEDETTI PROGRAMMA SVOLTO Anno scolastico Docente Classe Disciplina Testo/i in adozione 2012/2013 Prof.ssa Daniela Bellot 1 E Disegno e Storia dell Arte Dalla Preistoria all Arte romana Itinerario
LICEO G.B. BENEDETTI PROGRAMMA SVOLTO Anno scolastico Docente Classe Disciplina Testo/i in adozione 2012/2013 Prof.ssa Daniela Bellot 1 E Disegno e Storia dell Arte Dalla Preistoria all Arte romana Itinerario
Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali.
 Ha una conoscenza delle tecniche artistiche e dei codici del linguaggio iconico, funzionale all espressione figurativa, sulla base del talento innato e delle proprie potenzialità. Legge e comprende i testi
Ha una conoscenza delle tecniche artistiche e dei codici del linguaggio iconico, funzionale all espressione figurativa, sulla base del talento innato e delle proprie potenzialità. Legge e comprende i testi
A complicare il nostro rapporto con le immagini (e a volte anche con la realtà) intervengono i cosiddetti inganni percettivi
 REALTA E ILLUSIONE A complicare il nostro rapporto con le immagini (e a volte anche con la realtà) intervengono i cosiddetti inganni percettivi Chiaramente essi sono più facilmente realizzabili su una
REALTA E ILLUSIONE A complicare il nostro rapporto con le immagini (e a volte anche con la realtà) intervengono i cosiddetti inganni percettivi Chiaramente essi sono più facilmente realizzabili su una
Liceo Artistico M. Fabiani Gorizia
 Liceo Artistico M. Fabiani Gorizia architettura e ambiente design moda arti figurative pittura/scultura Piazzale Medaglie d Oro 2-34170 Gorizia wwww.liceoartegorizia.it Istituto Statale D'Arte M. Fabiani
Liceo Artistico M. Fabiani Gorizia architettura e ambiente design moda arti figurative pittura/scultura Piazzale Medaglie d Oro 2-34170 Gorizia wwww.liceoartegorizia.it Istituto Statale D'Arte M. Fabiani
CORSO DI INFOGRAFICA PROF. MANUELA PISCITELLI A.A.
 6. Lo spazio visivo Il presente file costituisce una SINTESI del materiale presentato nel corso delle lezioni. Tale sintesi non deve essere ritenuta esaustiva dell argomento, ma andrà integrata dallo studente
6. Lo spazio visivo Il presente file costituisce una SINTESI del materiale presentato nel corso delle lezioni. Tale sintesi non deve essere ritenuta esaustiva dell argomento, ma andrà integrata dallo studente
CAP 5: INTRODUZIONE ALLA GEOMETRIA DESCRITTIVA
 CAP 5: INTRODUZIONE ALLA GEOMETRIA DESCRITTIVA Non deve essere sottovalutata l importanza del disegno nella nostra civiltà caratterizzata dalla tecnica e dall immagine, perché esso rappresenta il primo
CAP 5: INTRODUZIONE ALLA GEOMETRIA DESCRITTIVA Non deve essere sottovalutata l importanza del disegno nella nostra civiltà caratterizzata dalla tecnica e dall immagine, perché esso rappresenta il primo
LICEO ARTISTICO documento "Riforma della Scuola Secondaria Superiore allegato A
 LICEO ARTISTICO documento "Riforma della Scuola Secondaria Superiore allegato A Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce: l acquisizione
LICEO ARTISTICO documento "Riforma della Scuola Secondaria Superiore allegato A Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce: l acquisizione
Palladio Oikos Venezia srl Palladio
 Palladio Venezia linea Palladio 8 L ESTETICa DEI RILIEvI, IL DISEGNO DELLE FORmE Roma 14 Milano 20 Firenze 26 / 2 / Linea PALLADIO / 3 / Il nuovo ciclo di verniciatura all acqua consente importanti vantaggi
Palladio Venezia linea Palladio 8 L ESTETICa DEI RILIEvI, IL DISEGNO DELLE FORmE Roma 14 Milano 20 Firenze 26 / 2 / Linea PALLADIO / 3 / Il nuovo ciclo di verniciatura all acqua consente importanti vantaggi
PIANO ANNUALE DI ARTE
 ISTITUTO COMPRENSIVO FOLGARIA - LAVARONE - LUSERNA SCUOLA PRIMARIA DI LAVARONE e LUSERNA PIANO ANNUALE DI ARTE CLASSE SECONDA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 Insegnanti : Bailoni Silvana- Krehan Susanne COMPETENZA
ISTITUTO COMPRENSIVO FOLGARIA - LAVARONE - LUSERNA SCUOLA PRIMARIA DI LAVARONE e LUSERNA PIANO ANNUALE DI ARTE CLASSE SECONDA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 Insegnanti : Bailoni Silvana- Krehan Susanne COMPETENZA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA DI BISUSCHIO
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA DI BISUSCHIO Anno scolastico 2010/2011 CURRICULUM VERTICALE DI ARTE E IMMAGINE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Riconoscere e utilizzare correttamente
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA DI BISUSCHIO Anno scolastico 2010/2011 CURRICULUM VERTICALE DI ARTE E IMMAGINE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Riconoscere e utilizzare correttamente
DISEGNO PROSPETTICO CAPITOLO 1 METODI DI RAPPRESENTAZIONE PER IL DISEGNO TECNICO: QUADRO GENERALE PROIEZIONI ORTOGRAFICHE PROIEZIONI ASSONOMETRICHE
 CAPITOLO DISEGNO PROSPETTICO METODI DI RAPPRESENTAZIONE PER IL DISEGNO TECNICO: QUADRO GENERALE La norma UNI EN ISO 0209-2 raccoglie i principali metodi di rappresentazione raccomandati per il disegno
CAPITOLO DISEGNO PROSPETTICO METODI DI RAPPRESENTAZIONE PER IL DISEGNO TECNICO: QUADRO GENERALE La norma UNI EN ISO 0209-2 raccoglie i principali metodi di rappresentazione raccomandati per il disegno
PROSPETTIVA ACCIDENTALE
 PROSPETTIVA ACCIDENTALE viene così chiamato l insieme di regole utili a rappresentare oggetti inclinati in modo casuale (accidentale) rispetto al quadro prospettico. inclinato rispetto al quadro --> prospettiva
PROSPETTIVA ACCIDENTALE viene così chiamato l insieme di regole utili a rappresentare oggetti inclinati in modo casuale (accidentale) rispetto al quadro prospettico. inclinato rispetto al quadro --> prospettiva
Scuola primaria classe prima. Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione.
 Scuola primaria classe prima competenze disciplinari 1 Usare gli elementi di base del linguaggio visuale per osservare e descrivere immagini statiche quali fotografie, manifesti, opere d'arte e messaggi
Scuola primaria classe prima competenze disciplinari 1 Usare gli elementi di base del linguaggio visuale per osservare e descrivere immagini statiche quali fotografie, manifesti, opere d'arte e messaggi
A lato: il crocifisso ligneo dell altare maggiore (particolare).
 L altare maggiore della chiesa. Il complesso marmoreo presenta una serie di gradini, che conducono verso il tabernacolo. Sulla porta del tabernacolo è rappresentata la scena di Gesù risorto che si manifesta
L altare maggiore della chiesa. Il complesso marmoreo presenta una serie di gradini, che conducono verso il tabernacolo. Sulla porta del tabernacolo è rappresentata la scena di Gesù risorto che si manifesta
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Anno scolastico Docente Resi Girardello Disciplina Discipline Pittoriche Classe Sezione Indirizzo II S
 Istituto d Istruzione Superiore POLO-LICEO ARTISTICO - VEIS02400C VENEZIA Liceo Artistico, Liceo Classico e Musicale Dorsoduro, 1073 30123 Venezia tel. 0415225252, fax 041 2414154 Modello A2 PROGRAMMAZIONE
Istituto d Istruzione Superiore POLO-LICEO ARTISTICO - VEIS02400C VENEZIA Liceo Artistico, Liceo Classico e Musicale Dorsoduro, 1073 30123 Venezia tel. 0415225252, fax 041 2414154 Modello A2 PROGRAMMAZIONE
Riprodurre visi e corpi con varie tecniche. Usare creativamente e/o in modo pertinente il colore.
 ARTE E IMMAGINE Esprimersi e comunicare; osservare e leggere le immagini; comprendere e apprezzare le opere d arte CLASSE PRIMA _Scuola Primaria L alunno si esprime attraverso il linguaggio visivo per
ARTE E IMMAGINE Esprimersi e comunicare; osservare e leggere le immagini; comprendere e apprezzare le opere d arte CLASSE PRIMA _Scuola Primaria L alunno si esprime attraverso il linguaggio visivo per
Liceo Scienze Umane e Artistico G. Pascoli. Anno scolastico MATERIA: discipline plastiche. Prof.ssa Nadia Pilati
 Liceo Scienze Umane e Artistico G. Pascoli MATERIA: discipline plastiche CLASSE 1G LIBRO DI TESTO: I MODI DELLA SCULTURA, figura modellata ornato plastico materiali, strumenti e tecniche, di Pino Di Gennaro,
Liceo Scienze Umane e Artistico G. Pascoli MATERIA: discipline plastiche CLASSE 1G LIBRO DI TESTO: I MODI DELLA SCULTURA, figura modellata ornato plastico materiali, strumenti e tecniche, di Pino Di Gennaro,
476 d. C. Storia Medievale. Anno del Romanico. Secoli XI XII - XIII. Storia civile Italiano Storia dell arte
 3500 a.c. Storia Antica 476 d. C. Storia Medievale 1492 Storia Moderna 1815 Storia Contemporanea Oggi Anno 0 1000 1200 2000 Il Romanico Secoli XI XII - XIII Storia civile Italiano Storia dell arte Superamento
3500 a.c. Storia Antica 476 d. C. Storia Medievale 1492 Storia Moderna 1815 Storia Contemporanea Oggi Anno 0 1000 1200 2000 Il Romanico Secoli XI XII - XIII Storia civile Italiano Storia dell arte Superamento
IL SEICENTO. Parliamo della rivoluzione scientifica.
 IL SEICENTO Parliamo della rivoluzione scientifica. La Rivoluzione Copernicana Niccolò Copernico nel 1543 presentò una nuova teoria astronomica Teoria Copernicana secondo la quale la Terra gira intorno
IL SEICENTO Parliamo della rivoluzione scientifica. La Rivoluzione Copernicana Niccolò Copernico nel 1543 presentò una nuova teoria astronomica Teoria Copernicana secondo la quale la Terra gira intorno
gino copelli lezioni di scienza della rappresentazione appunti 2012
 gino copelli lezioni di scienza della rappresentazione appunti 2012 Simbologia Il punto, la linea e la superficie sono enti geometrici fondamentali. I punti si indicano con lettere maiuscole dell alfabeto
gino copelli lezioni di scienza della rappresentazione appunti 2012 Simbologia Il punto, la linea e la superficie sono enti geometrici fondamentali. I punti si indicano con lettere maiuscole dell alfabeto
ESERCIZIO N.1 ESERCIZIO N.2. Campire 4 fogli con linee orizzontali, verticali, diagonali, cerchi concentrici.
 ESERCIZIO N.1 Realizzare composizioni monocromatiche di punti variando densità e/o dimensioni in modo da ricercare effetti espressivi di dilatazione, contrazione, ascensione, etc. ESERCIZIO N.2 Campire
ESERCIZIO N.1 Realizzare composizioni monocromatiche di punti variando densità e/o dimensioni in modo da ricercare effetti espressivi di dilatazione, contrazione, ascensione, etc. ESERCIZIO N.2 Campire
Sezione aurea e web design: come usarla e perché?
 Sezione aurea e web design: come usarla e perché? Se ne parla spesso come di un qualcosa di affascinante e sfuggente che ancora nelle nostre menti di web designer stenta a prendere forma in un concetto
Sezione aurea e web design: come usarla e perché? Se ne parla spesso come di un qualcosa di affascinante e sfuggente che ancora nelle nostre menti di web designer stenta a prendere forma in un concetto
La città ideale Scheda di laboratorio (II sessione classe II secondaria di I grado)
 La città ideale Scheda di laboratorio (II sessione classe II secondaria di I grado) Continuiamo con le nostre rappresentazioni in prospettiva. La volta scorsa vi sarete accorti che, quando vogliamo rappresentare
La città ideale Scheda di laboratorio (II sessione classe II secondaria di I grado) Continuiamo con le nostre rappresentazioni in prospettiva. La volta scorsa vi sarete accorti che, quando vogliamo rappresentare
ISTITUTO STATALE D ARTE VENTURI DI MODENA
 ISTITUTO STATALE D ARTE VENTURI DI MODENA MATERIA: DISCIPLINE PITTORICHE INSEGNANTE MARIA ANGELA ZAFFANI CLASSE I I C ANNO SCOLASTICO 2013/14 PROGRAMMA SVOLTO CONTENUTI Struttura modulare I contenuti del
ISTITUTO STATALE D ARTE VENTURI DI MODENA MATERIA: DISCIPLINE PITTORICHE INSEGNANTE MARIA ANGELA ZAFFANI CLASSE I I C ANNO SCOLASTICO 2013/14 PROGRAMMA SVOLTO CONTENUTI Struttura modulare I contenuti del
FIGURE ISOPERIMETRICHE HANNO LA STESSA AREA?
 Stefania Renna 3DL a.s. 2007/2008 FIGURE ISOPERIMETRICHE HANNO LA STESSA AREA? Si è partiti da qui: Due contadini si incontrano in un negozio di ferramenta: devono acquistare entrambi 40 m. di rete metallica
Stefania Renna 3DL a.s. 2007/2008 FIGURE ISOPERIMETRICHE HANNO LA STESSA AREA? Si è partiti da qui: Due contadini si incontrano in un negozio di ferramenta: devono acquistare entrambi 40 m. di rete metallica
Metodi di rappresentazione
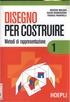 ;~ ~ -I' -. ~-... -... --~ ~--------~~~ -- MARZIO MILIANI IVANO MARCHESINI FRANCA PAVANELLI Metodi di rappresentazione IUAV - VENEZIA AREA SERI/. BIBLIOGRAFICI E DOCUMENTALI M 4902 BIBLIOTECA CENTRALE
;~ ~ -I' -. ~-... -... --~ ~--------~~~ -- MARZIO MILIANI IVANO MARCHESINI FRANCA PAVANELLI Metodi di rappresentazione IUAV - VENEZIA AREA SERI/. BIBLIOGRAFICI E DOCUMENTALI M 4902 BIBLIOTECA CENTRALE
Indirizzo ARTI FIGURATIVE
 Indirizzo ARTI FIGURATIVE DISCIPLINE PLASTICHE IV ANNO V ANNO Studio di un particolare anatomico complesso volto, mani, piedi, da realizzare in creta a rilievo o a tuttotondo: Studi grafici in preparazione
Indirizzo ARTI FIGURATIVE DISCIPLINE PLASTICHE IV ANNO V ANNO Studio di un particolare anatomico complesso volto, mani, piedi, da realizzare in creta a rilievo o a tuttotondo: Studi grafici in preparazione
 1 anno fisica -potenze di 10, equivalenze e notazione scientifica -misure ed incertezze -grandezze scalari e vettoriali e relative operazioni -esprimere il risultato di una misura e saper rappresentare
1 anno fisica -potenze di 10, equivalenze e notazione scientifica -misure ed incertezze -grandezze scalari e vettoriali e relative operazioni -esprimere il risultato di una misura e saper rappresentare
COMUNICAZIONE N.14 DEL
 COMUNICAZIONE N.14 DEL 13.03.20131 1- SECONDO MODULO - APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (13): ESEMPI 109-116 2 - TERZO MODULO - DISEGNI A MANO LIBERA (10): DISEGNI 91-100 I disegni di questa sezione
COMUNICAZIONE N.14 DEL 13.03.20131 1- SECONDO MODULO - APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (13): ESEMPI 109-116 2 - TERZO MODULO - DISEGNI A MANO LIBERA (10): DISEGNI 91-100 I disegni di questa sezione
Programma Didattico Annuale
 LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI PdQ - 7.06 Ediz.: 1 Rev.: 0 Data 02/09/05 Alleg.: D01 PROG. M2 PROCEDURA della QUALITA' Programma Didattico Annuale Anno Scolastico 2011/2012 MATERIA : Scienze
LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI PdQ - 7.06 Ediz.: 1 Rev.: 0 Data 02/09/05 Alleg.: D01 PROG. M2 PROCEDURA della QUALITA' Programma Didattico Annuale Anno Scolastico 2011/2012 MATERIA : Scienze
GRUPPO AMICI DEL PRESEPE Monte Porzio Catone Corso Presepistico on-line
 GRUPPO AMICI DEL PRESEPE Monte Porzio Catone www.presepitalia.it Corso Presepistico on-line PROSPETTIVA II Indice Indice... 1 1. La prospettiva... 2 Amici del Presepe Monte Porzio Catone pag. 1 1. La prospettiva
GRUPPO AMICI DEL PRESEPE Monte Porzio Catone www.presepitalia.it Corso Presepistico on-line PROSPETTIVA II Indice Indice... 1 1. La prospettiva... 2 Amici del Presepe Monte Porzio Catone pag. 1 1. La prospettiva
Le chiese. Chiesa Conventuale di S. Domenico Del 1475, dell originario impianto i resti di mura e di una delle porte di accesso alla Città.
 Le chiese (In alto) Chiesa di S. Francesco di Paola: interno (A sinistra) Il soffitto a cassettoni della chiesa, racchiude un dipinto di S. Francesco del 1719 Chiesa di S. Maria di Costantinopoli Nel XII
Le chiese (In alto) Chiesa di S. Francesco di Paola: interno (A sinistra) Il soffitto a cassettoni della chiesa, racchiude un dipinto di S. Francesco del 1719 Chiesa di S. Maria di Costantinopoli Nel XII
