con la riforma del diritto di famiglia ha voluto introdurre una concezione più elevata del matrimonio.
|
|
|
- Silvia Bianchini
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 36 Introduzione La domanda alla quale si è cercato, attraverso questo lavoro, di dare una risposta era quella di fare il punto sul problema dell età matrimoniale nel diritto canonico comparandola al diritto civile italiano. L argomento aggetto di questo studio è stato da una parte l analisi della capacità d agire e della capacità matrimoniale nel diritto civile e dall altra la capacità matrimoniale nell ordinamento canonico. Per quanto riguarda il diritto civile italiano, il punto di riferimento è senza dubbio la legge 19 maggio 1975 n. 151 cd. Riforma del diritto di famiglia, che con i suoi 240 articoli costituisce senza dubbio una delle più impegnative ed importanti riforme attuate dal Parlamento Italiano nel corso< della vita repubblicana, non solo per la mole dell opera, ma anche per i principi in essa contenuti. L art. 84 del codice civile italiano nella nuova formulazione della legge di riforma del diritto di famiglia del 19 maggio 1975 n. 151, muta radicalmente la disciplina dell età matrimoniale in quanto sottintende una diversa concezione dell istituto matrimoniale rispetto alla formula precedente. Infatti la disciplina anteriore alla riforma, che prende lo spunto dal codice napoleonico racchiude in se una concezione giusnaturalistica dell istituto, mentre invece il legislatore
2 37 con la riforma del diritto di famiglia ha voluto introdurre una concezione più elevata del matrimonio. La dottrina e la giurisprudenza hanno ben evidenziato come rispetto a concezioni giusnaturalistiche la riforma abbia compiuto notevoli passi avanti nel senso di dare quel carattere fondamentale che il matrimonio riveste per ogni individuo. Il matrimonio è un diritto inalienabile dell individuo, ma la nostra legislazione, sulla scia del codice napoleonico e nel tentativo di affrancarsi dai supposti e non dimostrati condizionamenti della Chiesa, aveva di fatto ridotto il matrimonio ad una mera figura contrattuale in cui la donna rivestiva un ruolo marginale. Va invece rilevato come la Chiesa si è fatta sempre portatrice del diritto al matrimonio, riconoscendolo a tutti coloro i quali il diritto non lo vieti. La disciplina introdotta dalla legge di riforma del diritto di famiglia ha mutato anche le procedure per le autorizzazioni ed i controlli ed in questo lavoro si cercherà di analizzare come il legislatore abbia attuato la disciplina delle autorizzazioni e dei controlli, nonché dei rimedi, capire quali lacune sono state individuate dalla elaborazione dottrinale copiosissima in materia e quali eventualmente i rimedi proposti. Dal punto di vista canonico si cercherà in questo lavoro di analizzare alla luce del Codice di diritto canonico vigente la capacità matrimoniale, individuandone il contesto alla luce del cambiamento di mentalità avvenuto in seguito al nuovo spirito introdotto dal Concilio
3 38 Vaticano II, in cui l uomo diventa l elemento centrale della dimensione ecclesiale. In una tesi spiccatamente comparativa non potrà mancare l analisi della normativa concordataria per comprendere fino a che punto le modificazioni introdotte con il cd. Accordo di Villa Madama ha potuto conciliare le esigenze della comunità cattolica italiana, che comunque resta maggioritaria nel nostro paese, con le velleità laicistiche emerse in un periodo storico in cui essere cattolico rappresentava se non un marchio, certamente una nota di demerito. Fuori dal dato strettamente giuridico si cercherà infine di comprendere quali sono i diritti del fanciullo sia nell ordinamento canonico che in quello civile, anche alla luce delle significative innovazioni che le convenzioni internazionali hanno prodotto negli ordinamenti giuridici statuali e dall altro lato dalla centralità data dalla Chiesa ai giovani attraverso l insegnamento costante dei pontefici a partire da Pio XI, con l enciclica divini illius magistri, che affrontava il tema dell educazione fino a Giovanni Paolo II, che con La carta dei diritti della famiglia ha presentato al mondo una formulazione completa ed ordinata dei fondamentali diritti inerenti a quella società naturale e universale che è la famiglia. In questa carta è presente la visione cristiana della famiglia i cui diritti sorgono dalla legge divina.
4 39 Capitolo primo: Capacità d agire e capacità matrimoniale 1.1 Capacità giuridica e capacità d agire: l età matrimoniale. Il concetto di capacità giuridica è stato elaborato in epoca relativamente recente, mentre per le esperienze precedenti al codice napoleonico era un concetto ignoto. 1 Il diritto romano distingueva gi uomini in base allo status e ne riconosceva tre: status libertatis, status familiae, status civitatis. 2 Nel diritto romano il termine persona non era usato nel senso di soggetto di diritto. 3 Nel diritto intermedio i tre status vengono modificati e subiscono profonde differenziazioni, amplificazioni e moltiplicazioni a seconda del condizionamento degli eventi storici. 4 1 Cfr. SCHLOSSMAN, Persona und Prosopon in Rechtund im christlichen dogma, Kiel- Liepzig, 1906, pag.6, il quale chiarisce che il concetto di personalità e capacità erano concetti elaborati alla fine del sec.xviii. 2 Così SCIASCIA, voce Capacità (Dir.Rom.), in Noviss.Dig,,II,Torino,1958,pag.1869; BURDESE, voce Capacità.(Dir.Rom),in Enc.del Diritto,VI,Milano,1960, pag.1; ma in senso contrario v.fadda,diritto delle Persone,Napoli 1910, pag.7, PACCHIONI, Corso di diritto romano, Torino, 1910, pag.3. 3 L evoluzione dei significati del termine era già presente in AULII GELLI, Noctes atticae,, L.V., cap.vii; per l uso di esso in alcuni testi giuridici v.gai Inst..,1,9 e 49; Paul. Dig.50,16; Ulp.Dig.50,17. 4 Così RASI, voce «Capacità giuridica (Dir. interm.)», in Noviss. Dig. it., Il, Torino, 1958, 870; MAFFEI, voce «Capacità (Dir. interm.)», in Enc. del dir., VI, Milano, 1960, p. 3 e ss.; cfr. tra gli altri, ROBERTI, Svolgimento storico del diritto privato in Italia, 1, Padova, 1935, p. 109 e ss.;
5 40 Solo con l introduzione delle teorie giusnaturalistiche si comincia ad affermare il concetto di persona come suddito di uno Stato uguale davanti a questo ed egualmente dipendente. 5 Un primo riferimento organico alla persona ed alla sua capacità si trova nel codice civile generale Austriaco del 1811, che al paragrafo 16 dichiarava Ogni uomo ha i diritti innati che si conoscono con la sola ragione: perciò egli è da considerarsi persona. 6 Dopo un attenta riflessione dei giuristi, soprattutto tedeschi, si giunse alla definizione che ogni singolo uomo è capace di diritto. 7 L ordine giuridico mutua dal diritto naturale i suoi fondamenti essenziali. L ordine giuridico è un complesso di regole che disciplina le dinamiche dei soggetti, che vivono, agiscono e si trasformano. 8 In Italia lo Statuto Albertino nella sezione intitolata ai Diritti e doveri dei cittadini sanciva L uguaglianza di tutti i regnicoli davanti alla legge. 9 TORELLI, Lezioni di storia del diritto italiano - Diritto privato: le persone, Milano, 1946, p. 143 e ss., ma v. anche sulla «polverizzazìone» degli status fino a tutto il secolo XVIII, AMELIO G., Illumínismo e scienza del diritto in Italia, Milano, 1965, specie p. 60 e ss. Cfr. peraltro, per la definizione di persona nella filosofia cristiana medíoevale, TOMMASO D'AQUINO, Summa theologíca, III, q. 2, a. 1, ad 2. 5 Già GROZIO ìndividuava accanto ai tre status della tradizione un più ampio status naturalis, spettante ad ogni uomo: De iure belli ac pacis, L. I, c. Il, 1, n. 5. Cfr. anche PUFENDORF, De iure naturae et gentium, L. 1, c. 1, par. 12; WOLFF Cr., Institutiones iuris naturac et gentium, Pars. 1, par. 68, 74, 96; DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Paris, 1977, L. 1, t. IX, sez. 1, p. 2 e ss. 6 ROUSSEAU, Contrat social, specie 1, 6; 11, 3. 7 Cfr. BATTAGLIA, voce «Dichiarazione dei diritti», in Enc. del dir., XII, Milano, RESCIGNO, Capacità giuridica, in Noviss. Dig.It, II, Torino, 1958, pag Sui caratteri dello Statuto Albertino V. STENDARDI, voce «Statuto del Regno», in Noviss. Dig. it., XVIII, Torino, 1971, p. 420; ma cfr. anche RACIOPPI e BRUNELLI, Commento allo Statuto del Regno, Torino, 1909; IEMOLO e GIANNINI, Lo Statuto Albertino, Firenze, 1946.
6 41 Per giungere però, ad una definizione organica della disciplina attinente ai soggetti bisognerà aspettare il codice del 1942 che introdusse nel titolo primo una esplicita regolamentazione della capacità ed indicava nella nascita il momento di acquisto della capacità giuridica, fissava al compimento dei ventuno anni il raggiungimento della maggiore età, con la quale si acquistava la capacità di compiere tutti gli atti, per cui non fosse prescritta un età diversa. Nella elaborazione dottrinale italiana della nozione di capacità giuridica si è fatto riferimento esclusivamente alle norme del codice civile ignorando completamente i valori espressi nella carta costituzionale che pure aveva contribuito a circoscrivere il concetto di persona indicando i diritti e gli obblighi di cui questa è portatrice, anche senza distinguere fra capacità giuridica e capacità di agire. 10 Per capacità giuridica si intende l attitudine ad essere titolare di diritti ed obblighi giuridici 11 da parte dell individuo, che sarebbe portatore di tutti gli interessi giuridici tutelati ed immediatamente ricollegabili alla sua personalità. 12 Ogni soggetto fin dalla nascita ha una capacità giuridica generale secondo quanto stabilito dall art. 1 del Codice Civile che stabilisce al 10 Per il soddisfacimento dei diritti «sociali» anche nei confronti di terzi privati, V. MAZZIOTTI, Diritti sociali, in Enc. del dir., XII, Milano, 1964, p Cosi FALZEA, voce cit., p. 11, ma cfr. già FADDA e BENSA, Note a Windscheid, cít., p. 716, V. anche MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, cit., 1, par. 15, p. 207; CARNELUTTI, Teoria generale del diritto, Milano, 1951, p Così la dottrina pressoché unanime. V. peraltro FALZEA, Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, cit., p. 82. E cfr. pure, TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1980, p. 66.
7 42 1 La capacità giuridica si acquista con la nascita. Per l acquisto della capacità è necessario il requisito della vita, non potendo il nato morto considerarsi persona ed acquistare diritti. Tale capacità, però, non è totale ed incondizionata: infatti, per l assunzione di determinati rapporti e diritti non è sempre sufficiente la semplice esistenza dell individuo, ma, accanto ad essa può essere richiesta la presenza di particolari condizioni, la cui mancanza impedendo al soggetto di acquistare la titolarità di quel particolare diritto o precludendogli la possibilità di partecipare a quel determinato rapporto, lo pone, conseguentemente in uno stato di incapacità. 13 Il nostro ordinamento, come tutti gli ordinamenti moderni, non prevede nessuna ipotesi di privazione generale della capacità giuridica, tale capacità generale si acquista con la nascita e si perde solo con la morte del soggetto. 14 La incapacità giuridica può essere influenzata e limitata dall esistenza di alcune cause che sono le più disparate (la condizione giuridica di straniero, le condanne penali, la cattiva condotta, il fallimento, le infermità e l età). In riferimento a questa ultima ipotesi è prescritta, per esempio un età minima per assumere obbligazioni di lavoro, effettuare donazioni, disporre delle proprie sostanze per testamento, contrarre matrimonio cfr.:santoro-passarelli,dottrine generali del diritto civile, Napoli 1966, pag cfr.:messineo, op.cit., pag cfr.: ALATI Capacità negoziale e processuale del lavoratore minorenne, in Dir. Lav., 1948, I, pag.148.
8 43 L art. 2 del Codice civile, infatti, nella sua originaria formulazione, stabiliva che la maggiore età è fissata al compimento del ventunesimo anno di età. Veniva altresì precisato che con essa si acquistava la capacità di compiere tutti gli atti per cui non fosse richiesta un età diversa. La legge 8/3/1975 n.39 modificando l art. 2 del codice civile fissava la maggiore età a tutti gli effetti al compimento del diciottesimo anno. 16 A differenza della capacità giuridica, che presuppone unicamente l esistenza del soggetto cui riferire la titolarità dei diritti e dei doveri, la capacità di agire richiede, accanto all esistenza, anche l idoneità psicofisica del soggetto. Cause limitatrici della capacità di agire sono l età, le imperfezioni fisiche e mentali, le condanne penali. 17 Per quanto riguarda l età è evidente che questa influisce in maniera diversa sulla maturità psicofisica di ogni soggetto, determinando un maggiore o minore grado di maturità; è anche evidente come non solo il tempo, ma anche fattori estranei e diversi, influiscono in eguale maniera: così l intelligenza, la cultura, l esperienza, l ambiente sono tutti elementi che incidono sulla personalità di un soggetto cfr.: BARBERO, Sistema istituzionale del diritto privato italiano, Torino,1970, pag cfr.:stanzione capacità e minore età, Napoli 1975, pag.260
9 44 Poiché non si può dire che raggiunta una determinata età un soggetto acquisti, per il solo fatto di avere compiuto tale età, automaticamente la maturità e la piena efficienza fisica 19, l ordinamento giuridico ha preferito porre una presunzione in base alla quale la capacità piena si raggiunge con la maggiore età. Da tale momento il soggetto divenuto maggiorenne e capace entra nel pieno della vita giuridica. Poiché, naturalmente, sul piano sostanziale vi sono delle ipotesi che non possono corrispondere alla realtà, l ordinamento ha predisposto degli istituti che mirano ad attenuare il rigore della presunzione del raggiungimento della capacità di agire al compimento della maggiore età. 20 Così l emancipazione attribuisce al soggetto minorenne e precocemente sviluppato la possibilità di acquistare prima del termine consueto la capacità di agire sia pure in misura ridotta. 21 Così l interdizione e l inabilitazione danno modo di correggere il rovescio di quella presunzione; 22 grazie a questi istituti al soggetto maggiorenne, ma non capace di intendere e di volere pienamente per ritardo di sviluppo fisico o per sopravvenuta infermità viene negata quella capacità che la presunzione della maggiore età gli aveva attribuito. 19 cfr.: BUSNELLI e GIARDINA, la protezione del minore nel diritto privato italiano, in Giur.It., 1980,IV, pag cfr.: ARENA, voce Incapacità in Enc.del dir.., XX, Milano 1970, pag cfr.:ferrara, Diritto delle persone e famiglia, Napoli, 1975,pag cfr.:torrente E SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, 1978, pag.77
10 45 Anche per l età matrimoniale vale la stessa regola. La nuova formulazione dell art. 84 del codice civile così come modificato dalla legge di riforma del diritto di famiglia(l. 29 maggio 1975, n. 151) stabilisce che i minori di età non possono contrarre matrimonio. Sulla base delle considerazioni espresse è necessario a questo punto chiarire la natura della capacità matrimoniale che fa capo al minore degli anni diciotto, 23 cioè se essa sia espressione della capacità giuridica e quindi ritenere come l impossibilità di compiere atti personalissimi traduce e realizza una ipotesi di incapacità giuridica, oppure se esso sia un riflesso dell incapacità di agire( non è menomata la spettanza del diritto, ma solo la possibilità di esercitarlo). 24 Inizialmente alcuni autori si sono posti il problema, 25 rilevando che l insieme delle cause per le quali secondo l ordinamento giuridico positivo, la capacità giuridica e la capacità di agire è più o meno piena, da luogo a quello che si dice stato della persona che è, poi, la misura della sua capacità e costituisce esso stesso un diritto soggettivo. 26 Cominciando dallo stato individuale, dobbiamo dire che le cause che, secondo il diritto positivo, influiscono nella misura della capacità giuridica della persona, in se stessa considerata, si possono raggruppare in cinque ordini di fatti, naturali o giuridici e cioè: A) 23 cfr.: STELLA-RICHTER,Profili attuali della potestà maritale, Milano 1965, pag cfr.:baviera, Diritto minorile, II, Milano, 1976, pag.5 25 cfr.:degni, Le persone fisiche e i diritti della personalità, Torino 1959, pag.9 26 cfr.: FINOCCHIARO A e M.,Riforma del diritto di famiglia, I,1975, pag.23
11 46 l età, B) le infermità, C) le condanne penali, D) la qualità di straniero, E) la razza, F) il sesso. L età influisce sulla capacità di agire, mentre di regola, non tocca la capacità giuridica. Solo eccezionalmente la capacità giuridica può mancare per ragioni di età. 27 Queste eccezioni si riferiscono all incapacità di adottare per chi non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età, all incapacità all ufficio tutelare sancita dall art. 350 del c.c., alla possibilità di essere dispensato dall ufficio tutelare per la persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età. Conformemente altri autori hanno sostenuto che l incapacità legale di agire del minore presenta caratteri assai particolari anche in relazione al matrimonio(art. 84 c.c.), ma questo genere di incapacità è temperata da due particolari profili della disciplina dell atto. 28 In maniera sostanzialmente conforme altri hanno affermato che prima ed essenziale limitazione, di particolare rilievo perché costituisce la più notevole deroga alle regole del diritto comune sulla capacità di agire delle persone(cfr.art.2), è quella relativa all età. Non possono contrarre matrimonio, l uomo che non ha compiuto gli anni 16, la donna che non ha compiuto gli anni cfr.:cossu, il matrimonio dei minori, in Dir. Fam. Pers., 1979,pag cfr.: GIARDINA, voce Minore età, in Enc.Giur.,XX, Roma, 1990, pag cfr.: BERTOLA, voce Matrimonio, in Nuovissimo Dig.It., IX, 1964, pag. 876
12 47 Altri autori 30 hanno affermato che poichè a sedici anni è possibile previa autorizzazione del tribunale, contrarre matrimonio (art.84), il tal modo, il soggetto emancipandosi, acquista una limitata capacità di agire. A favore della teoria della capacità di agire si è espressa una parte della dottrina 31 che ha affermato che il requisito dell età, quando manca, realizza una sorta di incapacità giuridica, e non configura, invece una mancanza di capacità di agire. Nettamente contraria altra parte della dottrina 32 che ha categoricamente affermato che Il difetto dell età previsto dalla norma in esame rileva come ipotesi di incapacità giuridica, e non già di semplice incapacità di agire. Invero, il soggetto che non abbia compiuto i sedici o i quattordici anni manca non solo dell idoneità a compiere l atto, ma è altresì incapace di divenire titolare del rapporto che con l atto si costituisce. Secondo alcuni autori 33 la differenza fra capacità giuridica e capacità di agire si coglie nella circostanza che gli atti afferenti alla capacità giuridica non possono essere compiuti se non dal titolare, mentre quelli afferenti la capacità di agire possono essere compiuti tramite un rappresentante. E stato però obbiettato 34 che tale differenza non è proponibile in quanto numerosi atti definiti 30 cfr.: GAZZONI, Manuale di diritto Privato, Napoli, 1996, pag cfr.: UCCELLA, voce Matrimonio,, in Enc. Giur., XIX, Roma, 1990, cfr.: STELLA RICHTER, Profili attuali della potestà maritale, Milano, 1965, pag cfr.: JANNUZZI, Manuale di volontaria giurisdizione, Milano, 1987, pag cfr.: TORRENTE, Manuale di diritto Privato, Milano, 1999, p.77.
13 48 personalissimi, non possono essere compiuti tramite rappresentanti: così ad esempio il testamento e così pure per il matrimonio( salvi i casi limitati di cui all art.111 c.c.): anche per queste ipotesi si è parlato di limitazioni speciali della capacità giuridica(perché l incapace minore, interdetto, non potrebbe accedere a quel tipo di rapporto), ma è una qualificazione di dubbia correttezza, trattandosi semplicemente di casi in cui il difetto di capacità di agire non è rimediabile attraverso lo sfruttamento della rappresentanza legale. Così altra parte della dottrina ha sostenuto 35 che quando la legge esclude che l atto possa essere validamente compiuto da un altro soggetto (atti personalissimi ad es.: matrimonio, riconoscimento del figlio naturale), si parlerebbe di incapacità giuridica, in quanto il divieto colpirebbe l atto, ma non il diritto che lo presuppone. Tuttavia tale assunto è stato talora vigorosamente contestato, 36 sulla considerazione che, nei casi suindicati la legge esclude la validità dell atto in relazione alla sua natura e non alla qualità del soggetto, e che, l atto sia compiuto dal soggetto incapace, esso sarà solo annullabile e non radicalmente nullo, 37 come dovrebbe essere se fosse in questione la capacità giuridica. In netto contrasto una altra parte della dottrina, 38 che ha precisato che l individuazione di una età matrimoniale si riconduce ad una scelta tipica dell ordinamento, tale da incidere sulla stessa capacità giuridica della persona, cioè sulla sua 35 cfr.: RESCIGNO, Trattato di diritto privato, Napoli, 1986, p cfr.: GANGI, Persone fisiche e giuridiche, Milano, 1948, pag cfr.: FERRARA, diritto delle persone e famiglia, Napoli, 1975, pag cfr.: FINOCCHIARO Matrimonio Civile, in Enc.Dir., XXV, Milano, 1975
14 49 idoneità a divenire titolare del rapporto coniugale e familiare, il prevedere una deroga avrebbe significato concederla per fatti non incidenti sulla capacità. Infine qualche autore 39 ha rilevato che contro l esclusività ( che parrebbe risultare dall art. 2, 1 comma, c.c., il quale sancisce che La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilità un età diversa ), del legame tra minore- maggiore età e incapacità - capacità di agire, si può innanzi tutto utilizzare l ipotesi, avanzata da parte della dottrina, che la minore età possa incidere anche sulla capacità giuridica di un soggetto. Come si è visto, nulla dice al riguardo l art. 2, co.1 c.c.(capacità giuridica), il quale sancisce la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquisisce la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un età diversa. Sembrerebbe escludere il legislatore tale eventualità; 40 ciononostante la dottrina si è posto il problema di verificare se talora l incapacità del minore di comporre determinati atti non sia che il riflesso della sua inidoneità ad essere titolare dei rapporti da essi nascenti. 41 La tesi per cui tali ipotesi potevano essere identificate con quelle in cui certi atti (cd. personalissimi) non possono essere compiute 39 cfr.: GIARDINA, Minore età, in Enc.Giur., XX, Roma, cfr.: BARBERO, Sistema istituzionale del diritto privato italiano, Torino,1970, pag cfr.: SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1959,pag.131
15 50 neppure dai legali rappresentanti del minore, è stata drasticamente ridimensionata sulla base di considerazioni relative all inefficacia di simili atti compiuti da un minore. 42 Infatti l incapacità giuridica di quest ultimo sarebbe incompatibile con la produzione in capo all incapace di qualsiasi effetto giuridico, sia pure eliminabile come conseguenza dell annullabilità dell atto, mentre anche in caso di atti personalissimi come il matrimonio o il testamento la conseguenza dell incapacità del minore non è la nullità ma la semplice annullabilità (v.art.117 dl C.C., il quale stabilisce che Il matrimonio contratto in violazione degli art. 86,87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo, un interesse legittimo ed attuale e 591, u.c. c.c., che a sua volta stabilisce Nei casi d incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. ) cfr.: TORRENTE-SCHLESINGER, Istituzioni di diritto privato, Milano, 1999, pag cfr.: BIANCA, Manuale di diritto privato, Milano, 1977, pag.109
I. Il contratto in generale; II. La nozione di parte; III. Il contratto. con se stesso; IV. Il concetto di bilateralità nel contratto con se
 INTRODUZIONE SOMMARIO I. Il contratto in generale; II. La nozione di parte; III. Il contratto con se stesso; IV. Il concetto di bilateralità nel contratto con se stesso; VI. Il ruolo del consenso. I. Il
INTRODUZIONE SOMMARIO I. Il contratto in generale; II. La nozione di parte; III. Il contratto con se stesso; IV. Il concetto di bilateralità nel contratto con se stesso; VI. Il ruolo del consenso. I. Il
Le situazioni giuridiche soggettive fanno capo a quelli che vengono definiti come soggetti
 Le situazioni giuridiche soggettive fanno capo a quelli che vengono definiti come soggetti La capacità giuridica è la idoneità a divenire titolari di diritti e di doveri. Nel nostro ordinamento per le
Le situazioni giuridiche soggettive fanno capo a quelli che vengono definiti come soggetti La capacità giuridica è la idoneità a divenire titolari di diritti e di doveri. Nel nostro ordinamento per le
Amministrazione di sostegno e scelte del. beneficiario.
 Amministrazione di sostegno e scelte del beneficiario. 1.L amministrazione di sostegno 1.1 L istituto dell amministrazione di sostegno L amministrazione di sostegno è un istituto giuridico entrato nel
Amministrazione di sostegno e scelte del beneficiario. 1.L amministrazione di sostegno 1.1 L istituto dell amministrazione di sostegno L amministrazione di sostegno è un istituto giuridico entrato nel
CAUSA DEL CONTRATTO. Tesi oggettiva: Tesi soggettiva:
 CAUSA DEL CONTRATTO Tesi oggettiva: funzione economico sociale dell atto di volontà, giustificazione dell autonomia privata. Ad esempio la causa del contratto di lavoro è lo scambio di prestazione di lavoro
CAUSA DEL CONTRATTO Tesi oggettiva: funzione economico sociale dell atto di volontà, giustificazione dell autonomia privata. Ad esempio la causa del contratto di lavoro è lo scambio di prestazione di lavoro
I SOGGETTI: LA PERSONA FISICA
 I SOGGETTI: LA PERSONA FISICA Premessa: protagonisti dell attività giuridica soggetti di diritto. SOGGETTO GIURIDICO è il titolare di situazioni giuridiche soggettive. SOGGETTI DI DIRITTO Sono i destinatari
I SOGGETTI: LA PERSONA FISICA Premessa: protagonisti dell attività giuridica soggetti di diritto. SOGGETTO GIURIDICO è il titolare di situazioni giuridiche soggettive. SOGGETTI DI DIRITTO Sono i destinatari
Il diritto del lavoro è il complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano
 DIRITTO DEL LAVORO NOZIONE Il diritto del lavoro è il complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano oltre che l interesse economico, anche la libertà, dignità, e personalità
DIRITTO DEL LAVORO NOZIONE Il diritto del lavoro è il complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano oltre che l interesse economico, anche la libertà, dignità, e personalità
Il riconoscimento di filiazione di cittadino straniero da parte di cittadino italiano: diritto applicabile, requisiti e condizioni.
 Il riconoscimento di filiazione di cittadino straniero da parte di cittadino italiano: diritto applicabile, requisiti e condizioni. In tema di riconoscimento di filiazione naturale di cittadino straniero
Il riconoscimento di filiazione di cittadino straniero da parte di cittadino italiano: diritto applicabile, requisiti e condizioni. In tema di riconoscimento di filiazione naturale di cittadino straniero
Indice. 1 La persona fisica
 INSEGNAMENTO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I LEZIONE VI I SOGGETTI E IL DIRITTO DELLE PERSONE (PARTE I) PROF. DOMENICO RUGGIERO Indice 1 La persona fisica------------------------------------------------------------------------------------------3
INSEGNAMENTO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I LEZIONE VI I SOGGETTI E IL DIRITTO DELLE PERSONE (PARTE I) PROF. DOMENICO RUGGIERO Indice 1 La persona fisica------------------------------------------------------------------------------------------3
Chiara Forino notaio Gardone V.T. 05/04/12
 TRE TIPI DI TESTAMENTO Olografo: (art. 602 c.c.) predisposto dal soggetto personalmente e conservato dallo stesso o fiduciariamente dal notaio; per la validità del testamento olografo è necessario che
TRE TIPI DI TESTAMENTO Olografo: (art. 602 c.c.) predisposto dal soggetto personalmente e conservato dallo stesso o fiduciariamente dal notaio; per la validità del testamento olografo è necessario che
Accettazione dell eredità BIBLIOGRAFIA
 BIBLIOGRAFIA AZZARITI-MARTINEZ-AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979. AZZARITI G., Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990. AZZARITI G., Le successioni e le donazioni.
BIBLIOGRAFIA AZZARITI-MARTINEZ-AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979. AZZARITI G., Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990. AZZARITI G., Le successioni e le donazioni.
Sezione prima - Adozione e assistenza: la prospettiva storica
 INTRODUZIONE UNA PREMESSA... 1 Sezione prima - Adozione e assistenza: la prospettiva storica 1. L età classica... 6 2. L avvento del Cristianesimo........ 9 3. Il Medioevo... 10 4. L età moderna e l istituzionalizzazione
INTRODUZIONE UNA PREMESSA... 1 Sezione prima - Adozione e assistenza: la prospettiva storica 1. L età classica... 6 2. L avvento del Cristianesimo........ 9 3. Il Medioevo... 10 4. L età moderna e l istituzionalizzazione
Storia del diritto medievale e moderno II modulo lezione 11
 Storia del diritto medievale e moderno II modulo lezione 11 prof. Federica Furfaro a. a. 2017/2018 I semestre Granducato di Toscana Dopo la Restaurazione: ripristino del sistema di diritto comune Leopoldo
Storia del diritto medievale e moderno II modulo lezione 11 prof. Federica Furfaro a. a. 2017/2018 I semestre Granducato di Toscana Dopo la Restaurazione: ripristino del sistema di diritto comune Leopoldo
INDICE SOMMARIO. Parte Prima L AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. Capitolo I PREMESSA
 INDICE SOMMARIO Parte Prima L AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO Capitolo I PREMESSA 1. Dall interdizione all amministrazione di sostegno... Pag. 3 2. Appunto metodologico...» 8 3. Difficoltà di applicazione
INDICE SOMMARIO Parte Prima L AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO Capitolo I PREMESSA 1. Dall interdizione all amministrazione di sostegno... Pag. 3 2. Appunto metodologico...» 8 3. Difficoltà di applicazione
INDICE. Premessa INTRODUZIONE
 INDICE Premessa... 11 INTRODUZIONE Lezione 1 COLLOCAZIONE SISTEMATICA DELLA PARTE GENERALE DEL DIRITTO CANONICO 1. Lo studio del diritto canonico e le sue branche... 15 2. La Parte generale del diritto
INDICE Premessa... 11 INTRODUZIONE Lezione 1 COLLOCAZIONE SISTEMATICA DELLA PARTE GENERALE DEL DIRITTO CANONICO 1. Lo studio del diritto canonico e le sue branche... 15 2. La Parte generale del diritto
In secondo luogo, il figlio naturale può essere riconosciuto da uno solo o da entrambi i genitori al momento della nascita:
 Lo Studio Legale Lunari di Milano offre assistenza e consulenza legale nell ambito del diritto di famiglia e nello specifico per promuovere azioni legali per il riconoscimento giudiziale di paternità o
Lo Studio Legale Lunari di Milano offre assistenza e consulenza legale nell ambito del diritto di famiglia e nello specifico per promuovere azioni legali per il riconoscimento giudiziale di paternità o
MARIA LUISA SERRA L IMPUGNAZIONE PER NULLITÀ DEL LODO RITUALE
 MARIA LUISA SERRA L IMPUGNAZIONE PER NULLITÀ DEL LODO RITUALE JOVENE EDITORE 2016 INDICE Introduzione... p. XV PARTE PRIMA IL PROBLEMA DELLA QUALIFICAZIONE DEGLI EFFETTI DEL LODO CAPITOLO PRIMO L ORDINAMENTO
MARIA LUISA SERRA L IMPUGNAZIONE PER NULLITÀ DEL LODO RITUALE JOVENE EDITORE 2016 INDICE Introduzione... p. XV PARTE PRIMA IL PROBLEMA DELLA QUALIFICAZIONE DEGLI EFFETTI DEL LODO CAPITOLO PRIMO L ORDINAMENTO
INDICE SOMMARIO. Elenco delle principali abbreviazioni... Capitolo 1 DALLA PATRIA POTESTAv ALLA POTESTAv GENITORIALE
 INDICE SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... xv Capitolo 1 DALLA PATRIA POTESTAv ALLA POTESTAv GENITORIALE 1.1. Breve profilo storico dell istituto... 1 1.2. La Novella del 1975.... 4 1.2.1.
INDICE SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... xv Capitolo 1 DALLA PATRIA POTESTAv ALLA POTESTAv GENITORIALE 1.1. Breve profilo storico dell istituto... 1 1.2. La Novella del 1975.... 4 1.2.1.
INDICE CAPITOLO II LE FONDAZIONI IN GENERALE
 INDICE Prefazione.... XIII CAPITOLO I CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE. L EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO: EXCURSUS. LE LINEE E LE FINALITAv DELLA RICERCA 1. Considerazioni introduttive... 1 2. Le premesse
INDICE Prefazione.... XIII CAPITOLO I CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE. L EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO: EXCURSUS. LE LINEE E LE FINALITAv DELLA RICERCA 1. Considerazioni introduttive... 1 2. Le premesse
INDICE-SOMMARIO. Parte Prima GENERALITÀ. Capitolo I LE FUNZIONI E I POTERI DEL GIUDICE TUTELARE
 INDICE-SOMMARIO Prefazione... xix Parte Prima GENERALITÀ Capitolo I LE FUNZIONI E I POTERI DEL GIUDICE TUTELARE 1.1. L istituzione del giudice tutelare... 3 1.2. La competenza... 6 1.2.1. La competenza
INDICE-SOMMARIO Prefazione... xix Parte Prima GENERALITÀ Capitolo I LE FUNZIONI E I POTERI DEL GIUDICE TUTELARE 1.1. L istituzione del giudice tutelare... 3 1.2. La competenza... 6 1.2.1. La competenza
Annullamento del matrimonio: EFFETTI CIVILI. Marco Falvo Dottore in Giurisprudenza
 Annullamento del matrimonio: EFFETTI CIVILI Marco Falvo Dottore in Giurisprudenza Sacra Rota: la riforma dei tribunali ecclesiastici operata da Papa Francesco in vigore dall 8 8 dicembre; cambiano le cause
Annullamento del matrimonio: EFFETTI CIVILI Marco Falvo Dottore in Giurisprudenza Sacra Rota: la riforma dei tribunali ecclesiastici operata da Papa Francesco in vigore dall 8 8 dicembre; cambiano le cause
I soggetti del diritto: le persone fisiche. Prof. ssa Magliocco Maria Arcangela Docente di Scienze Giuridiche ed Economiche Ite Lenoci Bari
 I soggetti del diritto: le persone fisiche Prof. ssa Magliocco Maria Arcangela Docente di Scienze Giuridiche ed Economiche Ite Lenoci Bari I soggetti del diritto I destinatari delle norme giuridiche sono
I soggetti del diritto: le persone fisiche Prof. ssa Magliocco Maria Arcangela Docente di Scienze Giuridiche ed Economiche Ite Lenoci Bari I soggetti del diritto I destinatari delle norme giuridiche sono
negozio giuridico contratto
 89 Il contratto in generale un esame preliminare della disciplina del contratto in generale costituisce il presupposto 1. 2. assicurazione categoria del negozio giuridico, da tale nozione deve pertanto
89 Il contratto in generale un esame preliminare della disciplina del contratto in generale costituisce il presupposto 1. 2. assicurazione categoria del negozio giuridico, da tale nozione deve pertanto
Bibliografia. Torino, 1997
 Bibliografia _G. Amato Usufrutto giudiziale e scioglimento della comunione legale dei beni, in Giur. it., I, 1985 ( nota a Trib. Min. Roma, 25 giugno 1984 ) _T. Auletta - Il diritto di famiglia, ed. IV,
Bibliografia _G. Amato Usufrutto giudiziale e scioglimento della comunione legale dei beni, in Giur. it., I, 1985 ( nota a Trib. Min. Roma, 25 giugno 1984 ) _T. Auletta - Il diritto di famiglia, ed. IV,
In merito alla capacità, per il fallito, di porre in essere atti negoziali, vengono in rilievo gli artt. 42, 44 e 46 L.F.
 Quesito di Impresa n. 39-2012/I FALLIMENTO E FONDO PATRIMONIALE Si espone la seguente fattispecie: una persona fisica, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bologna nell anno 2011, ha costituito
Quesito di Impresa n. 39-2012/I FALLIMENTO E FONDO PATRIMONIALE Si espone la seguente fattispecie: una persona fisica, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bologna nell anno 2011, ha costituito
Ministero della Giustizia UFFICIO LEGISLATIVO
 Ministero della Giustizia UFFICIO LEGISLATIVO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 1, COMMA 28, LETTERE A) E C), DELLA LEGGE 20 MAGGIO 2016, N. 76, CHE DELEGA IL GOVERNO AD ADOTTARE
Ministero della Giustizia UFFICIO LEGISLATIVO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 1, COMMA 28, LETTERE A) E C), DELLA LEGGE 20 MAGGIO 2016, N. 76, CHE DELEGA IL GOVERNO AD ADOTTARE
INDICE. Prefazione alla seconda edizione XIII. Prefazione alla prima edizione
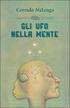 INDICE XI Prefazione alla seconda edizione XIII Prefazione alla prima edizione 1 Capitolo 1 La famiglia e il diritto. Linee di tenenza, problemi, prospettive 1 1. La famiglia e il diritto. Linee evolutive
INDICE XI Prefazione alla seconda edizione XIII Prefazione alla prima edizione 1 Capitolo 1 La famiglia e il diritto. Linee di tenenza, problemi, prospettive 1 1. La famiglia e il diritto. Linee evolutive
INDICE. Prefazione alla terza edizione. Prefazione alla seconda edizione XIII. Prefazione alla prima edizione
 INDICE IX XI XIII Prefazione alla terza edizione Prefazione alla seconda edizione Prefazione alla prima edizione 1 Capitolo 1 La famiglia e il diritto. Linee di tendenza, problemi, prospettive 1 1. La
INDICE IX XI XIII Prefazione alla terza edizione Prefazione alla seconda edizione Prefazione alla prima edizione 1 Capitolo 1 La famiglia e il diritto. Linee di tendenza, problemi, prospettive 1 1. La
PRIMA PARTE SPECIALE IL MATRIMONIO CONCORDATARIO
 INDICE-SOMMARIO SANDRO GHERRO PRIMA PARTE SPECIALE IL MATRIMONIO CONCORDATARIO CAPITOLO PRIMO PREMESSA: L ISTITUTO DEL MATRIMONIO TRA CHIESA E STATO MODERNO 1. 2. 3. 4. 5. Considerazioni introduttive.
INDICE-SOMMARIO SANDRO GHERRO PRIMA PARTE SPECIALE IL MATRIMONIO CONCORDATARIO CAPITOLO PRIMO PREMESSA: L ISTITUTO DEL MATRIMONIO TRA CHIESA E STATO MODERNO 1. 2. 3. 4. 5. Considerazioni introduttive.
CAPITOLO I. 4. Il concetto di segreto nel quadro dei diritti e delle libertà costituzionali:
 Introduzione... XV CAPITOLO I Il concetto di segreto nel quadro dei diritti e delle libertà costituzionali 1. Il ruolo del segreto nel quadro di un ordinamento liberaldemocratico: premesse generali...1
Introduzione... XV CAPITOLO I Il concetto di segreto nel quadro dei diritti e delle libertà costituzionali 1. Il ruolo del segreto nel quadro di un ordinamento liberaldemocratico: premesse generali...1
CACCAVALE C., Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie, in Notariato, 2006.
 BIBLIOGRAFIA ALBERTINI L., Conclusione e formazione progressiva del patto di famiglia, in Giust. civ., 2007. AMADIO G., L introduzione del Patto di famiglia e la categoria della successione anticipata,
BIBLIOGRAFIA ALBERTINI L., Conclusione e formazione progressiva del patto di famiglia, in Giust. civ., 2007. AMADIO G., L introduzione del Patto di famiglia e la categoria della successione anticipata,
SOMMARIO PARTE GENERALE I. NOZIONE ED EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 3
 SOMMARIO PARTE GENERALE I. NOZIONE ED EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 3 1. Nozione. 3 2. Classificazioni. 3 Riquadro di approfondimento Cosa si intende per principi UNIDROIT? 4 3.
SOMMARIO PARTE GENERALE I. NOZIONE ED EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 3 1. Nozione. 3 2. Classificazioni. 3 Riquadro di approfondimento Cosa si intende per principi UNIDROIT? 4 3.
III. GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO a cura di MASSIMO DOGLIOTTI egilda FERRANDO
 INDICE-SOMMARIO I. IL MATRIMONIO pag. 1. La promessa di matrimonio... 3 2. La libertà matrimoniale... 10 3. I requisiti per contrarre matrimonio... 17 a) differenza di sesso tra gli sposi... 17 b) vincolo
INDICE-SOMMARIO I. IL MATRIMONIO pag. 1. La promessa di matrimonio... 3 2. La libertà matrimoniale... 10 3. I requisiti per contrarre matrimonio... 17 a) differenza di sesso tra gli sposi... 17 b) vincolo
Dott.ssa Maria DOSSETTI nata a Cavriago (RE) il 2 luglio 1944
 Dott.ssa Maria DOSSETTI nata a Cavriago (RE) il 2 luglio 1944 Assistente ordinario di diritto civile Facoltà di Giurisprudenza Università statale di Milano PUBBLICAZIONI 1. Orientamenti giurisprudenziali
Dott.ssa Maria DOSSETTI nata a Cavriago (RE) il 2 luglio 1944 Assistente ordinario di diritto civile Facoltà di Giurisprudenza Università statale di Milano PUBBLICAZIONI 1. Orientamenti giurisprudenziali
Corso di Laurea quadriennale in Giurisprudenza
 Corso di Laurea quadriennale in Giurisprudenza La Facoltà assicura per il Corso di laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) il completamento delle attività necessarie per il conseguimento del titolo.
Corso di Laurea quadriennale in Giurisprudenza La Facoltà assicura per il Corso di laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) il completamento delle attività necessarie per il conseguimento del titolo.
LE FONTI DEL DIRITTO VATICANO
 LE FONTI DEL DIRITTO VATICANO 7 giugno 1929 prime sei Leggi dello SCV (Pio XI) L. n. I Legge Fondamentale della Città del Vaticano L. n. II Legge sulle fonti L. n. III Legge sulla cittadinanza e il soggiorno
LE FONTI DEL DIRITTO VATICANO 7 giugno 1929 prime sei Leggi dello SCV (Pio XI) L. n. I Legge Fondamentale della Città del Vaticano L. n. II Legge sulle fonti L. n. III Legge sulla cittadinanza e il soggiorno
Modulo 1 PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO (*) COMPETENZE ABILITA / CAPACITA CONOSCENZE
 Programmazione annuale di Diritto Classe 3^ Indirizzo Amministrazione Finanza e marketing e Sistemi Informativi Aziendali (n. 3 ore settimanali) Sezione Tecnica Modulo 1 PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO (*)
Programmazione annuale di Diritto Classe 3^ Indirizzo Amministrazione Finanza e marketing e Sistemi Informativi Aziendali (n. 3 ore settimanali) Sezione Tecnica Modulo 1 PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO (*)
INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA
 INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA 1. La nozione di famiglia.... p. 1 2. (segue) Famiglia parentale e famiglia nucleare....» 5 3. (segue) Famiglia, e rapporti giuridici familiari....» 8 4. Le norme
INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA 1. La nozione di famiglia.... p. 1 2. (segue) Famiglia parentale e famiglia nucleare....» 5 3. (segue) Famiglia, e rapporti giuridici familiari....» 8 4. Le norme
PARTE PRIMA QUESTIONI GENERALI
 INDICE-SOMMARIO Notizie sugli Autori...» V PARTE PRIMA QUESTIONI GENERALI CAPITOLO I IL DIRITTO ECCLESIASTICO: AMBITO E PRINCIPI 1. Concetto e ambito del «diritto ecclesiastico»... Pag. 3 2. segue...»
INDICE-SOMMARIO Notizie sugli Autori...» V PARTE PRIMA QUESTIONI GENERALI CAPITOLO I IL DIRITTO ECCLESIASTICO: AMBITO E PRINCIPI 1. Concetto e ambito del «diritto ecclesiastico»... Pag. 3 2. segue...»
pag. Prefazione alla prima edizione... Prefazione alla seconda edizione... Prefazione alla terza edizione... Prefazione alla quarta edizione...
 INDICE pag. Prefazione alla prima edizione............................ Prefazione alla seconda edizione........................... Prefazione alla terza edizione............................. Prefazione
INDICE pag. Prefazione alla prima edizione............................ Prefazione alla seconda edizione........................... Prefazione alla terza edizione............................. Prefazione
LE PERSONE GIURIDICHE
 1 LE PERSONE GIURIDICHE Soggetto del rapporto giuridico non è soltanto l individuo, la persona fisica singolarmente ed autonomamente considerata, ma anche organizzazioni collettive di uomini (persone giuridiche
1 LE PERSONE GIURIDICHE Soggetto del rapporto giuridico non è soltanto l individuo, la persona fisica singolarmente ed autonomamente considerata, ma anche organizzazioni collettive di uomini (persone giuridiche
INDICE VOLUME I. Parte I I FONDAMENTI DEL DIRITTO PRIVATO EUROPEO. CAPITOLO I L idea
 INDICE VOLUME I Prefazione... Gli autori... I contributi.... Abbreviazioni... V IX XI XIII Parte I I FONDAMENTI DEL DIRITTO PRIVATO EUROPEO CAPITOLO I L idea 1. Premessa... 3 2. Il diritto privato europeo
INDICE VOLUME I Prefazione... Gli autori... I contributi.... Abbreviazioni... V IX XI XIII Parte I I FONDAMENTI DEL DIRITTO PRIVATO EUROPEO CAPITOLO I L idea 1. Premessa... 3 2. Il diritto privato europeo
La PERIZIA PSICHIATRICA e PSICOLOGICA in ambito CANONICO. Marco Falvo Dottore in Giurisprudenza
 La PERIZIA PSICHIATRICA e PSICOLOGICA in ambito CANONICO Marco Falvo Dottore in Giurisprudenza La perizia in ambito canonico viene quasi esclusivamente richiesta per valutare la capacità matrimoniale.
La PERIZIA PSICHIATRICA e PSICOLOGICA in ambito CANONICO Marco Falvo Dottore in Giurisprudenza La perizia in ambito canonico viene quasi esclusivamente richiesta per valutare la capacità matrimoniale.
INDICE SOMMARIO. Prefazione... Pag. V CAPITOLO I IL PROBLEMA DEL CARATTERE INTERNAZIONALE DELLE FATTISPECIE E LE POSSIBILI SOLUZIONI
 INDICE SOMMARIO Prefazione... Pag. V CAPITOLO I IL PROBLEMA DEL CARATTERE INTERNAZIONALE DELLE FATTISPECIE E LE POSSIBILI SOLUZIONI 1.1. Il problema delle fattispecie con elementi di estraneità... Pag.
INDICE SOMMARIO Prefazione... Pag. V CAPITOLO I IL PROBLEMA DEL CARATTERE INTERNAZIONALE DELLE FATTISPECIE E LE POSSIBILI SOLUZIONI 1.1. Il problema delle fattispecie con elementi di estraneità... Pag.
PARTE PRIMA IL DIRITTO: NOZIONE E PRINCIPI GENERALI
 INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA IL DIRITTO: NOZIONE E PRINCIPI GENERALI Capitolo 1.1. IL DIRITTO 1.1.1. Diritto e società... 3 1.1.2. La norma giuridica... 4 1.1.3. L ordinamento giuridico... 6 1.1.4. Diritto
INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA IL DIRITTO: NOZIONE E PRINCIPI GENERALI Capitolo 1.1. IL DIRITTO 1.1.1. Diritto e società... 3 1.1.2. La norma giuridica... 4 1.1.3. L ordinamento giuridico... 6 1.1.4. Diritto
Storia del diritto medievale e moderno II modulo lezione 11
 Storia del diritto medievale e moderno II modulo lezione 11 prof. Federica Furfaro a. a. 2016/2017 I semestre Unità nazionale, unificazione giuridica, codificazione 1859-1861: raggiungimento dell unità
Storia del diritto medievale e moderno II modulo lezione 11 prof. Federica Furfaro a. a. 2016/2017 I semestre Unità nazionale, unificazione giuridica, codificazione 1859-1861: raggiungimento dell unità
SOMMARIO. Prefazione...
 SOMMARIO Prefazione... XIII Capitolo 1 Il potere rappresentativo: generalità 1.1. Il potere rappresentativo: cenni introduttivi... 1 1.1.1. La distinzione tra rappresentanza diretta e rappresentanza indiretta...
SOMMARIO Prefazione... XIII Capitolo 1 Il potere rappresentativo: generalità 1.1. Il potere rappresentativo: cenni introduttivi... 1 1.1.1. La distinzione tra rappresentanza diretta e rappresentanza indiretta...
ANALISI TECNICO-NORMATIVA (Dir. P.C.M. 10 settembre 2008) Amministrazione proponente: Ministro per gli affari regionali e le autonomie
 ANALISI TECNICO-NORMATIVA (Dir. P.C.M. 10 settembre 2008) Amministrazione proponente: Ministro per gli affari regionali e le autonomie Oggetto: SCHEMA DI NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER
ANALISI TECNICO-NORMATIVA (Dir. P.C.M. 10 settembre 2008) Amministrazione proponente: Ministro per gli affari regionali e le autonomie Oggetto: SCHEMA DI NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER
INDICE SOMMARIO LEZIONE I IL LESSICO DEL DIRITTO CIVILE
 LEZIONE I IL LESSICO DEL DIRITTO CIVILE pag. 1. La norma giuridica... 1 2. Civil law e common law... 3 3. Diritto privato e diritto pubblico... 3 4. Diritto oggettivo e diritti soggettivi.... 7 5. Fatti
LEZIONE I IL LESSICO DEL DIRITTO CIVILE pag. 1. La norma giuridica... 1 2. Civil law e common law... 3 3. Diritto privato e diritto pubblico... 3 4. Diritto oggettivo e diritti soggettivi.... 7 5. Fatti
1.1. Il diritto a procreare: la rilevanza costituzionale delle scelte inerenti alla procreazione
 INDICE SOMMARIO Parte I PROCREAZIONE Capitolo I La procreazione (S. ORRUv)................ Pag. 3 1.1. Il diritto a procreare: la rilevanza costituzionale delle scelte inerenti alla procreazione................................»
INDICE SOMMARIO Parte I PROCREAZIONE Capitolo I La procreazione (S. ORRUv)................ Pag. 3 1.1. Il diritto a procreare: la rilevanza costituzionale delle scelte inerenti alla procreazione................................»
Indice. Parte prima Il diritto in generale e le nozioni fondamentali del diritto privato. I. Il diritto e le sue fonti 5
 Indice Presentazione di Guido Neppi Modona Prefazione xi xiii Parte prima Il diritto in generale e le nozioni fondamentali del diritto privato I. Il diritto e le sue fonti 5 1. Il diritto: nozione e caratteristiche
Indice Presentazione di Guido Neppi Modona Prefazione xi xiii Parte prima Il diritto in generale e le nozioni fondamentali del diritto privato I. Il diritto e le sue fonti 5 1. Il diritto: nozione e caratteristiche
Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.
 Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c. Autore: Perrone Daria In: Diritto processuale civile A) La disciplina applicabile In base
Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c. Autore: Perrone Daria In: Diritto processuale civile A) La disciplina applicabile In base
Il minore nelle associazioni E noto come nel nostro ordinamento la capacità di agire, intesa come idoneità del soggetto a compiere validamente atti
 Il minore nelle associazioni E noto come nel nostro ordinamento la capacità di agire, intesa come idoneità del soggetto a compiere validamente atti giuridici impegnativi, si acquisti con il compimento
Il minore nelle associazioni E noto come nel nostro ordinamento la capacità di agire, intesa come idoneità del soggetto a compiere validamente atti giuridici impegnativi, si acquisti con il compimento
Quando scricchiola un paradigma
 Quando scricchiola un paradigma L orientamento sessuale e il diritto Prof. Paolo Veronesi (UniFe) Paradigma = Modello Orientamento sessuale Carta di Nizza (2000) Indice dei temi La depenalizzazione dei
Quando scricchiola un paradigma L orientamento sessuale e il diritto Prof. Paolo Veronesi (UniFe) Paradigma = Modello Orientamento sessuale Carta di Nizza (2000) Indice dei temi La depenalizzazione dei
4 lezione LO STATUTO DELL IMPRENDITORE COMMERCIALE
 4 lezione LO STATUTO DELL IMPRENDITORE COMMERCIALE IMPRENDITORE COMMERCIALE ATTIVITA INDISTRIALE DIRETTA ALLA PRODUZIONE BENI O SERVIZI O ATTIVITA INTERMEDIARIA NELLA CIRCOLAZIONE DI BENI O SERVIZI ATTIVITA
4 lezione LO STATUTO DELL IMPRENDITORE COMMERCIALE IMPRENDITORE COMMERCIALE ATTIVITA INDISTRIALE DIRETTA ALLA PRODUZIONE BENI O SERVIZI O ATTIVITA INTERMEDIARIA NELLA CIRCOLAZIONE DI BENI O SERVIZI ATTIVITA
Percorso di formazione per tutori volontari
 Percorso di formazione per tutori volontari Luigi Fadiga Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza LA TUTELA DEI DIRITTI DEL MINORE Bologna, 7 maggio 2013 Tutela - molti significati: tutela di beni
Percorso di formazione per tutori volontari Luigi Fadiga Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza LA TUTELA DEI DIRITTI DEL MINORE Bologna, 7 maggio 2013 Tutela - molti significati: tutela di beni
Codice civile Legge 6/2004
 La protezione giuridica per le persone incapaci di provvedere a se stesse Codice civile Legge 6/2004 cittadini A.S.L. Mi 1 1 La capacità di provvedere a se stessi Nel nostro ordinamento la persona che
La protezione giuridica per le persone incapaci di provvedere a se stesse Codice civile Legge 6/2004 cittadini A.S.L. Mi 1 1 La capacità di provvedere a se stessi Nel nostro ordinamento la persona che
Dove Come Quando. Capacità giuridica e Capacità d'agire. Premessa. Art. 1 Codice Civile. Diritti della persona
 Diritto Civile CORSO PER L ESAME DI AVVOCATO 2016 I^ Lezione Capacità giuridica e Capacità d'agire Premessa Dove Come Quando - 1 2 Art. 1 Codice Civile Diritti della persona Per capacità giuridica si intende:
Diritto Civile CORSO PER L ESAME DI AVVOCATO 2016 I^ Lezione Capacità giuridica e Capacità d'agire Premessa Dove Come Quando - 1 2 Art. 1 Codice Civile Diritti della persona Per capacità giuridica si intende:
INDICE SOMMARIO LIBRO PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
 INDICE SOMMARIO LIBRO PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA TITOLO VII Della filiazione CAPO I DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA Sezione I. Dello stato di figlio legittimo Art. 231. Paternità del marito...............................
INDICE SOMMARIO LIBRO PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA TITOLO VII Della filiazione CAPO I DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA Sezione I. Dello stato di figlio legittimo Art. 231. Paternità del marito...............................
LEGISLAZIONE DEL TURISMO: DIRITTO COSTITUZIONALE
 LEGISLAZIONE DEL TURISMO: DIRITTO COSTITUZIONALE Diritto = insieme di norme giuridiche fornite di sanzione. Diritto: 1) soggettivo = pretesa. Diritto di libertà negativa; diritto di libertà positiva (diritto
LEGISLAZIONE DEL TURISMO: DIRITTO COSTITUZIONALE Diritto = insieme di norme giuridiche fornite di sanzione. Diritto: 1) soggettivo = pretesa. Diritto di libertà negativa; diritto di libertà positiva (diritto
INDICE. 1 Introduzione. 7 Capitolo 1 Giudici e giurisdizione
 INDICE 1 Introduzione 7 Capitolo 1 Giudici e giurisdizione 7 1. La funzione giurisdizionale 9 2. Chi esercita la funzione giurisdizionale 9 2.1 Giudici ordinari e speciali 11 2.2 Temperamenti al divieto
INDICE 1 Introduzione 7 Capitolo 1 Giudici e giurisdizione 7 1. La funzione giurisdizionale 9 2. Chi esercita la funzione giurisdizionale 9 2.1 Giudici ordinari e speciali 11 2.2 Temperamenti al divieto
4 Unità didattica: Le relazioni giuridiche. Il rapporto giuridico e le persone fisiche
 4 Unità didattica: Le relazioni giuridiche Il rapporto giuridico e le persone fisiche Non tutte le relazioni tra gli individui sono prese in considerazione dal diritto. Quelle degne di rilievo, per l interesse
4 Unità didattica: Le relazioni giuridiche Il rapporto giuridico e le persone fisiche Non tutte le relazioni tra gli individui sono prese in considerazione dal diritto. Quelle degne di rilievo, per l interesse
Le recenti riforme del diritto di famiglia spagnolo in prospettiva comparatistica
 Università degli Studi di Teramo Facoltà di Giurisprudenza Le recenti riforme del diritto di famiglia spagnolo in prospettiva comparatistica di Marianna Vittore Relatore: Anna Veneziano A. A. 2007-08 Introduzione
Università degli Studi di Teramo Facoltà di Giurisprudenza Le recenti riforme del diritto di famiglia spagnolo in prospettiva comparatistica di Marianna Vittore Relatore: Anna Veneziano A. A. 2007-08 Introduzione
INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO DALLA COSTITUZIONE ALLA RIFORMA DEL 2012/2013
 INDICE SOMMARIO Presentazione............................................ VII CAPITOLO PRIMO DALLA COSTITUZIONE ALLA RIFORMA DEL 2012/2013 1. Una premessa......................................... 1 2.
INDICE SOMMARIO Presentazione............................................ VII CAPITOLO PRIMO DALLA COSTITUZIONE ALLA RIFORMA DEL 2012/2013 1. Una premessa......................................... 1 2.
INDICE SOMMARIO. Introduzione... Elenco delle principali abbreviazioni... Capitolo I L AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: UN LUNGO CAMMINO
 INDICE SOMMARIO Introduzione... Elenco delle principali abbreviazioni... XIII XV Capitolo I L AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: UN LUNGO CAMMINO 1. Origine e rilevanza... 1 2. Il perché della riforma... 3 2.1.
INDICE SOMMARIO Introduzione... Elenco delle principali abbreviazioni... XIII XV Capitolo I L AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: UN LUNGO CAMMINO 1. Origine e rilevanza... 1 2. Il perché della riforma... 3 2.1.
INDICE SOMMARIO. Principali abbreviazioni... p. XI. Introduzione... p. 1
 INDICE SOMMARIO Principali abbreviazioni.... p. XI Introduzione........ p. 1 PARTE PRIMA I PROCEDIMENTI VIGENTI IN ITALIA PER IL RICONOSCIMENTO E L ESECUZIONE DELLE DECISIONI STRANIERE CAPITOLO I LE NORME
INDICE SOMMARIO Principali abbreviazioni.... p. XI Introduzione........ p. 1 PARTE PRIMA I PROCEDIMENTI VIGENTI IN ITALIA PER IL RICONOSCIMENTO E L ESECUZIONE DELLE DECISIONI STRANIERE CAPITOLO I LE NORME
REGOLE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE SOSTENUTE ALL ESTERO NELL AMBITO DI PROGRAMMI DI MOBILITÀ Scuola di Giurisprudenza
 REGOLE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE SOSTENUTE ALL ESTERO NELL AMBITO DI PROGRAMMI DI MOBILITÀ Scuola di Giurisprudenza REGOLE GENERALI (VALIDE PER TUTTI I CORSI DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA
REGOLE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE SOSTENUTE ALL ESTERO NELL AMBITO DI PROGRAMMI DI MOBILITÀ Scuola di Giurisprudenza REGOLE GENERALI (VALIDE PER TUTTI I CORSI DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA
pag. Prefazione alla prima edizione... Prefazione alla seconda edizione... Prefazione alla terza edizione...
 INDICE pag. Prefazione alla prima edizione... Prefazione alla seconda edizione... Prefazione alla terza edizione.... XIII XV XVII Capitolo I REGOLAMENTI COMUNITARI E LEGGI NAZIONALI 1. Il «cammino comunitario»
INDICE pag. Prefazione alla prima edizione... Prefazione alla seconda edizione... Prefazione alla terza edizione.... XIII XV XVII Capitolo I REGOLAMENTI COMUNITARI E LEGGI NAZIONALI 1. Il «cammino comunitario»
INTRODUZIONE. di lavoro, di poter reagire nei confronti dello sciopero e se, il suddetto
 INTRODUZIONE Nella presente Tesi si parla della possibilità, da parte del datore di lavoro, di poter reagire nei confronti dello sciopero e se, il suddetto corrisponde perfettamente alle normative inerenti
INTRODUZIONE Nella presente Tesi si parla della possibilità, da parte del datore di lavoro, di poter reagire nei confronti dello sciopero e se, il suddetto corrisponde perfettamente alle normative inerenti
11 Lezione L ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO
 11 Lezione L ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO L ANNULLABILITÀ È UNA FORMA MENO GRAVE DI INVALIDITÀ, GRAZIE ALLA QUALE SI PERMETTE AL SOGGETTO CHE È STATO DANNEGGIATO DA UN NEGOZIO GIURIDICO VIZIATO, DI IMPUGNARLO
11 Lezione L ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO L ANNULLABILITÀ È UNA FORMA MENO GRAVE DI INVALIDITÀ, GRAZIE ALLA QUALE SI PERMETTE AL SOGGETTO CHE È STATO DANNEGGIATO DA UN NEGOZIO GIURIDICO VIZIATO, DI IMPUGNARLO
Elementi di Diritto Canonico
 1 José T. MARTÍN DE AGAR Elementi di Diritto Canonico 2ª edizione Edusc info@edusc.it, Roma 2008, 292 pag. Indice Generale NOTA ALLA SECONDA EDIZIONE PRESENTAZIONE BIBLIOGRAFIA GENERALE DI BASE IN ITALIANO:
1 José T. MARTÍN DE AGAR Elementi di Diritto Canonico 2ª edizione Edusc info@edusc.it, Roma 2008, 292 pag. Indice Generale NOTA ALLA SECONDA EDIZIONE PRESENTAZIONE BIBLIOGRAFIA GENERALE DI BASE IN ITALIANO:
Indice 1 LE FONTI NON CONTRATTUALI DELLE OBBLIGAZIONI. LA SISTEMATICA CODICISTICA
 INSEGNAMENTO DI: ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LA SISTEMATICA CODICISTICA PROF. BERNARDINO IZZI Indice 1 LE FONTI NON CONTRATTUALI DELLE OBBLIGAZIONI. LA SISTEMATICA CODICISTICA ----- 3 2 di 5 1 Le fonti
INSEGNAMENTO DI: ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LA SISTEMATICA CODICISTICA PROF. BERNARDINO IZZI Indice 1 LE FONTI NON CONTRATTUALI DELLE OBBLIGAZIONI. LA SISTEMATICA CODICISTICA ----- 3 2 di 5 1 Le fonti
DIRITTO PRIVATO E LIBERTÀ COSTITUZIONALI
 ALBERTO GIULIO CIANCI DIRITTO PRIVATO E LIBERTÀ COSTITUZIONALI I JOVENE EDITORE NAPOLI 2016 INDICE SOMMARIO Presentazione... p. XV INTRODUZIONE 1. Diritto privato e libertà costituzionali: le ragioni di
ALBERTO GIULIO CIANCI DIRITTO PRIVATO E LIBERTÀ COSTITUZIONALI I JOVENE EDITORE NAPOLI 2016 INDICE SOMMARIO Presentazione... p. XV INTRODUZIONE 1. Diritto privato e libertà costituzionali: le ragioni di
INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 RISARCIMENTO DEL DANNO PER TARDIVA ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE
 INDICE SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... XIII Introduzione L EFFETTIVITAv DEL DIRITTO COMUNITARIO ED IL CROLLO DEL DOGMA DELL IRRESPONSABILITAv DEL POTERE LEGISLATIVO 1 Parte Prima RISARCIBILITAv
INDICE SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... XIII Introduzione L EFFETTIVITAv DEL DIRITTO COMUNITARIO ED IL CROLLO DEL DOGMA DELL IRRESPONSABILITAv DEL POTERE LEGISLATIVO 1 Parte Prima RISARCIBILITAv
LA FECONDAZIONE ASSISTITA NEL SISTEMA PRECEDENTE ALL EMANAZIONE DELLA LEGGE N. 40 DEL 2004.
 LA FECONDAZIONE ASSISTITA NEL SISTEMA PRECEDENTE ALL EMANAZIONE DELLA LEGGE N. 40 DEL 2004. La pratica possibilità di attuare la fecondazione dell ovulo e, quindi, di arrivare al concepimento dell uomo
LA FECONDAZIONE ASSISTITA NEL SISTEMA PRECEDENTE ALL EMANAZIONE DELLA LEGGE N. 40 DEL 2004. La pratica possibilità di attuare la fecondazione dell ovulo e, quindi, di arrivare al concepimento dell uomo
Il contratto nullo e annullabile, le differenze e i caratteri
 Il contratto nullo e annullabile, le differenze e i caratteri Autore: Concas Alessandra In: Diritto civile e commerciale Come dicevano i latini, gli accordi devono essere sempre rispettati ( pacta sunt
Il contratto nullo e annullabile, le differenze e i caratteri Autore: Concas Alessandra In: Diritto civile e commerciale Come dicevano i latini, gli accordi devono essere sempre rispettati ( pacta sunt
INDICE-SOMMARIO. Capitolo I CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE IN TEMA DI ACCOLLO DEL DEBITO D IMPOSTA
 INDICE-SOMMARIO Prefazione... ix Capitolo I CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE IN TEMA DI ACCOLLO DEL DEBITO D IMPOSTA 1.1. La collocazione sistematica dell accollo tra gli istituti preordinati all estinzione
INDICE-SOMMARIO Prefazione... ix Capitolo I CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE IN TEMA DI ACCOLLO DEL DEBITO D IMPOSTA 1.1. La collocazione sistematica dell accollo tra gli istituti preordinati all estinzione
LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE AMMINISTRATIVA INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI
 DOMENICO CROCCO LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELLA FATTISPECIE QUALE ISTITUTO DI DIRITTO SPECIALE JOVENE EDITORE NAPOLI 2012 INDICE Prefazione di Raffaello
DOMENICO CROCCO LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELLA FATTISPECIE QUALE ISTITUTO DI DIRITTO SPECIALE JOVENE EDITORE NAPOLI 2012 INDICE Prefazione di Raffaello
INDICE. pag. Indice delle abbreviazioni delle riviste CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA. EVOLUZIONE E CARATTERI FONDAMENTALI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA
 VII INDICE Indice delle abbreviazioni delle riviste XIII CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA. EVOLUZIONE E CARATTERI FONDAMENTALI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA 1.1. Nozione di famiglia e pluralità di modelli. Parentela
VII INDICE Indice delle abbreviazioni delle riviste XIII CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA. EVOLUZIONE E CARATTERI FONDAMENTALI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA 1.1. Nozione di famiglia e pluralità di modelli. Parentela
PRIMA PARTE I PRINCIPI
 INDICE - SOMMARIO V INDICE-SOMMARIO Prefazione... pag. XV Indice delle abbreviazioni....» XIX PRIMA PARTE I PRINCIPI CAPITOLO I LA RESPONSABILITÀ PENALE SEZIONE I TRADIZIONE 1. Il diritto penale.... pag.
INDICE - SOMMARIO V INDICE-SOMMARIO Prefazione... pag. XV Indice delle abbreviazioni....» XIX PRIMA PARTE I PRINCIPI CAPITOLO I LA RESPONSABILITÀ PENALE SEZIONE I TRADIZIONE 1. Il diritto penale.... pag.
LA RIFORMA DEI POTERI DI CUI AGLI ARTT. 32 DPR N. 600/1973 E 51 DEL D.P.R. N. 633/1972. I POTERI DEGLI UFFICI E LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE
 Seminario di formazione LE INDAGINI FINANZIARIE Milano, 1 luglio 2008 LA RIFORMA DEI POTERI DI CUI AGLI ARTT. 32 DPR N. 600/1973 E 51 DEL D.P.R. N. 633/1972. I POTERI DEGLI UFFICI E LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE
Seminario di formazione LE INDAGINI FINANZIARIE Milano, 1 luglio 2008 LA RIFORMA DEI POTERI DI CUI AGLI ARTT. 32 DPR N. 600/1973 E 51 DEL D.P.R. N. 633/1972. I POTERI DEGLI UFFICI E LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE
SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO- SOCIALI ANNO ACCADEMICO CORSO DI LAUREA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO RAGUSA MARCO AULA II ANNO
 SCUOLA SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO- SOCIALI ANNO ACCADEMICO 2014-2015 CORSO DI LAUREA GIURISPRUDENZA - SEDE DI AGRIGENTO MAGISTRALE INSEGNAMENTO DIRITTO AMMINISTRATIVO I TIPO DI ATTIVITÀ CARATTERIZZANTE
SCUOLA SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO- SOCIALI ANNO ACCADEMICO 2014-2015 CORSO DI LAUREA GIURISPRUDENZA - SEDE DI AGRIGENTO MAGISTRALE INSEGNAMENTO DIRITTO AMMINISTRATIVO I TIPO DI ATTIVITÀ CARATTERIZZANTE
LA CITTADINANZA NELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
 LA CITTADINANZA NELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA Fabio Baggio Scalabrini International Migration Institute Introduzione La dottrina sociale della Chiesa: Insegnamenti e dettami su questioni relative
LA CITTADINANZA NELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA Fabio Baggio Scalabrini International Migration Institute Introduzione La dottrina sociale della Chiesa: Insegnamenti e dettami su questioni relative
Istituzioni di diritto privato. La famiglia. (traccia della lezione) prof. Angelo Venchiarutti IUSLIT Università di Trieste
 Istituzioni di diritto privato La famiglia (traccia della lezione) prof. Angelo Venchiarutti IUSLIT Università di Trieste La famiglia e il diritto di famiglia Art. 29 Cost: «società naturale» Limite del
Istituzioni di diritto privato La famiglia (traccia della lezione) prof. Angelo Venchiarutti IUSLIT Università di Trieste La famiglia e il diritto di famiglia Art. 29 Cost: «società naturale» Limite del
INDICE-SOMMARIO CAPITOLO I MATRIMONIO E FAMIGLIA. Sezione I Il matrimonio civile. Origini e principi pag.
 INDICE-SOMMARIO CAPITOLO I MATRIMONIO E FAMIGLIA Il matrimonio civile. Origini e principi pag. 1. Il matrimonio come fondamento della famiglia. Evoluzione storica, disciplina costituzionale e principi
INDICE-SOMMARIO CAPITOLO I MATRIMONIO E FAMIGLIA Il matrimonio civile. Origini e principi pag. 1. Il matrimonio come fondamento della famiglia. Evoluzione storica, disciplina costituzionale e principi
INDICE. Prima Parte IL TENTATIVO NELLA PENALISTICA EUROPEA DEL XIX SECOLO CAPITOLO I IL SISTEMA ITALIANO
 INDICE Abbreviazioni............................ XIII Premessa.............................. XVII Prima Parte IL TENTATIVO NELLA PENALISTICA EUROPEA DEL XIX SECOLO CAPITOLO I IL SISTEMA ITALIANO 1. La
INDICE Abbreviazioni............................ XIII Premessa.............................. XVII Prima Parte IL TENTATIVO NELLA PENALISTICA EUROPEA DEL XIX SECOLO CAPITOLO I IL SISTEMA ITALIANO 1. La
FABRIZIO DI MARZIO CONTRATTO ILLECITO E DISCIPLINA DEL MERCATO
 FABRIZIO DI MARZIO CONTRATTO ILLECITO E DISCIPLINA DEL MERCATO JOVENE EDITORE NAPOLI 2011 INDICE SOMMARIO Presentazione... p. XVII CAPITOLO PRIMO NORME E TEORIE DEL CONTRATTO ILLECITO I. I TERMINI DEL
FABRIZIO DI MARZIO CONTRATTO ILLECITO E DISCIPLINA DEL MERCATO JOVENE EDITORE NAPOLI 2011 INDICE SOMMARIO Presentazione... p. XVII CAPITOLO PRIMO NORME E TEORIE DEL CONTRATTO ILLECITO I. I TERMINI DEL
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA E CLAUSOLE RIPRODUTTIVE DEL DIVIETO DI CESSIONE
 Quesito di Impresa n. 655-2013/I SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA E CLAUSOLE RIPRODUTTIVE DEL DIVIETO DI CESSIONE Si espone la seguente fattispecie: una s.r.l. semplificata è stata costituita
Quesito di Impresa n. 655-2013/I SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA E CLAUSOLE RIPRODUTTIVE DEL DIVIETO DI CESSIONE Si espone la seguente fattispecie: una s.r.l. semplificata è stata costituita
MUTUO USURARIO E INVALIDITÀ DEL CONTRATTO
 DARIO BUZZELLI MUTUO USURARIO E INVALIDITÀ DEL CONTRATTO Seconda edizione ampliata e aggiornata JOVENE EDITORE 2012 INDICE Premessa... p. 1 CAPITOLO PRIMO INTRODUZIONE 1. Il mutuo usurario nella problematica
DARIO BUZZELLI MUTUO USURARIO E INVALIDITÀ DEL CONTRATTO Seconda edizione ampliata e aggiornata JOVENE EDITORE 2012 INDICE Premessa... p. 1 CAPITOLO PRIMO INTRODUZIONE 1. Il mutuo usurario nella problematica
nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante
 CAPITOLO 2 I soggetti del contratto di rete Principi generali "La legge" fornisce due indicazioni in relazione ai soggetti che possono essere parte di un contratto di rete. Innanzitutto, con riferimento
CAPITOLO 2 I soggetti del contratto di rete Principi generali "La legge" fornisce due indicazioni in relazione ai soggetti che possono essere parte di un contratto di rete. Innanzitutto, con riferimento
Struttura e funzionamento delle norme di DIPP
 Struttura e funzionamento delle norme di DIPP Programma della lezione Le cd. norme di conflitto I criteri di collegamento La qualificazione delle norme di conflitto Le questioni preliminari Come regolare
Struttura e funzionamento delle norme di DIPP Programma della lezione Le cd. norme di conflitto I criteri di collegamento La qualificazione delle norme di conflitto Le questioni preliminari Come regolare
INDICE. Parte prima DIRITTO DI DIFESA E PROCESSO CANONICO DI NULLITÀ MATRIMONIALE
 INDICE Parte prima DIRITTO DI DIFESA E PROCESSO CANONICO DI NULLITÀ MATRIMONIALE La tutela dei diritti nella Chiesa 1. La tutela giuridica quale diritto fondamentale del fedele p. 3 2. Diritto di difesa,
INDICE Parte prima DIRITTO DI DIFESA E PROCESSO CANONICO DI NULLITÀ MATRIMONIALE La tutela dei diritti nella Chiesa 1. La tutela giuridica quale diritto fondamentale del fedele p. 3 2. Diritto di difesa,
INDICE INTRODUZIONE ORIGINE E CONTENUTO DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ LA TENSIONE CULTURALE TRA LIBERTÀ E POTERE
 INDICE Abbreviazioni... pag. XIII INTRODUZIONE ORIGINE E CONTENUTO DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ LA TENSIONE CULTURALE TRA LIBERTÀ E POTERE 1. Agli albori del principio di proporzionalità... pag. 1
INDICE Abbreviazioni... pag. XIII INTRODUZIONE ORIGINE E CONTENUTO DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ LA TENSIONE CULTURALE TRA LIBERTÀ E POTERE 1. Agli albori del principio di proporzionalità... pag. 1
Il principio di intangibilità della legittima (seconda parte)
 Il principio di intangibilità della legittima (seconda parte) Prof.ssa Cinzia Criaco Il legato in sostituzione di legittima Altra eccezione al principio dell intangibilità della legittima è il legato in
Il principio di intangibilità della legittima (seconda parte) Prof.ssa Cinzia Criaco Il legato in sostituzione di legittima Altra eccezione al principio dell intangibilità della legittima è il legato in
INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
 INDICE SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... XI CAPITOLO PRIMO LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE Guida bibliografica... 3 1. La definizione del concetto potestà dei genitori... 5 2. La famiglia
INDICE SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... XI CAPITOLO PRIMO LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE Guida bibliografica... 3 1. La definizione del concetto potestà dei genitori... 5 2. La famiglia
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2003/86/CE RELATIVA AL DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE. 1. Il decreto attua una direttiva europea europea del 2003 in materia di
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2003/86/CE RELATIVA AL DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE. 1. Il decreto attua una direttiva europea europea del 2003 in materia di
LE PERSONE GIURIDICHE
 Prefazione.... Presentazione... Presentazione alla nuova edizione... VII IX XI PARTE PRIMA LE PERSONE GIURIDICHE Capitolo I Concetti generali 1. Nozione................................ 3 2. Brevi cenni
Prefazione.... Presentazione... Presentazione alla nuova edizione... VII IX XI PARTE PRIMA LE PERSONE GIURIDICHE Capitolo I Concetti generali 1. Nozione................................ 3 2. Brevi cenni
LA LEGGE N. 6 DEL 2004: PASSATO, PRESENTE E FUTURO AVV. FULVIO LUZZI CONTI FORO DI UDINE
 LA LEGGE N. 6 DEL 2004: PASSATO, PRESENTE E FUTURO AVV. FULVIO LUZZI CONTI FORO DI UDINE LA LEGGE 9 GENNAIO 2004, N. 6 Ha introdotto al Libro Primo nel Codice Civile mediante la cd. Tecnica della novella
LA LEGGE N. 6 DEL 2004: PASSATO, PRESENTE E FUTURO AVV. FULVIO LUZZI CONTI FORO DI UDINE LA LEGGE 9 GENNAIO 2004, N. 6 Ha introdotto al Libro Primo nel Codice Civile mediante la cd. Tecnica della novella
L'Amministratore di sostegno: L'istituto, il ruolo e il valore. Avv. Erica Brindisi 12 dicembre 2014
 L'Amministratore di sostegno: L'istituto, il ruolo e il valore Avv. Erica Brindisi 12 dicembre 2014 CODICE CIVILE TITOLO I DELLE PERSONE FISICHE Artt. 1-13 Art. 1. CAPACITA' GIURIDICA La capacità giuridica
L'Amministratore di sostegno: L'istituto, il ruolo e il valore Avv. Erica Brindisi 12 dicembre 2014 CODICE CIVILE TITOLO I DELLE PERSONE FISICHE Artt. 1-13 Art. 1. CAPACITA' GIURIDICA La capacità giuridica
IL LICENZIAMENTO PER INABILITA SOPRAVVENUTA. Dott.ssa Luisella Fontanella
 IL LICENZIAMENTO PER INABILITA SOPRAVVENUTA Dott.ssa Luisella Fontanella GRUPPO LAVORO E PREVIDENZA ODCEC TORINO IVREA PINEROLO Torino 29 novembre 2016 FONTI Cod. Civ., artt. 1366, 1463, 1464 e 2103 L.
IL LICENZIAMENTO PER INABILITA SOPRAVVENUTA Dott.ssa Luisella Fontanella GRUPPO LAVORO E PREVIDENZA ODCEC TORINO IVREA PINEROLO Torino 29 novembre 2016 FONTI Cod. Civ., artt. 1366, 1463, 1464 e 2103 L.
Libertà e diritti dei cittadini
 Libertà e diritti dei cittadini Aspetti giuridici della vita quotidiana dal condominio a internet Fondazione Università Popolare di Torino, Torino, 12.12.2013 Avv. Alessia Boario Avv. Daniele Beneventi
Libertà e diritti dei cittadini Aspetti giuridici della vita quotidiana dal condominio a internet Fondazione Università Popolare di Torino, Torino, 12.12.2013 Avv. Alessia Boario Avv. Daniele Beneventi
