Conflitto intergruppi
|
|
|
- Olivia Capasso
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Conflitto intergruppi Origine ed evoluzione del fenomeno Le dico esattamente ciò che penso. Bisognerebbe rispedirli da dove sono venuti. Metterli tutti su una bella nave e buttarli a mare. Violentano le ragazze e molestano i bambini. Non mi fraintenda, non sono razzista. Noi abbiamo bisogno dei negozi pakistani e dei take-away cinesi. Ma chi ha bisogno di questa gentaglia? <<Observer, 4 Ottobre 1998>>
2 Ostilità e conflitto intergruppi Quali sono i processi che portano a forme così dirette di aggressività e conflitto tra gruppi sociali? Come evolvono i conflitti? Come si risolvono? Aggressività e conflitto intergruppi Una reazione tipicamente associata al conflitto è quella di aggressività. Inclinazione a manifestare comportamenti che possono causare danno o dolore (fisico o psicologico) ad altri individui. In psicologia sociale, l aggressività dipende dalle motivazione della persona. Un atteggiamento o un comportamento sono aggressivi se vi è l intenzione di danneggiare gli altri. L aggressività può manifestarsi in forme e con intensità molto diverse, a seconda del contesto sociale e delle disposizioni individuali. L aggressività può, ad esempio, essere distinta in: Aggressività strumentale Aggressività emozionale
3 Teorie di conflitto intergruppi Teoria della frustazione/aggressività (Dollard e collaboratori, 1939) Teoria della deprivazione relativa (Stouffer, 1949) Teoria del Conflitto realistico (Sherif, 1966) Teoria della frustazione aggressività (Dollard et al., 1939) La presenza di un comportamento aggressivo è sempre conseguenza di uno stato di frustazione. La frustazione deriva da un deprivazione oggettiva determinata da un interferenza con il soddisfacimento di un bisogno primario dell individuo. Tale frustazione produce uno stato di arousal (attivazione, energia) aggressivo che deve essere sfogato.
4 Teoria della frustazione aggressività (Dollard et al., 1939) Tale carica aggressiva non sempre può essere sfogata verso la causa della frustazione: Troppo potente Non identificabile Non immediatamente disponibile Il più delle volte tale carica aggressiva viene dislocata su un gruppo estraneo (capro espiatorio): Diverso rispetto al gruppo frustato Debole Esposto, facilmente individuabile Teoria della frustazione aggressività (Dollard et al., 1939) Hovland e Sears (1940): ricerca d archivio negli Stati Uniti del Sud durante gli anni 50: la continua diminuzione del prezzo del cotone (stato di frustazione) era associata con l aumento di aggressioni razziali (linciaggio verso le persone di colore) Germania nazista: grande adesione a ideologie distruttive e aggressive verso gruppi minoritari causata da un passato di frustazioni e umiliazioni dovute al crollo dell economia tedesca.
5 Teoria della frustazione aggressività (Dollard et al., 1939) Interpretazione che si basa su un modello idraulico, fortemente influenzato da un approccio freudiano: Un energia che si accumula in un individuo o in gruppo non svanisce, deve necessariamente essere dissipata, dirigendosi anche lungo canali alternativi (dislocazione dell aggressività). Teoria della frustazione aggressività (Dollard et al., 1939) Teoria fortemente criticata.: Tiene conto di motivazioni intraindividuali, estendendoli a motivazioni intragruppo Difficile riuscire a prevedere e individuare quali sono i capri espiatori : Horowitz (1973): Birmania: polizia coloniale inglese reprime con violenza manifestazione dei birmani. Rivolta successiva colpì indiani musulmani (minoranza in Birmania) e non indiani induisti (altra minoranza). Perché?
6 Teoria della frustazione aggressività (Dollard et al., 1939) Ma soprattutto.: Ci possono essere dei comportamenti aggressivi senza la presenza di una frustazione oggettiva! (esperimenti di Milgram?) Reinterpretazione della teoria della frustazione/aggressività (Berkowitz, 1989) Recentemente Berkowitz (1989) ha reinterpretato la teoria di Dollard e coll., approfondendo tre diversi aspetti: Criterio fondamentale che identifica i gruppi capri espiatori : precedenti conflitti o sentimenti di antipatia e pregiudizio passati. La frustazione non è l unico elemento che determina aggressività, ma ci sono anche altri elementi oggettivi negativi: Dolore fisico Situazioni climatiche avverse (caldo o freddo eccesivo) Carlsmith e Anderson (1979): più probabili episodi di aggressività e rivolta nelle città americane quando faceva molto caldo, rispetto a quando le temperature erano moderate.
7 Reinterpretazione della teoria della frustazione/aggressività (Berkowitz, 1989) Ma soprattutto LA FRUSTAZIONE NON E SOLO UNO STATO DI DEPRIVAZIONE OGGETTIVA, MA PUO ANCHE INCLUDERE DEGLI ELEMENTI SOGGETTIVI LA SOLA IDEA DI ESSERE DEPRIVATI PUO DETERMINARE AGGRESSIVITA. Frustazione e insoddisfazione come stato soggettivo Dirigente di un azienda perennemente insoddisfatto, operaio della stessa azienda felice del suo posto di lavoro. Marco felicissimo della sua macchina di terza mano, Enrico insodisfatto nonostante la sua nuova Ferrari. Paesi Occidentali esprimono malcontento per la crisi economica mentre nei paesi Africani si continua a soffrire la fame.
8 La teoria della deprivazione relativa Assunzione principale: Lo stato di deprivazione (o soddisfazione) di una persona o di un gruppo è relativo, non è oggettivo. Le valutazioni di sé avvengono tramite il confronto. Se mi confronto con altri che stanno peggio di me, o con una situazione passata che reputo peggiore, allora non provo deprivazione. Prime evidenze di deprivazione relativa: la ricerca di Stouffer (1949) Ricerca su vasta scala volta a stabilire gli atteggiamenti del soldato americano. Evidenze che hanno provato l esistenza del concetto di deprivazione relativa: Lamentele per la mancata promozione (deprivazione) molto più veementi nell aereonautica che nella polizia militare. C erano però molte più promozioni nell aereonautica che nella polizia militare! I soldati di colore del Sud avevano un morale uguale se non più alto rispetto ai soldati del Nord. Eppure subivano molte più discriminazioni razziali! PERCHE?
9 Prime evidenze di deprivazione relativa: la ricerca di Stouffer (1949) Ciò che conta non è lo stato oggettivo ma il termine di confronto: Nel caso dell aereonautica il confronto è con gli altri commilitoni. Nel caso dei soldati di colore del Sud il confronto è con i civili di colore degli Stati del Sud. Sono però spiegazioni a posteriori, l individuazione del termine di paragone avviene soltanto successivamente. Indispensabile riuscire a capire i meccanismi che con cui le persone scelgono un termine di paragone. La teoria della deprivazione relativa Cosa determina le aspettative di una persona ed eventuale deprivazione relativa? Livello individuale: Gurr (1970): capacità e aspettative di valore Crosby (1976): cinque criteri fondamentali che portano a deprivazione Livello di gruppo: Davies (1969): confronto con esperienze passate Runciman(1966): deprivazione egoistica e fraterna
10 La teoria della deprivazione relativa in una prospettiva individuale Gurr (1970). L individuo percepisce uno stato di deprivazione relativa quando sente che c è discrepanza tra ciò che un individuo crede di meritare (aspettative di valore) e ciò che crede possibile ottenere (capacità di valore). Le persone provano deprivazione quando sentono di non avere la possibilità di avere ciò che vogliono e che spetta loro. Più il divario tra aspettative e capacità di valore è ampio più è probabile lo scontento sociale e la messa in atto di azioni di protesta. La teoria della deprivazione relativa in una prospettiva individuale Gurr (1970). Esistono tre tipi di deprivazione relativa: Decrementale (ad es., recessione economica): aspettative di valore rimangono costanti, capacità di valore diminuiscono. Aspettative Capacità Aspirazionale (ad es., promesse elettorali): aspettative di valore salgono, ma le capacità di valore rimangono costanti. Capacità Aspettative Progressiva (ad es., boom economico): salgono sia aspettative che capacità di valore, ma le aspettative più velocemente. Aspettative Capacità
11 La teoria della deprivazione relativa in una prospetti va individuale Crosby (1976). Affinchè un individuo provi deprivazione, sono necessari si verifichino cinque condizioni: vedere che qualcun altro possiede X volere X sentire di aver diritto (meritarlo) a possedere X sentire che è possibile possedere X non sentirsi responsabili per il fatto di non possedere X X è un qualcosa che un individuo può ottenere, sia concreto che astratto. La teoria della deprivazione relativa in una prospetti va individuale Esperimento di Bernstein e Crosby (1980). 528 studenti americani leggono una storiella in cui il protagonista è John, uno studente universitario. A seconda della condizione sperimentale, viene manipolata l assenza o presenza di una delle 5 condizioni. La X è l ottenimento di un voto alto.
12 La teoria della deprivazione relativa in una prospetti va individuale Esperimento di Bernstein e Crosby (1980). Sentire di aver diritto di possedere X: Presente: John pensa che il proprio lavoro sia stato eccellente e di meritare il massimo dei voti. Assente: John si accorge che il proprio lavoro non è stato un granchè e non merita più di un voto discreto. Sentirsi responsabili per non avere X: Presente: John sente che se non avesse scelto quel corso non sarebbe andata così. Per questo, si sente molto responsabile di questa situazione. Assente: John sa che non poteva prevedere l andamento degli eventi e perciò non si rimprovera della situazione in cui si trova. La teoria della deprivazione relativa in una prospetti va individuale Esperimento di Bernstein e Crosby (1980). A seconda della condizione sperimentale, chiesto ai partecipanti quanto secondo loro John si sentiva: Insoddisfatto, frustrato, arrabbiato, felice. La percezione di responsabilità sembra avere dei risultati contrari rispetto alle ipotesi: Tanto più John si sentiva responsabile di non avere X tanto si pensava provasse deprivazione.
13 La teoria della deprivazione relativa: verso una prospettiva di gruppo Davies (1969). Le aspettative di un gruppo si generano da un confronto con il passato: E più probabile si provi deprivazione dopo un lungo periodo di crescita, piuttosto che dopo un periodo di lunga privazione. E il declino improvviso delle condizioni di vita che porta alla deprivazione relativa. Nigeria CURVA A J Germania Condizioni di vita Condizioni di vita Periodo temporale Periodo temporale La teoria della deprivazione relativa: verso una prospettiva di gruppo Davies (1969). Le aspettative di un gruppo si generano da un confronto con il passato: Germania nazista, rivoluzione francese, guerra civile americana La deprivazione di un gruppo non si origina soltanto da un confronto con il passato ma anche con un confronto con altri gruppi..(ricerca di Stouffer)
14 La teoria della deprivazione relativa: verso una prospettiva di gruppo Runciman (1966): Distingue due tipi di deprivazione: Deprivazione egoistica (individuale): un individuo si sente deprivato a causa della sua condizione personale. Il confronto avviene, quindi, con altri individui. Deprivazione fraterna (collettiva): un individuo si sente deprivato per la condizione del suo gruppo di appartenenza. E questa deprivazione che porta con più probabilità alla volontà di cambiare la situazione sociale esistente. La teoria della deprivazione relativa: verso una prospettiva di gruppo Caplan (1970): leader politici del Black Power rappresentati da persone di ceto medio elevato (alta deprivazione fraterna), piuttosto che da persone emarginate. Crosby (1982): donne maggiormente attive in movimenti femministi erano coloro insoddisfatte della posizione della donna nella società rispetto agli uomini, rispetto a quelle insoddisfatte della loro posizione personale.
15 La teoria della deprivaz ione relativa: deprivazione fraterna e pregiudizio Vanneman e Pettigrew (1972): misurato in un campione di cittadini bianchi americani il rapporto tra deprivazione relativa e pregiudizio verso le persone di colore. Campione suddiviso in: Partecipanti gratificati : sentivano di stare meglio rispetto agli altri bianchi e anche rispetto all outgroup nero. Partecipanti egoisticamente deprivati : sentivano di stare meglio rispetto all outgroup nero ma peggio rispetto ai membri del loro stesso gruppo bianco. Partecipanti collettivamente deprivati : sentivano di stare peggio soltanto rispetto all outgroup nero. all outgroup nero ma peggio rispetto Partecipanti collettivamente ed egoisticamente deprivati : sentivano di stare peggio sia rispetto all outgroup nero che rispetto ai membri del loro stesso gruppo bianco. La teoria della deprivazione relativa: deprivazione fraterna e pregiudizio Vanneman e Pettigrew (1972): pregiudizio nei confronti dei neri Esempio di item: Ritieni che gli studenti bianchi e neri dovrebbero frequentare scuole separate? Tipo di deprivazione Gratificazione collettiva ed egoistica Deprivazione egoistica Deprivazione collettiva Deprivazione collettiva ed egoistica Pregiudizio N.B: punteggi positivi indicano pregiudizio, punteggi negativi assenza di pregiudizio
16 La teoria della deprivazione relativa: conclusioni e critiche Sembra dunque che solo una deprivazione relativa collettiva abbia delle conseguenze a livello intergruppo (aumento pregiudizio, sostegno attivo a movimenti di protesta). Tuttavia, ci sono alcuni problemi in questa teoria: 1. Come la teoria della frustazione/aggressività è una teoria che ha basi individuali, e viene soltanto successivamente generalizzata al gruppo. La teoria della deprivazione relativa: conclusioni e critiche 2. Non è chiaro quando effettivamente la deprivazione si traduce in azione collettiva. Tre sono gli elementi da considerare: L identificazione con l ingroup Percezione di sentirsi efficaci e attivi nel cambiare lo stato delle cose Sentirsi deprivati ingiustamente. Necessario percepire che la propria situazione di inferiorità sia ingiusta. 3. Impossibile stabilire a priori i confronti sociali, con chi si confronta il gruppo deprivato: Fortemente dipendente dal contesto sociale e dallo scopo che si vuole perseguire.
17 La Teoria del Conflitto Realistico (Sherif, 1966) Rispetto alla Teoria della Deprivazione Relativa la Teoria del conflitto realistico analizza: le origini dei conflitti intergruppi a un livello primariamente di gruppo. i conflitti tra gruppi con ugual potere e status. non solo le origini dei conflitti ma anche il loro evolversi e la loro evoluzione. La Teoria del Conflitto Realistico (Sherif, 1966) Assunto principale: Gli atteggiamenti e i comportamenti fra gruppi riflettono gli interessi oggettivi del proprio gruppo in confronto ad altri gruppi. All origine del conflitto c è un incompatibilità di obiettivi tra gruppi: Se gli obiettivi sono in contrasto, nasce il conflitto, che porta a atteggiamenti e comportamenti apertamente ostili e discriminativi. All origine dei rapporti armoniosi tra gruppi c è una compatibilità di obiettivi: Se al contrario gli scopi sono comuni, i comportamenti dei membri di gruppo diventano più concilianti e amichevoli, diminuisce il favoritismo per l ingroup e aumenta la cooperazione.
18 La Teoria del Conflitto Realistico (Sherif, 1966) I conflitti tra gruppi nascono principalmente quando c è competizione per scarse risorse. Le risorse possono essere di tipo: Materiale (ad es., territori contesi) Astratto (ad es., potere, status sociale). In tutti quei casi in cui il raggiungimento dell obiettivo del mio gruppo dipende dal fallimento dell outgroup. La Teoria del Conflitto Realistico (Sherif, 1966)
19 La Teoria del Conflitto Realistico (Sherif, 1966) I primissimi israeliani che vidi erano dei soldati. Vennero nel mio paese ed entrarono nella scuola. Penso che non ci sia nulla di buono da dire su di loro. Quando vedo dei soldati, penso che un giorno saranno uccisi Non ci sarà pace. Un giorno ci sarà un altra guerra, e gli arabi vinceranno. Ci riprenderemo tutta la Palestina. Najeh Hassan, 20 anni, palestinese Dovete capire gli ebrei. Noi siamo un piccolo popolo; la nostra identità nel passato era quella di gente perseguitata, gente odiata. I giovani israeliani come me sentono che è tempo che Israele non sia oppresso ma una nazione indipendente in grado di controllare il proprio destino (un palestinese) è uno che è povero, fisicamente e mentalmente debole la cui mentalità è rivolta a come ricavare un profitto Yaacov Leviatan, 20 anni, ebreo La Teoria del Conflitto Realistico (Sherif, 1966) C è un conflitto di interessi fondamentale tra noi e i palestinesi: ciò che è un bene per noi è un male per loro, e ciò che è bene per loro è un male per noi Shlomo Leviatan, padre di Yaacov
20 La Teoria del Conflitto Realistico (Sherif, 1966) La Teoria del conflitto realistico si sviluppa tra il 1949 e il 1953, a cavallo tra la fine della seconda Guerra Mondiale e l inizio della Guerra Fredda. Si basa su una visione razionale e funzionale dell individuo e dei gruppi: Comportamenti e atteggiamenti intergruppi determinati dalle relazioni funzionali tra gruppi; tutti i processi psicosociali intergruppi (favoritismo per l ingroup, derogazione dell outgroup) sono conseguenti della compatibilità o incompatibilità degli interessi tra ingroup e outgroup. La Teoria del Conflitto Realistico (Sherif, 1966) Ha origini dall approccio funzionale del sociologo Sumner (1905) e dal suo concetto di etnocentrismo: I membri di un we-group sono in rapporto di pace, ordine, legge, governo e operosità tra loro. La loro relazione con tutti gli estranei, o con altri gruppi, è di guerra e saccheggio..i sentimenti sono prodotti in rapporto a ciò. La fedeltà e lo spirito di sacrificio verso il proprio gruppo, il cameratismo al suo interno, l odio e il disprezzo per gruppi estranei e l ostilità contro di essi crescono tutti assieme, prodotti comuni della stessa situazione.
21 La Teoria del Conflitto Realistico (Sherif, 1966): Gli studi dei campi estivi Sherif e collaboratori hanno condotto tre diversi esperimenti sul campo Luogo: Studi effettuati in una situazione reale, campi estivi nel contesto statunitense della durata di tre settimane. Partecipanti: bambini bianchi (11 e 12 anni) di estrazione medio-borghese, senza alcun problema caratteriale. Animatori del campo erano in realtà i ricercatori. Obiettivo: confermare le assunzioni principali della teoria: atteggiamenti e comportamenti intergruppi si originano da un conflitto di interessi tra gruppi o da obiettivi comuni. La Teoria del Conflitto Realistico (Sherif, 1966): Gli studi dei campi estivi Variabili indipendenti: Introduzione compiti, attività, risorse che presupponevano obiettivi conflittuali o compatibili fra i due gruppi. Variabili dipendenti: Misurazione identificazione con l ingroup, atteggiamenti e comportamenti intergruppi.
22 La Teoria del Conflitto Realistico (Sherif, 1966): Gli studi dei campi estivi INTRODUZIONE COMPITI FUNZIONALI INTERINDIVIDUALI FASE I FORMAZIONE DEI GRUPPI SVILUPPO IDENTITA E CULTURA DI GRUPPO INTRODUZIONE COMPETIZIONE INTERGRUPPI PER SCARSE RISORSE FASE II CONFLITTO INTERGRUPPI ATTEGGIAMENTI DI FAVORITISMO PER L INGROUP E DEROGAZIONE DELL OUTGROUP INTRODUZIONE SCOPI SOVRAORDINATI FASE III COOPERAZIONE INTERGRUPPI RAPPORTI ARMONIOSI FRA GRUPPI La Teoria del Conflitto Realistico (Sherif, 1966): Gli studi dei campi estivi Fase I : a) amicizia interpersonale (Studio 1 e 2) e b) formazione del gruppo: 1) Amicizia interpersonale: i ragazzi inizialmente interagivano a livello interpersonale. Successivamente venivano divisi in due gruppi (due capanne diverse), in modo che migliori amici appartenessero a due gruppi diversi. In questo modo, si eliminava la possibilità che i risultati successivi fossero influenzati dall attrazione interpersonale.
23 La Teoria del Conflitto Realistico (Sherif, 1966): Gli studi dei campi estivi Fase I : 2) formazione del gruppo (Studio 3): the Robber s Cave Experiment (durata: 3 settimane). Durante la prima settimana, creati due gruppi, ognuno non consapevole della presenza dell altro. A questi gruppi assegnati: Un nome (Aquile vs. Serpenti) e un simbolo. Compiti (cucinare, campeggio) che presupponevano collaborazione tra i membri del gruppo, funzionali ad aumentare lo spirito di gruppo e coesione. La Teoria del Conflitto Realistico (Sherif, 1966): Gli studi dei campi estivi Fase I : 2) formazione del gruppo (Studio 3) Si forma un identità e cultura di gruppo: Si crea una leadership e una gerarchia di status. Norme di gruppo. Mini-culture all interno dello stesso gruppo. Soprannomi per i membri, segreti, modi preferiti dal gruppo per fare le cose.
24 La Teoria del Conflitto Realistico (Sherif, 1966): Gli studi dei campi estivi Fase II : introduzione conflitto realistico (Studio 3): Durante la seconda settimana, gruppi informati della presenza dell altro gruppo e introdotti compiti competitivi fra i due gruppi, che presupponevano un interdipendenza negativa: Competizioni atletiche, tiro alla fune, baseball; al gruppo vincitore veniva data una coppa e a ogni membro del gruppo vincitore un distintivo e un coltellino. La Teoria del Conflitto Realistico (Sherif, 1966): Gli studi dei campi estivi Fase II : introduzione conflitto realistico (Studio 3): Immediati atteggiamenti di favoritismo per il proprio gruppo : Favoritismo per il proprio gruppo era sistematico e si estendeva a tutte le situazioni di contatto. Il caso del gioco lancio dei fagioli : sistematica sovrastima della prestazione dei membri dell ingroup rispetto ai membri dell outgroup. Diviene importante la dimensione di giustizia: proprio gruppo considerato leale, giusto, l altro sleale e disonesto.
25 La Teoria del Conflitto Realistico (Sherif, 1966): Gli studi dei campi estivi Fase II : introduzione conflitto realistico (Studio 3): Immediati atteggiamenti di derogazione dell outgroup: Atti verbali intimidatori, appellattivi dispregiativi (ad es., stinkers, pigs, communists ). In alcuni casi vere e proprie aggressioni e atti vandalici. All aumentare del conflitto, gli atteggiamenti di favoritismo per l ingroup e di derogazione dell outgroup vanno al di là delle dimensioni di confronto rilevanti, ma si estendono a tutte le dimensioni La Teoria del Conflitto Realistico (Sherif, 1966): Gli studi dei campi estivi Fase II : introduzione conflitto realistico (Studio 3): I cambiamenti erano anche a livello intragruppo: Aumentava la coesione Aumentava l uniformità Cambiava la leadership (scelti i leader più bellicosi) aggressivi e
26 La Teoria del Conflitto Realistico (Sherif, 1966): Gli studi dei campi estivi Fase III : introduzione obiettivi sovraordinati (Studio 3): Cambiata l interdipendenza tra i due gruppi da negativa (conflitto di interessi) a positiva, attraverso l introduzione di obiettivi sovraordinati. Gli obiettivi sovraordinati sono degli obiettivi importanti per ogni gruppo, il cui raggiungimento dipende dalla cooperazione e partecipazione dell altro gruppo. I due gruppi devono dunque agire assieme e in maniera coordinata per raggiungerlo. La Teoria del Conflitto Realistico (Sherif, 1966): Gli studi dei campi estivi Fase III : introduzione obiettivi sovraordinati (terza settimana), (Studio 3): Principali scopi sovraordinati introdotti dagli sperimentatori: Rottura tubatura dell acqua: necessario la presenza di almeno 25 persone per individuare la causa del problema Guasto al camion che portava i viveri: per farlo ripartire necessario lo sforzo di molte persone.
27 La Teoria del Conflitto Realistico (Sherif, 1966): Gli studi dei campi estivi Fase III : introduzione obiettivi sovraordinati (Studio 3): Sviluppo comportamenti cooperativi e atteggiamenti favorevoli verso l altro gruppo: Entrambi i problemi risolti grazie alla cooperazione fra i due gruppi. Spariscono atteggiamenti di favoritismo per l ingroup e derogazione dell outgroup, relazioni intergruppi amichevoli e armoniosi. Nascono amicizie anche fra membri di gruppi diversi. Si riduce la salienza dei confini dei due gruppi. Alla fine della settimana addirittura si parla di NOI per rappresentare entrambi i gruppi!! La Teoria del Conflitto Realistico (Sherif, 1966): Gli studi dei campi estivi INTRODUZIONE COMPITI FUNZIONALI INTERINDIVIDUALI FASE I FORMAZIONE DEI GRUPPI SVILUPPO IDENTITA E CULTURA DI GRUPPO INTRODUZIONE COMPETIZIONE INTERGRUPPI PER SCARSE RISORSE FASE II CONFLITTO INTERGRUPPI ATTEGGIAMENTI DI FAVORITISMO PER L INGROUP E DEROGAZIONE DELL OUTGROUP INTRODUZIONE SCOPI SOVRAORDINATI FASE III COOPERAZIONE INTERGRUPPI RAPPORTI ARMONIOSI FRA GRUPPI
28 La Teoria del Conflitto Realistico (Sherif, 1966): i meriti La prima teoria che ha analizzato l origine, l evolversi e la risoluzione dei conflitti ad un livello di gruppo. Ha un grande e immediato potere applicativo (ad es., contesto aziendale) Ha valorizzato il ruolo degli scopi sovraordinati La Teoria del Conflitto Realistico (Sherif, 1966): un esempio di scopi sovraordinati LOTTA CONTRO LA FAME E MALNUTRIZIONE DISARMO NUCLEARE RISCALDAMENTO GLOBALE LOTTA CONTRO L AIDS NAZIONI UNITE E O.N.U
29 La Teoria del Conflitto Realistico (Sherif, 1966): i limiti L effetto positivo degli scopi sovraordinati dipende fortemente dal loro esito. Se fallisce il raggiungimento dell obiettivo? Quando è conflitto realistico e quando è conflitto percepito? Sherif ha sempre parlato di conflitto legato a problematiche reali (terreno, denaro, potere politico). Esistono però anche dei conflitti percepiti ma non necessariamente reali come risolverli? La Teoria del Conflitto Realistico (Sherif, 1966): i limiti La nascita di atteggiamenti di favoritismo per l ingroup e di derogazione dell outgroup non necessita dell introduzione di scopi conflittuali, basta anche una semplice categorizzazione tra ingroup e outgroup (..Teoria dell Identità Sociale???) Anche negli studi sui campi estivi, primi atteggiamenti di favoritismo per l ingroup appena ragazzi informati della presenza dell altro gruppo, ancor prima di introdurre gli scopi conflittuali!!
30 La Teoria del Conflitto Realistico (Sherif, 1966): i limiti Quando l ingroup cominciava ad essere chiaramente identificato, c era una tendenza a considerare gli altri come out-group I Serpenti non sapevano dell esistenza dell altro gruppo fino a quando non han sentito le Aquile giocare al campo da baseball; ma da quel momento l outgroup era costantemente presente nella loro vita Un giorno in cui le Aquile stavano giocando, Wilson (membro Serpenti) li sentì e si riferì a loro chiamandoli nigger campers.. (Sherif, 1966)
PSICOLOGIA SOCIALE E DI COMUNITA. Modulo di PSICOLOGIA SOCIALE E DEI GRUPPI IL PREGIUDIZIO. Lisa Pagotto
 PSICOLOGIA SOCIALE E DI COMUNITA Modulo di PSICOLOGIA SOCIALE E DEI GRUPPI IL PREGIUDIZIO Lisa Pagotto lisa.pagotto@unipd.it CHE COSA È IL PREGIUDIZIO? il pregiudizio è un antipatia fondata su una generalizzazione
PSICOLOGIA SOCIALE E DI COMUNITA Modulo di PSICOLOGIA SOCIALE E DEI GRUPPI IL PREGIUDIZIO Lisa Pagotto lisa.pagotto@unipd.it CHE COSA È IL PREGIUDIZIO? il pregiudizio è un antipatia fondata su una generalizzazione
LABORATORIO SPECIALISTICO: Buone pratiche di integrazione
 Facoltà di Psicologia Università di Milano-Bicocca Corso di laurea in PPSDCE LABORATORIO SPECIALISTICO: Buone pratiche di integrazione PARTE I - Simona Sacchi a.a. 2010-2011 Integrazione e risoluzione
Facoltà di Psicologia Università di Milano-Bicocca Corso di laurea in PPSDCE LABORATORIO SPECIALISTICO: Buone pratiche di integrazione PARTE I - Simona Sacchi a.a. 2010-2011 Integrazione e risoluzione
Psicologia Sociale (edizione 2010)
 Psicologia Sociale (edizione 2010) Elliot Aronson Timothy D. Wilson Robin M. Akert Capitoli: 1, 2, 3, 4, 6, 7,10, 11 Prof. M. Ravennna - Università di Ferrara, a.a. 2011-12 Argomenti del corso 1. INTRODUZIONE
Psicologia Sociale (edizione 2010) Elliot Aronson Timothy D. Wilson Robin M. Akert Capitoli: 1, 2, 3, 4, 6, 7,10, 11 Prof. M. Ravennna - Università di Ferrara, a.a. 2011-12 Argomenti del corso 1. INTRODUZIONE
Psicologia Sociale (edizione 2010)
 Psicologia Sociale (edizione 2010) Prof. M. Ravenna - Università di Ferrara, a.a. 2012-13 Elliot Aronson Timothy D. Wilson Robin M. Akert Capitoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 - Scienze e tecnologie
Psicologia Sociale (edizione 2010) Prof. M. Ravenna - Università di Ferrara, a.a. 2012-13 Elliot Aronson Timothy D. Wilson Robin M. Akert Capitoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 - Scienze e tecnologie
IDENTITA DEL GRUPPO IN FORMAZIONE. La gestione dei conflitti
 IDENTITA DEL GRUPPO IN FORMAZIONE La gestione dei conflitti Cosa è un Conflitto? Il conflitto è una situazione in cui una persona percepisce una incompatibilità con uno o più persone o fattori che ostacola
IDENTITA DEL GRUPPO IN FORMAZIONE La gestione dei conflitti Cosa è un Conflitto? Il conflitto è una situazione in cui una persona percepisce una incompatibilità con uno o più persone o fattori che ostacola
LABORATORIO SPECIALISTICO: Buone pratiche di integrazione
 Facoltà di Psicologia Università di Milano-Bicocca Corso di laurea in PPSDCE LABORATORIO SPECIALISTICO: Buone pratiche di integrazione L IPOTESI DEL CONTATTO 1 IPOTESI DEL CONTATTO (Allport, 1954; Williams,
Facoltà di Psicologia Università di Milano-Bicocca Corso di laurea in PPSDCE LABORATORIO SPECIALISTICO: Buone pratiche di integrazione L IPOTESI DEL CONTATTO 1 IPOTESI DEL CONTATTO (Allport, 1954; Williams,
La categorizzazione sociale come chiave di volta del comportamento intergruppi
 Pensare i gruppi La categorizzazione sociale come chiave di volta del comportamento intergruppi lp5 Strumento per affrontare la realtà, semplificare e comprendere l ambiente Linguaggio e comunicazione
Pensare i gruppi La categorizzazione sociale come chiave di volta del comportamento intergruppi lp5 Strumento per affrontare la realtà, semplificare e comprendere l ambiente Linguaggio e comunicazione
DA GIOVE E GIUNONE A BARBIE E KEN (LE CHIAVI DELLA CITTÀ): VALUTAZIONE DAVIDE DÈTTORE
 DA GIOVE E GIUNONE A BARBIE E KEN (LE CHIAVI DELLA CITTÀ): VALUTAZIONE DAVIDE DÈTTORE Università degli Studi di Firenze Istituto Miller, Genova/Firenze Da Giove e Giunone a Barbie e Ken: un intervento
DA GIOVE E GIUNONE A BARBIE E KEN (LE CHIAVI DELLA CITTÀ): VALUTAZIONE DAVIDE DÈTTORE Università degli Studi di Firenze Istituto Miller, Genova/Firenze Da Giove e Giunone a Barbie e Ken: un intervento
Capitolo 7 Pregiudizio e relazioni intergruppo
 Capitolo 7 Pregiudizio e relazioni intergruppo 1 Psicologia sociale Teorie e applicazioni 7.1 La natura del pregiudizio e la discriminazione Pregiudizio: Atteggiamento sfavorevole e talvolta ostile, ma
Capitolo 7 Pregiudizio e relazioni intergruppo 1 Psicologia sociale Teorie e applicazioni 7.1 La natura del pregiudizio e la discriminazione Pregiudizio: Atteggiamento sfavorevole e talvolta ostile, ma
LA TEORIA DELLA CATEGORIZZAZIONE DI SÉ
 LA TEORIA DELLA CATEGORIZZAZIONE DI SÉ 1 Origini e sviluppo La Teoria della Categorizzazione di Sé (Self-Categorization Theory, SCT, Turner et al., 1987) nasce con l obiettivo di comprendere, spiegare
LA TEORIA DELLA CATEGORIZZAZIONE DI SÉ 1 Origini e sviluppo La Teoria della Categorizzazione di Sé (Self-Categorization Theory, SCT, Turner et al., 1987) nasce con l obiettivo di comprendere, spiegare
PSICOLOGIA DI GRUPPO (a cura della Dr.ssa Catia Terra)
 C E F O PSICOLOGIA DI GRUPPO (a cura della Dr.ssa Catia Terra) Una Comunità è un insieme di individui che condividono lo stesso ambiente fisico formando un GRUPPO riconoscibile, unito da vincoli organizzativi,
C E F O PSICOLOGIA DI GRUPPO (a cura della Dr.ssa Catia Terra) Una Comunità è un insieme di individui che condividono lo stesso ambiente fisico formando un GRUPPO riconoscibile, unito da vincoli organizzativi,
BENESSERE ORGANIZZATIVO LA RICERCA IN OLTRE 200 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ITALIANE
 BENESSERE ORGANIZZATIVO LA RICERCA IN OLTRE 200 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ITALIANE Francesco Minchillo DAL LABORATORIO AL KIT SUL BENESSERE INIZIATIVA ANNO PARTECIPANTI LABORATORIO 2002 11 amministrazioni
BENESSERE ORGANIZZATIVO LA RICERCA IN OLTRE 200 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ITALIANE Francesco Minchillo DAL LABORATORIO AL KIT SUL BENESSERE INIZIATIVA ANNO PARTECIPANTI LABORATORIO 2002 11 amministrazioni
METODOLOGIA DELLA RICERCA IN PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO A.A APPUNTI DEL CORSO TENUTO DALLA Prof.Laura D Odorico N.3
 METODOLOGIA DELLA RICERCA IN PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO A.A. 2005-2006 APPUNTI DEL CORSO TENUTO DALLA Prof.Laura D Odorico N.3 Ricerche correlazionali In alcuni disegni di ricerca non c è una variabile
METODOLOGIA DELLA RICERCA IN PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO A.A. 2005-2006 APPUNTI DEL CORSO TENUTO DALLA Prof.Laura D Odorico N.3 Ricerche correlazionali In alcuni disegni di ricerca non c è una variabile
Sé, identità e gruppi
 Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale a.a. 2012/2013 PSICOLOGIA SOCIALE E DI COMUNITÀ Modulo di PSICOLOGIA SOCIALE E DEI GRUPPI Sé, identità e gruppi Alessio Nencini alessio.nencini@univr.it
Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale a.a. 2012/2013 PSICOLOGIA SOCIALE E DI COMUNITÀ Modulo di PSICOLOGIA SOCIALE E DEI GRUPPI Sé, identità e gruppi Alessio Nencini alessio.nencini@univr.it
Emozioni e stati d animo
 Emozioni e stati d animo Alcune definizioni Affetto: ampia gamma di sentimenti che le persone provano Emozioni: intensi sentimenti rivolti a qualcuno o a qualcosa Stati d animo: sentimenti meno intensi
Emozioni e stati d animo Alcune definizioni Affetto: ampia gamma di sentimenti che le persone provano Emozioni: intensi sentimenti rivolti a qualcuno o a qualcosa Stati d animo: sentimenti meno intensi
PSICOLOGIA COGNITIVA. Gaia Vicenzi - Psicologia Cognitiva
 PSICOLOGIA COGNITIVA Che cosa studia la psicologia sociale? Doise (1982) ha individuato quattro diversi livelli in cui lo studio della psicologia si colloca a seconda della natura delle variabili coinvolte
PSICOLOGIA COGNITIVA Che cosa studia la psicologia sociale? Doise (1982) ha individuato quattro diversi livelli in cui lo studio della psicologia si colloca a seconda della natura delle variabili coinvolte
L etica protestante e lo spirito del capitalismo
 LEZIONE 1 Max Weber L etica protestante e lo spirito del capitalismo Etica protestante e spirito del capitalismo Carattere prevalentemente protestante della proprietà capitalistica.. Non è solo un fatto
LEZIONE 1 Max Weber L etica protestante e lo spirito del capitalismo Etica protestante e spirito del capitalismo Carattere prevalentemente protestante della proprietà capitalistica.. Non è solo un fatto
06/10/2014. Che cos è la psicologia sociale? Capitolo 1. Obiettivi del corso. Programma del corso. Esame
 Obiettivi del corso Trasmettere i fondamenti della disciplina: Teorie, metodi, oggetti Trasmettere il linguaggio della disciplina Programma del corso Hogg, M.A. & Vaughan G.M. (2012). Psicologia sociale.
Obiettivi del corso Trasmettere i fondamenti della disciplina: Teorie, metodi, oggetti Trasmettere il linguaggio della disciplina Programma del corso Hogg, M.A. & Vaughan G.M. (2012). Psicologia sociale.
Esercitazioni per il corso di Storia economica (00-49) Parte II 12 maggio 2015
 Esercitazioni per il corso di Storia economica (00-49) Parte II 12 maggio 2015 Prof. Michelangelo Vasta 1 Oggi vedremo: (1) Economie di Scala (2) Disoccupazione e Legge di Okun (3) Inflazione e Curva di
Esercitazioni per il corso di Storia economica (00-49) Parte II 12 maggio 2015 Prof. Michelangelo Vasta 1 Oggi vedremo: (1) Economie di Scala (2) Disoccupazione e Legge di Okun (3) Inflazione e Curva di
CAP. 8 PROCESSI DI GRUPPO
 CAP. 8 PROCESSI DI GRUPPO Il gruppo come esperienza umana fondamentale 1) CHE COSA E UN GRUPPO? Perché le persone si riuniscono in gruppi? I criteri che definiscono un gruppo La natura dei gruppi sociali:
CAP. 8 PROCESSI DI GRUPPO Il gruppo come esperienza umana fondamentale 1) CHE COSA E UN GRUPPO? Perché le persone si riuniscono in gruppi? I criteri che definiscono un gruppo La natura dei gruppi sociali:
Tecniche della comunicazione e relazione Dinamiche e tecniche di comunicazione
 Tecniche della comunicazione e relazione Dinamiche e tecniche di comunicazione La prima esperienza di relazione è quella che avviene tra il bambino e la madre (relazione diadica) Diade: entità composta
Tecniche della comunicazione e relazione Dinamiche e tecniche di comunicazione La prima esperienza di relazione è quella che avviene tra il bambino e la madre (relazione diadica) Diade: entità composta
BENESSERE ORGANIZZATIVO
 BENESSERE ORGANIZZATIVO STRESS LAVORO-CORRELATO V A L U TA Z I O N E P R E L I M I N A R E E V A L U TA Z I O N E A P P R O F O N D I TA Anno 2015 La valutazione del rischio di stress correlato all ambiente
BENESSERE ORGANIZZATIVO STRESS LAVORO-CORRELATO V A L U TA Z I O N E P R E L I M I N A R E E V A L U TA Z I O N E A P P R O F O N D I TA Anno 2015 La valutazione del rischio di stress correlato all ambiente
Tecniche di Vendita 17 Giugno 2013
 Tecniche di Vendita 17 Giugno 2013 AGENDA le tecniche di vendita La tua strategia di vendita 2 Le slide di questo corso puoi scaricarle nel sito: www.wearelab.com www.brunobruni.it 3 BREVE RIEPILOGO Cambio
Tecniche di Vendita 17 Giugno 2013 AGENDA le tecniche di vendita La tua strategia di vendita 2 Le slide di questo corso puoi scaricarle nel sito: www.wearelab.com www.brunobruni.it 3 BREVE RIEPILOGO Cambio
Modelli e Metodi per la Simulazione (MMS)
 Modelli e Metodi per la Simulazione (MMS) adacher@dia.uniroma3.it Programma La simulazione ad eventi discreti, è una metodologia fondamentale per la valutazione delle prestazioni di sistemi complessi (di
Modelli e Metodi per la Simulazione (MMS) adacher@dia.uniroma3.it Programma La simulazione ad eventi discreti, è una metodologia fondamentale per la valutazione delle prestazioni di sistemi complessi (di
BISOGNI E PULSIONI (1 di 2)
 ISTINTI (2 di 3) Il primo a parlare di istinto fu James (1890) che lo considerava come la facoltà di agire in modo da produrre certi effetti finali senza aver preveduto e senza previa educazione ad agire
ISTINTI (2 di 3) Il primo a parlare di istinto fu James (1890) che lo considerava come la facoltà di agire in modo da produrre certi effetti finali senza aver preveduto e senza previa educazione ad agire
PNL, un decalogo per la gestione efficace dell aula
 SEMINARIO DI SVILUPPO PROFESSIONALE DEI FORMATORI IPAF 2016 PNL, un decalogo per la gestione efficace dell aula Pier Angelo Cantù Bologna, 21 Gennaio 2016 Savoia Regency Hotel La PNL E lo studio della
SEMINARIO DI SVILUPPO PROFESSIONALE DEI FORMATORI IPAF 2016 PNL, un decalogo per la gestione efficace dell aula Pier Angelo Cantù Bologna, 21 Gennaio 2016 Savoia Regency Hotel La PNL E lo studio della
I PARADIGMI E LE RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE DI KUHN
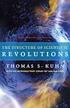 I PARADIGMI E LE RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE DI KUHN Corso di Dottorato di Ricerca Lezioni di Filosofia e Metodologia della Ricerca Scientifica Giacomo Zanni Dipartimento ENDIF Università di Ferrara Thomas
I PARADIGMI E LE RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE DI KUHN Corso di Dottorato di Ricerca Lezioni di Filosofia e Metodologia della Ricerca Scientifica Giacomo Zanni Dipartimento ENDIF Università di Ferrara Thomas
Noi non siamo un ricettacolo passivo di pulsioni nascoste ma costruiamo ATTIVAMENTE la nostra realtà
 LE EMOZIONI Noi non siamo un ricettacolo passivo di pulsioni nascoste ma costruiamo ATTIVAMENTE la nostra realtà IL DIALOGO INTERIORE Cos è? È l elaborazione cognitiva ed emotiva di ciò che ci è pervenuto
LE EMOZIONI Noi non siamo un ricettacolo passivo di pulsioni nascoste ma costruiamo ATTIVAMENTE la nostra realtà IL DIALOGO INTERIORE Cos è? È l elaborazione cognitiva ed emotiva di ciò che ci è pervenuto
Bagnasco, Barbagli, Cavalli, Corso di sociologia, Il Mulino, 2007 Capitolo VI. Identità e socializzazione. Identità e socializzazione
 Identità e socializzazione 1 Ogni società deve assicurare la propria continuità nel tempo. È necessario, quindi, che essa disponga di pratiche e istituzioni, atte a trasmettere almeno una parte del patrimonio
Identità e socializzazione 1 Ogni società deve assicurare la propria continuità nel tempo. È necessario, quindi, che essa disponga di pratiche e istituzioni, atte a trasmettere almeno una parte del patrimonio
CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA Modulo 7 - L empatia con la donna Aspetti più rilevanti F. PELLEGRINO, Salerno
 CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA Modulo 7 - L empatia con la donna Aspetti più rilevanti F. PELLEGRINO, Salerno empatia http://www.tuttogreen.it L empatia si basa sull autoconsapevolezza; quanto più si è
CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA Modulo 7 - L empatia con la donna Aspetti più rilevanti F. PELLEGRINO, Salerno empatia http://www.tuttogreen.it L empatia si basa sull autoconsapevolezza; quanto più si è
Prime lezioni di Economia
 Prime lezioni di Economia Paolo Ermano paolo.ermano@uniud.it Università degli studi di Udine 1 I Presupposti del Capitalismo 2 I Presupposti del Capitalismo Già nella Ricchezza delle Nazioni di Adam Smith
Prime lezioni di Economia Paolo Ermano paolo.ermano@uniud.it Università degli studi di Udine 1 I Presupposti del Capitalismo 2 I Presupposti del Capitalismo Già nella Ricchezza delle Nazioni di Adam Smith
STRESS LAVORO CORRELATO
 STRESS LAVORO CORRELATO Stress e valutazione del rischio CREMONA 24 febbraio 2009 Cos è lo Stress Lo stress è una condizione fisica o psicologica che insorge in una persona quando si trova ad affrontare
STRESS LAVORO CORRELATO Stress e valutazione del rischio CREMONA 24 febbraio 2009 Cos è lo Stress Lo stress è una condizione fisica o psicologica che insorge in una persona quando si trova ad affrontare
Che cos'è una teoria?
 Una teoria è: Che cos'è una teoria? un sistema di riferimento, una mappa mentale, uno schema concettuale che cerca di organizzare e spiegare i fenomeni in termini di principi generale o di leggi. Una teoria
Una teoria è: Che cos'è una teoria? un sistema di riferimento, una mappa mentale, uno schema concettuale che cerca di organizzare e spiegare i fenomeni in termini di principi generale o di leggi. Una teoria
Il conflitto. Dott.ssa E. Fraccaroli Psicologa Psicotarapeuta
 Il conflitto Abbiamo PAURA del conflitto se pensiamo che sia uno SCONTRO che porti ad una ROTTURA L importanza delle parole Di cosa stiamo parlando? Il termine conflitto viene utilizzato regolarmente come
Il conflitto Abbiamo PAURA del conflitto se pensiamo che sia uno SCONTRO che porti ad una ROTTURA L importanza delle parole Di cosa stiamo parlando? Il termine conflitto viene utilizzato regolarmente come
INTELLIGENZA EMOTIVA IL RUOLO DELLE EMOZIONI NELLO SVILUPPO
 INTELLIGENZA EMOTIVA IL RUOLO DELLE EMOZIONI NELLO SVILUPPO Perché occuparsi di educazione emotiva? In adolescenza e nella vita adulta EMOZIONI: sostanze stupefacenti naturali le uniche in grado di proteggere
INTELLIGENZA EMOTIVA IL RUOLO DELLE EMOZIONI NELLO SVILUPPO Perché occuparsi di educazione emotiva? In adolescenza e nella vita adulta EMOZIONI: sostanze stupefacenti naturali le uniche in grado di proteggere
DISCRIMINAZIONI: RICONOSCERE, PREVENIRE, CONTRASTARE
 Corso DISCRIMINAZIONI: RICONOSCERE, PREVENIRE, CONTRASTARE Giovanni Giulio Valtolina Fondazione Ismu Milano, 25 novembre 2014 Identitàsociale Categorizzazione Confronto sociale Pregiudizi e stereotipi
Corso DISCRIMINAZIONI: RICONOSCERE, PREVENIRE, CONTRASTARE Giovanni Giulio Valtolina Fondazione Ismu Milano, 25 novembre 2014 Identitàsociale Categorizzazione Confronto sociale Pregiudizi e stereotipi
IL PREGIUDIZIO Lisa Pagotto
 PSICOLOGIA SOCIALE E DI COMUNITA Modulo di PSICOLOGIA SOCIALE E DEI GRUPPI IL PREGIUDIZIO Lisa Pagotto lisa.pagotto@unipd.it CHE COSA È IL PREGIUDIZIO? il pregiudizio è un antipatia fondata su una generalizzazione
PSICOLOGIA SOCIALE E DI COMUNITA Modulo di PSICOLOGIA SOCIALE E DEI GRUPPI IL PREGIUDIZIO Lisa Pagotto lisa.pagotto@unipd.it CHE COSA È IL PREGIUDIZIO? il pregiudizio è un antipatia fondata su una generalizzazione
Lezione 5 La cultura organizzativa (Cap. 6: pp , Decastri, 2016) Università degli Studi di Roma Tor Vergata a.a
 Lezione 5 La cultura organizzativa (Cap. 6: pp. 201-236, Decastri, 2016) Università degli Studi di Roma Tor Vergata a.a. 2015-2016 1 Contenuti 1. Premessa 2. La cultura organizzativa Il concetto e le definizioni
Lezione 5 La cultura organizzativa (Cap. 6: pp. 201-236, Decastri, 2016) Università degli Studi di Roma Tor Vergata a.a. 2015-2016 1 Contenuti 1. Premessa 2. La cultura organizzativa Il concetto e le definizioni
Valutazione efficacia della terapia con campi magneto-elettrici ultradeboli ODONTOIATRIA. Risultati definitivi Marzo 2014
 Valutazione efficacia della terapia con campi magneto-elettrici ultradeboli ODONTOIATRIA Risultati definitivi Marzo 2014 1. Analisi descrittive sul campione Il campione è composto da 20 partecipanti, con
Valutazione efficacia della terapia con campi magneto-elettrici ultradeboli ODONTOIATRIA Risultati definitivi Marzo 2014 1. Analisi descrittive sul campione Il campione è composto da 20 partecipanti, con
La motivazione ad apprendere tra ricerca psicologica e senso comune
 La motivazione ad apprendere tra ricerca psicologica e senso comune Pietro Boscolo Università di Padova Conegliano, 12 febbraio 2009 Due definizioni di motivazione 1. processo dinamico mediante cui caratteristiche
La motivazione ad apprendere tra ricerca psicologica e senso comune Pietro Boscolo Università di Padova Conegliano, 12 febbraio 2009 Due definizioni di motivazione 1. processo dinamico mediante cui caratteristiche
La Customer satisfaction Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.
 La Customer satisfaction 2012 Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. la customer satisfaction principali evidenze utenti attivi convenzioni utenti attivi mercato elettronico 2 la
La Customer satisfaction 2012 Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. la customer satisfaction principali evidenze utenti attivi convenzioni utenti attivi mercato elettronico 2 la
la struttura di una teoria
 DIAGNOSTICA PSICOLOGICA lezione! Paola Magnano paola.magnano@unikore.it la struttura di una teoria la struttura di una teoria modello di Bagozzi (1994) I livello./.. un esempio Linguaggio: della matematica
DIAGNOSTICA PSICOLOGICA lezione! Paola Magnano paola.magnano@unikore.it la struttura di una teoria la struttura di una teoria modello di Bagozzi (1994) I livello./.. un esempio Linguaggio: della matematica
SPORTELLO PROVINCIALE AUTISMO
 MIUR - Direzione Generale per il Veneto Ufficio XIII - Ufficio Scolastico di Vicenza Rete dei CTI - Centri Territoriali per l Integrazione della provincia di Vicenza SPORTELLO PROVINCIALE AUTISMO Consulente
MIUR - Direzione Generale per il Veneto Ufficio XIII - Ufficio Scolastico di Vicenza Rete dei CTI - Centri Territoriali per l Integrazione della provincia di Vicenza SPORTELLO PROVINCIALE AUTISMO Consulente
SFIDE E OPPORTUNITA DEL LAVORO DI GRUPPO
 Carugate, 30 marzo 2012 SFIDE E OPPORTUNITA DEL LAVORO DI GRUPPO Chiara D Angelo, psicologa Esperta in Mediazione in ambito sportivo UNA GUIDA 1. Dal gruppo al gruppo di lavoro 2. Fuochi d attenzione per
Carugate, 30 marzo 2012 SFIDE E OPPORTUNITA DEL LAVORO DI GRUPPO Chiara D Angelo, psicologa Esperta in Mediazione in ambito sportivo UNA GUIDA 1. Dal gruppo al gruppo di lavoro 2. Fuochi d attenzione per
La teoria dell offerta
 La teoria dell offerta Tecnologia e costi di produzione In questa lezione approfondiamo l analisi del comportamento delle imprese e quindi delle determinanti dell offerta. In particolare: è possibile individuare
La teoria dell offerta Tecnologia e costi di produzione In questa lezione approfondiamo l analisi del comportamento delle imprese e quindi delle determinanti dell offerta. In particolare: è possibile individuare
VADO. Strumento di Valutazione delle Abilità e Definizione degli Obiettivi nell intervento di riabilitazione psichiatrica
 VADO Strumento di Valutazione delle Abilità e Definizione degli Obiettivi nell intervento di riabilitazione psichiatrica Viene utilizzato principalmente nella riabilitazione psichiatrica e psicosociale
VADO Strumento di Valutazione delle Abilità e Definizione degli Obiettivi nell intervento di riabilitazione psichiatrica Viene utilizzato principalmente nella riabilitazione psichiatrica e psicosociale
Le ragioni dell apprendere
 Motivazione come variabile complessa 1 a Approccio comportamentista alla motivazione ed evoluzione 2 a La teoria degli obiettivi di riuscita 1 b Tre dimensioni nel concetto di motivazione ad apprendere
Motivazione come variabile complessa 1 a Approccio comportamentista alla motivazione ed evoluzione 2 a La teoria degli obiettivi di riuscita 1 b Tre dimensioni nel concetto di motivazione ad apprendere
MEDICI DI MEDICINA GENERALE E SERT: DUE ESPERIENZE A CONFRONTO
 MEDICI DI MEDICINA GENERALE E SERT: DUE ESPERIENZE A CONFRONTO Regione Toscana Azienda USL 8 Arezzo Direttore Generale Dr. Enrico Desideri Direttore Amministrativo Dr. Moraldo Neri Ser.t. Arezzo Dott.
MEDICI DI MEDICINA GENERALE E SERT: DUE ESPERIENZE A CONFRONTO Regione Toscana Azienda USL 8 Arezzo Direttore Generale Dr. Enrico Desideri Direttore Amministrativo Dr. Moraldo Neri Ser.t. Arezzo Dott.
L idea di cultura nella tradizione sociologica
 L idea di cultura nella tradizione sociologica Scemo e più Scemo, 1994 L idea di cultura in due tradizioni sociologiche di ricerca Émile Durkheim (1858 1917) Max Weber (1864 1920) La scuola Francese La
L idea di cultura nella tradizione sociologica Scemo e più Scemo, 1994 L idea di cultura in due tradizioni sociologiche di ricerca Émile Durkheim (1858 1917) Max Weber (1864 1920) La scuola Francese La
L amicizia tra bambini. Floriana La Femina Lasino, 22 marzo 2010
 L amicizia tra bambini Floriana La Femina Lasino, 22 marzo 2010 Oltre i genitori Lo sviluppo sociale del bambino è influenzato anche da altre figure significative: nonni educatori e insegnanti pari Gli
L amicizia tra bambini Floriana La Femina Lasino, 22 marzo 2010 Oltre i genitori Lo sviluppo sociale del bambino è influenzato anche da altre figure significative: nonni educatori e insegnanti pari Gli
Che cos è la Psicologia sociale? Dott.ssa Daniela Cipollone
 Che cos è la Psicologia sociale? Dott.ssa Daniela Cipollone Difficoltà ad identificare una definizione sufficientemente articolata e sintetica: - complessità del campo di pertinenza della psicologia sociale;
Che cos è la Psicologia sociale? Dott.ssa Daniela Cipollone Difficoltà ad identificare una definizione sufficientemente articolata e sintetica: - complessità del campo di pertinenza della psicologia sociale;
Ben-essere a scuola: l insegnante come base sicura. Rosalinda Cassibba Università degli Studi di Bari
 Ben-essere a scuola: l insegnante come base sicura Rosalinda Cassibba Università degli Studi di Bari Teoria dell attaccamento Legame emotivo con adulti significativi Radice di uno sviluppo psicologico
Ben-essere a scuola: l insegnante come base sicura Rosalinda Cassibba Università degli Studi di Bari Teoria dell attaccamento Legame emotivo con adulti significativi Radice di uno sviluppo psicologico
Firenze 09/11/2016 PERCHÉ ABBIAMO FATTO UNA SCUOLA CALCIO?
 Announcement n. 6/2016 Firenze 09/11/2016 Come ben sapete, il Centro Storico Lebowski è una società sportiva dilettantistica che intende lo sport come veicolo di conoscenza, solidarietà e trasformazione
Announcement n. 6/2016 Firenze 09/11/2016 Come ben sapete, il Centro Storico Lebowski è una società sportiva dilettantistica che intende lo sport come veicolo di conoscenza, solidarietà e trasformazione
Il modello dell Azione Ragionata (Ajzen e Fishbein1980)
 Il modello dell Azione Ragionata (Ajzen e Fishbein1980) La teoria dell azione ragionata (Ajzen e Fishbein, 1980) fornisce una struttura di base che mira a spiegare e comprendere come si vengono a concretizzare
Il modello dell Azione Ragionata (Ajzen e Fishbein1980) La teoria dell azione ragionata (Ajzen e Fishbein, 1980) fornisce una struttura di base che mira a spiegare e comprendere come si vengono a concretizzare
su come può essere valutata l'attività di personalità del mondo politico. rispondendo alle domande che seguono in modo altrettanto accurato.
 QB1-X Stiamo svolgendo un'indagine sugli atteggiamenti verso alcuni rilevanti temi sociali e su come può essere valutata l'attività di personalità del mondo politico. Ti preghiamo di leggere attentamente
QB1-X Stiamo svolgendo un'indagine sugli atteggiamenti verso alcuni rilevanti temi sociali e su come può essere valutata l'attività di personalità del mondo politico. Ti preghiamo di leggere attentamente
modo di comunicare (comportamento) più 1. Conoscere se stessi (analizzare comportamenti manifesti e nascosti)
 Assertività: modo di comunicare (comportamento) più adatto alla situazione sociale Obiettivi: 1. Conoscere se stessi (analizzare comportamenti manifesti e nascosti) 2. Costruire buona immagine di sé privata
Assertività: modo di comunicare (comportamento) più adatto alla situazione sociale Obiettivi: 1. Conoscere se stessi (analizzare comportamenti manifesti e nascosti) 2. Costruire buona immagine di sé privata
Dr.ssa Alice Corà Dr.ssa Irene Fiorini
 Dr.ssa Alice Corà Dr.ssa Irene Fiorini La perdita per me è perdere qualcosa a cui si tiene, che sia qualcosa di materiale o anche qualcosa di spirituale. Il dolore può essere suddiviso in: dolore della
Dr.ssa Alice Corà Dr.ssa Irene Fiorini La perdita per me è perdere qualcosa a cui si tiene, che sia qualcosa di materiale o anche qualcosa di spirituale. Il dolore può essere suddiviso in: dolore della
Psicologia delle relazioni intra- e intergruppi
 Psicologia delle relazioni intra- e intergruppi Programma a.a. 2016/2017 Obiettivi del corso Questo corso è dedicato allo studio dei processi di gruppo e alla loro declinazione in ambito organizzativo.
Psicologia delle relazioni intra- e intergruppi Programma a.a. 2016/2017 Obiettivi del corso Questo corso è dedicato allo studio dei processi di gruppo e alla loro declinazione in ambito organizzativo.
Corso di Economia Internazionale Prof. Gianfranco Viesti
 Dipartimento di Scienze Politiche Università di Bari Corso di Economia Internazionale 2016-17 Prof. Gianfranco Viesti Modulo 2 Fattori produttivi e commercio internazionale Krugman-Obstfeld, cap. 4 Copyright
Dipartimento di Scienze Politiche Università di Bari Corso di Economia Internazionale 2016-17 Prof. Gianfranco Viesti Modulo 2 Fattori produttivi e commercio internazionale Krugman-Obstfeld, cap. 4 Copyright
A. Luisi Urbino, 8 marzo 2013
 EMPOWERMENT Sviluppo di potere e di responsabilità A. Luisi Urbino, 8 marzo 2013 Non è solo potenziamento Non è solo arricchimento Non è solo sviluppo Chi ne parla: diverse prospettive e denominatori i
EMPOWERMENT Sviluppo di potere e di responsabilità A. Luisi Urbino, 8 marzo 2013 Non è solo potenziamento Non è solo arricchimento Non è solo sviluppo Chi ne parla: diverse prospettive e denominatori i
Che cosa tiene insieme la società?
 Storia del pensiero sociologico EMILE DURKHEIM ( 1858-1917) Vita 1858 nasce a Epinal, Lorena (Francia) la sua famiglia apparteneva al ceto degli ebrei osservanti, padre rabbino 1879 studia all'ecole Normale"
Storia del pensiero sociologico EMILE DURKHEIM ( 1858-1917) Vita 1858 nasce a Epinal, Lorena (Francia) la sua famiglia apparteneva al ceto degli ebrei osservanti, padre rabbino 1879 studia all'ecole Normale"
Alessandro Rosina Professore ordinario Demografia Direttore L.S.A. Università Cattolica S.C.
 Alessandro Rosina Professore ordinario Demografia Direttore L.S.A. Università Cattolica S.C. 1 Commissione Europea: Le sfide poste in questo secolo da globalizzazione e invecchiamento della pop. Si vincono
Alessandro Rosina Professore ordinario Demografia Direttore L.S.A. Università Cattolica S.C. 1 Commissione Europea: Le sfide poste in questo secolo da globalizzazione e invecchiamento della pop. Si vincono
ANZIANI IN MOVIMENTO : L ATTIVITA MOTORIA E LA SALUTE
 ANZIANI IN MOVIMENTO : L ATTIVITA MOTORIA E LA SALUTE Il Comitato Territoriale UISP di Jesi organizza e gestisce, da, Attività Motorie rivolte al benessere psico-fisico ed al miglioramento della qualità
ANZIANI IN MOVIMENTO : L ATTIVITA MOTORIA E LA SALUTE Il Comitato Territoriale UISP di Jesi organizza e gestisce, da, Attività Motorie rivolte al benessere psico-fisico ed al miglioramento della qualità
FATTORI PSICOSOCIALI E RILEVAZIONE DEI BISOGNI DEGLI UTENTI
 FATTORI PSICOSOCIALI E RILEVAZIONE DEI BISOGNI DEGLI UTENTI Edificio salubre Un edificio può essere definito salutare, confortevole ed efficiente dal punto di vista energetico se non causa né aggrava malattie
FATTORI PSICOSOCIALI E RILEVAZIONE DEI BISOGNI DEGLI UTENTI Edificio salubre Un edificio può essere definito salutare, confortevole ed efficiente dal punto di vista energetico se non causa né aggrava malattie
IL METODO. Supponiamo che ad una festa un amico ti offenda con brutte parole: Come ti sentiresti? Probabilmente arrabbiato
 IL METODO ABC Supponiamo che ad una festa un amico ti offenda con brutte parole: Come ti sentiresti? Probabilmente arrabbiato Ora fermiamoci a riflettere, e cerchiamo di esaminare bene l episodio: 1. Il
IL METODO ABC Supponiamo che ad una festa un amico ti offenda con brutte parole: Come ti sentiresti? Probabilmente arrabbiato Ora fermiamoci a riflettere, e cerchiamo di esaminare bene l episodio: 1. Il
Karl Marx. La critica all Ideologia. La critica alla religione
 Karl Marx La critica all Ideologia. La critica alla religione Marx e Hegel Anche se il suo pensiero si forma nell ambito dell hegelismo, Marx, sin dal 1843 (Per la critica della filosofia del diritto di
Karl Marx La critica all Ideologia. La critica alla religione Marx e Hegel Anche se il suo pensiero si forma nell ambito dell hegelismo, Marx, sin dal 1843 (Per la critica della filosofia del diritto di
RESILIENZA. Elementi chiave: condizione di avversità, manifestazione di adattamento positivo
 E VULNERABILITÀ In fisica indica la proprietà dei materiali di riprendere la forma originaria dopo aver subito un colpo. In psicologia indica la capacità di un individuo o di un gruppo sociale di riuscire
E VULNERABILITÀ In fisica indica la proprietà dei materiali di riprendere la forma originaria dopo aver subito un colpo. In psicologia indica la capacità di un individuo o di un gruppo sociale di riuscire
Lo sviluppo psicologico dall'adolescenza all'età adulta: fattori di protezione e di rischio. L'autonomia emotiva in adolescenza
 Lo sviluppo psicologico dall'adolescenza all'età adulta: fattori di protezione e di rischio L'autonomia emotiva in adolescenza Autonomia adolescenziale e gruppo dei pari Nel passaggio dall'esclusiva appartenenza
Lo sviluppo psicologico dall'adolescenza all'età adulta: fattori di protezione e di rischio L'autonomia emotiva in adolescenza Autonomia adolescenziale e gruppo dei pari Nel passaggio dall'esclusiva appartenenza
Psicologia come scienza: Il metodo scientifico
 Psicologia come scienza: Il metodo scientifico identificare domande su un evento formulare un ipotesi per spiegare l evento eseguire una ricerca per supportare e confutare la spiegazione Ripetere la ricerca
Psicologia come scienza: Il metodo scientifico identificare domande su un evento formulare un ipotesi per spiegare l evento eseguire una ricerca per supportare e confutare la spiegazione Ripetere la ricerca
La Gestione della Prestazione
 La Gestione della Prestazione 1 La gestione della prestazione 3 1.1 Come è possibile individuare correttamente gli obiettivi per i singoli ruoli? 3 1.2 Come si possono valutare le capacità in modo oggettivo?
La Gestione della Prestazione 1 La gestione della prestazione 3 1.1 Come è possibile individuare correttamente gli obiettivi per i singoli ruoli? 3 1.2 Come si possono valutare le capacità in modo oggettivo?
La vocazione professionale e la carriera accademica. Report della prima fase di ricerca
 La vocazione professionale e la carriera accademica Report della prima fase di ricerca 1 Obiettivi dell indagine Il focus della nostra ricerca è la vocazione professionale: l esperienza di una passione
La vocazione professionale e la carriera accademica Report della prima fase di ricerca 1 Obiettivi dell indagine Il focus della nostra ricerca è la vocazione professionale: l esperienza di una passione
INTRODUZIONE AL MARKETING DEGLI STUDI PROFESSIONALI
 INTRODUZIONE AL MARKETING DEGLI STUDI PROFESSIONALI SOMMARIO DELLA LEZIONE Definire il marketing Il marketing e la deontologia Le caratteristiche delle prestazioni professionali Il cliente al centro Introdurre
INTRODUZIONE AL MARKETING DEGLI STUDI PROFESSIONALI SOMMARIO DELLA LEZIONE Definire il marketing Il marketing e la deontologia Le caratteristiche delle prestazioni professionali Il cliente al centro Introdurre
Psicoterapia cognitivo-comportamentale in età evolutiva. Dott.ssa Elena Luisetti
 Psicoterapia cognitivo-comportamentale in età evolutiva Dott.ssa Elena Luisetti PIU CHE UNA SCUOLA E UNA PROSPETTIVA EMERSE CON IL CONVERGERE DI PIU FILONI PRINCIPI BASE Kendell, 1993 A. L individuo reagisce
Psicoterapia cognitivo-comportamentale in età evolutiva Dott.ssa Elena Luisetti PIU CHE UNA SCUOLA E UNA PROSPETTIVA EMERSE CON IL CONVERGERE DI PIU FILONI PRINCIPI BASE Kendell, 1993 A. L individuo reagisce
Il modello di Lasswell, o delle 5W (1948)
 Il modello di Lasswell, o delle 5W (1948) Il modello di Lasswell A convenient way to describe an act of communication is to answer the following questions: Who Says What in Which Channel To Whom With What
Il modello di Lasswell, o delle 5W (1948) Il modello di Lasswell A convenient way to describe an act of communication is to answer the following questions: Who Says What in Which Channel To Whom With What
Fare famiglia in Italia. Un secolo di cambiamenti Marzio Barbagli Maria Castiglioni Gianpiero Dalla Zuanna
 Fare famiglia in Italia. Un secolo di cambiamenti Marzio Barbagli Maria Castiglioni Gianpiero Dalla Zuanna Oggetto di studio 1) Età in cui uomini e donne - terminano gli studi - entrano nel mercato del
Fare famiglia in Italia. Un secolo di cambiamenti Marzio Barbagli Maria Castiglioni Gianpiero Dalla Zuanna Oggetto di studio 1) Età in cui uomini e donne - terminano gli studi - entrano nel mercato del
PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO GRUPPO DISCIPLINARE SCIENZE UMANE A.S. 2015/2016
 ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE Enrico Mattei ISTITUTO TECNICO ECONOMICO LICEO SCIENTIFICO LICEO delle SCIENZE UMANE Via delle Rimembranze, 26 40068 San Lazzaro di Savena BO Tel. 051 464510 464545 fax
ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE Enrico Mattei ISTITUTO TECNICO ECONOMICO LICEO SCIENTIFICO LICEO delle SCIENZE UMANE Via delle Rimembranze, 26 40068 San Lazzaro di Savena BO Tel. 051 464510 464545 fax
Commercio e Disoccupazione
 Economia Internazionale Alireza Naghavi Capitolo 10 (a) La mobilità internazionale del lavoro e capitale 1 Commercio e Disoccupazione L apertura al commercio implica lo spostamento di posti di lavoro dai
Economia Internazionale Alireza Naghavi Capitolo 10 (a) La mobilità internazionale del lavoro e capitale 1 Commercio e Disoccupazione L apertura al commercio implica lo spostamento di posti di lavoro dai
Per influenza sociale si intende un cambiamento che si verifica nei giudizi, nelle opinioni, e negli atteggiamenti di un individuo in seguito
 L'influenza sociale Per influenza sociale si intende un cambiamento che si verifica nei giudizi, nelle opinioni, e negli atteggiamenti di un individuo in seguito all'esposizione ai giudizi, alle opinioni
L'influenza sociale Per influenza sociale si intende un cambiamento che si verifica nei giudizi, nelle opinioni, e negli atteggiamenti di un individuo in seguito all'esposizione ai giudizi, alle opinioni
MOL MONITOR SUL LAVORO FUORI CLASSE LAVORATORI E RAPPRESENTAZIONI DEL LAVORO. Daniele Marini
 MOL MONITOR SUL LAVORO FUORI CLASSE LAVORATORI E RAPPRESENTAZIONI DEL LAVORO Daniele Marini Università di Padova Direttore Scientifico Community Media Research MOL MONITOR SUL LAVORO CONDIZIONI DI LAVORO,
MOL MONITOR SUL LAVORO FUORI CLASSE LAVORATORI E RAPPRESENTAZIONI DEL LAVORO Daniele Marini Università di Padova Direttore Scientifico Community Media Research MOL MONITOR SUL LAVORO CONDIZIONI DI LAVORO,
ELEMENTI DI SOCIOLOGIA II
 ELEMENTI DI SOCIOLOGIA II Funzioni della sociologia in generale e per gli AS COSA VUOL DIRE PENSARE SOCIOLOGICO a) Non ci sono solo individui, c è la società b) Esistono le istituzioni, le norme c) Apparteniamo
ELEMENTI DI SOCIOLOGIA II Funzioni della sociologia in generale e per gli AS COSA VUOL DIRE PENSARE SOCIOLOGICO a) Non ci sono solo individui, c è la società b) Esistono le istituzioni, le norme c) Apparteniamo
Esercitazioni per il corso di Storia Economica (00-49)
 Esercitazioni per il corso di Storia Economica (00-49) Parte II.2 10 maggio 2016 DI COSA ABBIAMO PARLATO LA SCORSA SETTIMANA Ripasso I costi dell impresa Economie di scala Disoccupazione Legge di Okun
Esercitazioni per il corso di Storia Economica (00-49) Parte II.2 10 maggio 2016 DI COSA ABBIAMO PARLATO LA SCORSA SETTIMANA Ripasso I costi dell impresa Economie di scala Disoccupazione Legge di Okun
PARADIGMA UTILITARISTICO
 PARADIGMA UTILITARISTICO 1. SCUOLA CLASSICA (o GIURIDICA) DOTTRINA DEL CONTRATTO SOCIALE (C. Beccaria 1700) 2. TEORIA DELLA SCELTA RAZIONALE (Cornish e Clark, 1986) 3. TEORIA DEL DETERRENTE (1960 ) 4.
PARADIGMA UTILITARISTICO 1. SCUOLA CLASSICA (o GIURIDICA) DOTTRINA DEL CONTRATTO SOCIALE (C. Beccaria 1700) 2. TEORIA DELLA SCELTA RAZIONALE (Cornish e Clark, 1986) 3. TEORIA DEL DETERRENTE (1960 ) 4.
Epistemologia e metodologia della ricerca qualitativa. Corso di Metodi della ricerca qualitativa - a.a [Eugenio De Gregorio]
![Epistemologia e metodologia della ricerca qualitativa. Corso di Metodi della ricerca qualitativa - a.a [Eugenio De Gregorio] Epistemologia e metodologia della ricerca qualitativa. Corso di Metodi della ricerca qualitativa - a.a [Eugenio De Gregorio]](/thumbs/54/33896183.jpg) Epistemologia e metodologia della ricerca qualitativa Come si giunge a una conoscenza del mondo? Superstizione (irrazionale) Intuizione (esperienza soggettiva) Ragionamento (induzione o deduzione) Autorità
Epistemologia e metodologia della ricerca qualitativa Come si giunge a una conoscenza del mondo? Superstizione (irrazionale) Intuizione (esperienza soggettiva) Ragionamento (induzione o deduzione) Autorità
Attori istituzionali con poteri di veto (2)
 Attori istituzionali con poteri di veto (2) Teoria dei veto players La teoria degli attori con potere di veto (veto players) consente di comparare le istituzioni politiche dei vari paesi in modo coerente
Attori istituzionali con poteri di veto (2) Teoria dei veto players La teoria degli attori con potere di veto (veto players) consente di comparare le istituzioni politiche dei vari paesi in modo coerente
Meeting Nazionale ACEF 28 ottobre 2016
 Meeting Nazionale ACEF 28 ottobre 2016 Gestire il gruppo nel cambiamento Dott. Adriano Bilardi Regione Emilia-Romagna - Terza Torre Viale della Fiera, 8 - Bologna LA PSICHE UMANA Verso la fine del 18 secolo
Meeting Nazionale ACEF 28 ottobre 2016 Gestire il gruppo nel cambiamento Dott. Adriano Bilardi Regione Emilia-Romagna - Terza Torre Viale della Fiera, 8 - Bologna LA PSICHE UMANA Verso la fine del 18 secolo
Perché andare dallo psicologo?
 Perché andare dallo psicologo? Idee e false credenze: Dal passato.. - Freud e il lettino: in base all'approccio teorico utilizzato ci possono essere diversi modi di entrare in relazione con l altra persona.
Perché andare dallo psicologo? Idee e false credenze: Dal passato.. - Freud e il lettino: in base all'approccio teorico utilizzato ci possono essere diversi modi di entrare in relazione con l altra persona.
Offerta aggregata, AS
 Lezione 9 (BAG cap. 8) Un analisi di equilibrio generale: il modello AS-AD Corso di Macroeconomia Prof. Guido Ascari, Università di Pavia Offerta aggregata, AS L offerta aggregata, AS, descrive gli effetti
Lezione 9 (BAG cap. 8) Un analisi di equilibrio generale: il modello AS-AD Corso di Macroeconomia Prof. Guido Ascari, Università di Pavia Offerta aggregata, AS L offerta aggregata, AS, descrive gli effetti
Matrici di Raven (PM47)
 Matrici di Raven (PM47) Matrici di Raven (PM47) Matrici di Raven (PM47) Matrici di Raven (PM38) TRA I TEST DI TIPICA PERFORMANCE Test proiettivi Test self-report di personalità Questionari psichiatrici
Matrici di Raven (PM47) Matrici di Raven (PM47) Matrici di Raven (PM47) Matrici di Raven (PM38) TRA I TEST DI TIPICA PERFORMANCE Test proiettivi Test self-report di personalità Questionari psichiatrici
Indice della lezione. Incertezza e rischio: sinonimi? Le Ipotesi della Capital Market Theory UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA FACOLTA DI ECONOMIA
 UNIVERSIT DEGLI STUDI DI PRM FCOLT DI ECONOMI Indice della lezione Corso di Pianificazione Finanziaria Introduzione al rischio Rischio e rendimento per titoli singoli La Teoria di Portafoglio di Markowitz
UNIVERSIT DEGLI STUDI DI PRM FCOLT DI ECONOMI Indice della lezione Corso di Pianificazione Finanziaria Introduzione al rischio Rischio e rendimento per titoli singoli La Teoria di Portafoglio di Markowitz
Levity IV. Framework per la narrazione interattiva Giocare con i bambini
 Levity IV Framework per la narrazione interattiva Giocare con i bambini Levity IV Giocare con i bambini GLI ELEMENTI BASE DI LEVITY Levity in una pagina Levity è un framework per la narrazione interattiva
Levity IV Framework per la narrazione interattiva Giocare con i bambini Levity IV Giocare con i bambini GLI ELEMENTI BASE DI LEVITY Levity in una pagina Levity è un framework per la narrazione interattiva
Atteggiamenti e rappresentazioni sociali
 Atteggiamenti e rappresentazioni sociali L importanza dello studio degli atteggiamenti risiede nella loro rilevanza per la nostra vita sociale: - a livello individuale; - a livello interpersonale; - a
Atteggiamenti e rappresentazioni sociali L importanza dello studio degli atteggiamenti risiede nella loro rilevanza per la nostra vita sociale: - a livello individuale; - a livello interpersonale; - a
La statistica. Elaborazione e rappresentazione dei dati Gli indicatori statistici. Prof. Giuseppe Carucci
 La statistica Elaborazione e rappresentazione dei dati Gli indicatori statistici Introduzione La statistica raccoglie ed analizza gruppi di dati (su cose o persone) per trarne conclusioni e fare previsioni
La statistica Elaborazione e rappresentazione dei dati Gli indicatori statistici Introduzione La statistica raccoglie ed analizza gruppi di dati (su cose o persone) per trarne conclusioni e fare previsioni
I Questionari docenti, studenti, genitori
 I Questionari docenti, studenti, genitori 1 «Funzioni» dei questionari Esiti formativi, successo scolastico e indicazioni sulle possibili azioni di miglioramento PISTE INTERPRETATIVE Efficacia nella promozione
I Questionari docenti, studenti, genitori 1 «Funzioni» dei questionari Esiti formativi, successo scolastico e indicazioni sulle possibili azioni di miglioramento PISTE INTERPRETATIVE Efficacia nella promozione
PISA 2012: Contributi di approfondimento
 PISA 2012: Contributi di approfondimento Sessione: Analisi delle differenze di risultati in funzione di specifiche variabili individuali, di scuola e di contesto. Parte 2 Discussant: Angela Martini Roma,
PISA 2012: Contributi di approfondimento Sessione: Analisi delle differenze di risultati in funzione di specifiche variabili individuali, di scuola e di contesto. Parte 2 Discussant: Angela Martini Roma,
Federazione Maestri del Lavoro d Italia. PROGETTO Scuola Lavoro «Importanza dello Studio»
 Federazione Maestri del Lavoro d Italia PROGETTO Scuola Lavoro «Importanza dello Studio» PARLIAMO DI AUTOSTIMA AUTOSTIMA = Percezione di fiducia e di stima nei propri confronti. Tale percezione si manifesta:
Federazione Maestri del Lavoro d Italia PROGETTO Scuola Lavoro «Importanza dello Studio» PARLIAMO DI AUTOSTIMA AUTOSTIMA = Percezione di fiducia e di stima nei propri confronti. Tale percezione si manifesta:
Selezione del disegno di ricerca. Quantitativo e qualitativo
 Selezione del disegno di ricerca Quantitativo e qualitativo Principali differenze tra ricerca quantitativa e qualitativa Quantitativa Natura della realtà Qualitativa Realtà indagabile con modalità obiettive
Selezione del disegno di ricerca Quantitativo e qualitativo Principali differenze tra ricerca quantitativa e qualitativa Quantitativa Natura della realtà Qualitativa Realtà indagabile con modalità obiettive
Il tossicodipendente e la sua famiglia
 Il tossicodipendente e la sua famiglia Uno dei maggiori compiti evolutivi dell adolescente è quello di costruire la propria identità cercando anche di staccarsi dalla sua famiglia di origine, non sentendosi
Il tossicodipendente e la sua famiglia Uno dei maggiori compiti evolutivi dell adolescente è quello di costruire la propria identità cercando anche di staccarsi dalla sua famiglia di origine, non sentendosi
Bullismo da dove partire? Carlo Callegaro
 Bullismo da dove partire? Carlo Callegaro Ho chiuso il mio cuore in una scatola e l'ho buttata nel lago Scrivi e se lo vuoi racconta tu un episodio che hai vissuto come atto di bullismo Non tutto è bullismo
Bullismo da dove partire? Carlo Callegaro Ho chiuso il mio cuore in una scatola e l'ho buttata nel lago Scrivi e se lo vuoi racconta tu un episodio che hai vissuto come atto di bullismo Non tutto è bullismo
LEARNIT DONNE NEL SETTORE INFOMATICO
 LEARNIT DONNE NEL SETTORE INFOMATICO BERNADETTA (PL) Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione)
LEARNIT DONNE NEL SETTORE INFOMATICO BERNADETTA (PL) Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione)
Università degli Studi di Roma Tor Vergata Facoltà di Lettere
 Università degli Studi di Roma Tor Vergata Facoltà di Lettere CORSO DI ECONOMIA AZIENDALE Lezione 2: L attività economica ed il sistema azienda Dott. Fabio Monteduro L attività economica ed il sistema
Università degli Studi di Roma Tor Vergata Facoltà di Lettere CORSO DI ECONOMIA AZIENDALE Lezione 2: L attività economica ed il sistema azienda Dott. Fabio Monteduro L attività economica ed il sistema
