Lingua Linguaggio acquisire e usare
|
|
|
- Eugenia Corradi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Il linguaggio Lingua vs linguaggio Proprietà delle lingue Struttura delle lingue Processi di riconoscimento dei suoni e delle parole Acquisizione Linguaggio e pensiero
2 Lingua vs linguaggio Lingua: il sistema convenzionale di simboli (dotati di significato) e di regole condiviso da un determinato gruppo sociale. E il modo concreto e determinato storicamente in cui si manifesta la capacità del linguaggio umano Linguaggio: La facoltà mentale propria dei membri della specie umana di acquisire e usare la lingua o le lingue a cui sono esposti
3 La psicolinguistica? «Il compito centrale di questa nuova scienza consiste nel descrivere i processi psicologici che hanno luogo quando ci serviamo di enunciati.» (George Miller, 1967)
4 Psicolinguistica: Studio dei processi sottostanti a comprensione, produzione e acquisizione del linguaggio LINGUAGGIO Comprensione lettura modalità visiva/scritta scrittura parole frasi testo Produzione ascolto modalità uditiva/orale parlato Acquisizione
5 Le Funzioni adattive del linguaggio Ogni cultura umana per quanto isolata ha sviluppato una o più lingue Le funzioni adattive del linguaggio: Si è evoluto quando gli uomini si riunirono per costituire unità sociali più ampie: suddivisione del lavoro, necessità di sviluppare costumi sociali, di comunicare pensieri, conoscenze È alla bas edi moltissime attività anche del nostro pensiero Potente meccanismo di apprendimento: in forma orale o scritta rende disponibile conoscenze accumulate nel corso di generazioni
6 Le proprietà delle lingue Proprietà fondamentali: È simbolico È strutturato Trasmette un significato È generativo Consente la dislocazione
7 È simbolico Le proprietà delle lingue Sistema che mette in relazione segnali < --- > significato Capacità di produrre e capire segnali 1) Segnali (codici esterni): suoni, segni grafici, segni gestuali 2) Significato (codice interno): rappresentazione mentale
8 Le proprietà delle lingue E strutturato Grammatica: insieme delle regole che dettano come si possono combinare i simboli per creare unità di comunicazione dotate di significato Sintassi: insieme delle regole che determinano l'ordine delle parole all'interno della frase
9 Le proprietà delle lingue Trasmette un significato Benche siano arbitrari I segni/simboli attivano delle rappresentazione mentali nella mente di un altra persona. La parola porta un significato che si arricchisce o si impoverisce con l uso della parola e ne riflette le variazioni culturali
10 Memoria semantica: Rete di unità concettuali interconnesse
11 Parole ambigue semanticamente merlo vite Parole polisemiche: operazione, linea
12 Le proprietà delle lingue È generativo: è possibile combinare I simboli della lingua per generare un lnumero infinito di messaggi con significato nuovo (fonemi, lettere dall alfabeto, parole) Consente la dislocazione: è possiile parlare di eventi e oggetto che non sono presenti.
13 Linguaggio e Comunicazione Linguaggio e comunicazione sono la stessa cosa? Gli esseri umani non comunicano solo verbalmente Anche gli altri animali comunicano
14 Linguaggio delle api Mediante : schemi di movimento ( danze ) eseguiti sulle pareti verticali dell alveare 1) danza circolare 2) danza dell addome Che cosa comunicano le api : - distanza - direzione - tipo di cibo
15 Linguaggio delle api Schemi di movimento ( danze ) sulle pareti verticali dell alveare 1) danza circolare: - la fonte di cibo è nel raggio di 10 metri - la velocità e la durata segnalano la ricchezza della fonte di cibo - la fragranza dell ape segnala il tipo di fonte di cibo 2) danza dell addome: - indica posizione di fonti di cibo a distanze superiori ai 100 metri - direzione - distanza esatta
16 Linguaggio delle api Parametri : - velocità - durata - inclinazione (angolo) - direzione - fragranza à combinatoria
17 Linguaggio delle api : Combinatoria MA: sistema di significati limitato à impossibilità di utilizzare segnali nuovi, di comunicare su situazioni nuove (diverse) Linguaggio animale : Sistema di segni chiuso
18 Linguaggio umano: Sistema aperto Combinatoria illimitata (sfruttata solo in parte) fra parti del segnale e parti del significato Possibilità di trasmettere un numero infinito di significati = produttività
19 Il linguaggio utilizzato dagli animali manca della grammatica e delle costruzioni complesse
20 Struttura della lingua: Parti del Segnale Settori di studio Suoni o fonemi Morfemi Parole Frasi Discorsi, testi, conversazioni Fonologia Morfologia Semantica Sintassi Pragmatica Lessico
21 La struttura delle lingue
22 La struttura delle lingue Fonema: unità minima di suono che viene riconosciuta come distinta in una data lingua Gli esseri umani sono in grado di produrre 100 fonemi; l italiano ne ha circa 30 Morfema: unità più piccola del linguaggio dotata di significato Solitamente una sillaba I morfemi formano le parole
23 Morfologia flessiva TAVOL(o/i) BELL(o/a) BELL(i/e) PIANG(ev(o) numero genere e numero persona, numero, tempo, modo Morfologia derivazionale TAVOLO TAVOLATA INTAVOLARE CENTROTAVOLO
24 La struttura delle lingue Le parole formano le frasi Le frasi formano un periodo Discorso: frasi combinate in paragrafi, articoli, libri, conversazioni, ecc. Il più completo livello di comunicazione
25 Comprendere e produrre il discorso Elaborazione bottom-up: analizza i singoli elementi di uno stimolo per poi combinarli a formare una percezione unificata Singoli fonemi /k/a/s/a/ à casa àsingole paroleàfrasi
26 Come riconosciamo i suoni (o fonemi)? Il sistema uditivo esegue un compito incredibilmente complesso consentendoci di riconoscere i suoni linguistici: filtriamo i suoni non linguistici, siamo insensibili alle variazioni di timbro di accento di chi parla Studi di fmri mostrano che alcune aree del cervello sono attivate maggiormente quando le persone ascoltano vocalizzazioni umane invece rispetto ad altri suoni: le regioni più marcate sono nel lobo temporale, sulla corteccia uditiva
27 Come riconosciamo i suoni (o fonemi)? Quindi l elaborazione del linguaggio inizia con l elaborazione uditiva delle differenze sensoriali Una di queste differenze ad esempio è Voice onset time: o VOT (tempo di inizio della sonorità. /ba/ /pa/: le corde vocali vibrano per entrambi i suoni, ma a tempi diversi /ba/ entro 20 msec. /pa/ 40 msec. dopo l apertura delle labbra.
28 La percezione del parlato è più difficile di quella dello scritto: fenomeno della coarticolazione mancanza di confini fra le parole (segmentazione):
29 La percezione del parlato è più difficile di quella dello scritto: mancanza di invarianza:uno stesso fonema cambia struttura acustica a seconda del contesto (fonemi vicini). Privi sia di autonomia percettiva sia di invarianza acustica Esperimento: I due fonemi /d/ e /u/ che noi percepiamo nella sillaba / du/ in realtà sono fusi ed embricati tra loro che non è possibile, neppure con una strumentazione sofisticata, individuare il punto dove finisce l uno e inizia l altro. Se a partire dalla banda magnetica dove è stata registrata la sillaba /du/, si tolgono progressivamente porzioni sempre più ampie di registrazione, ad un certo punto si cessa di percepire la sillaba senza arrivare a percepire il fonema /d/, cosa che sarebbe logico avvenisse se i due fonemi fossero giustapposti. Riconosciamo i suoni linguistici sulla base di raggruppamenti più ampi dei singoli fonemi
30 La percezione del parlato è più difficile di quella dello scritto: mancanza di confini fra le parole (segmentazione): la percezione di dove esattamente comincia e finisce ogni parola di una frase è difficoltosa perchè le persone quando parlano non fanno una pausa tra una parola e l'altra I cali dell emissione di energia tra una parole e l altra sono spesso minori dei cali tra i segmenti all interno delle singole parole
31 Dal continuo al discreto
32 Comprendere e produrre il discorso Elaborazione top-down: le informazioni sensoriali vengono interpretate alla luce di conoscenze, idee e aspettative esistenti
33 Percezione dei fonemi: ruolo del contesto v Effetto di reintegrazione dei fonemi (Warren & Warren, 1970) up top [peel buccia, heel tacco ] bottom down */ee/l - Il contesto è in grado di disambiguare il fonema mascherato: It was found that the *eel was on the orange It was found that the *eel was on the shoe [peel e heel] Riconosciamo I suoni linguistici sulla base di raggruppamenti più ampi
34 Segmentazione del parlato: effetto del contesto Implicitamente impariamo ad utilizzare diversi indizi per capire quando finisce una parola e ne comincia un'altra Impariamo che è improbabile che si verifichino alcune sequenze di fonemi all'interno di una stessa parola Utilizziamo il contesto fornito dalle altre parole di una frase per interpretare il significato di ogni singola parola Pollack e Pickett: hanno registrato delle conversazioni e fatto ascoltare a soggetti indipendenti segmenti di una, due, tre o quattro parole estratte da queste registrazioni: la prima parola da sola veniva riconosciuta nel 32%-65% Se ascoltavano segmenti di 4 parole i soggetti erano in grado di identificare la parola iniziale nel 70%-100%
35 e per il linguaggio scritto c è un elaborazione top-down?
36 Comprendere e produrre il discorso Elaborazione top-down: le informazioni sensoriali vengono interpretate alla luce di conoscenze, idee e aspettative esistenti Implicitamente impariamo ad utilizzare diversi indizi per capire quando finisce una parola e ne comincia un'altra Impariamo che è improbabile che si verifichino alcune sequenze di fonemi all'interno di una stessa parola Utilizziamo il contesto fornito dalle altre parole di una frase per interpretare il significato di ogni singola parola
37 Come avviene il riconoscimento delle parole e quali variabili lo influenzano?
38 Riconoscimento udi0vo Riconoscimento visivo Lessico fonologico di input / albero/ Lessico ortografico di input ALBERO Sistema semantico Lessico fonologico di output / albero/ Lessico ortografico di output ALBERO
39 Il riconoscimento visivo delle parole Il processo di riconoscimento visivo delle parole è automatico e obbligatorio, come dimostrato dall'effetto Stroop
40 Modelli a due vie (Coltheart, 1978) Macchina /makkina/ VIA LESSICALE VIA NON-LESSICALE Risposta
41 19 Analisi Quan0ta0va La partita è molto combattuta perché le due squadre 8 tentano di vincere fino all'ultimo minuto. Era l'ultima giornata del campionato e il risultato era molto importante per la classifica finale. 14 La partita è molto combattuta perché le due squadre tentano di vincere fino all'ultimo minuto. Era l'ultima giornata del campionato e il risultato era molto importante per la classifica finale
42 Proprietà delle parole che influenzano velocità e accuratezza di esecuzione dei compi0 lessicali ü FREQUENZA ü ETA DI ACQUISIZIONE ü FAMILIARITA ü CONCRETEZZA ü IMMAGINABILITA ü COMPOSIZIONE MORFOLOGICA ü LUNGHEZZA
43 Il riconoscimento delle parole Frequenza delle parole Quanto spesso una parola si presenta in una data lingua orale o scritta Influenza la velocità di riconoscimento Molti lessici di frequenza a disposizione (bambini adulto; orale, scritto) Età di acquisizione Età alla quale si impara una parola Denominazione più rapida per parole acquisite in giovane età e ad elevata frequenza rispetto a quelle acquisite tardi e a bassa frequenza
44 Istruzioni Con questo studio intendiamo raccogliere le vostre valutazioni sull età a cui pensate di avere appreso per la prima volta una serie di parole e il loro significato, o in forma parlata o in forma scritta. Nelle pagine seguenti troverete una lista di parole. Ogni parola è seguita da una scala a sette punti, come quella riportata qui sotto: appresa all età di e oltre anni anni anni anni anni anni anni Il vostro compito consiste nell attribuire un punteggio a ciascuna parola in base all età a cui pensate di averla appresa. Segnate con una crocetta il valore che avete scelto. Ad esempio, se pensate di aver appreso una parola all età di 7 anni, allora segnate il valore 4 sulla scala accanto a quella parola; se pensate di aver appreso una parola all età di 2 anni, allora segnate il valore 1 sulla scala accanto a quella parola; e così via. Cercate di utilizzare l intera scala e al tempo stesso non preoccupatevi di quanto spesso attribuite un valore rispetto ad un altro. Assegnare un solo punteggio a ciascuna parola. Ricordarsi di valutare tutte le parole. Attenzione: il compito può essere eseguito solo da persone di madrelingua italiana Barrare con una crocetta il sesso di appartenenza e indicare l età F M Età:
45 Misure oggecve di EA : Denominazione di figure da parte di bambini di età diverse Valutazioni di genitori e insegnank
46 IL PRIMO VOCABOLARIO DEL BAMBINO (PVB) (Caselli & Casadio, 1995) È un questionario rivolto a genitori, pediatri, psicologi, insegnanti e ricercatori. Consente di raccogliere dati sullo sviluppo linguistico dei bambini e di confrontarli con quelli di popolazioni differenti. Gesti e Parole Per bambini di età tra 8-17 mesi Composto da due schede distinte Parole e Frasi Per bambini di età tra mesi (670 parole in 23 categorie)
47 Il Primo Vocabolario del Bambino -Questionario MacArthur- (Caselli e Casadio, 1995) Appendice E - Percentuale di bambini che producono le singole parole (età mesi) Parole % Mamma 97,15 Papà 96,11 Nonna 94,56 Bau Bau 94,30 Acqua 93,78 Nonno 90,93 Miao 88,86 Pappa 85,23 Palla 84,72 Latte 84,46 Scarpe 84,46 Pane 82,12 Mela 80,05 Biscotti 79,53 Bimbi 78,76 Mano 77,72 Parole % Zia 76,94 Cane 74,87 Pizza 74,09 Caramella 73,83 Bocca 73,58 Gatto 73,32 Naso 73,32 Carne 73,06 Ciuccio 73,06 Zio 72,80 Banana 72,02 Bello 72,02 Occhio 71,50 Piede 70,98 Dito 70,73 Capelli 70,21
48 Proprietà delle parole che influenzano velocità e accuratezza nei compiti lessicali Frequenza della parola AF BF ORGANO vs ARGANO Ø influenza : Lettura Ø Decisione lessicale ORTANO - ORGANO ARTANO - ARGANO Ø Categorizzazione semantica Ø Comprensione Ø Denominazione di oggetti Ø
49
50 EffeC di frequenza Età acquisizione
51
52 LIBRO FEBBRE QUATTRO CUORE OLIO RAGNO IMPORTANZA DELL ETA DI ACQUISIZIONE DI UNA PAROLA > > > > > > FIBRA FABBRO QUARTO CUOIO BALIA OGNUNO Parole Fd U Fd U EA Parole Fd U Fd U EA LE LA LE LA Scienza ,80 Zebra ,80 Coscienza ,03 Litro ,45 Igiene 0 5 4,33 Cetra 0 0 5,70 Società ,07 Febbre ,37 Usciere 0 0 5,23 Labbro ,00 Ascella 0 0 3,70 Quattro ,20 Gente ,87 Fabbro ,13 Scena ,97 Spettro ,53 Macello 0 0 4,47 Febbre ,37 Conoscenza ,50 Labbro ,00 Aglio 8 0 3,47 Quattro ,20 Caviglia 9 0 3,60 Fabbro ,13 Migliaia ,00 Spettro ,53 Paglia ,23 Cuoco ,30 Olio ,87 Scuola ,37 Balia 8 8 4,33 Cuore ,40 Vigilia ,63 Cuoio ,07 Milione ,17 Scuotere ,70 Italia ,60 Squalo ,20 Vaniglia 0 0 3,93 Aquila ,10 Ognuno ,07 Quarto ,97 Segno ,47 Quarzo 0 0 5,40 Compagno ,90 Squama 0 0 4,57 Pugnale 7 9 3,43 Quota ,63 Ragno ,60 Liquore ,00 Niente ,37 Equo 0 0 5,17 Genio ,97 Iniquo 0 0 5,97 Geranio 0 7 4,17 Obliquo ,43 Paniere ,30 Cerniera 0 0 3,50 Libro ,33 Fibra ,77
53 ORIGINAL RESEARCH ARTICLE published: 19 November 2014 doi: /fpsyg The effect of morphology on spelling and reading accuracy: a study on Italian children Paola Angelelli 1 *, Chiara Valeria Marinelli 2 and Cristina Burani 3,4 1 Department of History, Society and Human Studies, University of Salento, Lecce, Italy 2 Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Santa Lucia, Rome, Italy 3 Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Rome, Italy 4 Department of Life Sciences, University of Trieste, Trieste, Italy Edited by: Peter F. De Jong, University of Amsterdam, Netherlands Reviewed by: Séverine Casalis, Université de Lille Nord de France, France Judith Rispens, University of Amsterdam, Netherlands *Correspondence: Paola Angelelli, Department of History, Society and Human Studies, University of Salento, 45/47 Stampacchia Street, Lecce, Italy paola.angelelli@ unisalento.it In opaque orthographies knowledge of morphological information helps in achieving reading and spelling accuracy. In transparent orthographies with regular print-to-sound correspondences, such as Italian, the mappings of orthography onto phonology and phonology onto orthography are in principle sufficient to read and spell most words. The present study aimed to investigate the role of morphology in the reading and spelling accuracy of Italian children as a function of school experience to determine whether morphological facilitation was present in children learning a transparent orthography. The reading and spelling performances of 15 third-grade and 15 fifth-grade typically developing children were analyzed. Children read aloud and spelled both low-frequency words and pseudowords. Low-frequency words were manipulated for the presence of morphological structure (morphemic words vs. non-derived words). Morphemic words could also vary for the frequency (high vs. low) of roots and suffixes. Pseudo-words were made up of either a real root and a real derivational suffix in a combination that does not exist in the Italian language or had no morphological constituents. Results showed that, in Italian, morphological information is a useful resource for both reading and spelling. Typically developing children benefitted from the presence of morphological structure when they read and spelled pseudowords; however, in processing low-frequency words, morphology facilitated reading but not spelling. These findings are discussed in terms of morpho-lexical access and successful cooperation between lexical and sublexical processes in reading and spelling. Keywords: morphology, spelling, orthography, typically developing readers/spellers, transparent orthographies
54 Non Parole FIGURE 2 Reading and spelling performance (percentage of errors) on pseudowords made up of real roots and derivational suffixes [R + S + ]
55 Comprendere e produrre il discorso Linguaggio e cervello: Le funzioni del linguaggio sono distribuite in diverse aree del cervello L'area di Broca è quella più coinvolta nella produzione e nell'articolazione delle parole L'area di Wernicke è cruciale per la comprensione del linguaggio La corteccia visiva gioca un ruolo importante nell'elaborazione di lettere e parole scritte
56 Corteccia motrice Area di Broca Corteccia udi0va primaria
57 Aree cerebrali coinvolte nei vari aspetti del linguaggio
58 L'acquisizione della lingua madre Acquisizione del linguaggio: processo innescato a livello biologico all'interno di un ambiente di apprendimento sociale Chomsky: Dispositivo di acqusizione del linguaggio (LAD): meccanismo biologico innato che fornisce le regole generali della grammatica ( grammatica universale ) comuni a tutte le lingue Tra I principi insiti: le lingue contengono elementi nominali ed elementi verbali (soggetti, predicati e aggettivi) che sono organizzati in modo particolare
59 L acquisizione del linguaggio Il processo di apprendimento sociale Le madri e i padri parlano ai figli in un'intonazione alta definita maternese: utilizzo di frasi brevi, semplici, ben strutturate e ripetitive pronuncia chiara, intonazioni esagerate, accurate distinzioni tra fonemi simili, parole concrete Il discorso si riferisce ad oggetti tangibili, che il bambino può vedere (modo pià semplice per imparere le parole) Tommasello e Ferrar: I bambini di mamme che parlavo soprattutto degli oggetti che esse stavano guardando cominciavano a parlare prima
60 L acquisizione del linguaggio Gli adulti spesso estendono il discorso dei bambini e questo senza dubbio aiuta ad imparare la struttura sintattica BAMBINO SEGGIOLONE IL BAMBINO è NEL SEGGIOLONE? Quando gli aduli parlano con i bambini l elemento più importante è l attenzione del bambino: quando un bambino sembra interessato continuamo, se notiamo segni di disattenzione semplifichiamo il livello del discorso fino a quando non otteniamo di nuovo la sua attenzione
61 Il normale sviluppo del linguaggio 1-3 mesi: Distingue i suoni verbali da quelli non verbali e preferisce i primi 4-6 mesi: Cominciano i suoni balbettanti, che contengono virtualmente suoni di tutte le lingue mesi: I suoni balbettanti si limitano ai soli fonemi che sente nella lingua parlata dagli altri. Comincia a imitare i suoni delle parole che sente pronunciare dagli altri. 12: Prime parole riconoscibili mesi: Il vocabolario si espande fino a comprendere un numero di parole che va da 50 a 200. Prime frasi rudimentali con scarso o nullo uso di funtori o dei verbi ausiliari (posso, voglio)
62 Il normale sviluppo del linguaggio 2 4 anni: Il vocabolario si espande rapidamente al ritmo di diverse centinaia di parole ogni sei mesi. Comparsa di parole che esprimono concetti astratti o descrivere oggetti immaginari e idee -Sintassi basilare: le frasi diventanompiù lunghe, e sintatticamente più corrette 4-5 anni: Il bambino ha imparato la regole grammaticali basilari per unire nomi, aggettivi, articoli, congiunzioni e verbi e combinarle in frasi dotate di significato
63 Linguaggio e pensiero
64 Linguaggio e pensiero Ipotesi del relativismo linguistico (Sapir e Whorf) il linguaggio non solo influenza, ma modella e produce il pensiero Un essere umano può pensare solo nelle categorie dategli dal linguaggio delle sua cultura Quindi le persone che parlano lingue differenti avrebbero sistemi cognitivi diversi
65 Linguaggio e pensiero Ipotesi del relativismo linguistico (Sapir e Whorf) Vari studi antropologici Gli indiani Hopi non hanno parole che indicano il tempo (passato, futuro): concetti come il tempo e il suo scorrere, ritenuti universali, non costituisce una nozione generale per un indiano Hopi
66 Piaget: al pensiero spetta il primato sul linguaggio Il linguaggio è una espressione della capacità umana di pensare in simboli. Tale capacità si sviluppa in uno stadio prelinguistico dell intelligenza sensomotoria Gli schemi di azione come per esempio il prendere si formano prima degli schemi linguistici: quindi lo sviluppo del pensiero precede lo sviluppo del linguaggio
67 Linguaggio e pensiero Una versione rinnovata dell ipotesi del relativismo linguistico considera come alcune forme di linguaggio influiscano su determinati aspetti di pensiero Ad esempio abilità matematiche più carenti nei bambini inglesi rispetto agli asiatici (Zhou et al. 2005): La logica di pensiero in base 10 è favorita dal sistema lessicale dei numeri nei bambini cinesi (11 dieci-uno; 12 dieci-due, etc)
68 Il bilinguismo Un rispetto alle relazioni tra pensiero e linguaggio è il bilinguismo La capacità di parlare due lingue fornisce vantaggi cognitivi significativi rispetto al parlare una sola lingua: Per esempio, soggetti bilingui dimostrano più flessibilità cognitiva e comprendono concetti con più facilità rispetto a chi parla una sola lingua.! Questo li rende generalmente più flessibili nella risoluzione di problemi (Hong, 2000; Sanz, 2000; Heyman e Diesendruck, 2002)
69 Il bilinguismo Il cervello bilingue: Esiste una certa variabilità interindividuale rispetto a come le diverse lingue siano rappresentate nel cervello La lingua madre e la seconda lingua hanno maggiore probabilità di condividere la stessa rete neurale quando: La seconda lingua è stata appresa in tenera età La seconda lingua è stata appresa più avanti negli anni ma è padroneggiata quasi perfettamente
70 Il Modello della Coorte (Marslen-Wilson e Tyler, 1980; Marslen-Wilson e Warren, 1994) Quando sentiamo una parola costruiamo contemporaneamente una coorte di possibili item che condividono una parte iniziale T TA TAL TALP Tabella TAbella Tale Talpa TAle TAlpa TALe TALpa TALPa Tinca Torbido T... La coorte contiene progressivamente un numero sempre minore di elementi fino ad arrivare al riconoscimento della parola
71 Il modello della Coorte (Marslen-Wilson, 1984; 1989) Il processo di riconoscimento procede secondo tre fasi: Accesso Informazioni acustiche sono usate per attivare item lessicali, si genera un set di candidati: la coorte Selezione Viene scelto uno solo dei candidati Punto di riconoscimento/unicità Integrazione Vengono utilizzate proprietà semantiche e sintattiche della parola per integrarla nella rappresentazione della frase La coorte contiene progressivamente un numero sempre minore di elementi fino al riconoscimento della parola. Il contesto può intervenire nelle fasi di selezione e integrazione.
06/03/2017. Modalità d esame. Introduzione. Cristina Burani. Linguaggio: disturbi evolutivi e trattamento 1.
 Linguaggio: disturbi evolutivi e trattamento 1. Introduzione Cristina Burani Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, CNR, Roma Università degli studi di Trieste, anno accademico 2016-2017 Corso
Linguaggio: disturbi evolutivi e trattamento 1. Introduzione Cristina Burani Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, CNR, Roma Università degli studi di Trieste, anno accademico 2016-2017 Corso
Linguaggio e Comunicazione
 Linguaggio e Comunicazione ò LINGUAGGIO: sistema per comunicare con altri individui usando segnali che trasmettono un signifcato e che sono combinati secondo regole di grammatica ò Ogni lingua umana consiste
Linguaggio e Comunicazione ò LINGUAGGIO: sistema per comunicare con altri individui usando segnali che trasmettono un signifcato e che sono combinati secondo regole di grammatica ò Ogni lingua umana consiste
APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA
 APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA COSA SONO LA LETTURA E LA SCRITTURA? I sistemi di comunicazione distinzione tra sistemi comunicativi verbali e non - verbali; i sistemi di scrittura sono strettamente
APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA COSA SONO LA LETTURA E LA SCRITTURA? I sistemi di comunicazione distinzione tra sistemi comunicativi verbali e non - verbali; i sistemi di scrittura sono strettamente
Il significato. Anno accademico 2017/2018 Psicologia della Comunicazione Prof.ssa Serino. Quinta Lezione
 Il significato Anno accademico 2017/2018 Psicologia della Comunicazione Prof.ssa Serino Quinta Lezione Quinta lezione: Il significato Sommario Universalità vs. Relatività Capitolo 3 «Comunicazione e Significato»
Il significato Anno accademico 2017/2018 Psicologia della Comunicazione Prof.ssa Serino Quinta Lezione Quinta lezione: Il significato Sommario Universalità vs. Relatività Capitolo 3 «Comunicazione e Significato»
Elementi di Psicologia dello Sviluppo (II modulo) Mirco Fasolo
 Elementi di Psicologia dello Sviluppo (II modulo) Mirco Fasolo mirco.fasolo@unimib.it Bibliografia Testi obbligatori - D amico, Devescovi (2003). Comunicazione e linguaggio nei bambini. Carocci: Roma.
Elementi di Psicologia dello Sviluppo (II modulo) Mirco Fasolo mirco.fasolo@unimib.it Bibliografia Testi obbligatori - D amico, Devescovi (2003). Comunicazione e linguaggio nei bambini. Carocci: Roma.
Prerequisiti linguistici e scrittura
 Prerequisiti linguistici e scrittura Paola Viterbori Polo Bozzo Università di Genova Scrittura come attività complessa Codifica (Alfabetizzazione o Literacy) Attività linguistica di trasformazione del
Prerequisiti linguistici e scrittura Paola Viterbori Polo Bozzo Università di Genova Scrittura come attività complessa Codifica (Alfabetizzazione o Literacy) Attività linguistica di trasformazione del
Lo sviluppo del linguaggio
 Lo sviluppo del linguaggio Natura del linguaggio e dei suoi sottoinsiemi: Suono: fonologia Significato: semantica Lessico Morfologia Sintassi Contesto : pragmatica Funzioni comunicative Conversazione,
Lo sviluppo del linguaggio Natura del linguaggio e dei suoi sottoinsiemi: Suono: fonologia Significato: semantica Lessico Morfologia Sintassi Contesto : pragmatica Funzioni comunicative Conversazione,
1) Quale studioso ha ipotizzato l'esistenza di un dispositivo innato per l'acquisizione del linguaggio?
 Capitolo V. Esercizi 1) Quale studioso ha ipotizzato l'esistenza di un dispositivo innato per l'acquisizione del linguaggio? a. Chomsky b. Skinner c. Vygotskij 2) Secondo Piaget l'acquisizione del linguaggio:
Capitolo V. Esercizi 1) Quale studioso ha ipotizzato l'esistenza di un dispositivo innato per l'acquisizione del linguaggio? a. Chomsky b. Skinner c. Vygotskij 2) Secondo Piaget l'acquisizione del linguaggio:
Sviluppo del linguaggio MG Baglietto
 Sviluppo del linguaggio MG Baglietto Neuropsichiatria Infantile Istituto G. Gaslini Genova Componenti del Linguaggio 1) Componente fonologica: uso dei suoni, delle vocali e delle consonanti La FONOLOGIA
Sviluppo del linguaggio MG Baglietto Neuropsichiatria Infantile Istituto G. Gaslini Genova Componenti del Linguaggio 1) Componente fonologica: uso dei suoni, delle vocali e delle consonanti La FONOLOGIA
Lo sviluppo del linguaggio nel bambino
 Lo sviluppo del linguaggio nel bambino Caratteristiche distintive del linguaggio Capacità comunicativa Linguaggio Creatività Chi parla una lingua è capace di produrre una grande varietà di messaggi combinando
Lo sviluppo del linguaggio nel bambino Caratteristiche distintive del linguaggio Capacità comunicativa Linguaggio Creatività Chi parla una lingua è capace di produrre una grande varietà di messaggi combinando
Corso di laurea in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE (B184) PSICOLOGIA GENERALE (2CFU)
 Corso di laurea in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE (B184) PSICOLOGIA GENERALE (2CFU) COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO: La comunicazione è un attività sociale: per definizione, si ha comunicazione
Corso di laurea in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE (B184) PSICOLOGIA GENERALE (2CFU) COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO: La comunicazione è un attività sociale: per definizione, si ha comunicazione
APPRENDIMENTO E NEUROSCIENZE
 APPRENDIMENTO E NEUROSCIENZE Modello interattivo e multicomponenziale della compresione Eleonora Aliano Apprendimento e neuroscienze Apprendere: variare la struttura e l attività dei neuroni Ultime notizie
APPRENDIMENTO E NEUROSCIENZE Modello interattivo e multicomponenziale della compresione Eleonora Aliano Apprendimento e neuroscienze Apprendere: variare la struttura e l attività dei neuroni Ultime notizie
Comunicazione Vs. Linguaggio
 Comunicazione Vs. Linguaggio Comunicazione: rete di scambi di informazioni e di relazioni sociali sirealizzaall internodiungruppo(naturasociale) ne costituisce la base dell interazione e delle relazioni
Comunicazione Vs. Linguaggio Comunicazione: rete di scambi di informazioni e di relazioni sociali sirealizzaall internodiungruppo(naturasociale) ne costituisce la base dell interazione e delle relazioni
Teorie sull acquisizione del linguaggio
 Teorie sull acquisizione del linguaggio I principali problemi intorno al linguaggio sono: 1. Ruolo dei fattori genetici e di quelli ambientali 2. Rapporti tra il linguaggio e il pensiero/cognizione 3.
Teorie sull acquisizione del linguaggio I principali problemi intorno al linguaggio sono: 1. Ruolo dei fattori genetici e di quelli ambientali 2. Rapporti tra il linguaggio e il pensiero/cognizione 3.
CURRICOLO VERTICALE ITALIANO
 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo R. Franceschi Via Concordia, 2/4-20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Tel. 02 48 40 20 46 - Fax 02 48 49 01 97 E-mail: segreteria@icfranceschi.gov.it
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo R. Franceschi Via Concordia, 2/4-20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Tel. 02 48 40 20 46 - Fax 02 48 49 01 97 E-mail: segreteria@icfranceschi.gov.it
I discorsi e le parole
 Curricolo verticale Dai 3 anni ai 6 anni I discorsi e le parole TRAGUARDI DI COMPETENZA al termine della scuola dell Infanzia AMBITI DI CONTENUTO SEZ: COMPETENZE/OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Il bambino.
Curricolo verticale Dai 3 anni ai 6 anni I discorsi e le parole TRAGUARDI DI COMPETENZA al termine della scuola dell Infanzia AMBITI DI CONTENUTO SEZ: COMPETENZE/OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Il bambino.
PROGRAMMAZIONE CLASSI PRIME A.S. 2018/19 ITALIANO
 PROGRAMMAZIONE CLASSI PRIME A.S. 2018/19 ITALIANO COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella madrelingua. Competenza digitale. Imparare ad imparare. COMPETENZE TRASVERSALI Comprendere e comunicare;
PROGRAMMAZIONE CLASSI PRIME A.S. 2018/19 ITALIANO COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella madrelingua. Competenza digitale. Imparare ad imparare. COMPETENZE TRASVERSALI Comprendere e comunicare;
BUONE PRASSI NEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA LETTO SCRITTURA
 BUONE PRASSI NEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA LETTO SCRITTURA ( CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA PREVENZIONE DELLE DIFFICOLTA SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO DSA) SCUOLA INFANZIA / SCUOLA PRIMARIA DISEGNO
BUONE PRASSI NEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA LETTO SCRITTURA ( CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA PREVENZIONE DELLE DIFFICOLTA SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO DSA) SCUOLA INFANZIA / SCUOLA PRIMARIA DISEGNO
CURRICOLO VERTICALE ITALIANO
 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo R. Franceschi Via Concordia, 2/4-20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Tel. 02 48 40 20 46 - Fax 02 48 49 01 97 E-mail: segreteria@icfranceschi.gov.it
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo R. Franceschi Via Concordia, 2/4-20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Tel. 02 48 40 20 46 - Fax 02 48 49 01 97 E-mail: segreteria@icfranceschi.gov.it
PROGRAMMAZIONE CLASSI PRIME A.S. 2017/18 ITALIANO
 PROGRAMMAZIONE CLASSI PRIME A.S. 2017/18 ITALIANO COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella madrelingua. Competenza digitale. Imparare ad imparare. COMPETENZE TRASVERSALI Comprendere e comunicare;
PROGRAMMAZIONE CLASSI PRIME A.S. 2017/18 ITALIANO COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella madrelingua. Competenza digitale. Imparare ad imparare. COMPETENZE TRASVERSALI Comprendere e comunicare;
LABORATORIO Corso di Pedagogia speciale Prof.ssa Zappaterra IV anno GRUPPO 1 23 settembre :00/19:00 Dr.ssa Lucia Donata Nepi
 Scuola di Studi Umanistici e della Formazione CdS in Scienze della Formazione Primaria! LABORATORIO Corso di Pedagogia speciale Prof.ssa Zappaterra IV anno GRUPPO 1 23 settembre 2015 16:00/19:00 Dr.ssa
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione CdS in Scienze della Formazione Primaria! LABORATORIO Corso di Pedagogia speciale Prof.ssa Zappaterra IV anno GRUPPO 1 23 settembre 2015 16:00/19:00 Dr.ssa
LINGUA INGLESE CLASSE 4^
 DISCIPLINA LINGUA INGLESE CLASSE 4^ LEGENDA per gli : A= Ascolto (comprensione orale) P = Parlato (produzione e interazione orale) L = Lettura (comprensione scritta) S = Scrittura (produzione scritta)
DISCIPLINA LINGUA INGLESE CLASSE 4^ LEGENDA per gli : A= Ascolto (comprensione orale) P = Parlato (produzione e interazione orale) L = Lettura (comprensione scritta) S = Scrittura (produzione scritta)
IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE
 IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE Per
IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE Per
Abilità L alunno sa: Acquisire un comportamento di ascolto attento e partecipativo. Ascoltare semplici letture di testi di vario genere.
 DISCIPLINA ITALIANO CLASSE PRIMA COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE Comunicazione nella madrelingua. COMPETENZA/E TRASVERSALI Imparare a imparare. Competenze digitali. Conoscenze L alunno conosce: Ascolto e parlato.
DISCIPLINA ITALIANO CLASSE PRIMA COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE Comunicazione nella madrelingua. COMPETENZA/E TRASVERSALI Imparare a imparare. Competenze digitali. Conoscenze L alunno conosce: Ascolto e parlato.
LINGUA INGLESE CLASSE 5^ ABILITA -Sa ascoltare e comprendere il tema generale di un breve discorso e/o dialogo. ABILITA
 DISCIPLINA LINGUA INGLESE CLASSE 5^ LEGENDA per gli : A= Ascolto (comprensione orale) P = Parlato (produzione e interazione orale) L = Lettura (comprensione scritta) S = Scrittura (produzione scritta)
DISCIPLINA LINGUA INGLESE CLASSE 5^ LEGENDA per gli : A= Ascolto (comprensione orale) P = Parlato (produzione e interazione orale) L = Lettura (comprensione scritta) S = Scrittura (produzione scritta)
CASERTA - Spesso ci si interroga sulla conoscenza del mondo e sul senso da dare agli interventi educativi e formativi.
 CASERTA - Spesso ci si interroga sulla conoscenza del mondo e sul senso da dare agli interventi educativi e formativi. Le informazioni che ci giungono continuamente attraverso i sensi sono elaborate e
CASERTA - Spesso ci si interroga sulla conoscenza del mondo e sul senso da dare agli interventi educativi e formativi. Le informazioni che ci giungono continuamente attraverso i sensi sono elaborate e
PROGETTAZIONE DISCIPLINARE
 PROGETTAZIONE DISCIPLINARE ITALIANO classe 3^ PER ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE I Q. II Q. CONTENUTI /ATTIVITA 1a) Ascolto e comprensione di ciò che l insegnante e i compagni comunicano
PROGETTAZIONE DISCIPLINARE ITALIANO classe 3^ PER ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE I Q. II Q. CONTENUTI /ATTIVITA 1a) Ascolto e comprensione di ciò che l insegnante e i compagni comunicano
Memoria dichiarativa e memoria procedurale. Memoria semantica e memoria episodica
 ORGANIZZAZIONE DELLA CONOSCENZA Come è organizzata la conoscenza? l organizzazione della conoscenza si riferisce in parte ai sistemi di memoria: Ø Memoria sensoriale, a breve, a lungo termine Memoria dichiarativa
ORGANIZZAZIONE DELLA CONOSCENZA Come è organizzata la conoscenza? l organizzazione della conoscenza si riferisce in parte ai sistemi di memoria: Ø Memoria sensoriale, a breve, a lungo termine Memoria dichiarativa
La comprensione del testo. Lezione 1
 La comprensione del testo Lezione 1 La competenza chiave Il 17 gennaio del 2018 l UE ha aggiornato il quadro delle competenze chiave per l apprendimento permanente. La competenza che veniva definita Comunicazione
La comprensione del testo Lezione 1 La competenza chiave Il 17 gennaio del 2018 l UE ha aggiornato il quadro delle competenze chiave per l apprendimento permanente. La competenza che veniva definita Comunicazione
IL LINGUAGGIO VERBALE
 IL LINGUAGGIO VERBALE Clemente Danieli «La mente e l albero» Binazzi Tucci «Scienze sociali» AIME «Ciò che noi siamo» Ugo Fabietti «Antropologia» Avalle Maranzana «L individuo fra natura e cultura» 50.000
IL LINGUAGGIO VERBALE Clemente Danieli «La mente e l albero» Binazzi Tucci «Scienze sociali» AIME «Ciò che noi siamo» Ugo Fabietti «Antropologia» Avalle Maranzana «L individuo fra natura e cultura» 50.000
Seconda Lingua Comunitaria (Francese Spagnolo) Classe seconda secondaria
 CURRICOLO DISCIPLINARE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE Seconda Lingua Comunitaria (Francese Spagnolo) Classe seconda secondaria Traguardi per lo sviluppo delle competenze Conoscenze Obiettivi di apprendimento
CURRICOLO DISCIPLINARE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE Seconda Lingua Comunitaria (Francese Spagnolo) Classe seconda secondaria Traguardi per lo sviluppo delle competenze Conoscenze Obiettivi di apprendimento
APPRENDIMENTO DELLA LETTO-SCRITTURA. 4 settembre 2014 Alessandra Scabia
 APPRENDIMENTO DELLA LETTO-SCRITTURA 4 settembre 2014 Alessandra Scabia L apprendimento della letto-scrittura presuppone l acquisizione di: competenze fonologiche: produzione di tutti i suoni, ripetizioni
APPRENDIMENTO DELLA LETTO-SCRITTURA 4 settembre 2014 Alessandra Scabia L apprendimento della letto-scrittura presuppone l acquisizione di: competenze fonologiche: produzione di tutti i suoni, ripetizioni
AREA DI APPRENDIMENTO: ITALIANO
 AREA DI APPRENDIMENTO: ITALIANO A. ascoltare e comprendere semplici messaggi e comunicazioni degli insegnanti Competenza n. 1: INTERAGIRE E COMUNICARE VERBALMENTE IN CONTESTI DI DIVERSA NATURA ASCOLTO
AREA DI APPRENDIMENTO: ITALIANO A. ascoltare e comprendere semplici messaggi e comunicazioni degli insegnanti Competenza n. 1: INTERAGIRE E COMUNICARE VERBALMENTE IN CONTESTI DI DIVERSA NATURA ASCOLTO
SPM. TEST di ABILITA di SOLUZIONE dei PROBLEMI MATEMATICI
 SPM TEST di ABILITA di SOLUZIONE dei PROBLEMI MATEMATICI CAPACITA di RISOLVERE I PROBLEMI È una delle principali competenze del sistema cognitivo KATONA e WURTHEIMER (Gestaltisti) Una mente strategica
SPM TEST di ABILITA di SOLUZIONE dei PROBLEMI MATEMATICI CAPACITA di RISOLVERE I PROBLEMI È una delle principali competenze del sistema cognitivo KATONA e WURTHEIMER (Gestaltisti) Una mente strategica
Psicofisiologia della Lettura. Lettura: 2 processi. Lettura vs. Linguaggio. Lettura = processo di decodifica. - comprensione del messaggio
 Psicofisiologia della Lettura Il propagandarsi o l essere il protagonista comunque sulla base quotidiana dei mezzi di comunicazione è un esigenza che molti hanno ma che è altamente inflazionistica. Andrea
Psicofisiologia della Lettura Il propagandarsi o l essere il protagonista comunque sulla base quotidiana dei mezzi di comunicazione è un esigenza che molti hanno ma che è altamente inflazionistica. Andrea
DISCIPLINA LINGUA INGLESE CURRICOLO VERTICALE SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA
 DISCIPLINA LINGUA INGLESE CURRICOLO VERTICALE SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO relative ai testi in uso o alle varie attività proposte. ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) Comprendere brevi
DISCIPLINA LINGUA INGLESE CURRICOLO VERTICALE SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO relative ai testi in uso o alle varie attività proposte. ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) Comprendere brevi
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
 UNITA DI APPRENDIMENTO N. 1 SETTEMBRE OTTOBRE Disciplina: ITALIANO Utenti destinatari: CLASSI SECONDE Denominazione: DI NUOVO INSIEME Competenze chiave europee Comunicare nella madre lingua Imparare ad
UNITA DI APPRENDIMENTO N. 1 SETTEMBRE OTTOBRE Disciplina: ITALIANO Utenti destinatari: CLASSI SECONDE Denominazione: DI NUOVO INSIEME Competenze chiave europee Comunicare nella madre lingua Imparare ad
Istituto Comprensivo Francesco D'Assisi TEZZE SUL BRENTA Scuola Primaria CLASSE 1 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE ITALIANO
 Istituto Comprensivo Francesco D'Assisi TEZZE SUL BRENTA Scuola Primaria CLASSE 1 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE ITALIANO OBIETTIVI FORMATIVI CONOSCENZE ABILITA COMPETENZE ASCOLTO-PARLATO Intuire che
Istituto Comprensivo Francesco D'Assisi TEZZE SUL BRENTA Scuola Primaria CLASSE 1 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE ITALIANO OBIETTIVI FORMATIVI CONOSCENZE ABILITA COMPETENZE ASCOLTO-PARLATO Intuire che
Linguistica Generale
 Linguistica Generale Docente: Paola Monachesi Aprile-Maggio 2003 Contents 1 La linguistica e i suoi settori 2 2 La grammatica come mezzo per rappresentare la competenza linguistica 2 3 Le componenti della
Linguistica Generale Docente: Paola Monachesi Aprile-Maggio 2003 Contents 1 La linguistica e i suoi settori 2 2 La grammatica come mezzo per rappresentare la competenza linguistica 2 3 Le componenti della
PROGETTAZIONE DISCIPLINARE
 PROGETTAZIONE DISCIPLINARE ITALIANO classe 1^ PER ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE CONTENUTI /ATTIVITA 1 bim. 2 bim. 3 bim. 4 bim. 1a) Ascolto e comprensione di semplici comunicazioni legate
PROGETTAZIONE DISCIPLINARE ITALIANO classe 1^ PER ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE CONTENUTI /ATTIVITA 1 bim. 2 bim. 3 bim. 4 bim. 1a) Ascolto e comprensione di semplici comunicazioni legate
Comunicazione Vs. Linguaggio
 Comunicazione Vs. Linguaggio Comunicazione: La trasmissione di informazioni mediante messaggi da un emittente a un ricevente si realizza all interno di un gruppo (natura sociale) ne costituisce la base
Comunicazione Vs. Linguaggio Comunicazione: La trasmissione di informazioni mediante messaggi da un emittente a un ricevente si realizza all interno di un gruppo (natura sociale) ne costituisce la base
LA CONOSCENZA SOCIALE
 LA CONOSCENZA SOCIALE A partire dagli anni 50-60 il cognitivismo ha avuto una grande influenza sulla psicologia sociale. La teoria cognitiva si occupa dello studio di come l uomo raccoglie informazioni
LA CONOSCENZA SOCIALE A partire dagli anni 50-60 il cognitivismo ha avuto una grande influenza sulla psicologia sociale. La teoria cognitiva si occupa dello studio di come l uomo raccoglie informazioni
https://www.youtube.com/watch?v=hkq6d8fqoo8 Tratti da Dans le pays des sourds, Nicolas Philibert Linguaggio e sordità
 https://www.youtube.com/watch?v=hkq6d8fqoo8 Tratti da Dans le pays des sourds, Nicolas Philibert Linguaggio e sordità AA 2017/2018 Perdita uditiva da 20 a 40 db da 40 a 70 db da 70 a 90 db maggiore di
https://www.youtube.com/watch?v=hkq6d8fqoo8 Tratti da Dans le pays des sourds, Nicolas Philibert Linguaggio e sordità AA 2017/2018 Perdita uditiva da 20 a 40 db da 40 a 70 db da 70 a 90 db maggiore di
UNITÀ DI APPRENDIMENTO I QUADRIMESTRE SCUOLE PRIMARIE CLASSI QUARTE
 UNITÀ DI APPRENDIMENTO I QUADRIMESTRE SCUOLE PRIMARIE CLASSI QUARTE Denominazione ACQUA: FONTE DI VITA. 1 UDA L ACQUA: ELEMENTO DELLA NATURA Compito-prodotto Cartelloni e /o fascicolo 1 Competenze mirate
UNITÀ DI APPRENDIMENTO I QUADRIMESTRE SCUOLE PRIMARIE CLASSI QUARTE Denominazione ACQUA: FONTE DI VITA. 1 UDA L ACQUA: ELEMENTO DELLA NATURA Compito-prodotto Cartelloni e /o fascicolo 1 Competenze mirate
Psicologia dello sviluppo Corso I Z C. di L. in Scienze e Tecniche Psicologiche
 Psicologia dello sviluppo Corso I Z C. di L. in Scienze e Tecniche Psicologiche Dott.ssa Paola Cerratti cerratti.psy@hotmail.it Ai fini dell'esame non è necessario studiare le slides contrassegnate dal
Psicologia dello sviluppo Corso I Z C. di L. in Scienze e Tecniche Psicologiche Dott.ssa Paola Cerratti cerratti.psy@hotmail.it Ai fini dell'esame non è necessario studiare le slides contrassegnate dal
Competenze chiave europee
 UNITA DI APPRENDIMENTO N.1 Disciplina: ITALIANO Utenti destinatari: CLASSI PRIME Denominazione: BAMBINI A SCUOLA Comunicazione nella madrelingua. Imparare ad imparare. Competenze chiave europee Conoscenze
UNITA DI APPRENDIMENTO N.1 Disciplina: ITALIANO Utenti destinatari: CLASSI PRIME Denominazione: BAMBINI A SCUOLA Comunicazione nella madrelingua. Imparare ad imparare. Competenze chiave europee Conoscenze
PIANI DI STUDIO LINGUA ITALIANA
 Istituto Comprensivo Taio PIANI DI STUDIO LINGUA ITALIANA Primo biennio Classe Prima ANNO SCOLASTICO 2017-2018 Competenza 1 1. Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura Attenzione
Istituto Comprensivo Taio PIANI DI STUDIO LINGUA ITALIANA Primo biennio Classe Prima ANNO SCOLASTICO 2017-2018 Competenza 1 1. Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura Attenzione
BIN 4-6 Batteria per la valutazione dell intelligenza numerica. Adriana Molin, Silvana Poli, Daniela Lucangeli
 BIN 4-6 Batteria per la valutazione dell intelligenza numerica Adriana Molin, Silvana Poli, Daniela Lucangeli Nati per contare L Intelligenza Numerica è la capacità di intelligere attraverso il numero
BIN 4-6 Batteria per la valutazione dell intelligenza numerica Adriana Molin, Silvana Poli, Daniela Lucangeli Nati per contare L Intelligenza Numerica è la capacità di intelligere attraverso il numero
Scuola statale italiana di Madrid Anno scolastico 2016/17 LINGUA ITALIANA Classe 2C Insegnante: Cristina Contri. ABILITÀ Obiettivi di apprendimento
 Scuola statale italiana di Madrid Anno scolastico 2016/17 LINGUA ITALIANA Classe 2C Insegnante: Cristina Contri NUCLEI FONDANTI ASCOLTO E PARLATO COMPETENZE Ascoltare e comprendere messaggi in contesti
Scuola statale italiana di Madrid Anno scolastico 2016/17 LINGUA ITALIANA Classe 2C Insegnante: Cristina Contri NUCLEI FONDANTI ASCOLTO E PARLATO COMPETENZE Ascoltare e comprendere messaggi in contesti
INGLESE SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA
 INGLESE SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE RELATIVI AD ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) L alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
INGLESE SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE RELATIVI AD ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) L alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
Ascolto e parlato. Ascolto e parlato. Ascolto e parlato. Quarto bimestre A.S COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
 Quarto bimestre AS 2014-2015 CURRICOLO DI ITALIANO Classe seconda Primaria COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE AMBIENTE DI APPRENDIMENTO L allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione
Quarto bimestre AS 2014-2015 CURRICOLO DI ITALIANO Classe seconda Primaria COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE AMBIENTE DI APPRENDIMENTO L allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione
LINGUA INGLESE PROGRAMMAZIONE ANNUALE CLASSE I
 LINGUA INGLESE PROGRAMMAZIONE ANNUALE CLASSE I OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTESI ALLA FINE DELLA CLASSE PRIMA 1. ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) a) Acquisire una consapevolezza plurilinguistica e multiculturale.
LINGUA INGLESE PROGRAMMAZIONE ANNUALE CLASSE I OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTESI ALLA FINE DELLA CLASSE PRIMA 1. ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) a) Acquisire una consapevolezza plurilinguistica e multiculturale.
19 Dicembre Dott.ssa Giuliana Wolf Logopedista
 19 Dicembre 2017 Dott.ssa Giuliana Wolf Logopedista Lettura a. L azione di leggere, di decifrare un testo scritto o stampato ovvero una DECODIFICA, cioè la traduzione di un testo scritto in un codice in
19 Dicembre 2017 Dott.ssa Giuliana Wolf Logopedista Lettura a. L azione di leggere, di decifrare un testo scritto o stampato ovvero una DECODIFICA, cioè la traduzione di un testo scritto in un codice in
PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO PRIMO BIENNIO CLASSI TERZE
 PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO PRIMO BIENNIO CLASSI TERZE ITALIANO INDICATORE DISCIPLINARE Sviluppare le abilità di base come l ascoltare, il parlare, il leggere e lo scrivere per maturare padronanza linguistica
PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO PRIMO BIENNIO CLASSI TERZE ITALIANO INDICATORE DISCIPLINARE Sviluppare le abilità di base come l ascoltare, il parlare, il leggere e lo scrivere per maturare padronanza linguistica
Sommario Linguaggi, messaggi e comunicazione. Introduzione ai Linguaggi di Programmazione. Linguaggio (1) Linguaggio (2)
 Sommario Linguaggi, messaggi e comunicazione Traduzione di programmi Interpreti e compilatori Introduzione al processo di compilazione 1 2 Linguaggio (1) Linguaggio (2) Insieme di sequenze di simboli,
Sommario Linguaggi, messaggi e comunicazione Traduzione di programmi Interpreti e compilatori Introduzione al processo di compilazione 1 2 Linguaggio (1) Linguaggio (2) Insieme di sequenze di simboli,
Indice. 1. Pittogrammi e ideogrammi Ilogogrammi 35. Premessa 11. Le origini del linguaggio 13. II. Gli animali e il linguaggio umano 21
 Indice Premessa 11 Le origini del linguaggio 13 1. L'origine divina 13 2. La teoria dei suoni naturali 14 3. La teoria dell'adattamento fisico 15 4. Denti, labbra, bocca, laringe e faringe 16 5. Il cervello
Indice Premessa 11 Le origini del linguaggio 13 1. L'origine divina 13 2. La teoria dei suoni naturali 14 3. La teoria dell'adattamento fisico 15 4. Denti, labbra, bocca, laringe e faringe 16 5. Il cervello
ITALIANO A. S. 2018/2019
 A. S. 2018/2019 Ascoltare in modo attivo e comprendere l argomento di una conversazione. Ascoltare in modo attivo e comprendere l oggetto e le diverse argomentazioni di una discussione. Ascoltare in modo
A. S. 2018/2019 Ascoltare in modo attivo e comprendere l argomento di una conversazione. Ascoltare in modo attivo e comprendere l oggetto e le diverse argomentazioni di una discussione. Ascoltare in modo
Curricolo per Competenze: LINGUE
 Scuola dell Infanzia COMPETENZE/CAMPO DI ESPERIENZA 1. Comprendere vari tipi di messaggi orali e scritti relativi a situazioni note 2. Interagire in diverse situazioni comunicative scambiando informazioni
Scuola dell Infanzia COMPETENZE/CAMPO DI ESPERIENZA 1. Comprendere vari tipi di messaggi orali e scritti relativi a situazioni note 2. Interagire in diverse situazioni comunicative scambiando informazioni
C U R R I C O L O D I I T A L I A N O SCUOLA PRIMARIA CLASSE 2ª
 C U R R I C O L O D I I T A L I A N O SCUOLA PRIMARIA CLASSE 2ª COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura. Durante l ascolto l alunno è in grado di:
C U R R I C O L O D I I T A L I A N O SCUOLA PRIMARIA CLASSE 2ª COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura. Durante l ascolto l alunno è in grado di:
Sommario Linguaggi, messaggi e comunicazione. Introduzione ai Linguaggi di Programmazione. Linguaggio. Messaggio
 Sommario Linguaggi, messaggi e comunicazione Traduzione di programmi Interpreti e compilatori Introduzione al processo di compilazione 1 2 Linguaggio Messaggio Insieme di sequenze di simboli, le parole,
Sommario Linguaggi, messaggi e comunicazione Traduzione di programmi Interpreti e compilatori Introduzione al processo di compilazione 1 2 Linguaggio Messaggio Insieme di sequenze di simboli, le parole,
LINGUAGGIO E APPRENDIMENTO PISA,
 LINGUAGGIO E APPRENDIMENTO PISA, 12.04.2008 RISULTATI dell EQUIPE PISANA Precocità dell intervento Ripristino precoce anche della schisi ossea, garanzia di perfetta simmetria del cavo orale Assistenza
LINGUAGGIO E APPRENDIMENTO PISA, 12.04.2008 RISULTATI dell EQUIPE PISANA Precocità dell intervento Ripristino precoce anche della schisi ossea, garanzia di perfetta simmetria del cavo orale Assistenza
Imparare a parlare è una abilità complessa Ma come fanno i bambini a imparare a parlare?
 Imparare a parlare è una abilità complessa Ma come fanno i bambini a imparare a parlare? QUALCOSA SULLE TEORIE SULL ACQUISIZIONE DEL LINGUAGGIO Piaget: il linguaggio è una conquista della transizione dall
Imparare a parlare è una abilità complessa Ma come fanno i bambini a imparare a parlare? QUALCOSA SULLE TEORIE SULL ACQUISIZIONE DEL LINGUAGGIO Piaget: il linguaggio è una conquista della transizione dall
Le competenze metafonologiche: attività, giochi metalinguistici e fonologici per favorire il loro sviluppo. Relatrice: Maria Angela Berton
 Le competenze metafonologiche: attività, giochi metalinguistici e fonologici per favorire il loro sviluppo Relatrice: Maria Angela Berton IL LINGUAGGIO VERBALE E UNO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE COME SI
Le competenze metafonologiche: attività, giochi metalinguistici e fonologici per favorire il loro sviluppo Relatrice: Maria Angela Berton IL LINGUAGGIO VERBALE E UNO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE COME SI
Istituto Comprensivo di Pralboino Curricolo Verticale
 ITALIANO CLASSE 2 a PRIMARIA ASCOLTO E PARLATO -L allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando
ITALIANO CLASSE 2 a PRIMARIA ASCOLTO E PARLATO -L allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando
Traguardi per lo sviluppo delle competenze. Linguaggi, creatività espressività. Obiettivi di apprendimento
 Progetto educazione alla salute La musica, la danza, favoriscono il coordinamento motorio, l attenzione, la concentrazione, il ragionamento logico, la memoria, l espressione di sé, il pensiero creativo.
Progetto educazione alla salute La musica, la danza, favoriscono il coordinamento motorio, l attenzione, la concentrazione, il ragionamento logico, la memoria, l espressione di sé, il pensiero creativo.
I.C. Francesco Cilea via Cilea 269 Roma
 (al termine della classe Terza della Scuola Primaria). conosce le principali differenze fonetiche rispetto alla lingua madre e comprende semplici messaggi verbali orali. Ascolto (Listening) CLASSE PRIMA
(al termine della classe Terza della Scuola Primaria). conosce le principali differenze fonetiche rispetto alla lingua madre e comprende semplici messaggi verbali orali. Ascolto (Listening) CLASSE PRIMA
Istituto Comprensivo Statale di Goito (MN) Via D. Alighieri, Goito (MN) a.s PROGRAMMAZIONE DI ALFABETIZZAZIONE
 Istituto Comprensivo Statale di Goito (MN) Via D. Alighieri, 49-46044 Goito (MN) a.s. 2014-2015 PROGRAMMAZIONE DI ALFABETIZZAZIONE OBIETTIVO GENERALE L obiettivo generale sarà quello di fornire ai bambini
Istituto Comprensivo Statale di Goito (MN) Via D. Alighieri, 49-46044 Goito (MN) a.s. 2014-2015 PROGRAMMAZIONE DI ALFABETIZZAZIONE OBIETTIVO GENERALE L obiettivo generale sarà quello di fornire ai bambini
CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE QUARTA
 CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE QUARTA CONTENUTI ABILITA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI LINGUA PER NARRARE Testo fantastico fiaba favola mito leggenda racconto di fantasia Testo realistico
CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE QUARTA CONTENUTI ABILITA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI LINGUA PER NARRARE Testo fantastico fiaba favola mito leggenda racconto di fantasia Testo realistico
LINGUA INGLESE CLASSE PRIMA NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE. Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni di uso quotidiano
 LINGUA INGLESE (comprensione orale) Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari Parlato (produzione e interazione orale) Descrivere oralmente, in modo semplice, aspetti del
LINGUA INGLESE (comprensione orale) Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari Parlato (produzione e interazione orale) Descrivere oralmente, in modo semplice, aspetti del
POTENZIAMENTO GRAMMATICA E LESSICO. Dott.ssa Renata Salvadorini IRCCS Stella Maris Calambrone - Pisa Con la partecipazione di:
 POTENZIAMENTO GRAMMATICA E LESSICO Dott.ssa Renata Salvadorini IRCCS Stella Maris Calambrone - Pisa Con la partecipazione di: LESSICO Il lessico o vocabolario è il complesso delle parole che appartengono
POTENZIAMENTO GRAMMATICA E LESSICO Dott.ssa Renata Salvadorini IRCCS Stella Maris Calambrone - Pisa Con la partecipazione di: LESSICO Il lessico o vocabolario è il complesso delle parole che appartengono
UNITÀ DI APPRENDIMENTO ITALIANO 1. ASCOLTO Terze Bornato Cazzago - Pedrocca
 NUMERO UNITÀ D APPRENDIMENTO 1 ASCOLTO ARTICOLAZIONE DELL 1. Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte pertinenti 2. Comprendere l argomento e le informazioni di discorsi affrontati
NUMERO UNITÀ D APPRENDIMENTO 1 ASCOLTO ARTICOLAZIONE DELL 1. Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte pertinenti 2. Comprendere l argomento e le informazioni di discorsi affrontati
Il bambino audioleso a scuola. Alessandra Pompilio Francesca Premier
 Il bambino audioleso a scuola Alessandra Pompilio Francesca Premier 28.09.2017 Le tappe dello sviluppo dell ascolto e del linguaggio nel bambino normudente Il bambino normudente... Acquisisce queste tappe
Il bambino audioleso a scuola Alessandra Pompilio Francesca Premier 28.09.2017 Le tappe dello sviluppo dell ascolto e del linguaggio nel bambino normudente Il bambino normudente... Acquisisce queste tappe
Cognitivismo e neuroscienze cognitive. Alberto Oliverio Università di Roma, Sapienza
 Cognitivismo e neuroscienze cognitive Alberto Oliverio Università di Roma, Sapienza L importanza dell azione. Il controllo motorio è in qualche modo il contrario di quanto si verifica nella percezione.
Cognitivismo e neuroscienze cognitive Alberto Oliverio Università di Roma, Sapienza L importanza dell azione. Il controllo motorio è in qualche modo il contrario di quanto si verifica nella percezione.
PROGRAMMAZIONE CLASSI TERZE A.S. 2018/19 ITALIANO
 PROGRAMMAZIONE CLASSI TERZE A.S. 2018/19 ITALIANO COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. Competenza digitale. Imparare ad imparare. COMPETENZE TRASVERSALI Comprendere
PROGRAMMAZIONE CLASSI TERZE A.S. 2018/19 ITALIANO COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. Competenza digitale. Imparare ad imparare. COMPETENZE TRASVERSALI Comprendere
Il bambino audioleso a scuola. Servizio di Neurologia e Riabilitazione dell età evolutiva
 Il bambino audioleso a scuola Servizio di Neurologia e Riabilitazione dell età evolutiva 28.09.2018 Le tappe dello sviluppo dell ascolto e del linguaggio nel bambino normudente Il bambino normudente...
Il bambino audioleso a scuola Servizio di Neurologia e Riabilitazione dell età evolutiva 28.09.2018 Le tappe dello sviluppo dell ascolto e del linguaggio nel bambino normudente Il bambino normudente...
PIANI DI STUDIO LINGUA ITALIANA
 Istituto Comprensivo Taio PIANI DI STUDIO LINGUA ITALIANA Primo biennio Classe Seconda ANNO SCOLASTICO 2017-2018 Competenza 1 1. Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura Attenzione
Istituto Comprensivo Taio PIANI DI STUDIO LINGUA ITALIANA Primo biennio Classe Seconda ANNO SCOLASTICO 2017-2018 Competenza 1 1. Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura Attenzione
PROGETTAZIONE DISCIPLINARE
 PROGETTAZIONE DISCIPLINARE ITALIANO classe 2^ PER ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE 1 bim. 2 bim. 3 bim. 4 bim. 1a) Attenzione entro i tempi richiesti. 1b) Ascolto e intervento nelle conversazioni
PROGETTAZIONE DISCIPLINARE ITALIANO classe 2^ PER ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE 1 bim. 2 bim. 3 bim. 4 bim. 1a) Attenzione entro i tempi richiesti. 1b) Ascolto e intervento nelle conversazioni
PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: ITALIANO Scuola primaria A. Sabin - CLASSI PRIME - Anno scolastico 201 /201
 PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: ITALIANO Scuola primaria A. Sabin - CLASSI PRIME - Anno scolastico 201 /201 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE ASCOLTO E PARLATO ABILITÀ
PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: ITALIANO Scuola primaria A. Sabin - CLASSI PRIME - Anno scolastico 201 /201 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE ASCOLTO E PARLATO ABILITÀ
PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: ITALIANO
 PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: ITALIANO Scuola primaria A. Sabin - CLASSI SECONDE - Anno scolastico 201 /201 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE ASCOLTO E PARLATO L alunno
PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: ITALIANO Scuola primaria A. Sabin - CLASSI SECONDE - Anno scolastico 201 /201 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE ASCOLTO E PARLATO L alunno
Le difficoltà di apprendimento e l intervento di aiuto APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA
 Le difficoltà di apprendimento e l intervento di aiuto APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA COSA SONO LA LETTURA E LA SCRITTURA? Come si colloca la funzione della scrittura all interno dei sistemi di comunicazione?
Le difficoltà di apprendimento e l intervento di aiuto APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA COSA SONO LA LETTURA E LA SCRITTURA? Come si colloca la funzione della scrittura all interno dei sistemi di comunicazione?
ISTITUTO COMPRENSIVO FOSSACESIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO FOSSACESIA Curricolo a.s. 2018-2019 Competenze Chiave per l apprendimento permanente Comunicazione nella madrelingua; Comunicazione nelle lingue straniere; Competenza matematica e
ISTITUTO COMPRENSIVO FOSSACESIA Curricolo a.s. 2018-2019 Competenze Chiave per l apprendimento permanente Comunicazione nella madrelingua; Comunicazione nelle lingue straniere; Competenza matematica e
Linguistica Generale. Docente: Paola Monachesi. Contents First Last Prev Next
 Linguistica Generale Docente: Paola Monachesi Contents 1 La linguistica e i suoi settori............................... 3 2 La grammatica come mezzo per rappresentare la competenza linguistica...............................................
Linguistica Generale Docente: Paola Monachesi Contents 1 La linguistica e i suoi settori............................... 3 2 La grammatica come mezzo per rappresentare la competenza linguistica...............................................
Linguaggi, messaggi e comunicazione Traduzione di programmi Interpreti e compilatori Introduzione al processo di compilazione
 Sommario Linguaggi, messaggi e comunicazione Traduzione di programmi Interpreti e compilatori Introduzione al processo di compilazione 1 2 Linguaggio (1) Linguaggio (2) Insieme di sequenze di simboli,
Sommario Linguaggi, messaggi e comunicazione Traduzione di programmi Interpreti e compilatori Introduzione al processo di compilazione 1 2 Linguaggio (1) Linguaggio (2) Insieme di sequenze di simboli,
ISTITUTO COMPRENSIVO DI RASTIGNANO CURRICOLO VERTICALE DI MUSICA
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI RASTIGNANO CURRICOLO VERTICALE DI MUSICA 1. SAPER COMUNICARE 1.1 Acquisire il lessico specifico Percepire la velocità di un brano Confrontare suoni secondo le qualità di intensità
ISTITUTO COMPRENSIVO DI RASTIGNANO CURRICOLO VERTICALE DI MUSICA 1. SAPER COMUNICARE 1.1 Acquisire il lessico specifico Percepire la velocità di un brano Confrontare suoni secondo le qualità di intensità
SCUOLA PRIMARIA BRENTONICO
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI MORI-BRENTONICO Via Giovanni XXIII, n. 64-38065 MORI Cod. Fisc. 94024510227 - Tel. 0464-918669 Fax 0464-911029 www.icmori.it e-mail: segr.ic.mori@scuole.provincia.tn.it REPUBBLICA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MORI-BRENTONICO Via Giovanni XXIII, n. 64-38065 MORI Cod. Fisc. 94024510227 - Tel. 0464-918669 Fax 0464-911029 www.icmori.it e-mail: segr.ic.mori@scuole.provincia.tn.it REPUBBLICA
ITALIANO CLASSE 1 1. ASCOLTARE E COMPRENDERE TESTI NARRATIVI.
 ITALIANO OB. FORMATIVI COMPETENZE CLASSE 1 1. ASCOLTARE E COMPRENDERE TESTI 1.1 Ascoltare una semplice narrazione individuando personaggi, luoghi, successione temporale. 1.2 Ascoltare una semplice descrizione
ITALIANO OB. FORMATIVI COMPETENZE CLASSE 1 1. ASCOLTARE E COMPRENDERE TESTI 1.1 Ascoltare una semplice narrazione individuando personaggi, luoghi, successione temporale. 1.2 Ascoltare una semplice descrizione
U. A. 1 ITALIANO settembre-ottobre-novembre
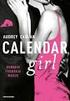 U. A. 1 ITALIANO settembre-ottobre-novembre ABILITÀ a. Ascoltare attivamente e comprendere vari tipi di testo. b. Intervenire appropriatamente ed esprimere attraverso il parlato pensieri e stati d animo.
U. A. 1 ITALIANO settembre-ottobre-novembre ABILITÀ a. Ascoltare attivamente e comprendere vari tipi di testo. b. Intervenire appropriatamente ed esprimere attraverso il parlato pensieri e stati d animo.
CURRICOLO ITALIANO - CLASSE SECONDA -
 CURRICOLO ITALIANO - CLASSE SECONDA - ASCOLTO E PARLATO - Ascoltare con attenzione le Collaborare e comunicazioni dei compagni. partecipare - Comprendere messaggi orali e lo scopo per cui sono attivati.
CURRICOLO ITALIANO - CLASSE SECONDA - ASCOLTO E PARLATO - Ascoltare con attenzione le Collaborare e comunicazioni dei compagni. partecipare - Comprendere messaggi orali e lo scopo per cui sono attivati.
Ascoltare e parlare. Leggere. Scrivere OBIETTIVI MINIMI SCUOLA PRIMARIA PIANI DI STUDIO ITALIANO ANNO SCOLASTICO 2010/2011 CLASSE 1
 SCUOLA PRIMARIA PIANI DI STUDIO ITALIANO ANNO SCOLASTICO 2010/2011 CLASSE 1 Ascoltare e comprende le regole della scuola. Ascoltare e comprendere una indicazione di lavoro Saper raccontare le proprie esperienze
SCUOLA PRIMARIA PIANI DI STUDIO ITALIANO ANNO SCOLASTICO 2010/2011 CLASSE 1 Ascoltare e comprende le regole della scuola. Ascoltare e comprendere una indicazione di lavoro Saper raccontare le proprie esperienze
CURRICOLO ITALIANO - CLASSE PRIMA -
 CURRICOLO ITALIANO - CLASSE PRIMA - COMPETENZE NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI -Ascoltare con attenzione la Collaborare e partecipare ASCOLTO E PARLATO comunicazione dei compagni -Intervenire nel dialogo.
CURRICOLO ITALIANO - CLASSE PRIMA - COMPETENZE NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI -Ascoltare con attenzione la Collaborare e partecipare ASCOLTO E PARLATO comunicazione dei compagni -Intervenire nel dialogo.
CURRICOLO VERTICALE ITALIANO
 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo R. Franceschi Via Concordia, 2/4-20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Tel. 02 48 40 20 46 - Fax 02 48 49 01 97 E-mail: segreteria@icfranceschi.gov.it
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo R. Franceschi Via Concordia, 2/4-20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Tel. 02 48 40 20 46 - Fax 02 48 49 01 97 E-mail: segreteria@icfranceschi.gov.it
UNITÀ DI APPRENDIMENTO II QUADRIMESTRE SCUOLE PRIMARIE CLASSI QUARTE
 UNITÀ DI APPRENDIMENTO II QUADRIMESTRE SCUOLE PRIMARIE CLASSI QUARTE Denominazione ACQUA: FONTE DI VITA. II UDA L ACQUA: PAESAGGI E CIVILTÁ Compito-prodotto Cartelloni e /o fascicolo 1 Competenze mirate
UNITÀ DI APPRENDIMENTO II QUADRIMESTRE SCUOLE PRIMARIE CLASSI QUARTE Denominazione ACQUA: FONTE DI VITA. II UDA L ACQUA: PAESAGGI E CIVILTÁ Compito-prodotto Cartelloni e /o fascicolo 1 Competenze mirate
Patologia del linguaggio in età evolutiva
 Patologia del linguaggio in età evolutiva U.O. e Cattedra di Neuropsichiatria Infantile Dipartimento di Scienze Neurologiche e della Visione Sezione di Neuroscienze dello Sviluppo IRCCS G. Gaslini Disturbi
Patologia del linguaggio in età evolutiva U.O. e Cattedra di Neuropsichiatria Infantile Dipartimento di Scienze Neurologiche e della Visione Sezione di Neuroscienze dello Sviluppo IRCCS G. Gaslini Disturbi
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CUNARDO. UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 1
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CUNARDO Ordine di scuola Secondaria di Primo grado Classe/i prime Materia italiano Anno scolastico 2017/18 UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 1 Il testo narrativo Sa ascoltare testi
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CUNARDO Ordine di scuola Secondaria di Primo grado Classe/i prime Materia italiano Anno scolastico 2017/18 UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 1 Il testo narrativo Sa ascoltare testi
CURRICOLO DI ITALIANO Ore settimanali: 4 Monte ore annuali: 132
 I.T.T. L. da Vinci Foligno A.s. 2016-17 CURRICOLO DI ITALIANO Ore settimanali: 4 Monte ore annuali: 132 COMPETENZE ATTESE A CONCLUSIONE DEL BIENNIO Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi
I.T.T. L. da Vinci Foligno A.s. 2016-17 CURRICOLO DI ITALIANO Ore settimanali: 4 Monte ore annuali: 132 COMPETENZE ATTESE A CONCLUSIONE DEL BIENNIO Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi
PROGETTAZIONE DISCIPLINARE. LINGUA ITALIANA classe 5^
 PROGETTAZIONE DISCIPLINARE LINGUA ITALIANA classe 5^ PER ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE 1a) Intuizione del significato globale di un messaggio orale ( serie di parole, comunicazioni brevi,
PROGETTAZIONE DISCIPLINARE LINGUA ITALIANA classe 5^ PER ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE 1a) Intuizione del significato globale di un messaggio orale ( serie di parole, comunicazioni brevi,
3 LEZIONE. I MODELLI DI APPRENDIMENTO DELLA LETTURA E LA DISLESSIA: DALLO SCREENING PRECOCE ALLA DIAGNOSI
 3 LEZIONE. I MODELLI DI APPRENDIMENTO DELLA LETTURA E LA DISLESSIA: DALLO SCREENING PRECOCE ALLA DIAGNOSI Introduzione L obiettivo di questo capitolo e dei prossimi, è quello di comprendere ed analizzare
3 LEZIONE. I MODELLI DI APPRENDIMENTO DELLA LETTURA E LA DISLESSIA: DALLO SCREENING PRECOCE ALLA DIAGNOSI Introduzione L obiettivo di questo capitolo e dei prossimi, è quello di comprendere ed analizzare
OBIETTIVI MINIMI. Racconto di esperienze personali con l ausilio di domande stimolo; interventi pertinenti e regolati nelle conversazioni
 ITALIANO Classe prima as 2018-2019 PERIODO: 1 quadrimestre da Ottobre a Gennaio NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA OBIETTIVI MINIMI PROVE MINIME 1. COMUNICARE ORALMENTE a) Intervenire
ITALIANO Classe prima as 2018-2019 PERIODO: 1 quadrimestre da Ottobre a Gennaio NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA OBIETTIVI MINIMI PROVE MINIME 1. COMUNICARE ORALMENTE a) Intervenire
SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA ITALIANO CLASSE PRIMA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO. Micro- obiettivi
 SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA ITALIANO CLASSE PRIMA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Nuclei Macro- obiettivi al termine della classe terza Ascolto e parlato Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA ITALIANO CLASSE PRIMA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Nuclei Macro- obiettivi al termine della classe terza Ascolto e parlato Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
