USO IN CANTINA DI STARMERELLA BACILLARIS (SIN. CANDIDA ZEMPLININA) PER LA PRODUZIONE DI VINI ROSSI CON MENO ALCOL E PIU GLICEROLO
|
|
|
- Antonio Cappelletti
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 USO IN CANTINA DI STARMERELLA BACILLARIS (SIN. CANDIDA ZEMPLININA) PER LA PRODUZIONE DI VINI ROSSI CON MENO ALCOL E PIU GLICEROLO Daniele Oliva 1, Gabriele Amore 1, Eleonora Barone 1, Teresa Fasciana 1-2, Nicola Francesca 3, Valentina Gandolfo 1, Pieramaria Giaramida 1, Manuela Monteleone 1, Giovanna Ponticello 1, Margherita Squadrito 1. 1 Istituto Regionale del Vino e dell Olio (IRVO), Regione Sicilia, via Libertà 66, Palermo 2 Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile G. D Alessandro, Università degli studi di Palermo, via del Vespro 133, Palermo 3 Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, Università degli studi di Palermo, viale delle Scienze 13, Palermo corresponding author: daniele.oliva@regione.sicilia.it Riassunto Nel 2014, in quattro diverse cantine siciliane, sono state realizzate vinificazioni di Merlot da hl. In ogni cantina sono state realizzate due vinificazioni parallele con uve provenienti dallo stesso vigneto: una massa di mosto è stata inoculata con un Saccharomyces cerevisiae commerciale, mentre una massa analoga veniva inoculata con il ceppo di Starmerella bacillaris (sinonimo Candida zemplinina) IRVO Cz3 e, dopo qualche giorno, con lo stesso S. cerevisiae commerciale. I controlli microbiologici e molecolari hanno dimostrato che i ceppi inoculati erano quelli effettivamente responsabili del consumo degli zuccheri. Tutti i vini hanno completato regolarmente sia la fermentazione alcolica che quella malolattica. Le analisi chimiche hanno dimostrato che le fermentazioni miste avevano prodotto vini con una resa minore in etanolo (circa 0,3 gradi alcolici in meno ogni 100 g di zuccheri fermentati) e maggiore in glicerolo (circa 1,0 g in più ogni 100 g di zuccheri fermentati) rispetto alle fermentazioni inoculate con il solo S. cerevisiae. Alla fine della fermentazione alcolica i valori di acido acetico delle vinificazioni miste erano circa il doppio di quelle tradizionali, ma sempre ben al di sotto dei limiti legali, con una concentrazione media di 0,32 g/l contro 0,18 g/l. Anche le concentrazioni relative dei composti organici volatili sono risultate differenti tra le due tipologie di vino. Poiché i vini aziendali prodotti con Starm. bacillaris sono sempre stati preferiti nelle degustazioni tecniche, probabilmente grazie alla maggiore quantità di glicerolo in essi contenuta, si propone l impiego di questo ceppo per la produzione commerciale di vini rossi. Introduzione Nelle fermentazioni spontanee dei mosti le prime fasi sono dominate da lieviti presenti già sulle uve ed appartenenti a generi diversi quali Candida, Cryptococcus, Hanseniaspora, Kluyveromyces, Lachancea, Metschnikowia, Pichia, nel loro insieme definiti genericamente non-saccharomyces per distinguerli dal genere principalmente presente in cantina ed in grado di portare a termine la fermentazione alcolica, il Saccharomyces (Varela, 2016). Per lungo tempo i lieviti non-saccharomyces sono stati scarsamente considerati in enologia, perché non in grado di tollerare alti livelli di alcol e perché in genere produttori di sostanze poco gradite nel vino, come l acido acetico. Negli ultimi quindici anni si è registrata però una inversione di tendenza, con molti lavori scientifici che hanno dimostrato la possibilità di selezionare ceppi di lievito non- Saccharomyces in grado di migliorare la qualità dei vini prodotti per fermentazione mista, dove l inoculo viene realizzato con due diversi ceppi, un non-saccharomyces ed un Saccharomyces, di solito in modo sequenziale. In particolare è stata descritta la capacità di questi lieviti di diminuire il contenuto alcolico dei vini, di aumentare la concentrazione finale di glicerolo, di aumentare la gamma di composti aromatici attraverso la produzione di esteri, alcoli superiori e beta-glucosidasi, di produrre attività proteolitiche e pectinolitiche, di influenzare la concentrazione di polisaccaridi (Jolly et al. 2014; Padilla et al., 2016).
2 Una delle specie più promettenti per l impiego enologico è rappresentata da Starmerella bacillaris (sinonimo Candida zemplinina) di cui è stato più volte riportato l isolamento da uve, mosti e vini in diverse parti del mondo. Di particolare interesse sono risultati la sua capacità di resistere all alcol e quindi di riuscire ancora a fermentare in stadi avanzati della vinificazione, il suo carattere fruttosofilo e le rese in alcol minori di quelle del S. cerevisiae (Englezos et al., 2017). Quest ultima caratteristica indica l impiego di ceppi selezionati di Starm. bacillaris come un metodo naturale per contrastare l aumento delle gradazioni alcoliche dei vini registrato negli ultimi anni e di cui alcuni identificano le cause nei cambiamenti climatici in atto (Mira de Orduña, 2010). In passato abbiamo riportato l isolamento, la selezione e l impiego sperimentale di alcuni ceppi di Starm. bacillaris isolati in Sicilia (Di Maio et al., 2012; Giaramida et al., 2013). In questo lavoro descriviamo i risultati ottenuti in quattro diverse cantine siciliane nella produzione di vini rossi con l impiego del ceppo identificato dalla sigla IRVO Cz3. Materiali e Metodi Vinificazioni Tra il 29 agosto ed il 6 settembre 2014, uve della varietà Merlot provenienti da vigneti dei territori limitrofi e con grado Babo compreso tra 21,9 e 23,6 sono state conferite presso le cantine siciliane Colomba Bianca (stabilimento Tre Cupole, Mazara del Vallo, TP), Primavera (Fulgatore, TP), Settesoli (Menfi, AG) e CVA Canicattì (Canicattì, AG). Le uve sono state diraspate e pigiate separandole, in ogni cantina, in due masse di eguale volume divise in altrettante vasche di acciaio inox. I mosti, con volumi compresi tra 25 e 58 hl, APA 250 mg/l e addizionati di anidride solforosa (5 g/hl) e di tiamina (60 mg/hl), in ogni cantina sono stati inoculati o con il ceppo commerciale Saccharomyces cerevisiae NDA21 (Fermentis, Marcq-en-Baroeul, Francia), sotto forma di LSA reidratato secondo le indicazioni del produttore (fermentazione di controllo), o con il ceppo di Starm. bacillaris (C. zemplinina) IRVO Cz3 (Giaramida et al., 2013) in forma di lievito fresco in pasta (produzione non commercializzabile realizzata specificamente per le attività progettuali da SG Biotech, Villanova sull Arda, PC). Dopo 3-4 giorni il 5-10% della massa in fermentazione del controllo è stata travasata nella massa in fermentazione con il ceppo IRVO Cz3. Le fermentazioni sono state realizzate alla temperatura di 26 C con uno o più rimontaggi al giorno, avendo cura che operazioni identiche venissero effettuate in ogni singola coppia di mosti all interno di ogni cantina. Alla fine della fermentazione alcolica, i vini sono stati svinati e, dopo la fermentazione malo-lattica, imbottigliati tra il mese di marzo e quello di maggio Analisi microbiologiche, molecolari, fisico-chimiche e gas-cromatografiche Ogni giorno campioni di mosto in fermentazione venivano diluiti serialmente in acqua peptonata (0,1% w/v peptone) e piastrati, in triplicato, su WL Nutrient Agar (Pallmann et al., 2001), Lysine Agar (Fowell, 1965) e WL Differential Agar (come modificato in Di Maio et al., 2011). Dopo cinque giorni di incubazione a 30 C, le colonie venivano contate e, per i terreni WL, anche differenziate per morfologia. Per l identificazione molecolare dei ceppi di lievito, eseguita tramite analisi RFLP (Restriction Fragments Length Polymorphism), e per la determinazione delle caratteristiche chimicofisiche dei vini sono stati seguiti i metodi descritti in Giaramida et al. (2013). I composti organici volatili (VOC) sono stati determinati seguendo i metodi di Corona et al. (2010). Analisi statistiche Per rappresentare graficamente i valori e la distribuzione dei VOC, è stata realizzata una analisi HMCA (Heat Map and Clustering Analysis; come descritto in Martorana et al., 2017) in cui le concentrazioni relative dei VOC vengono rappresentate attraverso la gamma dei colori che vanno dal giallo chiaro (concentrazione più bassa) al rosso (concentrazione più alta). L analisi statistica è stata realizzata usando il software XLStat versione (Addinsoft, New York, USA) per Excel.
3 Risultati e Discussione Durante la vendemmia 2014, in quattro diverse cantine siciliane, il ceppo di Starm. bacillaris (sinonimo C. zemplinina) IRVO Cz3 è stato utilizzato con uve Merlot in fermentazioni miste sequenziali con il ceppo commerciale S. cerevisiae NDA21. Il ceppo IRVO Cz3 è stato inoculato per primo ad una concentrazione di 69 ± 19 x 10 6 ufc/ml, ha raggiunto la fase stazionaria in 1-2 giorni mantenendo una concentrazione di 210 ± 45 x 10 6 ufc/ml, per poi diminuire rapidamente e drasticamente quando il grado Babo delle masse in fermentazione era diminuito del 80,1 ± 12,1%, corrispondente ad un grado alcolico presunto di 12,2 ± 2,1 % (v/v). Il ceppo NDA21 è stato inoculato in queste stesse masse 3-4 giorni dopo il ceppo IRVO Cz3, quando il grado Babo era diminuito del 47,3 ± 6,0%, ed il grado alcolico presunto era pari a 6,5 ± 1,0 % (v/v); tali inoculi sono stati realizzati ad una concentrazione di 2,9 ± 1,1 x 10 6 ufc/ml, che nell arco di pochi giorni aumentava a valori medi di 19 ± 13 x 10 6 ufc/ml per poi diminuire gradatamente fino alla fine della fermentazione. Gli altri lieviti non-saccharomyces si sono mantenuti a concentrazioni inferiori a quelle rilevabili con i metodi utilizzati (fig. 1). I controlli molecolari, eseguiti a metà ed alla fine della fermentazione alcolica, hanno confermato che i ceppi di lievito presenti erano effettivamente quelli inoculati (dati non mostrati). Fig. 1. Curve di crescita dei ceppi Starm. bacillaris IRVO Cz3 (linea rossa) e S. cerevisiae NDA21 (linea blu) nelle diverse fermentazioni miste sequenziali realizzate in quattro cantine siciliane durante la vendemmia In grigio è indicato il grado Babo. Le fermentazioni di controllo, realizzate con inoculo del solo ceppo S. cerevisiae NDA21 a concentrazioni di 19 ± 1,7 x 10 6 ufc/ml, hanno mostrato prima la classica fase di crescita esponenziale e quindi, nell arco di 1-4 giorni, l instaurarsi della fase stazionaria con concentrazioni pari a 64 ± 27 x 10 6 ufc/ml, per poi concludersi in media tre giorni prima di quelle miste.
4 Dopo la svinatura, in tutti i vini si è realizzata in modo completo la fermentazione malo-lattica. L analisi dei parametri chimico-fisici ha mostrato le differenze tra le coppie di vini ottenuti con fermentazione mista e con quella tradizionale di controllo all interno di ogni cantina. Il grado alcolico è risultato sempre più basso nei vini prodotti per fermentazione mista sequenziale con il ceppo di Starm. bacillaris IRVO Cz3, con valori medi più bassi di 0,29 gradi alcolici ogni 100 g di zuccheri fermentati (fig. 2A). Viceversa le concentrazioni di glicerolo ritrovate nei vini ottenuti con l impiego di Starm. bacillaris IRVO Cz3 sono sempre state significativamente maggiori, con un incremento medio di 0,87 g/l ogni 100 g di zuccheri fermentati, rispetto ai vini di controllo ottenuti con il solo S. cerevisiae (fig. 2B). Anche il contenuto di acido acetico è risultato più alto nei vini ottenuti con fermentazione mista, ma a livelli sempre ben inferiori ai limiti legali previsti per questo composto (incrementi medi pari a 0,07 g/l ogni 100 g di zuccheri fermentati; fig. 2C). A B C Fig. 2. Differenze medie nel contenuto di alcol etilico (A), glicerolo (B) ed acido acetico (C) dei vini prodotti nella vendemmia 2014 con il solo ceppo S. cerevisiae NDA21 o tramite fermentazione sequenziale mista con i ceppi Starm. bacillaris IRVO Cz3 e S. cerevisiae NDA21 (rispettivamente alla sinistra ed alla destra in ogni istogramma). Le analisi gascromatografiche hanno rilevato la presenza degli stessi composti organici volatili in tutti i vini prodotti, ma con concentrazioni relative differenti tra i vini di controllo, fermentati con il solo S. cerevisiae, e quelli ottenuti con Starm. bacillaris. Al fine di rappresentare graficamente i valori e la distribuzione delle concentrazioni dei VOC, abbiamo utilizzato una HMCA (Heat Map and Clustering Analysis) basata su un doppio dendrogramma gerarchico (fig. 3). L analisi dimostra che i vini prodotti per fermentazione mista con i ceppi di Starm. bacillaris IRVO Cz3 e S. cerevisiae NDA21 sono molto più simili tra loro rispetto ai vini prodotti con il solo S. cerevisiae NDA21. Questo significa che, oltre alle differenze prodotte a livello di alcol e glicerolo, anche la componente aromatica prodotta dalla fermentazione mista risulta modificata, contribuendo alla caratterizzazione di questa tipologia di vino più di altri fattori, quali ad esempio il vigneto di provenienza: vini prodotti a partire da uve di vigneti diversi ed in cantine diverse si raggruppano insieme in funzione del tipo di fermentazione con cui sono stati prodotti, e viceversa ogni vino di controllo prodotto con il solo S. cerevisiae si separa dal vino prodotto nella stessa cantina a partire da uve dello stesso vigneto, ma tramite fermentazione con Starm. bacillaris e S. cerevisiae.
5 Fig. 3. Heat map and clustering analysis (HMCA), basata su un doppio dendrogramma gerarchico, che rappresenta le diverse concentrazioni dei composti volatili (indicati sul margine destro con i relativi descrittori) con colori differenti che vanno dal giallo chiaro (concentrazione più bassa) al rosso (concentrazione più alta). I vini prodotti con fermentazione mista (IRVO Cz3 + NDA21, a sinistra) si raggruppano insieme, separandosi nettamente dai vini fermentati con il solo S. cerevisiae (NDA21 Controllo, a destra), indipendentemente dal vigneto di provenienza delle uve e dalla Cantina dove è stata realizzata la vinificazione. Le degustazioni tecniche dei vini prodotti, condotte alla cieca nei tre anni successivi alla vendemmia, hanno sempre rilevato una chiara distinzione tra i vini prodotti con fermentazione mista ed i corrispondenti controlli, con una preferenza nettamente a favore dei vini fermentati da Starm. bacillaris, descritti sempre come più morbidi e rotondi in bocca. Riteniamo quindi che i risultati riportati in questo lavoro siano utili a dimostrare la possibilità ed i vantaggi dell impiego del ceppo Starm. bacillaris IRVO Cz3 nella produzione di vini rossi aziendali. Tutti gli esperimenti e le analisi descritte in questo lavoro sono stati realizzati nell ambito del progetto Innovazione di processo e di prodotto nella filiera vitivinicola siciliana CUP G85C finanziato dal PO FESR SICILIA 2007/ Linea di intervento Azioni di sostegno all'attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in connessione con filiere produttive, distretti tecnologici e produttivi in settori di potenziale eccellenza che sperimentino un elevato grado di integrazione tra università, centri di ricerca, PMI e grandi imprese. Bibliografia Corona,O., Wine-making with protection of must against oxidation in a warm semi-arid terroir. SAJEV 31, Di Maio,S., Polizzotto,G., Planeta,D., Oliva, D., A method to discriminate between the Candida stellata and Saccharomyces cerevisiae in mixed fermentation on WLD and Lysine Agar Media. SAJEV 32,
6 Di Maio,S., Genna,G., Gandolfo,V., Amore,G., Ciaccio,M., Oliva,D., Presence of Candida zemplinina in Sicilian musts and selection of a strain for wine mixed fermentations. SAJEV 33, Englezos,V., Giacosa,S., Rantsiou,K., Rolle,L., Cocolin,L., Starmerella bacillaris in winemaking: opportunities and risks. COFS, Fowell,R.R., The identification of wild yeast colonies on Lysine Agar. J Appl Bacteriol 28, Giaramida,P., Ponticello,G., Di Maio,S., Squadrito,M., Genna,G., Barone,E., Scacco,A., Corona,O., Amore,G., Di Stefano,R., Oliva,D., Candida zemplinina for production of wines with less alcohol and more glycerol. SAJEV 34, Jolly,N.P., Varela,C., Pretorius,I.S., Not your ordinary yeast: non-saccharomyces yeasts in wine production uncovered. FEMS Yeast Res 14, Martorana,A., Alfonzo,A., Gaglio,R., Settanni,L., Corona,O., La Croce,F., Vagnoli,P., Caruso,T., Moschetti, G., Francesca,N., Evaluation of different conditions to enhance the performances of Lactobacillus pentosus OM13 during industrial production of Spanish-style table olives. Food Microbiol 61, Mira de Orduña,R., Climate change associated effects on grape and wine quality and production. Food Res Int 43(7): Padilla,B., Gil,J.V., Manzanares,P., Past and future of non-saccharomyces yeasts: from spoilage microorganisms to biotechnological tools for improving wine aroma complexity. Front Microbiol 7, 411. doi: /fmicb Pallmann,C.L., Brown,J.A., Olineka,T.L., Cocolin,L., Mills,D.A., Bisson,L.F., Use of WL Medium to profile native flora fermentations. Am J Enol Vitic 52, Varela,C., The impact of non-saccharomyces yeasts in the production of alcoholic beverages. Appl Microbiol Biotechnol. 100:
VIVIANA CORICH Docente di Microbiologia - Università di padova
 CARATTERIZZAZIONE DEI LIEVITI NON SACCHAROMYCES PER LA PRODUZIONE DI VINI A GRADAZIONE ALCOLICA RIDOTTA VIVIANA CORICH Docente di Microbiologia - Università di padova Caratterizzazione di lieviti non-saccharomyces
CARATTERIZZAZIONE DEI LIEVITI NON SACCHAROMYCES PER LA PRODUZIONE DI VINI A GRADAZIONE ALCOLICA RIDOTTA VIVIANA CORICH Docente di Microbiologia - Università di padova Caratterizzazione di lieviti non-saccharomyces
<< Isolamento e caratterizzazione dei lieviti autoctoni della cantina VICAS >>
 Filiera corta produttori fra Arno e Sieve Produzione in cantina di lieviti starter autoctoni VICASTART PROGETTO SOTTOMISURA 16.2 PSR 2014-2020 della Regione Toscana
Filiera corta produttori fra Arno e Sieve Produzione in cantina di lieviti starter autoctoni VICASTART PROGETTO SOTTOMISURA 16.2 PSR 2014-2020 della Regione Toscana
Protocollo sperimentale per la produzione di vini senza solfiti. Dr.ssa Graziana Grassini
 Protocollo sperimentale per la produzione di vini senza solfiti Dr.ssa Graziana Grassini SO2 e salute Viene impiegata in tutti i campi alimentari: Vino, aceto, bevande a base di succo di frutta, baccalà,
Protocollo sperimentale per la produzione di vini senza solfiti Dr.ssa Graziana Grassini SO2 e salute Viene impiegata in tutti i campi alimentari: Vino, aceto, bevande a base di succo di frutta, baccalà,
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEI VINI ROSSI TRAMITE L IMPIEGO IN CANTINA DI CEPPI DI CANDIDA ZEMPLININA ISOLATI IN SICILIA
 CANDIDA ZEMPLININA ISOLATI IN SICILIA, PAG. 1 MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEI VINI ROSSI TRAMITE L IMPIEGO IN CANTINA DI CEPPI DI CANDIDA ZEMPLININA ISOLATI IN SICILIA Giovanna PONTICELLO a, Pieramaria GIARAMIDA
CANDIDA ZEMPLININA ISOLATI IN SICILIA, PAG. 1 MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEI VINI ROSSI TRAMITE L IMPIEGO IN CANTINA DI CEPPI DI CANDIDA ZEMPLININA ISOLATI IN SICILIA Giovanna PONTICELLO a, Pieramaria GIARAMIDA
«Produzione di vini nella cantina VICAS mediante i lieviti autoctoni selezionati»
 Filiera corta produttori fra Arno e Sieve Produzione in cantina di lieviti starter autoctoni VICASTART PROGETTO SOTTOMISURA 16.2 PSR 214-22 della Regione Toscana «Produzione di vini nella cantina VICAS
Filiera corta produttori fra Arno e Sieve Produzione in cantina di lieviti starter autoctoni VICASTART PROGETTO SOTTOMISURA 16.2 PSR 214-22 della Regione Toscana «Produzione di vini nella cantina VICAS
La microbiologia per i vini rosati
 La microbiologia per i vini rosati Angela Capece Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali (SAFE) Università degli Studi della Basilicata Uva Cultivar Condizioni colturali Stato sanitario
La microbiologia per i vini rosati Angela Capece Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali (SAFE) Università degli Studi della Basilicata Uva Cultivar Condizioni colturali Stato sanitario
«Selezione dei ceppi autoctoni mediante meso-vinificazioni»
 Filiera corta produttori fra Arno e Sieve Produzione in cantina di lieviti starter autoctoni VICASTART PROGETTO SOTTOMISURA 16.2 PSR 2014-2020 della Regione Toscana «Selezione dei ceppi autoctoni mediante
Filiera corta produttori fra Arno e Sieve Produzione in cantina di lieviti starter autoctoni VICASTART PROGETTO SOTTOMISURA 16.2 PSR 2014-2020 della Regione Toscana «Selezione dei ceppi autoctoni mediante
«Selezione dei ceppi autoctoni mediante meso-vinificazioni»
 Filiera corta produttori fra Arno e Sieve Produzione in cantina di lieviti starter autoctoni VICASTART PROGETTO SOTTOMISURA 16.2 PSR 2014-2020 della Regione Toscana «Selezione dei ceppi autoctoni mediante
Filiera corta produttori fra Arno e Sieve Produzione in cantina di lieviti starter autoctoni VICASTART PROGETTO SOTTOMISURA 16.2 PSR 2014-2020 della Regione Toscana «Selezione dei ceppi autoctoni mediante
Fermentazione acetaldeide sotto controllo!
 Fermentazione acetaldeide sotto controllo! A cura dell Ufficio Tecnico Tebaldi srl Nella fermentazione alcolica l acetaldeide rappresenta fino al 90% delle aldeidi, composti carbonilici presenti nel vino
Fermentazione acetaldeide sotto controllo! A cura dell Ufficio Tecnico Tebaldi srl Nella fermentazione alcolica l acetaldeide rappresenta fino al 90% delle aldeidi, composti carbonilici presenti nel vino
ISTITUTO AGRARIO DI S. MICHELE CAVIT PROGRAMMA DI CONTROLLO QUALITÀ DEI PREPARATI DI LIEVITO SECCO PER LA VENDEMMIA 2002.
 ISTITUTO AGRARIO DI S. MICHELE CAVIT PROGRAMMA DI CONTROLLO QUALITÀ DEI PREPARATI DI LIEVITO SECCO PER LA VENDEMMIA 2. In queste pagine si riportano i risultati dei controlli, effettuati presso l U.O.
ISTITUTO AGRARIO DI S. MICHELE CAVIT PROGRAMMA DI CONTROLLO QUALITÀ DEI PREPARATI DI LIEVITO SECCO PER LA VENDEMMIA 2. In queste pagine si riportano i risultati dei controlli, effettuati presso l U.O.
Origine e valutazione della qualità percepibile dei vini
 Workshop su: Origine e valutazione della qualità percepibile dei vini in collaborazione con la Società Italiana di Scienze Sensoriali Firenze, 28 maggio 2007 Iolanda Rosi* Microrganismi e proprietà sensoriali:
Workshop su: Origine e valutazione della qualità percepibile dei vini in collaborazione con la Società Italiana di Scienze Sensoriali Firenze, 28 maggio 2007 Iolanda Rosi* Microrganismi e proprietà sensoriali:
28 marzo 2013 ASTRA Tebano Castellari Lorena e Jacopo Giovannini SELEZIONE DI LIEVITI AUTOCTONI PER LA VALORIZZAZIONE DI VINI ALBANA E SANGIOVESE DI
 28 marzo 2013 ASTRA Tebano Castellari Lorena e Jacopo Giovannini SELEZIONE DI LIEVITI AUTOCTONI PER LA VALORIZZAZIONE DI VINI ALBANA E SANGIOVESE DI UN AZIENDA DELL IMOLESE Premessa Lieviti indigeni/autoctoni
28 marzo 2013 ASTRA Tebano Castellari Lorena e Jacopo Giovannini SELEZIONE DI LIEVITI AUTOCTONI PER LA VALORIZZAZIONE DI VINI ALBANA E SANGIOVESE DI UN AZIENDA DELL IMOLESE Premessa Lieviti indigeni/autoctoni
Centro Interdipartimentale di ricerca per l Innovazione in Viticoltura ed Enologia
 Indagini sulla biodiversità dei lieviti enologici in Franciacorta ed Oltrepò Pavese Centro Interdipartimentale di ricerca per l Innovazione in Viticoltura ed Enologia Riccagioia, 14 gennaio 2014 Dr. Ileana
Indagini sulla biodiversità dei lieviti enologici in Franciacorta ed Oltrepò Pavese Centro Interdipartimentale di ricerca per l Innovazione in Viticoltura ed Enologia Riccagioia, 14 gennaio 2014 Dr. Ileana
SOSTENIBILITÁ E INNOVAZIONE IN CANTINA COME STRUMENTI DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE
 SOSTENIBILITÁ E INNOVAZIONE IN CANTINA COME STRUMENTI DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE Progetto Marenco Scrapona Strevi, 4 aprile 2018 Prof. Vincenzo Gerbi 2 3 Per produrre rispettando l ambiente occorre
SOSTENIBILITÁ E INNOVAZIONE IN CANTINA COME STRUMENTI DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE Progetto Marenco Scrapona Strevi, 4 aprile 2018 Prof. Vincenzo Gerbi 2 3 Per produrre rispettando l ambiente occorre
SPECIE MICROBICHE DOMINANTI NEL VINO
 SPECIE MICROBICHE DOMINANTI NEL VINO FERMENTAZIONE ALCOLICA (FA) E FERMENTAZIONE MALOLATTICA (FML) SONO PROCESSI POLIMICROBICI NELLE VARIE FASI DELLA VINIFICAZIONE LO SVILUPPO DELLE SPECIE FERMENTANTI
SPECIE MICROBICHE DOMINANTI NEL VINO FERMENTAZIONE ALCOLICA (FA) E FERMENTAZIONE MALOLATTICA (FML) SONO PROCESSI POLIMICROBICI NELLE VARIE FASI DELLA VINIFICAZIONE LO SVILUPPO DELLE SPECIE FERMENTANTI
Progetto ewine (Joint Project 2005)
 Progetto ewine (Joint Project 2005) Il concetto di tracciabilità applicato ad un processo di produzione di batteri selezionati per uso alimentare Fabio Fracchetti Dip. Biotecnologie - Microbiologia Alimentare
Progetto ewine (Joint Project 2005) Il concetto di tracciabilità applicato ad un processo di produzione di batteri selezionati per uso alimentare Fabio Fracchetti Dip. Biotecnologie - Microbiologia Alimentare
SIECZKOWSKI, BERGAGLIO - SELEZIONE DI UN CEPPO DI LIEVITO SPECIFICO PER IL VITIGNO SYRAH PAG. 1
 SIECZKOWSKI, BERGAGLIO - SELEZIONE DI UN CEPPO DI LIEVITO SPECIFICO PER IL VITIGNO SYRAH PAG. 1 SELEZIONE DI UN CEPPO DI LIEVITO SPECIFICO PER IL VITIGNO SYRAH Nathalie Sieczkowski - Servizio Tecnico Martin
SIECZKOWSKI, BERGAGLIO - SELEZIONE DI UN CEPPO DI LIEVITO SPECIFICO PER IL VITIGNO SYRAH PAG. 1 SELEZIONE DI UN CEPPO DI LIEVITO SPECIFICO PER IL VITIGNO SYRAH Nathalie Sieczkowski - Servizio Tecnico Martin
Test tecnico dei lieviti selezionati 2011
 250 Land- und Forstwirtschaftliches Test tecnico dei lieviti selezionati 2011 Come l anno scorso all inizio dell estate è stato svolto un sondaggio nel quale abbiamo chiesto ai produttori di vino sudtirolesi
250 Land- und Forstwirtschaftliches Test tecnico dei lieviti selezionati 2011 Come l anno scorso all inizio dell estate è stato svolto un sondaggio nel quale abbiamo chiesto ai produttori di vino sudtirolesi
Benedetta Turchetti Dipartimento di Biologia Applicata Università degli Studi di Perugia Curatore della Collezione dei Lieviti Industriali DBVPG
 Benedetta Turchetti Dipartimento di Biologia Applicata Università degli Studi di Perugia Curatore della Collezione dei Lieviti Industriali DBVPG ICLAVA Risultati progetto MIPAF - OIGA 18829/2009 Partecipanti
Benedetta Turchetti Dipartimento di Biologia Applicata Università degli Studi di Perugia Curatore della Collezione dei Lieviti Industriali DBVPG ICLAVA Risultati progetto MIPAF - OIGA 18829/2009 Partecipanti
Centro Interdipartimentale di ricerca per l Innovazione in Viticoltura ed Enologia
 Centro Interdipartimentale di ricerca per l Innovazione in Viticoltura ed Enologia Riccagioia, 14 gennaio 2014 Prof. Roberto Foschino Il Progetto Georgia Impiego di ceppi non-saccharomyces per migliorare
Centro Interdipartimentale di ricerca per l Innovazione in Viticoltura ed Enologia Riccagioia, 14 gennaio 2014 Prof. Roberto Foschino Il Progetto Georgia Impiego di ceppi non-saccharomyces per migliorare
Esperienze di produzione di vini in assenza di anidride solforosa C.Riponi, L.Pirrone, F.Chinnci, F.Sonni, N.Natali. Vicenza 12 dicembre 2009
 Esperienze di produzione di vini in assenza di anidride solforosa C.Riponi, L.Pirrone, F.Chinnci, F.Sonni, N.Natali Vicenza 12 dicembre 2009 Negli ultimi anni la ricerca nel settore alimentare è stata
Esperienze di produzione di vini in assenza di anidride solforosa C.Riponi, L.Pirrone, F.Chinnci, F.Sonni, N.Natali Vicenza 12 dicembre 2009 Negli ultimi anni la ricerca nel settore alimentare è stata
Microbiologia applicata al settore enologico
 Microbiologia applicata al settore enologico Emilia Garcia-Moruno, Enrico Vaudano Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura Centro di Ricerca per l Enologia -ASTI LA FERMENTAZIONE ALCOLICA
Microbiologia applicata al settore enologico Emilia Garcia-Moruno, Enrico Vaudano Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura Centro di Ricerca per l Enologia -ASTI LA FERMENTAZIONE ALCOLICA
-Coordinamento : CRA- Centro di ricerca per l Enologia (CRA_ENO) via P.Micca, 35-Asti Responsabile scientifico : dott.ssa Antonella Bosso
 Applicazione norme europee di vinificazione biologica e miglioramento della qualità e della conservabilità dei vini biologici nel rispetto delle peculiarità territoriali PROGETTO EUVINBIO -Coordinamento
Applicazione norme europee di vinificazione biologica e miglioramento della qualità e della conservabilità dei vini biologici nel rispetto delle peculiarità territoriali PROGETTO EUVINBIO -Coordinamento
POR FESR SICILIA 2007/2013. Innovazione di processo e di prodotto nella filiera vitivinicola siciliana. Linea di intervento
 POR FESR SICILIA 2007/2013 Innovazione di processo e di prodotto nella filiera vitivinicola siciliana Linea di intervento 4.1.1.1 Attività 1: Vinificazioni con il lievito Candida zemplinina Premessa Denominazione
POR FESR SICILIA 2007/2013 Innovazione di processo e di prodotto nella filiera vitivinicola siciliana Linea di intervento 4.1.1.1 Attività 1: Vinificazioni con il lievito Candida zemplinina Premessa Denominazione
LIEVITI SECCHI Controllo qualità e caratteristiche enologiche.
 LIEVITI SECCHI 23. Controllo qualità e caratteristiche enologiche. RISULTATI I preparati di lievito secco usati nella vendemmia 23 dalle Cantine Sociali trentine associate alla Cavit sono stati sottoposti
LIEVITI SECCHI 23. Controllo qualità e caratteristiche enologiche. RISULTATI I preparati di lievito secco usati nella vendemmia 23 dalle Cantine Sociali trentine associate alla Cavit sono stati sottoposti
Lieviti autoctoni: genius loci del territorio?
 Lieviti autoctoni: genius loci del territorio? Giovanna Suzzi e Rosanna Tofalo Università degli Studi di Teramo Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali La spumantizzazione come
Lieviti autoctoni: genius loci del territorio? Giovanna Suzzi e Rosanna Tofalo Università degli Studi di Teramo Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali La spumantizzazione come
DR. DANIELE OLIVA Marsala, 20 giugno 2013
 DR. DANIELE OLIVA Marsala, 20 giugno 2013 ASSE 1: Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei
DR. DANIELE OLIVA Marsala, 20 giugno 2013 ASSE 1: Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei
modulo LA VINIFICAZIONE LA VINIFICAZIONE unità didattiche VINIFICAZIONE IN BIANCO ore richieste: 2 ore di lezione, con osservazioni in CANTINA
 modulo LA VINIFICAZIONE LA VINIFICAZIONE unità didattiche VINIFICAZIONE IN ROSSO VINIFICAZIONE IN BIANCO MACERAZIONE CARBONICA ore richieste: 2-3 ore di lezione integrate da osservazioni/sperimentazioni
modulo LA VINIFICAZIONE LA VINIFICAZIONE unità didattiche VINIFICAZIONE IN ROSSO VINIFICAZIONE IN BIANCO MACERAZIONE CARBONICA ore richieste: 2-3 ore di lezione integrate da osservazioni/sperimentazioni
QUANDO IL GIOCO SI FA DURO: LE CONDIZIONI DIFFICILI DEI MOSTI DA UVE PASSITE A cura dell Ufficio Tecnico di Tebaldi Srl
 QUANDO IL GIOCO SI FA DURO: LE CONDIZIONI DIFFICILI DEI MOSTI DA UVE PASSITE A cura dell Ufficio Tecnico di Tebaldi Srl Dal momento dell inoculo alla fine della fermentazione i lieviti possono essere sottoposti
QUANDO IL GIOCO SI FA DURO: LE CONDIZIONI DIFFICILI DEI MOSTI DA UVE PASSITE A cura dell Ufficio Tecnico di Tebaldi Srl Dal momento dell inoculo alla fine della fermentazione i lieviti possono essere sottoposti
CARATTERIZZAZIONE DI UN NUOVO CEPPO DI LIEVITO
 ROSI E POLSINELLI, SELEZIONE E CARATTERIZZAZIONE DI UN NUOVO CEPPO DI LIEVITO ENOLOGICO, PAG. 1 SELEZIONE E ENOLOGICO. CARATTERIZZAZIONE DI UN NUOVO CEPPO DI LIEVITO Iolanda ROSI 1 e Mario POLSINELLI 2
ROSI E POLSINELLI, SELEZIONE E CARATTERIZZAZIONE DI UN NUOVO CEPPO DI LIEVITO ENOLOGICO, PAG. 1 SELEZIONE E ENOLOGICO. CARATTERIZZAZIONE DI UN NUOVO CEPPO DI LIEVITO Iolanda ROSI 1 e Mario POLSINELLI 2
Le analisi del vino in una produzione fai da te
 Le analisi del vino in una produzione fai da te Categories : Anno 2016, N. 237 - luglio 2016 di Marco Sollazzo Una procedura sottovalutata ma fondamentale nel migliorare la produzione casalinga di vino
Le analisi del vino in una produzione fai da te Categories : Anno 2016, N. 237 - luglio 2016 di Marco Sollazzo Una procedura sottovalutata ma fondamentale nel migliorare la produzione casalinga di vino
 AMA 2010 IL VIGNETO Con l annata 2010 nasce questo nuovo Chianti Classico. La superficie totale a vigneto specializzato di proprietà del Castello di Ama ammonta a circa 90 ettari, di questi circa 65 ettari
AMA 2010 IL VIGNETO Con l annata 2010 nasce questo nuovo Chianti Classico. La superficie totale a vigneto specializzato di proprietà del Castello di Ama ammonta a circa 90 ettari, di questi circa 65 ettari
INNOVAZIONE NELLA VINIFICAZIONE DELLE UVE APPASSITE/DISIDRATATE
 CREA Viticoltura Enologia Laboratorio di Velletri INNOVAZIONE NELLA VINIFICAZIONE DELLE UVE APPASSITE/DISIDRATATE Paolo Pietromarchi 7 Corso di appassimento Scansano (GR) 1 Interventi in vigneto Attitudine
CREA Viticoltura Enologia Laboratorio di Velletri INNOVAZIONE NELLA VINIFICAZIONE DELLE UVE APPASSITE/DISIDRATATE Paolo Pietromarchi 7 Corso di appassimento Scansano (GR) 1 Interventi in vigneto Attitudine
in cantina SECCO O FRESCO
 Reidratazione di lieviti secchi attivi. SECCO O FRESCO PURCHÉ DI QUALITÀ SELEZIONATO PER L OBIETTIVO ENOLOGICO DESIDERATO E RISPONDENTE A IRRINUNCIABILI STANDARD QUALITATIVI: ECCO IL LIEVITO GIUSTO, INDIPENDENTEMENTE
Reidratazione di lieviti secchi attivi. SECCO O FRESCO PURCHÉ DI QUALITÀ SELEZIONATO PER L OBIETTIVO ENOLOGICO DESIDERATO E RISPONDENTE A IRRINUNCIABILI STANDARD QUALITATIVI: ECCO IL LIEVITO GIUSTO, INDIPENDENTEMENTE
La storia. Adattamento evolutivo Orientare e accelerare i processi naturali di evoluzione per migliorare il metabolismo del lievito
 La storia Adattamento evolutivo Orientare e accelerare i processi naturali di evoluzione per migliorare il metabolismo del lievito Maggio 2014 Obiettivo iniziale del progetto Ridirezionare il flusso di
La storia Adattamento evolutivo Orientare e accelerare i processi naturali di evoluzione per migliorare il metabolismo del lievito Maggio 2014 Obiettivo iniziale del progetto Ridirezionare il flusso di
Accademia della vite e del vino
 Accademia della vite e del vino Nuovi approcci per la produzione di Vinsanto e Vinsanto occhio di pernice del Chianti Classico Accademico Dott. Nicola Menditto Direttore dell Azienda Agricola Montepaldi
Accademia della vite e del vino Nuovi approcci per la produzione di Vinsanto e Vinsanto occhio di pernice del Chianti Classico Accademico Dott. Nicola Menditto Direttore dell Azienda Agricola Montepaldi
Corso di laurea in Viticoltura ed enologia a.a MICROBIOLOGIA GENERALE ED ENOLOGICA (MICROGE 006GG)
 Corso di laurea in Viticoltura ed enologia a.a. 2015-2016 MICROBIOLOGIA GENERALE ED ENOLOGICA (MICROGE 006GG) Docente: Annita TOFFANIN, Dip. Scienze Agrarie Alimentari e Agro-ambientali Via del Borghetto
Corso di laurea in Viticoltura ed enologia a.a. 2015-2016 MICROBIOLOGIA GENERALE ED ENOLOGICA (MICROGE 006GG) Docente: Annita TOFFANIN, Dip. Scienze Agrarie Alimentari e Agro-ambientali Via del Borghetto
INDAGINE QUALITATIVA SUI PREPARATI DI LIEVITO SECCO ATTIVO
 Fondazione Edmund Mach - Centro di Trasferimento Tecnologico Laboratorio Analisi Chimiche e Consulenza Enologica INDAGINE QUALITATIVA SUI PREPARATI DI LIEVITO SECCO ATTIVO Anno 2010 Raffaele Guzzon, Veronica
Fondazione Edmund Mach - Centro di Trasferimento Tecnologico Laboratorio Analisi Chimiche e Consulenza Enologica INDAGINE QUALITATIVA SUI PREPARATI DI LIEVITO SECCO ATTIVO Anno 2010 Raffaele Guzzon, Veronica
I lieviti per la produzione di vino Vermentino
 I lieviti per la produzione di vino Vermentino DISAABA - Università degli Studi di Sassari SEVERINO ZARA - GIOVANNI ANTONIO FARRIS VERMENTINO: un vitigno di antica tradizione che guarda al futuro Vitigno
I lieviti per la produzione di vino Vermentino DISAABA - Università degli Studi di Sassari SEVERINO ZARA - GIOVANNI ANTONIO FARRIS VERMENTINO: un vitigno di antica tradizione che guarda al futuro Vitigno
La fermentazione malolattica
 GESTIONE DELLA FERMENTAZIONE MALOLATTICA MEDIANTE COINOCULO LIEVITI/BATTERI dim.tristezza 1,L.diFeo 2, M.Tufariello 3,F.Grieco 4, G.Bleve 1,P.Alifano 5, F.Grieco 1,* Microvinificazioni in laboratorio seguite
GESTIONE DELLA FERMENTAZIONE MALOLATTICA MEDIANTE COINOCULO LIEVITI/BATTERI dim.tristezza 1,L.diFeo 2, M.Tufariello 3,F.Grieco 4, G.Bleve 1,P.Alifano 5, F.Grieco 1,* Microvinificazioni in laboratorio seguite
Lettura DEFINIZIONI DI MOSTI E VINI - OIV
 Lettura DEFINIZIONI DI MOSTI E VINI - OIV Mosti Mosto d uva (18/73) Prodotto liquido ottenuto da uva fresca, sia spontaneamente sia mediante processi fisici, quali: pigiatura (*), diraspatura (*), sgrondatura
Lettura DEFINIZIONI DI MOSTI E VINI - OIV Mosti Mosto d uva (18/73) Prodotto liquido ottenuto da uva fresca, sia spontaneamente sia mediante processi fisici, quali: pigiatura (*), diraspatura (*), sgrondatura
POL-TP METODI ANALITICI RAPIDI PER LA MISURA DELLE FRAZIONI POLIFENOLICHE E QUALITÀ DEL VINO
 POL-TP METODI ANALITICI RAPIDI PER LA MISURA DELLE FRAZIONI POLIFENOLICHE E QUALITÀ DEL VINO Enol. Stefano Ferrari POL-TP Obiettivi del Progetto Caratterizzare la qualità fenolica delle uve Sangiovese
POL-TP METODI ANALITICI RAPIDI PER LA MISURA DELLE FRAZIONI POLIFENOLICHE E QUALITÀ DEL VINO Enol. Stefano Ferrari POL-TP Obiettivi del Progetto Caratterizzare la qualità fenolica delle uve Sangiovese
Levaduras en la producción del Aceto Balsamico Tradizionale
 Levaduras en la producción del Aceto Balsamico Tradizionale Paolo Giudici Universidad de Modena y Reggio Emilia Jornada puertas abiertas: Actualización en la elaboración de vinagres Principali specie di
Levaduras en la producción del Aceto Balsamico Tradizionale Paolo Giudici Universidad de Modena y Reggio Emilia Jornada puertas abiertas: Actualización en la elaboración de vinagres Principali specie di
Valutazione di protocolli di utilizzo dei microrganismi in enologia per la riduzione dei consumi energetici nei processi di vinificazione
 Applicativo sperimentale dimostrativo Valutazione di protocolli di utilizzo dei microrganismi in enologia per la riduzione dei consumi energetici nei processi di vinificazione Sperimentazione 2013 Villa
Applicativo sperimentale dimostrativo Valutazione di protocolli di utilizzo dei microrganismi in enologia per la riduzione dei consumi energetici nei processi di vinificazione Sperimentazione 2013 Villa
Vinificazione in rosso e bianco
 Trasformazione dei Prodotti Vinificazione in rosso e bianco Acquisire le basi teoriche per il controllo qualitativo del processo di vinificazione Conoscere i fenomeni che caratterizzano le trasformazioni
Trasformazione dei Prodotti Vinificazione in rosso e bianco Acquisire le basi teoriche per il controllo qualitativo del processo di vinificazione Conoscere i fenomeni che caratterizzano le trasformazioni
VINIFICAZIONE SPONTANEA: ASPETTI MICROBIOLOGICI
 VINIFICAZIONE SPONTANEA: ASPETTI MICROBIOLOGICI uve sane e mature presentano molte specie di lieviti (alcune a metabolismo ossidativo, altre anche fermentativo) Lieviti non-saccharomyces Hanseniaspora
VINIFICAZIONE SPONTANEA: ASPETTI MICROBIOLOGICI uve sane e mature presentano molte specie di lieviti (alcune a metabolismo ossidativo, altre anche fermentativo) Lieviti non-saccharomyces Hanseniaspora
SAFE - SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI ED AMBIENTALI
 Programma di insegnamento per l anno accademico 2013/2014 Programma dell insegnamento di: MICROBIOLOGIA DELLE BEVANDE FERMENTATE (italiano) Course title: Microbiology of fermented beverages (inglese) Corso/i
Programma di insegnamento per l anno accademico 2013/2014 Programma dell insegnamento di: MICROBIOLOGIA DELLE BEVANDE FERMENTATE (italiano) Course title: Microbiology of fermented beverages (inglese) Corso/i
INNOWINE UR 1 UR 2 : UR 3 : AgriFood Innovation Day Bari, 26 0ttobre 2012
 INNOWINE UR 1: Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA) UR 2: Istituto per la Microelettronica e i Microsistemi (IMM) UR 3: Istituto di Fisiologia Clinica (IFC) Imprese Partecipanti 1) Cantina
INNOWINE UR 1: Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA) UR 2: Istituto per la Microelettronica e i Microsistemi (IMM) UR 3: Istituto di Fisiologia Clinica (IFC) Imprese Partecipanti 1) Cantina
Selezionato in collaborazione con. Più acidità, più equilibrio!
 In LI no EV Va ITO TI VO Selezionato in collaborazione con Più acidità, più equilibrio! 1 L acidità nel vino Sebbene acidità totale e ph siano in parte correlati, questi due parametri hanno una valenza
In LI no EV Va ITO TI VO Selezionato in collaborazione con Più acidità, più equilibrio! 1 L acidità nel vino Sebbene acidità totale e ph siano in parte correlati, questi due parametri hanno una valenza
Controllo della evoluzione delle popolazioni microbiche con attività di monitoraggio in linea
 Consorzio Tuscania - Del. CIPE 35/2004-Relazione scientifica 2008-2010 Controllo della evoluzione delle popolazioni microbiche con attività di monitoraggio in linea Granchi L., Bronzini M., Lupi M., Collina
Consorzio Tuscania - Del. CIPE 35/2004-Relazione scientifica 2008-2010 Controllo della evoluzione delle popolazioni microbiche con attività di monitoraggio in linea Granchi L., Bronzini M., Lupi M., Collina
Tecniche enologiche volte a favorire la fermentazione malolattica nei vini rossi
 Tecniche enologiche volte a favorire la fermentazione malolattica nei vini rossi Fabrizio Torchio Università Cattolica Sacro Cuore Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali Il consumatore oggi
Tecniche enologiche volte a favorire la fermentazione malolattica nei vini rossi Fabrizio Torchio Università Cattolica Sacro Cuore Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali Il consumatore oggi
PRODUZIONE DI SOLFITI DA PARTE DEL LIEVITO
 WERNER ET AL., PREODUZIONE DI SOLFITI DA PARTE DEL LIEVITO, PAG. 1 PRODUZIONE DI SOLFITI DA PARTE DEL LIEVITO Maik WERNER 1, Doris RAUHUT 1, Philippe COTTEREAU 2 1 State Research Institute Geisenheim,
WERNER ET AL., PREODUZIONE DI SOLFITI DA PARTE DEL LIEVITO, PAG. 1 PRODUZIONE DI SOLFITI DA PARTE DEL LIEVITO Maik WERNER 1, Doris RAUHUT 1, Philippe COTTEREAU 2 1 State Research Institute Geisenheim,
Analisi degli zuccheri del vino nella vinificazione Dr. Simone Bellassai Enologo e CDR WineLab specialist
 Analisi degli zuccheri del vino nella vinificazione Dr. Simone Bellassai Enologo e CDR WineLab specialist Quali sono i metodi normalmente usati per l analisi degli zuccheri del vino? Quali sono le loro
Analisi degli zuccheri del vino nella vinificazione Dr. Simone Bellassai Enologo e CDR WineLab specialist Quali sono i metodi normalmente usati per l analisi degli zuccheri del vino? Quali sono le loro
CHIRIOTTI EDITORI OTTOBRE 2002 ANNO 31 - N. 181 ISSN N. 5 - BIMESTRALE SPED. ABB. POST. -45% - ART. 2 COMMA 20/B LEGGE 662/96 - TORINO I.P.
 OTTOBRE 2002 ANNO 31 - N. 181 ISSN 0390-0541 N. 5 - BIMESTRALE SPED. ABB. POST. -45% - ART. 2 COMMA 20/B LEGGE 662/96 - TORINO I.P. CHIRIOTTI EDITORI 10064 PINEROLO - Tel. 0121 393127 - Fax 0121 794480
OTTOBRE 2002 ANNO 31 - N. 181 ISSN 0390-0541 N. 5 - BIMESTRALE SPED. ABB. POST. -45% - ART. 2 COMMA 20/B LEGGE 662/96 - TORINO I.P. CHIRIOTTI EDITORI 10064 PINEROLO - Tel. 0121 393127 - Fax 0121 794480
Innovazione nella vinificazione delle uve appassite/disidratate
 Viticoltura-Enologia Lab. Velletri Innovazione nella vinificazione delle uve appassite/disidratate Domenico Tiberi Scansano 22/11/17 26/11/2017 1 Viticoltura-Enologia Lab. Velletri 26/11/2017 2 VINI SPECIALI
Viticoltura-Enologia Lab. Velletri Innovazione nella vinificazione delle uve appassite/disidratate Domenico Tiberi Scansano 22/11/17 26/11/2017 1 Viticoltura-Enologia Lab. Velletri 26/11/2017 2 VINI SPECIALI
Metodi per il controllo microbiologico dei mosti e dei vini in assenza di anidride solforosa
 Convegno tecnico: LA RIDUZIONE DEI SOLFITI NEI VINI COME GRANDE OPPORTUNITÀ DI MERCATO Metodi per il controllo microbiologico dei mosti e dei vini in assenza di anidride solforosa SANDRA TORRIANI Dipartimento
Convegno tecnico: LA RIDUZIONE DEI SOLFITI NEI VINI COME GRANDE OPPORTUNITÀ DI MERCATO Metodi per il controllo microbiologico dei mosti e dei vini in assenza di anidride solforosa SANDRA TORRIANI Dipartimento
Innovazione nel controllo di qualità del processo in laboratorio
 Innovazione nel controllo di qualità del processo in laboratorio Franco Battistutta Dipartimento di Scienze degli alimenti Università degli studi di Udine INFORMAZIONE TECNOLOGICA Acquisizione dell informazione
Innovazione nel controllo di qualità del processo in laboratorio Franco Battistutta Dipartimento di Scienze degli alimenti Università degli studi di Udine INFORMAZIONE TECNOLOGICA Acquisizione dell informazione
Certificazione Genetica del Vino di Origine Siciliana
 Certificazione Genetica del Vino di Origine Siciliana Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2007/2013 Misura 124 Descrizione dei protocolli di certificazione genetica, microbiologica e biogeochimica 07/05/2014
Certificazione Genetica del Vino di Origine Siciliana Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2007/2013 Misura 124 Descrizione dei protocolli di certificazione genetica, microbiologica e biogeochimica 07/05/2014
Fermentazione di uve appassite della varietà Corvina ad alta concentrazione zuccherina
 STUDI PRELIMINARI Fermentazione di uve appassite della varietà Corvina ad alta concentrazione zuccherina È stata valutata la cinetica di fermentazione impiegando un lievito commerciale, ibrido naturale
STUDI PRELIMINARI Fermentazione di uve appassite della varietà Corvina ad alta concentrazione zuccherina È stata valutata la cinetica di fermentazione impiegando un lievito commerciale, ibrido naturale
Test tecnico per culture starter di batteri lattici 2012
 Test tecnico per culture starter di batteri lattici 2012 Il presente rapporto contiene l esame tecnico per culture STARTER di batteri lattici per la fermentazione malolattica. Lo scopo non è quello di
Test tecnico per culture starter di batteri lattici 2012 Il presente rapporto contiene l esame tecnico per culture STARTER di batteri lattici per la fermentazione malolattica. Lo scopo non è quello di
Sperimentazione in scala di cantina presso azienda Capodarco (Grottaferrata- Roma)
 Sperimentazione in scala di cantina presso azienda Capodarco (Grottaferrata- Roma) Prof. Marco Esti Dipartimento per l Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) Università dellatuscia
Sperimentazione in scala di cantina presso azienda Capodarco (Grottaferrata- Roma) Prof. Marco Esti Dipartimento per l Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) Università dellatuscia
Ricerca condotta dalla Mendel Universityin Brno (Rep. Ceca) Stabilità microbiologica di diversi prodotti a base di Aloe.
 Ricerca condotta dalla Mendel Universityin Brno (Rep. Ceca) Stabilità microbiologica di diversi prodotti a base di Aloe. 1. Analisi microbiologica dei prodotti fatti con Aloe in 47 giorni Metodologia Tre
Ricerca condotta dalla Mendel Universityin Brno (Rep. Ceca) Stabilità microbiologica di diversi prodotti a base di Aloe. 1. Analisi microbiologica dei prodotti fatti con Aloe in 47 giorni Metodologia Tre
Realtà vitivinicola regionale
 Realtà vitivinicola regionale Regione Emilia Romagna nella storia raro crocevia di flussi genetici domesticazione della Vitis vinifera spp. silvestris da parte polazioni paleo liguri del tardo neolitico
Realtà vitivinicola regionale Regione Emilia Romagna nella storia raro crocevia di flussi genetici domesticazione della Vitis vinifera spp. silvestris da parte polazioni paleo liguri del tardo neolitico
Dr. Giacomo Buscioni e Dr.ssa. Silvia Mangani FoodMicroTeam SRL Spinoff accademico dell Università degli Studi di Firenze
 Filiera corta produttori fra Arno e Sieve Produzione in cantina di lieviti starter autoctoni VICASTART PROGETTO SOTTOMISURA 16.2 PSR 2014-2020 della Regione Toscana «Individuazione di un protocollo per
Filiera corta produttori fra Arno e Sieve Produzione in cantina di lieviti starter autoctoni VICASTART PROGETTO SOTTOMISURA 16.2 PSR 2014-2020 della Regione Toscana «Individuazione di un protocollo per
INFORMAZIONE CONFIDENZIALE. La riproduzione e la diffusione del documento è vietata senza approvazione scritta da parte di Lallemand Inc.
 Storia della selezione Produttori e distributori europei Sede centrale a Rolle, Svizzera Produzione totale: 96 milioni di bottiglie Più di 300 marchi registrati 440 Ha di vigneto in Europa Top 6 mercati:
Storia della selezione Produttori e distributori europei Sede centrale a Rolle, Svizzera Produzione totale: 96 milioni di bottiglie Più di 300 marchi registrati 440 Ha di vigneto in Europa Top 6 mercati:
L industria alimentare: le bevande
 L industria alimentare: le bevande Le bevande sono moltissime e di diversa provenienza. Esistono bevande analcoliche e bevande alcoliche a seconda che siano prive di alcol (acqua,birra ecc.). L acqua potabile
L industria alimentare: le bevande Le bevande sono moltissime e di diversa provenienza. Esistono bevande analcoliche e bevande alcoliche a seconda che siano prive di alcol (acqua,birra ecc.). L acqua potabile
movia vitigni autoctoni Tocai Friulano Sauvignon Merlot Pinot Nero Chardonnay vendemmia manualità macerazione
 21 ha - 100.000 bt primorski slovenia movia Mirko & Aleš Kristancic a Dobrovo 1820 peschi tradizionale Brda zac zac ciliegi humus collina vini del protocollo vigneron giardiniere albicocche vitigni autoctoni
21 ha - 100.000 bt primorski slovenia movia Mirko & Aleš Kristancic a Dobrovo 1820 peschi tradizionale Brda zac zac ciliegi humus collina vini del protocollo vigneron giardiniere albicocche vitigni autoctoni
CURRICULUM VITAE del Dott. Giacomo BUSCIONI
 CURRICULUM VITAE del Dott. Giacomo BUSCIONI Informazioni anagrafiche Nato a Pistoia il 22 Agosto 1968 Residente a Pistoia, via Ponte dei Tesi n 1 51030 Canapale Telefono: mobile 3476749727; abitazione
CURRICULUM VITAE del Dott. Giacomo BUSCIONI Informazioni anagrafiche Nato a Pistoia il 22 Agosto 1968 Residente a Pistoia, via Ponte dei Tesi n 1 51030 Canapale Telefono: mobile 3476749727; abitazione
TOSI ET AL., IMPIEGO DI UN LIEVITO IBRIDO NATURALE NELLA FERMENTAZIONE DELL AMARONE, PAG. 1
 TOSI ET AL., IMPIEGO DI UN LIEVITO IBRIDO NATURALE NELLA FERMENTAZIONE DELL AMARONE, PAG. 1 I LIEVITI IBRIDI IMPIEGATI IN ENOLOGIA: L ESEMPIO DEL CEPPO INDUSTRIALE S6U, IBRIDO NATURALE SACCHAROMYCES CEREVISIAE
TOSI ET AL., IMPIEGO DI UN LIEVITO IBRIDO NATURALE NELLA FERMENTAZIONE DELL AMARONE, PAG. 1 I LIEVITI IBRIDI IMPIEGATI IN ENOLOGIA: L ESEMPIO DEL CEPPO INDUSTRIALE S6U, IBRIDO NATURALE SACCHAROMYCES CEREVISIAE
Affinity ECA5. Un esplosione aromatica per i tuoi vini.
 Un esplosione aromatica per i tuoi vini. Che cos è? è una soluzione innovativa per controllare la fermentazione alcolica e aumentare l espressione aromatica in vini bianchi, rosati e rossi destinati ad
Un esplosione aromatica per i tuoi vini. Che cos è? è una soluzione innovativa per controllare la fermentazione alcolica e aumentare l espressione aromatica in vini bianchi, rosati e rossi destinati ad
Castello di Buttrio è un azienda di antica tradizione vinicola, oggi proprietà di Alessandra Felluga. Al Castello di Buttrio, storia e tradizione
 CASTELLO DI BUTTRIO Castello di Buttrio è un azienda di antica tradizione vinicola, oggi proprietà di Alessandra Felluga. Al Castello di Buttrio, storia e tradizione vitivinicola si intrecciano e sono
CASTELLO DI BUTTRIO Castello di Buttrio è un azienda di antica tradizione vinicola, oggi proprietà di Alessandra Felluga. Al Castello di Buttrio, storia e tradizione vitivinicola si intrecciano e sono
Produzione in cantina di lieviti starter autoctoni (VICASTART) Resoconto del primo anno di attività. (Responsabile scientifico Prof.
 PROGETTO SOTTOMISURA 16.2 PSR 2014-2020 della Regione Toscana TITOLO: Filiera corta produttori fra Arno e Sieve Produzione in cantina di lieviti starter autoctoni (VICASTART) Resoconto del primo anno di
PROGETTO SOTTOMISURA 16.2 PSR 2014-2020 della Regione Toscana TITOLO: Filiera corta produttori fra Arno e Sieve Produzione in cantina di lieviti starter autoctoni (VICASTART) Resoconto del primo anno di
RELAZIONE DEL PROGETTO RECUPERO DEL NIBIO DI TASSAROLO ANNO 2006 A cura dei Tecnici del Centro
 RELAZIONE DEL PROGETTO RECUPERO DEL NIBIO DI TASSAROLO ANNO 2006 A cura dei Tecnici del Centro Introduzione Nell anno 2000 il Centro Sperimentale Vitivinicolo Tenuta Cannona di Carpeneto venne contattato
RELAZIONE DEL PROGETTO RECUPERO DEL NIBIO DI TASSAROLO ANNO 2006 A cura dei Tecnici del Centro Introduzione Nell anno 2000 il Centro Sperimentale Vitivinicolo Tenuta Cannona di Carpeneto venne contattato
Come eliminare o ridurre l impiego della solforosa in vinificazione
 INCONTRO TECNICO Full immersion Dentro al Vino Scoprire come migliorare Vini Bianchi e Spumanti Come eliminare o ridurre l impiego della solforosa in vinificazione Roberto Zironi Università degli Studi
INCONTRO TECNICO Full immersion Dentro al Vino Scoprire come migliorare Vini Bianchi e Spumanti Come eliminare o ridurre l impiego della solforosa in vinificazione Roberto Zironi Università degli Studi
Il Prosecco: un vino di successo ASPETTI TECNICI DELLA NUOVA DOC PROSECCO
 Sesto al Reghena (PN), Sabato 22 Ottobre 2011 Il Prosecco: un vino di successo ASPETTI TECNICI DELLA NUOVA DOC PROSECCO Prof. Roberto Zironi Università degli Studi di Udine Dipartimento di Scienze degli
Sesto al Reghena (PN), Sabato 22 Ottobre 2011 Il Prosecco: un vino di successo ASPETTI TECNICI DELLA NUOVA DOC PROSECCO Prof. Roberto Zironi Università degli Studi di Udine Dipartimento di Scienze degli
I FATTORI DI RIUSCITA DELLA PRESA DI SPUMA
 DELLA PRESA DI SPUMA Dominique LEBOEUF, Œnologue Directeur SOEC La presa di spuma presenta molte similitudini con la fermentazione alcolica. L equazione globale di questa fermentazione è la stessa: C 6
DELLA PRESA DI SPUMA Dominique LEBOEUF, Œnologue Directeur SOEC La presa di spuma presenta molte similitudini con la fermentazione alcolica. L equazione globale di questa fermentazione è la stessa: C 6
Foodmicroteam SRL; Via Santo Spirito 14, FIRENZE
 F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome [BUSCIONI GIACOMO ] Indirizzo Telefono Fax E-mail giacomo@foodmicroteam.it Nazionalità Italiana Data di nascita 22,08,1968 ESPERIENZA
F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome [BUSCIONI GIACOMO ] Indirizzo Telefono Fax E-mail giacomo@foodmicroteam.it Nazionalità Italiana Data di nascita 22,08,1968 ESPERIENZA
IMPORTANZA DEL MOMENTO DI INOCULO NELLA FERMENTAZIONE MALOLATTICA DI RABOSO PIAVE
 DOCUMENTO TECNICO Viviana Corich Milena Carlot Nicola Giusti Paola Vagnoli Alessio Giacomini Facoltà di Agraria - Università di Padova - Sede di Conegliano (TV) Da sinistra: M. Carlot, A. Giacomini, P.
DOCUMENTO TECNICO Viviana Corich Milena Carlot Nicola Giusti Paola Vagnoli Alessio Giacomini Facoltà di Agraria - Università di Padova - Sede di Conegliano (TV) Da sinistra: M. Carlot, A. Giacomini, P.
Il lisozima è un agente antimicrobico
 ECNICA T ABBATTERE LA MICROFLORA LATTICA SPONTANEA NEL MOSTO E NEL VINO Il lisozima ritarda nei rossi e blocca nei bianchi la malolattica I risultati hanno evidenziato la diversa efficienza del lisozima
ECNICA T ABBATTERE LA MICROFLORA LATTICA SPONTANEA NEL MOSTO E NEL VINO Il lisozima ritarda nei rossi e blocca nei bianchi la malolattica I risultati hanno evidenziato la diversa efficienza del lisozima
Il Grigio Chianti Classico Riserva Docg
 Il Grigio CARATTERISTICHE ANNATA L annata 2015 sarà ricordata come una delle più calde degli ultimi anni; ad un inverno e una primavera miti e con piogge regolari, è succeduta un estate calda e avara di
Il Grigio CARATTERISTICHE ANNATA L annata 2015 sarà ricordata come una delle più calde degli ultimi anni; ad un inverno e una primavera miti e con piogge regolari, è succeduta un estate calda e avara di
Enologia Biodinamica, etica, eco-compatibile. compatibile Corso Apab
 Enologia Biodinamica, etica, eco-compatibile compatibile Corso Apab www.apab.it Filippo Ferrari & Cristian Giorni www.vinietici.it vinietici@gmail.com CODICE DI BUONE PRATICHE PER LA VITICOLTURA E L'ENOLOGIA
Enologia Biodinamica, etica, eco-compatibile compatibile Corso Apab www.apab.it Filippo Ferrari & Cristian Giorni www.vinietici.it vinietici@gmail.com CODICE DI BUONE PRATICHE PER LA VITICOLTURA E L'ENOLOGIA
Progetto Barbera 2.0:
 Progetto Barbera 2.0: Caratteristiche dei vini commerciali Caratterizzazione delle potenzialità enologiche Simone Giacosa, Susana Río Segade, Luca Rolle, Vincenzo Gerbi Università degli Studi di Torino
Progetto Barbera 2.0: Caratteristiche dei vini commerciali Caratterizzazione delle potenzialità enologiche Simone Giacosa, Susana Río Segade, Luca Rolle, Vincenzo Gerbi Università degli Studi di Torino
Indicazione Geografica Tipica
 GRADAZIONE ALCOLICA 13% Vol. Veneto - Colli Pinot Nero Indicazione Geografica Tipica Macerazione del pigiato con piccola percentuale di uva intera per 12 giorni. Rimontaggi frequenti nei primi giorni di
GRADAZIONE ALCOLICA 13% Vol. Veneto - Colli Pinot Nero Indicazione Geografica Tipica Macerazione del pigiato con piccola percentuale di uva intera per 12 giorni. Rimontaggi frequenti nei primi giorni di
BOMBINO PUGLIA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
 BOMBINO Uve: Bombino 100% Estensione vigneto: 4.8 ha Tipo di impianto: Pergola garganica e nuovi impianti ad alberello Densità ceppi per ettaro: pergola: 2500, alberello: 5000 Produzione per ettaro: 80/90
BOMBINO Uve: Bombino 100% Estensione vigneto: 4.8 ha Tipo di impianto: Pergola garganica e nuovi impianti ad alberello Densità ceppi per ettaro: pergola: 2500, alberello: 5000 Produzione per ettaro: 80/90
Il ruolo del lievito Saccharomyces cerevisiae nella produzione di alcuni vini da dessert della Sardegna
 VINI DA DESSERT: dalla vigna al bicchiere ORISTANO 19 giugno 2007 Il ruolo del lievito Saccharomyces cerevisiae nella produzione di alcuni vini da dessert della Sardegna Marilena Budroni, Giovanni Antonio
VINI DA DESSERT: dalla vigna al bicchiere ORISTANO 19 giugno 2007 Il ruolo del lievito Saccharomyces cerevisiae nella produzione di alcuni vini da dessert della Sardegna Marilena Budroni, Giovanni Antonio
Agricoltura. Studio dei lieviti Saccharomyces nei vini della Valtellina
 Agricoltura Studio dei lieviti Saccharomyces nei vini della Valtellina QUADERNI DELLA RICERCA N 55 GIUGNO 2006 1 INDICE PRESENTAZIONE (V.Beccalossi) 3 PREMESSA 4 I LIEVITI 5 Lieviti autoctoni e tipicità
Agricoltura Studio dei lieviti Saccharomyces nei vini della Valtellina QUADERNI DELLA RICERCA N 55 GIUGNO 2006 1 INDICE PRESENTAZIONE (V.Beccalossi) 3 PREMESSA 4 I LIEVITI 5 Lieviti autoctoni e tipicità
EFFETTI DELLA VINIFICAZIONE A GRADIENTE SULLE CARATTERISTICHE ENOLOGICHE DI VINI DI NERO DI TROIA IN PUGLIA
 EFFETTI DELLA VINIFICAZIONE A GRADIENTE SULLE CARATTERISTICHE ENOLOGICHE DI VINI DI NERO DI TROIA IN PUGLIA EFFECTS OF GRADIENT VINIFICATION ON WINE NERO DI TROIA Savino M., Suriano S., Mazzone F., Nobile
EFFETTI DELLA VINIFICAZIONE A GRADIENTE SULLE CARATTERISTICHE ENOLOGICHE DI VINI DI NERO DI TROIA IN PUGLIA EFFECTS OF GRADIENT VINIFICATION ON WINE NERO DI TROIA Savino M., Suriano S., Mazzone F., Nobile
LA CAPACITÀ DEI LIEVITI ENOLOGICI DI ASSIMILARE GLUCOSIO E FRUTTOSIO IN MODO SELETTIVO. Introduzione DOCUMENTO AZIENDALE
 DOCUMENTO AZIENDALE *Ann Dumont **Paola Vagnoli **Junio-Francesco Lo Paro ***Céline Raynal ***Françoise Raginel ***Anne Ortiz-Julien * Lallemand Division Oenologie Montréal QC (Canada) ** Lallemand Italia
DOCUMENTO AZIENDALE *Ann Dumont **Paola Vagnoli **Junio-Francesco Lo Paro ***Céline Raynal ***Françoise Raginel ***Anne Ortiz-Julien * Lallemand Division Oenologie Montréal QC (Canada) ** Lallemand Italia
Premessa. Stefano Ferrari ISVEA srl
 Lieviti autoctoni: obiettivi del loro impiego, metodi di isolamento e selezione Premessa Nel corso degli ultimi decenni, la consapevolezza sempre maggiore e diffusa dei fenomeni connessi con la produzione
Lieviti autoctoni: obiettivi del loro impiego, metodi di isolamento e selezione Premessa Nel corso degli ultimi decenni, la consapevolezza sempre maggiore e diffusa dei fenomeni connessi con la produzione
Interdepartmental Research Centre for Innovation in Viticulture and Oenology
 La biodiversità microbica Che cosa è? Come si genera? Come si valuta, misura? Come si può sfruttare? Che cosa è? fermentazione alcolica respirazione aerobia fotosintesi separazione Eukarya-Archea separazione
La biodiversità microbica Che cosa è? Come si genera? Come si valuta, misura? Come si può sfruttare? Che cosa è? fermentazione alcolica respirazione aerobia fotosintesi separazione Eukarya-Archea separazione
La personalità di un vino nasce sempre dalla terra, dal sole e dall aria: non è qualcosa che si può costruire.
 La personalità di un vino nasce sempre dalla terra, dal sole e dall aria: non è qualcosa che si può costruire. E con questa filosofia, dall amore per la natura e dal lavoro quotidiano che Ivana Adami ed
La personalità di un vino nasce sempre dalla terra, dal sole e dall aria: non è qualcosa che si può costruire. E con questa filosofia, dall amore per la natura e dal lavoro quotidiano che Ivana Adami ed
Schede di autocertificazione dei vini
 IL VINO Umbria Grechetto Annata: 2016 La viticoltura Nome vigneto/i: Le Pretelle Suolo: di medio impasto, ricco di scheletro Esposizione dei filari: nord-est Altitudine: 220 Vitigno/i: Grechetto Portainnesto/i:
IL VINO Umbria Grechetto Annata: 2016 La viticoltura Nome vigneto/i: Le Pretelle Suolo: di medio impasto, ricco di scheletro Esposizione dei filari: nord-est Altitudine: 220 Vitigno/i: Grechetto Portainnesto/i:
Azoto prontamente assimilabile e gestione della nutrizione nella fermentazione alcolica
 A Quality Selection For You Azoto prontamente assimilabile e gestione della nutrizione nella fermentazione alcolica Christian Scrinzi Coordinamento enologico Gruppo Italiano Vini Elaborazione dei dati
A Quality Selection For You Azoto prontamente assimilabile e gestione della nutrizione nella fermentazione alcolica Christian Scrinzi Coordinamento enologico Gruppo Italiano Vini Elaborazione dei dati
Introduzione. Materiali e metodi
 BOVO ET AL., VALUTAZIONE LIEVITO AUTOCTONO PER AMARONE, PAG. 1 VALUTAZIONE TECNOLOGICA DEL LIEVITO AUTOCTONO SACCHAROMYCES UVARUM VP2 SELEZIONATO PER LA PRODUZIONE DI VINO AMARONE, IN COMPARAZIONE AD ALTRI
BOVO ET AL., VALUTAZIONE LIEVITO AUTOCTONO PER AMARONE, PAG. 1 VALUTAZIONE TECNOLOGICA DEL LIEVITO AUTOCTONO SACCHAROMYCES UVARUM VP2 SELEZIONATO PER LA PRODUZIONE DI VINO AMARONE, IN COMPARAZIONE AD ALTRI
PROGETTAZIONE ANNUALE PER COMPETENZE Classe V Trasformazione dei prodotti
 ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA AGRARIA Mario Rigoni Stern Bergamo PROGETTAZIONE ANNUALE PER COMPETENZE Classe V Trasformazione dei prodotti articolazione: Gestione dell ambiente e del territorio
ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA AGRARIA Mario Rigoni Stern Bergamo PROGETTAZIONE ANNUALE PER COMPETENZE Classe V Trasformazione dei prodotti articolazione: Gestione dell ambiente e del territorio
L ENOLOGO NOVEMBRE 2008
 DOCUMENTO TECNICO *Emanuele Tosi *Michela Azzolini **Giacomo Zapparoli *Centro per la Sperimentazione in Vitivinicoltura, Provincia di Verona, Servizio Agricoltura, San Floriano (VR) **Dipartimento Scientifico
DOCUMENTO TECNICO *Emanuele Tosi *Michela Azzolini **Giacomo Zapparoli *Centro per la Sperimentazione in Vitivinicoltura, Provincia di Verona, Servizio Agricoltura, San Floriano (VR) **Dipartimento Scientifico
Campo Bargello. Marco Querci e Marta Matteini Querci, proprietari di Campo Bargello
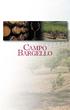 CAMPO BARGELLO Campo Bargello Situata nel cuore della Maremma Toscana, in località Fontino, comune di Massa Marittima, a 150 metri di altitudine, l Azienda Agricola Campo Bargello nasce nel 2000 da un
CAMPO BARGELLO Campo Bargello Situata nel cuore della Maremma Toscana, in località Fontino, comune di Massa Marittima, a 150 metri di altitudine, l Azienda Agricola Campo Bargello nasce nel 2000 da un
I lieviti autoctoni: selezione e impiego. in enologia. Lisa Granchi. Lisa Granchi. Sezione Scienze e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche
 Lisa Granchi Sezione Scienze e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche e-mail: lisa.granchi@unifi.it I lieviti autoctoni: selezione e impiego Lisa Granchi in enologia Montepaldi, 5 luglio 2018 Lieviti
Lisa Granchi Sezione Scienze e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche e-mail: lisa.granchi@unifi.it I lieviti autoctoni: selezione e impiego Lisa Granchi in enologia Montepaldi, 5 luglio 2018 Lieviti
Loc. Nassar 37, Pedemonte (VR), Italy (2) Fondazione Edmund Mach - Istituto Agrario di S. Michele.Centro Sperimentale
 IL PROCESSO DI REIDRATAZIONE COME PRIMO STRUMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL LIEVITO. E. Bocca (1), A. Cavazza (2), R. Ferrarini (3), (1) Enologica Vason s.r.l. Loc. Nassar 37, 37029 Pedemonte (VR), Italy
IL PROCESSO DI REIDRATAZIONE COME PRIMO STRUMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL LIEVITO. E. Bocca (1), A. Cavazza (2), R. Ferrarini (3), (1) Enologica Vason s.r.l. Loc. Nassar 37, 37029 Pedemonte (VR), Italy
ATTIVANTI DI FERMENTAZIONE DIVERSIFICARE LA STRATEGIA NUTRIZIONALE FRUTTA
 ATTIVANTI DI FERMENTAZIONE DIVERSIFICARE LA STRATEGIA NUTRIZIONALE FRUTTA MYCOSTART IN CONTROTENDENZA NELLA RIATTIVAZIONE DEI LIEVITI STIMOLA LA MOLTIPLICAZIONE CELLULARE CON TASSO DI CRESCITA OTTIMALE
ATTIVANTI DI FERMENTAZIONE DIVERSIFICARE LA STRATEGIA NUTRIZIONALE FRUTTA MYCOSTART IN CONTROTENDENZA NELLA RIATTIVAZIONE DEI LIEVITI STIMOLA LA MOLTIPLICAZIONE CELLULARE CON TASSO DI CRESCITA OTTIMALE
