Capitolo 21 La teoria del federalismo fiscale
|
|
|
- Damiano Savino
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Capitolo 21 La teoria del federalismo fiscale
2 I rapporti tra i diversi livelli di governo sono un aspetto fondamentale dell organizzazione del settore pubblico, e riguardano sia le competenze e le spese gestite da ciascun livello sia le modalità di finanziamento. In questo capitolo presenteremo la teoria tradizionale del federalismo fiscale e accenneremo ad alcuni dei contributi più recenti, spesso definiti la teoria del federalismo fiscale di seconda generazione.
3 Le questioni più rilevanti analizzate dalla branca della finanza pubblica denominata teoria del federalismo fiscale sono le seguenti: 1. Come allocare le responsabilità ai diversi livelli di governo? 2. La decentralizzazione delle decisioni governative è auspicabile? 3. Le imposte riscosse a livello locale rappresentano una buona soluzione per il pagamento dei servizi offerti dalle Amministrazioni locali? In quali circostanze i fondi dovrebbero arrivare dal Governo centrale?
4 Il rapporto di accentramento In generale si può dire che un sistema è più accentrato rispetto a un altro quando una quota maggiore dei suoi poteri decisionali è nelle mani dei livelli di governo sovraordinati. Il criterio più diffuso per misurare il livello di accentramento di un Paese è il rapporto di accentramento, ossia la proporzione delle spese dirette complessive effettuate dal Governo centrale. I rapporti di accentramento variano notevolmente a seconda degli Stati e non necessariamente sono maggiori per quelli che hanno una forma di Stato federale.
5
6 Teoria tradizionale vs. seconda generazione La teoria tradizionale del federalismo fiscale è un approccio normativo connotato dall idea che esista un Governo benevolente. La seconda generazione della teoria del federalismo fiscale assume, invece, che politici e burocrati abbiano obiettivi propri, che ne influenzano significativamente l azione di governo.
7 Teoria tradizionale vs. seconda generazione Secondo l approccio tradizionale, il vantaggio principale di un assetto decentrato sta nel guadagno in termini di efficienza consentito dal decentramento della funzione allocativa. Al Governo centrale si riconosce una maggiore efficacia nello svolgimento delle funzioni di ridistribuzione e di stabilizzazione macroeconomica (Musgrave,1959).
8 Teoria tradizionale vs. seconda generazione Il nucleo centrale della teoria tradizionale del federalismo fiscale è il teorema del decentramento di Oates (1972), che fornisce una giustificazione teorica all esistenza di diversi livelli di governo. Il problema delle competenze e dell estensione territoriale degli Enti è invece affrontato facendo ricorso ad alcune prescrizioni elaborate da Buchanan, nell ambito della teoria dei club (1965). Il collegamento tra il voto come strumento per l espressione delle preferenze e la fornitura di beni e servizi pubblici locali è stabilito dall idea del voto con i piedi, formulata da Tiebout (1956) a integrazione delle riflessioni di Samuelson ( ) nell ambito della teoria dei beni pubblici.
9 Il teorema del decentramento di Oates Il teorema di Oates stabilisce che, con preferenze differenziate, è sempre preferibile una soluzione decentrata. Infatti, poiché la fornitura pubblica di un bene o servizio comporta una perdita secca, dovuta alla distanza tra le preferenze individuali e il livello offerto, la soluzione decentrata, variando l offerta pubblica, permette di ridurre questa perdita di benessere.
10 Il teorema del decentramento di Oates
11 Il teorema del decentramento di Oates Il guadagno di efficienza è tanto maggiore quanto più sono omogenee le preferenze all interno di una collettività e non vi sarebbe vantaggio alcuno se le preferenze dell intera comunità nazionale non fossero diversificate territorialmente.
12 Il teorema del decentramento di Oates I limiti più rilevanti di questo teorema sono evidenti dalle ipotesi necessarie affinché sia valido: 1. Oates assume che il costo marginale di offerta del bene locale sia costante (MC è una retta orizzontale), ossia che nella fornitura non vi siano economie di scala; se così non è, la soluzione decentrata potrebbe non essere necessariamente quella più efficiente; 2. la perfetta corrispondenza tra giurisdizione economica e giurisdizione politica è difficilmente riscontrabile nella realtà. Proprio a partire da questo limite della teoria tradizionale, è stata avanzata la teoria del federalismo funzionale (Casella e Frey 1992; Eichenberger e Frey 2002), secondo la quale ciascun ente deve essere responsabile di un unica funzione e deve esserlo solo rispetto ai cittadini che beneficiano del servizio.
13 La teoria dei club Nella teoria tradizionale l analisi sulle dimensioni delle collettività locali e sul livello di servizio che queste dovrebbero fornire è stata condotta utilizzando il concetto di club, che per altro si addice meglio all idea del federalismo funzionale che non a quello di una collettività che fornisce una pluralità di servizi.
14 La teoria dei club 1. Omogeneità dei gusti all interno della comunità locale 2. Costi di esclusione nulli 3. Costi di gestione nulli 4. Variabili da determinare: 1. Dimensione dell ente (N=partecipanti) 2. Livello del servizio (Q) Rosen, Gayer, Scienza delle finanze 4e Copyright 2014 McGraw-Hill Education s.r.l.
15 La teoria dei club Dimensioni dell ente, Q fisso Asse x: Numero di partecipanti al club Asse y: C e B Curva A Benefici I costi procapite sono decrescenti (diluizione dei costi su più soggetti) Curva B Costi Costi di congestione nella fruizione del bene pubblico
16 La teoria dei club Livello del servizio, N fisso Asse x: livello del servizio Q Asse y: C e B Curva D Domanda Utilità marginale decrescente Curva M Offerta Costi marginali crescenti dovuti all impegno addizionale di terra
17 La teoria dei club
18 La teoria dei club Problemi aperti 1. Come finanziare i beni pubblici? 2. Come risolvere il problema del free rider quando l esclusione non è praticabile? 3. La distribuzione dei beni pubblici è efficiente in presenza di diversi club differenziati?
19 Il modello di Tiebout 1. In determinate circostanze i mercati falliscono, non riuscendo a offrire i cosiddetti beni pubblici in modo efficiente perché il mercato non incentiva gli individui a rivelare le loro vere preferenze, incoraggiando tutti a comportarsi da free rider. 2. Tiebout (1956): la possibilità di spostamento degli individui tra diverse collettività locali può essere una soluzione simile a quella di mercato anche per i beni pubblici locali. 3. Sotto determinate condizioni, individui perfettamente razionali dovrebbero stabilirsi nella collettività locale che offre la combinazione di servizi e imposte pubbliche che essi gradiscono di più.
20 Il modello di Tiebout: le assunzioni 1. Esiste una categoria di beni pubblici, detti appunto beni pubblici locali, i cui benefici sono strettamente limitati a una data collettività. 2. Gli individui sono completamente liberi di spostarsi a costo zero. 3. Le persone dispongono di informazioni perfette relativamente ai servizi e alle imposte pubbliche di ciascuna collettività locale. 4. Esiste una certa differenziazione tra le collettività locali e ciascun individuo può trovarne una con servizi pubblici che soddisfano le sue esigenze. 5. Il costo per unità dei servizi pubblici è costante. 6. La tecnologia dell offerta del servizio pubblico è tale per cui, se raddoppia il numero di residenti, raddoppia anche la quantità di servizi pubblici offerta (rendimenti di scala costanti)
21 Il modello di Tiebout 1.Il modello di Tiebout non è una descrizione fedele di come funziona il mondo (le persone non sono perfettamente mobili, non vi sono abbastanza collettività locali perché ciascuno trovi quella per lui migliore ecc.). 2.Inoltre, contrariamente alle implicazioni del modello, si possono osservare molte collettività locali all interno delle quali vi sono differenze di reddito rilevanti e quindi, presumibilmente, differenze nei livelli desiderati di offerta di pubblico servizio. 3.Detto questo, il modello di Tiebout è uno schema di riferimento utile per studiare la gestione dei servizi e il loro finanziamento nelle grandi aree metropolitane, nelle quali esiste un ampia gamma di scelte relativamente alla localizzazione della residenza, e considerevoli differenze di reddito e nei livelli dei servizi.
22 Quali funzioni a quale livello di governo? Qual è la distribuzione ottimale delle funzioni tra i diversi livelli di governo? Concordando con l iniziale contributo di Musgrave (1959), la maggior parte degli economisti condivide l idea che le decisioni di spesa e d imposizione fiscale volte a incidere sui livelli di disoccupazione e inflazione andrebbero prese dal Governo centrale (funzione macroeconomica di stabilizzazione del reddito e dei prezzi). Nessuna Amministrazione regionale o locale è abbastanza grande da influenzare il livello complessivo di attività economica e le esternalità connesse agli interventi di questo tipo li renderebbero inefficaci. Non avrebbe senso che ogni località emettesse una propria moneta e perseguisse una politica monetaria indipendente.
23 Quali funzioni a quale livello di governo? Le argomentazioni sull attribuzione della funzione redistributiva ai Governi locali o a quello centrale sono più articolate. In prima approssimazione si può pensare di assegnarla al Governo centrale sulla base della seguente argomentazione: si supponga che la composizione delle imposte e delle spese in una particolare collettività locale sia favorevole ai suoi membri a basso reddito; se non vi sono barriere al movimento tra le collettività locali, dobbiamo aspettarci una inmigrazione dei meno abbienti dal resto del Paese. L aumento della popolazione meno abbiente determina un analogo incremento nel costo della politica fiscale ridistribuiva; allo stesso tempo, i più abbienti possono decidere di andarsene. Di conseguenza aumentano le esigenze di risorse per la collettività locale mentre diminuisce il livello di base imponibile e il programma ridistribuivo potrebbe essere abbandonato.
24 Quali funzioni a quale livello di governo? Si può inoltre sostenere che il dittatore benevolente, assunto dalla teoria tradizionale del federalismo fiscale, sia depositario di una funzione del benessere sociale, o meglio di un criterio di equità sulla distribuzione delle risorse, condiviso dall intera collettività nazionale, e si teme che un autonomia locale, rispetto a questa categoria di politiche, possa essere di ostacolo o in contraddizione con gli obiettivi definiti dal Governo centrale e come tali largamente condivisi.
25 Quali funzioni a quale livello di governo? 1. Secondo Pauly (1973) è difficile assumere realisticamente che le preferenze dei cittadini, diversificate territorialmente rispetto alla fornitura di beni e servizi pubblici, non lo siano anche per quanto riguarda le politiche tributarie e di ridistribuzione del reddito. 2. Può accadere che una certa collettività nazionale esprima, in un certo momento storico, un giudizio circa un criterio di equità per la ridistribuzione delle risorse, e che questo giudizio sia correttamente interpretato dalla classe politica nazionale. 3. Altrimenti, la valutazione deve essere più articolata, e può includere una diversificazione territoriale delle preferenze e/o l analisi dei meccanismi decisionali con cui classi politiche locali e nazionali contribuiscono alla definizione delle politiche distributive.
26 Quali funzioni a quale livello di governo? Inoltre, considerazioni di tipo equitativo, apparentemente escluse dall analisi nell approccio del federalismo fiscale, spesso sono indispensabili se si considera l impatto ridistributivo di alcuni beni e servizi pubblici locali (come per esempio i servizi sanitari e l istruzione).
27 Quali funzioni a quale livello di governo? 1. Per quanto attiene la funzione allocativa, è opinione largamente condivisa che si debba far riferimento alla distinzione tra beni pubblici puri e beni pubblici locali che abbiamo illustrato sopra. 2. Nei primi rientrano la difesa nazionale, la sicurezza, la politica estera, la giustizia, le grandi infrastrutture di comunicazione, per i quali la responsabilità centrale trova diversi ordini di giustificazioni, tra cui le esternalità, le economie di scala, le ragioni di interesse collettivo, le caratteristiche intrinseche dei beni stessi ecc. 3. Gli altri beni pubblici, tra cui alcuni interventi del welfare state, sembrano essere meglio gestiti dalle collettività locali, per definizione più vicine al cittadino-elettore.
28 La teoria del federalismo fiscale di seconda generazione 1. L elemento che accomuna la seconda generazione della teoria del federalismo fiscale è un analisi più accurata dei meccanismi che regolano le decisioni pubbliche che non sono più scatole nere che assorbono risorse per fornire bene pubblici, ma sono uno degli aspetti che deve essere analizzato per comprendere il funzionamento del settore pubblico. 2. Sotto l influenza della scuola di public choice, lo studio del decentramento fiscale parte dal presupposto che, mentre se i dirigenti di imprese private che non riescono a minimizzare i costi alla fine vengono estromessi dall azienda, nel settore pubblico essi possono continuare a spendere in maniera inefficiente.
29 La teoria del federalismo fiscale di seconda generazione Se i cittadini possono scegliere tra giurisdizioni locali diverse, una gestione significativamente non condivisibile può spingerli a scegliere di vivere altrove; o meglio, questa minaccia può creare incentivi affinché i dirigenti pubblici producano in modo più efficiente e siano più sensibili verso i propri cittadini-elettori.
30 La teoria del federalismo fiscale di seconda generazione 1. In particolare, Brennan e Buchanan (1980) ritengono che il principale pregio di un sistema decentrato sia nella frammentazione del potere, inteso come sfruttamento fiscale di politici e burocrati nei confronti dei cittadini. 2. La presenza di più livelli di governo e di più governi dello stesso livello, associata alla libertà degli individui di spostarsi da una circoscrizione all altra, comportano una forma di competizione tra governi che permette di limitare il potere del Leviatano
31 La teoria del federalismo fiscale di seconda generazione 1. La competizione è il secondo elemento centrale dell approccio che stiamo qui analizzando. 2. Salmon (1987) e Breton (1996) mostrano come il decentramento assicuri una competizione orizzontale (tra governi dello stesso livello) e verticale (tra governi gerarchicamente ordinati) anche qualora gli agenti economici non siano perfettamente mobili, ossia quando i costi di spostamento non siano nulli. 3. Tra l altro, il meccanismo competitivo ipotizzato da questi autori non richiede la mobilità perfetta di tutti gli agenti economici coinvolti dall attività di governo di una data amministrazione, ma semplicemente una corretta informazione circa i risultati raggiunti da amministrazioni comparabili.
32 Il finanziamento delle collettività locali In linea generale il finanziamento delle collettività locali può avvenire tramite: 1. le sovrimposte e le addizionali, denominando così le aliquote che i livelli inferiori di governo stabiliscono sulla base imponibile o sull imposta di un altro livello di governo, normalmente quello centrale; 2. le compartecipazioni, ossia le quote di gettito di imposte di altri livelli di governo assegnate a livelli di governo inferiori; 3. i tributi propri; 4. i trasferimenti tra livelli di governo.
33 Il finanziamento delle collettività locali 1. Nei primi due casi, l autonomia dell Ente locale è piuttosto ristretta e limitata alla definizione dell aliquota: tale autonomia spesso non esiste proprio per le compartecipazioni e per le addizionali è limitata a una forchetta definita dalla legge nazionale. 2. Per i tributi propri, invece, non solo il gettito è interamente, o in gran parte, destinato all Ente periferico, ma questo ha una certa autonomia nel fissare le aliquote. È più difficile che l Ente locale possa autonomamente disciplinare la base imponibile di un tributo. 3. Quando il finanziamento di un Ente periferico è assicurato da trasferimenti di risorse dai livelli superiori, la sua autonomia è pressoché nulla.
34
35 L imposta locale sulla proprietà immobiliare 1. L imposta sulla proprietà immobiliare (terreni e dei fabbricati) è il sistema di finanziamento delle collettività periferiche adottato da quasi tutti i Paesi che hanno una finanza pubblica decentrata. 2. L ammontare dell imposta è determinato dal prodotto dell aliquota per il valore figurativo dell immobile o del terreno, assegnato dall amministrazione. 3. L amministrazione cerca di stabilire una corrispondenza tra il valore figurativo e quello di mercato, ma questa operazione richiede frequenti revisioni.
36 L imposta locale sulla proprietà immobiliare Perché gli Enti locali si finanziano con questo tipo di imposta? 1. Le imposte sulla proprietà immobiliare possono garantire che la base imponibile non venga spostata in altre giurisdizioni. 2. L analisi dell incidenza di questa imposta è argomento piuttosto controverso: nell approccio tradizionale l imposta sulla proprietà è un imposta specifica sui consumi che grava su terreni e fabbricati. 3. L incidenza dell imposta è determinata dall andamento delle curve di domanda e di offerta, rispettivamente dei terreni e dei fabbricati.
37 L imposta locale sulla proprietà immobiliare 1. Per quanto riguarda i terreni, se assumiamo che la quantità offerta sia fissa, ne deriva che la curva di offerta è perfettamente verticale. 2. Un fattore che presenta una curva di offerta di questo tipo sopporta tutto il carico di un eventuale imposta. 3. Poiché sono in quantità fissa, i terreni non possono sfuggire all imposta, come illustra la figura che segue.
38 L imposta locale sulla proprietà immobiliare
39 L imposta locale sulla proprietà immobiliare 1. Per l incidenza dell imposta sulla proprietà dei fabbricati, occorre considerare il mercato nazionale dei capitali. 2. Il capitale può essere utilizzato per scopi diversi: costruzione di immobili, impianti di produzione, progetti del settore pubblico ecc... e, in ogni momento, il capitale ha un certo prezzo che ne condiziona l impiego. 3. Secondo l approccio tradizionale, nel lungo periodo l industria delle costruzioni può ottenere tutto il capitale domandato al prezzo di mercato e quindi la curva di offerta dei fabbricati di lungo periodo è perfettamente orizzontale.
40 L imposta locale sulla proprietà immobiliare
41 L imposta locale sulla proprietà immobiliare 1. Secondo l approccio tradizionale, l imposta sulla proprietà dei terreni ricade sui proprietari degli stessi (o quanto meno sui proprietari nel momento dell introduzione dell imposta), mentre l imposta sui fabbricati viene trasferita sugli acquirenti. 2. Quali sono quindi le implicazioni distributive per quest ultima? 3. La progressività dell imposta sulla proprietà dei fabbricati dipende dal fatto che il reddito da fabbricati aumenta o diminuisce al crescere del reddito. Se diminuisce l imposta è regressiva, e viceversa. Esistono molti studi econometrici che hanno cercato di verificare questa relazione, ma le conclusioni non sono univoche e dipendono, tra le altre variabili, dal tipo di concetto di reddito che si adotta (annuale o permanente?).
42 Trasferimenti tra diversi livelli di governo 1. Le modalità con cui le risorse sono trasferite dal Governo centrale possono influenzare le scelte della collettività locale. 2. In particolare, i trasferimenti possono essere vincolati o non vincolati; per i primi il soggetto erogatore specifica le finalità per le quali l Ente che riceve può utilizzare i fondi. I secondi possono essere impiegati dagli Enti in piena autonomia. 3. I trasferimenti vincolati possono essere compartecipati: per ogni euro trasferito dal Governo centrale per sostenere una particolare attività, l Ente locale deve spendere in quella stessa attività una certa somma di denaro. 4. I trasferimenti compartecipati possono essere a stanziamento definito.
43 Un trasferimento compartecipato
44 Un trasferimento compartecipato a stanziamento determinato
45 Un trasferimento non compartecipato
46 Le modalità di riparto dei trasferimenti perequativi 1. Un obiettivo del Governo centrale è solitamente quello di perequare le risorse a disposizione delle Amministrazioni periferiche se le imposte amministrate a livello locale non sono sufficienti a soddisfare le necessità finanziarie di alcuni. 2. In effetti, la distinzione tra le due possibili finalità dei trasferimenti erariali (a fini di efficienza e di perequazione) difficilmente si manifesta con forme distinte di erogazione monetaria: i trasferimenti dal livello superiore di governo possono essere vincolati o no al finanziamento di una data funzione, per migliorare l allocazione efficiente delle risorse, ma la ripartizione del fondo iscritto nel Bilancio dello Stato può essere guidata da principi perequativi.
47 Le modalità di riparto dei trasferimenti perequativi Semplificando molto rispetto alle soluzioni adottate nella realtà, i possibili criteri di riparto dei trasferimenti erariali sono i seguenti: 1. la spesa storica; 2. pro capite; 3. per perequare la capacità fiscale; 4. per perequare i fabbisogni di spesa.
48 Il criterio della spesa storica Ripartire i trasferimenti erariali secondo il criterio della spesa storica significa assegnare a ciascun Ente una somma proporzionale al livello di spesa sostenuto nell anno precedente o in media in un intervallo ritenuto indicativo. In sostanza, l erogazione va a coprire la differenza tra la spesa sostenuta effettivamente e le entrate proprie dell Ente. Si tratta di una modalità di ripartizione neutrale rispetto alla finalità perequativa.
49 Il criterio della spesa pro-capite Anche il riparto in base alla spesa pro capite è neutrale dal punto di vista della perequazione delle risorse, perché, assegnando a ogni cittadino residente nelle varie giurisdizioni una stessa somma, il Governo centrale non tiene conto né delle risorse proprie degli Enti periferici né delle diverse necessità di spesa, o meglio, tiene conto solo delle differenze imputabili alla popolosità della collettività locale. Il trasferimento può essere illustrato dalla seguente formula: & F # T = $! N i N i % " dove: Ti è l assegnazione all ente i-esimo; F è l ammontare di risorse che lo Stato trasferisce agli enti periferici; N è la popolazione nazionale; Ni è la popolazione della collettività i-esima.
50 Il criterio della capacità fiscale Il criterio della capacità fiscale, invece, è una modalità di ripartizione che tiene conto delle disponibilità delle singole collettività e, dunque, delle sue capacità di finanziamento autonome. L assegnazione in questo caso è così determinata: Ti = ty tyi = t (Y Yi) con: Ti è il trasferimento alla collettività i-esima; t è l aliquota media di riferimento; Yi è la base imponibile della giurisdizione locale; Y è la base imponibile nazionale.
51 Lo sforzo fiscale 1. Il tipo di assegnazione precedentemente illustrato è interamente determinato dalle differenze di basi imponibili e non dalle aliquote applicate dagli Enti locali. 2. Se il Governo centrale volesse premiare lo sforzo fiscale dovrebbe erogare un assegnazione proporzionale all aliquota applicata dall Ente locale e alla differenza tra basi imponibili. 3. La formula precedente dovrebbe essere modificata come segue: T i = t i (Y Y i ) dove t i è l aliquota adottata dall ente periferico.
52 e i fabbisogni 1. Talvolta il Governo centrale può voler tener conto dei differenti bisogni a cui ciascuna collettività deve rispondere: gli Enti locali possono differire anche per la popolazione di riferimento (per esempio perché particolarmente anziana) o per i costi di determinati input (per esempio a causa della conformazione geografica del territorio). 2. Se l obiettivo di chi eroga il trasferimento è colmare le differenze di finanziamento riconducibili a questi elementi, l erogazione dovrebbe essere determinata: TG i = t i (Y ay i ) dove a rappresenta una funzione dei costi e dei fabbisogni della popolazione della collettività
53 L effetto carta moschicida 1. L analisi dell effetto dei trasferimenti effettuata utilizzando le curve di indifferenza che abbiamo condotto finora non considera un aspetto fondamentale: a chi si riferiscono le curve d indifferenza? 2. Sono le preferenze dell elettore mediano e burocrati e politici hanno un ruolo passivo nella realizzazione dei desideri degli elettori? 3. Se sì, una conseguenza diretta della regola dell elettore mediano è che un aumento di un euro nel reddito della collettività locale ha esattamente lo stesso impatto sulla spesa pubblica dell ottenimento di un trasferimento non vincolato dello stesso importo.
54 L effetto carta moschicida Un numero considerevole di studi econometrici sui fattori determinanti della spesa pubblica locale (si veda per tutti Oates 1999) hanno mostrato che un euro ricevuto dalla collettività locale sotto forma di trasferimento provoca un aumento della spesa pubblica superiore all incremento derivante da un analogo incremento nel reddito della collettività locale.
55 L effetto carta moschicida 1. Questo fenomeno è stato soprannominato effetto della carta moschicida e le spiegazioni più accreditate indagano sul processo decisionale pubblico. 2. Filimon, Romer e Rosenthal (1982) sostengono che i burocrati cercano di massimizzare le dimensioni dei loro budget e per questo non sono incentivati a informare i cittadini sul reale livello di trasferimenti a disposizione della collettività locale; nascondendo questa informazione, possono ingannare i cittadini facendoli esprimere a favore di un maggiore livello di spesa di quanto sarebbe avvenuto altrimenti. 3. Secondo questa visione, l effetto della carta moschicida si verifica perché i cittadini sono inconsapevoli del vincolo di bilancio effettivo.
Il federalismo fiscale
 Il federalismo fiscale Cosa intendere per federalismo fiscale? Cosa intendere per federalismo? decentramento o accentramento? Cosa intendere per fiscale? Ragioni a favore del FF (1) Aderenza alle preferenze
Il federalismo fiscale Cosa intendere per federalismo fiscale? Cosa intendere per federalismo? decentramento o accentramento? Cosa intendere per fiscale? Ragioni a favore del FF (1) Aderenza alle preferenze
MECCANISMO PEREQUATIVO CONTENUTO NEL DECRETO LEGISLATIVO 57/2000
 Lezione 8 Il fondo perequativo regionale MECCANISMO PEREQUATIVO CONTENUTO NEL DECRETO LEGISLATIVO 57/2000 In sostituzione dei trasferimenti preesistenti, il decreto legislativo 57/2000 ha attribuito alle
Lezione 8 Il fondo perequativo regionale MECCANISMO PEREQUATIVO CONTENUTO NEL DECRETO LEGISLATIVO 57/2000 In sostituzione dei trasferimenti preesistenti, il decreto legislativo 57/2000 ha attribuito alle
Capitolo 20 Le imposte sui consumi
 Capitolo 20 Le imposte sui consumi Le imposte generali sulle vendite e l imposta sul valore aggiunto Le imposte generali sulle vendite possono colpire l intero valore di un bene o l incremento di valore
Capitolo 20 Le imposte sui consumi Le imposte generali sulle vendite e l imposta sul valore aggiunto Le imposte generali sulle vendite possono colpire l intero valore di un bene o l incremento di valore
concorrenza perfetta vs. monopolio
 Lezione di Giacomo Degli Antoni, 20-3- 13 concorrenza perfetta vs. monopolio (Cap. 3 e 4 Carlton - Perloff) Piano della lezione Caratteristiche principali della concorrenza perfetta Caratteristiche principali
Lezione di Giacomo Degli Antoni, 20-3- 13 concorrenza perfetta vs. monopolio (Cap. 3 e 4 Carlton - Perloff) Piano della lezione Caratteristiche principali della concorrenza perfetta Caratteristiche principali
Struttura di mercato: insieme di elementi che incidono sul comportamento e il rendimento delle imprese di mercato, quali numero di imprese e tipo di
 Struttura di mercato: insieme di elementi che incidono sul comportamento e il rendimento delle imprese di mercato, quali numero di imprese e tipo di bene venduto Concorrenzialità del mercato: dipende dalla
Struttura di mercato: insieme di elementi che incidono sul comportamento e il rendimento delle imprese di mercato, quali numero di imprese e tipo di bene venduto Concorrenzialità del mercato: dipende dalla
Programma di Scienza delle Finanze (A-Z) Laurea Magistrale a Ciclo Unico Telematica A.A. 2015/2016 Prof.ssa Giorgia Marini
 Programma di Scienza delle Finanze (A-Z) Laurea Magistrale a Ciclo Unico Telematica A.A. 2015/2016 Prof.ssa Giorgia Marini Il corso propone un analisi normativa dell intervento pubblico in economia con
Programma di Scienza delle Finanze (A-Z) Laurea Magistrale a Ciclo Unico Telematica A.A. 2015/2016 Prof.ssa Giorgia Marini Il corso propone un analisi normativa dell intervento pubblico in economia con
LE IMPOSTE: concetti generali
 Anno Accademico 2009-2010 Scienza delle Finanze Argomenti Finalitá delle imposte Definizioni di base Classificazioni Definizione di Osservazioni Metodi per realizzare la e Imposte personali e reali Criteri
Anno Accademico 2009-2010 Scienza delle Finanze Argomenti Finalitá delle imposte Definizioni di base Classificazioni Definizione di Osservazioni Metodi per realizzare la e Imposte personali e reali Criteri
La grande frontiera dell utilità nell economia del benessere
 Seminario di Scienza delle Finanze Marco Passarella La grande frontiera dell utilità nell economia del benessere Martedì 3 maggio 2011 Legenda: Parti trattate in Bosi (2006, cap. 1.2-1.3) Parti non trattate
Seminario di Scienza delle Finanze Marco Passarella La grande frontiera dell utilità nell economia del benessere Martedì 3 maggio 2011 Legenda: Parti trattate in Bosi (2006, cap. 1.2-1.3) Parti non trattate
SCIENZA DELLE FINANZE A.A Esercitazione - Debito Pubblico e Saldi di Bilancio TESTO e SOLUZIONI
 SCIENZA DELLE FINANZE A.A. 2012-2013 Esercitazione - Debito Pubblico e Saldi di Bilancio TESTO e SOLUZIONI Esercizio 1 Nel 2011 il rapporto debito pubblico/pil del Paese X era pari al 130% e le previsioni
SCIENZA DELLE FINANZE A.A. 2012-2013 Esercitazione - Debito Pubblico e Saldi di Bilancio TESTO e SOLUZIONI Esercizio 1 Nel 2011 il rapporto debito pubblico/pil del Paese X era pari al 130% e le previsioni
ESERCITAZIONI DI ECONOMIA POLITICA (programma di MICROECONOMIA) seconda parte
 ESERCITAZIONI DI ECONOMIA POLITICA (programma di MICROECONOMIA) anno accademico 01 013 seconda parte Per domande, dubbi o chiarimenti scrivere a: gaetano.lisi@unicas.it 1 1. IMPORTANZA DEI COSTI (MEDI)
ESERCITAZIONI DI ECONOMIA POLITICA (programma di MICROECONOMIA) anno accademico 01 013 seconda parte Per domande, dubbi o chiarimenti scrivere a: gaetano.lisi@unicas.it 1 1. IMPORTANZA DEI COSTI (MEDI)
IL SISTEMA TRIBUTARIO
 IL SISTEMA TRIBUTARIO - Le entrate fiscali hanno: finalità fiscali LE ENTRATE FISCALI finanziamento della spesa per l erogazione di beni e servizi ai cittadini finalità extrafiscali redistribuzione correzione
IL SISTEMA TRIBUTARIO - Le entrate fiscali hanno: finalità fiscali LE ENTRATE FISCALI finanziamento della spesa per l erogazione di beni e servizi ai cittadini finalità extrafiscali redistribuzione correzione
DOMANDE a risposta multipla (ogni risposta esatta riceve una valutazione di due; non sono previste penalizzazioni in caso di risposte non corrette)
 In un ora rispondere alle dieci domande a risposta multipla, alla domanda a risposta aperta, e risolvere l esercizio. DOMANDE a risposta multipla (ogni risposta esatta riceve una valutazione di due; non
In un ora rispondere alle dieci domande a risposta multipla, alla domanda a risposta aperta, e risolvere l esercizio. DOMANDE a risposta multipla (ogni risposta esatta riceve una valutazione di due; non
La teoria dell offerta
 La teoria dell offerta Tecnologia e costi di produzione In questa lezione approfondiamo l analisi del comportamento delle imprese e quindi delle determinanti dell offerta. In particolare: è possibile individuare
La teoria dell offerta Tecnologia e costi di produzione In questa lezione approfondiamo l analisi del comportamento delle imprese e quindi delle determinanti dell offerta. In particolare: è possibile individuare
I Costi di Produzione
 I Costi di Produzione Misurazione del costi: di quali costi tenere conto? I costi nel breve periodo I costi nel lungo periodo Curve di costo nel lungo e nel breve periodo a confronto Produzione di due
I Costi di Produzione Misurazione del costi: di quali costi tenere conto? I costi nel breve periodo I costi nel lungo periodo Curve di costo nel lungo e nel breve periodo a confronto Produzione di due
Teoria del federalismo fiscale. Bosi (a cura di), Corso di scienza delle finanze, il Mulino,
 Teoria del federalismo fiscale Bosi (a cura di), Corso di scienza delle finanze, il Mulino, 2010 1 A quali domande vogliamo rispondere Perché esistono diversi livelli di governo: Stato, Regioni, Province
Teoria del federalismo fiscale Bosi (a cura di), Corso di scienza delle finanze, il Mulino, 2010 1 A quali domande vogliamo rispondere Perché esistono diversi livelli di governo: Stato, Regioni, Province
Macroeconomia: la visione. Cap.16
 Macroeconomia: la visione d insieme del sistema economico Cap.16 Macroeconomia studio dei fenomeni che riguardano il sistema economico nel suo complesso e le politiche adottate dallo Stato per cercare
Macroeconomia: la visione d insieme del sistema economico Cap.16 Macroeconomia studio dei fenomeni che riguardano il sistema economico nel suo complesso e le politiche adottate dallo Stato per cercare
Capitolo 7 La ridistribuzione del reddito: aspetti teorici
 Capitolo 7 La ridistribuzione del reddito: aspetti teorici È questione di cui si devono occupare gli economisti? La prima questione da affrontare è se la distribuzione del reddito rientri nella sfera di
Capitolo 7 La ridistribuzione del reddito: aspetti teorici È questione di cui si devono occupare gli economisti? La prima questione da affrontare è se la distribuzione del reddito rientri nella sfera di
IMPOSTE GENERALI SUI CONSUMI
 IMPOSTE GENERALI SUI CONSUMI A) Giustificazioni 1) C: indicatore di capacità contributiva ma: a) C/R decresce al crescere di R b) se tassati consumi necessari IC regressive rispetto al R I) aliquote differenziate
IMPOSTE GENERALI SUI CONSUMI A) Giustificazioni 1) C: indicatore di capacità contributiva ma: a) C/R decresce al crescere di R b) se tassati consumi necessari IC regressive rispetto al R I) aliquote differenziate
Bosi (a cura di), Corso di scienza delle finanze, il Mulino, 2012 Capitolo I, lezione 1 Il problema e alcune premesse
 Il problema e alcune premesse La costruzione della grande frontiera delle utilità e l ottimo l paretiano La scienza delle finanze studia le entrate e le uscite pubbliche con un approccio normativo e positivo
Il problema e alcune premesse La costruzione della grande frontiera delle utilità e l ottimo l paretiano La scienza delle finanze studia le entrate e le uscite pubbliche con un approccio normativo e positivo
2. La teoria delle esternalitá
 Economia dell ambiente 2. La teoria delle 2.1 Diritti di proprietá 2.2 Analisi economica delle Economia dell ambiente - Giacomo Branca, Universitá della Tuscia 2.1 Diritti di proprietà esternalità 2.1
Economia dell ambiente 2. La teoria delle 2.1 Diritti di proprietá 2.2 Analisi economica delle Economia dell ambiente - Giacomo Branca, Universitá della Tuscia 2.1 Diritti di proprietà esternalità 2.1
Capitolo 8. La ridistribuzione del reddito: aspetti teorici. sabato 25 maggio 13. Scienza delle finanze 3/ed Harvey S.
 Capitolo 8 La ridistribuzione del reddito: aspetti teorici E questione di cui si devono occupare gli economisti? La prima questione da affrontare è se la distribuzione del reddito rientri nella sfera di
Capitolo 8 La ridistribuzione del reddito: aspetti teorici E questione di cui si devono occupare gli economisti? La prima questione da affrontare è se la distribuzione del reddito rientri nella sfera di
STATO E RIDISTRIBUZIONE DELLE RISORSE
 STATO E RIDISTRIBUZIONE DELLE RISORSE CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE, FACOLTÁ DI SOCIOLOGIA A.A. 2008-2009 ANNA TEMPIA 3 LEZIONE CENNI DI TEORIA DELL IMPOSTA (PARTE PRIMA) BIBLIOGRAFIA: P. Bosi (
STATO E RIDISTRIBUZIONE DELLE RISORSE CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE, FACOLTÁ DI SOCIOLOGIA A.A. 2008-2009 ANNA TEMPIA 3 LEZIONE CENNI DI TEORIA DELL IMPOSTA (PARTE PRIMA) BIBLIOGRAFIA: P. Bosi (
Capitolo 9 La produzione
 Capitolo 9 La produzione LA PRODUZIONE Le risorse che le imprese usano per produrre beni e servizi sono dette fattori produttivi o input I beni e i servizi realizzati dalle imprese sono definiti semplicemente
Capitolo 9 La produzione LA PRODUZIONE Le risorse che le imprese usano per produrre beni e servizi sono dette fattori produttivi o input I beni e i servizi realizzati dalle imprese sono definiti semplicemente
Prova scritta del 14 dicembre traccia A -
 Università degli studi di Bari A. Moro Corso di laurea in Economia e commercio SCIENZA DELLE FINANZE Anno accademico 2015/2016 Prova scritta del 14 dicembre 2015 - traccia A - Prima parte (per un totale
Università degli studi di Bari A. Moro Corso di laurea in Economia e commercio SCIENZA DELLE FINANZE Anno accademico 2015/2016 Prova scritta del 14 dicembre 2015 - traccia A - Prima parte (per un totale
1. Introduzione alle forme di mercato - Concorrenza perfetta
 1. Introduzione alle forme di mercato - Concorrenza perfetta Alessandra Michelangeli November 3, 2010 Alessandra Michelangeli () 1. Forme di mercato - Concorrenza perfetta November 3, 2010 1 / 16 Forme
1. Introduzione alle forme di mercato - Concorrenza perfetta Alessandra Michelangeli November 3, 2010 Alessandra Michelangeli () 1. Forme di mercato - Concorrenza perfetta November 3, 2010 1 / 16 Forme
LA TEORIA DELL OFFERTA. Tecnologia e costi di produzione
 LA TEORIA DELL OFFERTA Tecnologia e costi di produzione IL COMPORTAMENTO DELL IMPRESA In questa lezione approfondiremo l analisi del comportamento delle imprese e quindi delle determinanti dell offerta.
LA TEORIA DELL OFFERTA Tecnologia e costi di produzione IL COMPORTAMENTO DELL IMPRESA In questa lezione approfondiremo l analisi del comportamento delle imprese e quindi delle determinanti dell offerta.
Teoria dell imposta. Teoria dell imposta
 Teoria dell imposta Teoria dell imposta Il punto di partenza è che occorre finanziare le attività del settore pubblico (che può essere più o meno ampio). Storicamente, la dottrina ha distinto tra diversi
Teoria dell imposta Teoria dell imposta Il punto di partenza è che occorre finanziare le attività del settore pubblico (che può essere più o meno ampio). Storicamente, la dottrina ha distinto tra diversi
IL DECENTRAMENTO FISCALE. Scienza delle finanze lezione 13
 IL DECENTRAMENTO FISCALE Scienza delle finanze lezione 13 ALCUNE DOMANDE Perché esistono diversi livelli di governo: stato, regioni, comuni? Quali sono i compiti più appropriati per il centro e la periferia?
IL DECENTRAMENTO FISCALE Scienza delle finanze lezione 13 ALCUNE DOMANDE Perché esistono diversi livelli di governo: stato, regioni, comuni? Quali sono i compiti più appropriati per il centro e la periferia?
Economia Politica (Mod I) Nota integrativa n. 3
 Economia Politica (Mod I) Nota integrativa n. 3 I costi di produzione Mankiw, Capitolo 13 Premessa Nell analisi della legge dell offerta, vista fino a questo momento, abbiamo sinteticamente descritto le
Economia Politica (Mod I) Nota integrativa n. 3 I costi di produzione Mankiw, Capitolo 13 Premessa Nell analisi della legge dell offerta, vista fino a questo momento, abbiamo sinteticamente descritto le
LAUREE SPECIALISTICHE DELLE PROFESSIONI SANITARIE PROGRAMMAZIONE ED ECONOMIA SANITARIA
 LAUREE SPECIALISTICHE DELLE PROFESSIONI SANITARIE PROGRAMMAZIONE ED ECONOMIA SANITARIA Titolare del modulo di POLITICA ECONOMICA: Dott.ssa Silvia Bertarelli 1. Il meccanismo di mercato LEZIONE 2 Definizione
LAUREE SPECIALISTICHE DELLE PROFESSIONI SANITARIE PROGRAMMAZIONE ED ECONOMIA SANITARIA Titolare del modulo di POLITICA ECONOMICA: Dott.ssa Silvia Bertarelli 1. Il meccanismo di mercato LEZIONE 2 Definizione
Economia Politica. Efficienza dei mercati. Cap 7. Appunti delle lezioni Fabiano Schivardi
 Economia Politica Appunti delle lezioni Fabiano Schivardi testo di riferimento: Mankiw, Principi di economia, 3 ed., 2004, Zanichelli Cap 7 Efficienza dei mercati Vedremo infine in quali circostanze il
Economia Politica Appunti delle lezioni Fabiano Schivardi testo di riferimento: Mankiw, Principi di economia, 3 ed., 2004, Zanichelli Cap 7 Efficienza dei mercati Vedremo infine in quali circostanze il
NOTE DI MATEMATICA APPLICATA ALL ECONOMIA
 NOTE DI MATEMATICA APPLICATA ALL ECONOMIA «[ ] lo scopo dell analisi infinitesimale è quello di fare acquisire strumenti di calcolo atti alla ricerca ottimale di funzioni vincolate, soprattutto di natura
NOTE DI MATEMATICA APPLICATA ALL ECONOMIA «[ ] lo scopo dell analisi infinitesimale è quello di fare acquisire strumenti di calcolo atti alla ricerca ottimale di funzioni vincolate, soprattutto di natura
Scienza delle Finanze Cleam 2 A.A Alessandra Casarico
 Scienza delle Finanze 30018-Cleam 2 A.A. 2011-2012 Alessandra Casarico Orario di ricevimento Alessandra Casarico (Via Roentgen 1, 3B1-05) Mercoledì 16.15-17.45 (controllare sempre su internet) alessandra.casarico@unibocconi.it
Scienza delle Finanze 30018-Cleam 2 A.A. 2011-2012 Alessandra Casarico Orario di ricevimento Alessandra Casarico (Via Roentgen 1, 3B1-05) Mercoledì 16.15-17.45 (controllare sempre su internet) alessandra.casarico@unibocconi.it
APPROPRIATEZZA EFFICACIA EFFICIENZA in Sanità
 Corso di Alta Formazione Modulo 2 APPROPRIATEZZA EFFICACIA EFFICIENZA in Sanità Dott.ssa F.Camilli Il Paradigma della gestione della qualità ECONOMICITA EFFICIENZA EFFICACIA Economicità Per ogni tipologia
Corso di Alta Formazione Modulo 2 APPROPRIATEZZA EFFICACIA EFFICIENZA in Sanità Dott.ssa F.Camilli Il Paradigma della gestione della qualità ECONOMICITA EFFICIENZA EFFICACIA Economicità Per ogni tipologia
RICETTIVITÀ TURISTICA a.a. 2008/09
 RICETTIVITÀ TURISTICA a.a. 2008/09 PROF. FRANCESCO MARANGON Dipartimento di Scienze Economiche Di cosa si occupa l economia? l L economia è la scienza che studia il modo in cui la società alloca in maniera
RICETTIVITÀ TURISTICA a.a. 2008/09 PROF. FRANCESCO MARANGON Dipartimento di Scienze Economiche Di cosa si occupa l economia? l L economia è la scienza che studia il modo in cui la società alloca in maniera
Domande ed Esercizi Corso di Istituzioni di Economia Politica
 Domande ed Esercizi Corso di Istituzioni di Economia Politica Simone D Alessandro Ottobre 2009 Indice 1 Teoria del Consumatore 1 1.1 Esercizi.............................. 1 2 Teoria della Produzione 3
Domande ed Esercizi Corso di Istituzioni di Economia Politica Simone D Alessandro Ottobre 2009 Indice 1 Teoria del Consumatore 1 1.1 Esercizi.............................. 1 2 Teoria della Produzione 3
CONSUMO. 3. Il Saggio Marginale di Sostituzione (SMS)
 CONSUMO 1. Le Preferenze del Consumatore 2. Curve di Indifferenza 3. Il Saggio Marginale di Sostituzione (SMS) 4. La Funzione di Utilità Utilità Marginale e Utilità Marginale Decrescente Utilità Marginale
CONSUMO 1. Le Preferenze del Consumatore 2. Curve di Indifferenza 3. Il Saggio Marginale di Sostituzione (SMS) 4. La Funzione di Utilità Utilità Marginale e Utilità Marginale Decrescente Utilità Marginale
percorso 4 Estensione on line lezione 2 I fattori della produzione e le forme di mercato La produttività La produzione
 Estensione on line percorso 4 I fattori della produzione e le forme di mercato lezione 2 a produzione a produttività Una volta reperiti i fattori produttivi necessari l imprenditore dovrà decidere come
Estensione on line percorso 4 I fattori della produzione e le forme di mercato lezione 2 a produzione a produttività Una volta reperiti i fattori produttivi necessari l imprenditore dovrà decidere come
Lezione 12 Argomenti
 Lezione 12 Argomenti Costi di produzione: differenza tra costo economico e costo contabile I costi nel breve periodo Relazione di breve periodo tra funzione di produzione, produttività del lavoro e costi
Lezione 12 Argomenti Costi di produzione: differenza tra costo economico e costo contabile I costi nel breve periodo Relazione di breve periodo tra funzione di produzione, produttività del lavoro e costi
Analisi positiva e normativa
 Analisi positiva e normativa ANALISI POSITIVA Come si possono valutare gli effetti di un intervento pubblico Gli effetti delle politiche pubbliche sono difficili da determinare La teoria economica aiuta
Analisi positiva e normativa ANALISI POSITIVA Come si possono valutare gli effetti di un intervento pubblico Gli effetti delle politiche pubbliche sono difficili da determinare La teoria economica aiuta
Introduzione all economia. Scelta individuale. Trade-off (scelte tra alternative)
 Introduzione all economia Scelta individuale Tutte le questioni economiche, in essenza, comportano scelte individuali: decisioni prese da un individuo su cosa fare e cosa non fare Perché gli individui
Introduzione all economia Scelta individuale Tutte le questioni economiche, in essenza, comportano scelte individuali: decisioni prese da un individuo su cosa fare e cosa non fare Perché gli individui
RICETTIVITÀ TURISTICA a.a. 2008/09
 RICETTIVITÀ TURISTICA a.a. 2008/09 PROF. FRANCESCO MARANGON Dipartimento di Scienze Economiche Come è descritto in microeconomia il problema di scelta del Secondo l ottica consequenzialista la scelta tra
RICETTIVITÀ TURISTICA a.a. 2008/09 PROF. FRANCESCO MARANGON Dipartimento di Scienze Economiche Come è descritto in microeconomia il problema di scelta del Secondo l ottica consequenzialista la scelta tra
Lezioni di Economia Politica
 Università degli Studi di Roma TRE - Dipartimento di Giurisprudenza Lezioni di Economia Politica Le scelte e l equilibrio del consumatore Giovanni Nicola De Vito Le scelte del consumatore Il consumatore
Università degli Studi di Roma TRE - Dipartimento di Giurisprudenza Lezioni di Economia Politica Le scelte e l equilibrio del consumatore Giovanni Nicola De Vito Le scelte del consumatore Il consumatore
Indice. XI Prefazione XV Gli Autori XVII L editore ringrazia 3 Parte I L economia del benessere
 Indice XI Prefazione XV Gli Autori XVII L editore ringrazia 3 Parte I L economia del benessere 5 Capitolo 1 L equilibrio economico generale e i teoremi dell economia del benessere 5 I.1.1 Pareto-efficienza:
Indice XI Prefazione XV Gli Autori XVII L editore ringrazia 3 Parte I L economia del benessere 5 Capitolo 1 L equilibrio economico generale e i teoremi dell economia del benessere 5 I.1.1 Pareto-efficienza:
In che quantità verrà acquistato un bene?
 In che quantità verrà acquistato un bene? LEGGE DELLA DOMANDA Se il prezzo aumenta, la quantità domandata diminuisce Se il prezzo diminuisce, la quantità domandata aumenta L entità di tale aumento o diminuzione
In che quantità verrà acquistato un bene? LEGGE DELLA DOMANDA Se il prezzo aumenta, la quantità domandata diminuisce Se il prezzo diminuisce, la quantità domandata aumenta L entità di tale aumento o diminuzione
Il sistema finanziario cap.10
 10-5-2017 Il sistema finanziario cap.10 Svolge la funzione di trasferire risorse finanziarie ai soggetti che ne dispongono a quelli che le impiegano Strumenti finanziari principali (par. 10.2.1) Strumenti
10-5-2017 Il sistema finanziario cap.10 Svolge la funzione di trasferire risorse finanziarie ai soggetti che ne dispongono a quelli che le impiegano Strumenti finanziari principali (par. 10.2.1) Strumenti
Lezione 15 Equilibrio economico generale
 Corso di Economia Politica prof. S. Papa Lezione 15 Equilibrio economico generale e pareto ottimalità Facoltà di Economia Università di Roma La Sapienza (valutare le allocazioni) Economia del benessere
Corso di Economia Politica prof. S. Papa Lezione 15 Equilibrio economico generale e pareto ottimalità Facoltà di Economia Università di Roma La Sapienza (valutare le allocazioni) Economia del benessere
Economia del benessere
 Politica economica (A-D) Sapienza Università di Rome Economia del benessere Giovanni Di Bartolomeo Sapienza Università di Roma Economia del benessere Analizzando l equilibrio di mercato concorrenziale
Politica economica (A-D) Sapienza Università di Rome Economia del benessere Giovanni Di Bartolomeo Sapienza Università di Roma Economia del benessere Analizzando l equilibrio di mercato concorrenziale
La teoria del consumo
 La teoria del consumo Il surplus del consumatore e la domanda di mercato. Mario Sportelli Dipartimento di Matematica Università degli Studi di Bari Via E. Orabona, 4 I-70125 Bari (Italy) (Tel.: +39 (0)99
La teoria del consumo Il surplus del consumatore e la domanda di mercato. Mario Sportelli Dipartimento di Matematica Università degli Studi di Bari Via E. Orabona, 4 I-70125 Bari (Italy) (Tel.: +39 (0)99
Introduzione. L oggetto di studio dell Economia sanitaria. Quadro teorico di riferimento. Le peculiarità del mercato delle prestazioni sanitarie
 Introduzione NB: Questi lucidi presentano solo parzialmente gli argomenti trattati ttati in classe. In particolare non contengono i modelli economici per i quali si rinvia direttamente al libro di testo
Introduzione NB: Questi lucidi presentano solo parzialmente gli argomenti trattati ttati in classe. In particolare non contengono i modelli economici per i quali si rinvia direttamente al libro di testo
L AUTONOMIA FINANZIARIA LE ENTRATE SECONDO LA PROVENIENZA LE ENTRATE TRIBUTARIE RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER FUNZIONI LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI
 2006 L AUTONOMIA FINANZIARIA LE ENTRATE SECONDO LA PROVENIENZA LE ENTRATE TRIBUTARIE LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI DESTINAZIONE ECONOMICA DELLA SPESA RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER FUNZIONI AUTONOMIA FINANZIARIA
2006 L AUTONOMIA FINANZIARIA LE ENTRATE SECONDO LA PROVENIENZA LE ENTRATE TRIBUTARIE LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI DESTINAZIONE ECONOMICA DELLA SPESA RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER FUNZIONI AUTONOMIA FINANZIARIA
Agenzia specializzata in: Assicurazione del Credito. Cauzioni e Fideiussioni. Rischi della Costruzione. La Compagnia
 Agenzia specializzata in: Assicurazione del Credito Cauzioni e Fideiussioni Rischi della Costruzione La Compagnia SACE BT SpA, società del gruppo SACE SpA fornisce alle imprese, prodotti e servizi assicurativi
Agenzia specializzata in: Assicurazione del Credito Cauzioni e Fideiussioni Rischi della Costruzione La Compagnia SACE BT SpA, società del gruppo SACE SpA fornisce alle imprese, prodotti e servizi assicurativi
5. L elasticità dei costi totali rispetto alla quantità, in termini semplificati si scrive come = AC
 Capitolo 8 Le curve di costo Soluzioni delle Domande di ripasso 1. La curva del costo totale di lungo periodo mostra il costo totale minimo per ogni livello di output, tenendo fissi i prezzi degli input.
Capitolo 8 Le curve di costo Soluzioni delle Domande di ripasso 1. La curva del costo totale di lungo periodo mostra il costo totale minimo per ogni livello di output, tenendo fissi i prezzi degli input.
Prova scritta dell 11 gennaio traccia A -
 Università degli studi di Bari A. Moro Corso di laurea in Economia e commercio SCIENZA DELLE FINANZE Anno accademico 2015/2016 Prova scritta dell 11 gennaio 2016 - traccia A - Prima parte (per un totale
Università degli studi di Bari A. Moro Corso di laurea in Economia e commercio SCIENZA DELLE FINANZE Anno accademico 2015/2016 Prova scritta dell 11 gennaio 2016 - traccia A - Prima parte (per un totale
ISTITUZIONI DI ECONOMIA (a.a ) PROVE D ESAME
 Giuseppe Garofalo Dipartimento di Economia pubblica Facoltà di Economia Università degli studi di Roma La Sapienza ISTITUZIONI DI ECONOMIA (a.a. 1999-2000) PROVE D ESAME Prova intermedia di Macro (4-3-2000)
Giuseppe Garofalo Dipartimento di Economia pubblica Facoltà di Economia Università degli studi di Roma La Sapienza ISTITUZIONI DI ECONOMIA (a.a. 1999-2000) PROVE D ESAME Prova intermedia di Macro (4-3-2000)
Vedremo come i mercati di concorrenza perfetta garantiscono, di norma, il raggiungimento del massimo livello di benessere per il sistema economico.
 Economia Politica ppunti delle lezioni Raffaele Paci testo di riferimento: Mankiw, Principi di economia, 3 ed., 2004, Zanichelli ap 7 Efficienza dei mercati MERTI, ENESSERE E INTERVENTO PULIO Questo modulo
Economia Politica ppunti delle lezioni Raffaele Paci testo di riferimento: Mankiw, Principi di economia, 3 ed., 2004, Zanichelli ap 7 Efficienza dei mercati MERTI, ENESSERE E INTERVENTO PULIO Questo modulo
Prima parte (per un totale di 25 punti)
 PROVA SCRITTA DI SCIENZA DELLE FINANZE Corso di laurea in Marketing e comunicazione d azienda 17 dicembre 2012 TRACCIA A Prima parte (per un totale di 25 punti) Esercizio 1. (2 punti) Si considerino tredici
PROVA SCRITTA DI SCIENZA DELLE FINANZE Corso di laurea in Marketing e comunicazione d azienda 17 dicembre 2012 TRACCIA A Prima parte (per un totale di 25 punti) Esercizio 1. (2 punti) Si considerino tredici
Capitolo 1 Pensare da economisti. Robert H. Frank Microeconomia - 4 a Edizione Copyright The McGraw-Hill Companies, srl
 Capitolo 1 Pensare da economisti L APPROCCIO COSTI-BENEFICI La microeconomia studia i processi decisionali in condizioni di scarsità Le scelte vengono effettuate seguendo l approccio costi-benefici Se
Capitolo 1 Pensare da economisti L APPROCCIO COSTI-BENEFICI La microeconomia studia i processi decisionali in condizioni di scarsità Le scelte vengono effettuate seguendo l approccio costi-benefici Se
Il sistema tributario italiano
 SCIENZA DELLE FINANZE Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche Corso di Economia aziendale Prof. MICHELE SABATINO Il sistema tributario italiano Imposta: prelievo coattivo di denaro senza vincoli di
SCIENZA DELLE FINANZE Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche Corso di Economia aziendale Prof. MICHELE SABATINO Il sistema tributario italiano Imposta: prelievo coattivo di denaro senza vincoli di
Definizioni economia applicata all ingegneria
 Definizioni economia applicata all ingegneria October 28 2011 In questo documento assolutamente non ufficiale sono contenute le definizioni date durante le lezioni di economia applicata all ingegneria.
Definizioni economia applicata all ingegneria October 28 2011 In questo documento assolutamente non ufficiale sono contenute le definizioni date durante le lezioni di economia applicata all ingegneria.
i-x_1-179_imbriani_07.qxp :10 Pagina V Indice
 i-x_1-179_imbriani_07.qxp 20-04-2007 11:10 Pagina V 3 CAPITOLO 1 Introduzione alla macroeconomia 3 1.1 L oggetto della macroeconomia 5 1.2 Dalla microeconomia alla macroeconomia 6 1.3 La produzione e la
i-x_1-179_imbriani_07.qxp 20-04-2007 11:10 Pagina V 3 CAPITOLO 1 Introduzione alla macroeconomia 3 1.1 L oggetto della macroeconomia 5 1.2 Dalla microeconomia alla macroeconomia 6 1.3 La produzione e la
Lavoro Quantità. si determinino prodotto marginale e medio del fattore lavoro.
 Microeconomia, Esercitazione 3. A cura di Giuseppe Gori (giuseppe.gori@unibo.it) 1 Esercizi. 1.1 Produzione/1 Data una certa tecnologia di produzione definita solo nell input lavoro (o, in alternativa,
Microeconomia, Esercitazione 3. A cura di Giuseppe Gori (giuseppe.gori@unibo.it) 1 Esercizi. 1.1 Produzione/1 Data una certa tecnologia di produzione definita solo nell input lavoro (o, in alternativa,
Concorrenza perfetta (Frank - Capitolo 11)
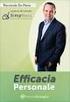 Concorrenza perfetta (Frank - Capitolo 11) MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO In economia tradizionalmente si assume che l obiettivo principale dell impresa sia la massimizzazione del profitto Il profitto economico
Concorrenza perfetta (Frank - Capitolo 11) MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO In economia tradizionalmente si assume che l obiettivo principale dell impresa sia la massimizzazione del profitto Il profitto economico
Il Veneto a confronto con le Regioni a statuto speciale
 Il Veneto a confronto con le Regioni a statuto speciale 1. Sulla base dei dati dei bilanci regionali e di quelli consolidati utilizzati nei precedenti capitoli, focalizziamo ora l analisi sul confronto
Il Veneto a confronto con le Regioni a statuto speciale 1. Sulla base dei dati dei bilanci regionali e di quelli consolidati utilizzati nei precedenti capitoli, focalizziamo ora l analisi sul confronto
Economia Internazionale il vantaggio comparato
 Paolo Sospiro Dipartimento degli Studi sullo Sviluppo Economico Facoltà di Scienze Politiche Università di Macerata paolo.sospiro@unimc.it Economia Internazionale il vantaggio comparato Macerata 16 Novembre
Paolo Sospiro Dipartimento degli Studi sullo Sviluppo Economico Facoltà di Scienze Politiche Università di Macerata paolo.sospiro@unimc.it Economia Internazionale il vantaggio comparato Macerata 16 Novembre
ESERCIZIO n. 2. Soluzione
 Economia Internazionale e Politiche Commerciali a.a. 2013/14 ESERCIZIO n. 2 Krugman, Obstfeld e Melitz, Capitolo 4: Problemi n. 2, 3, 4, 5 e 6 (pp. 101 103) Problema 3 domanda d): Calcolate Discutete gli
Economia Internazionale e Politiche Commerciali a.a. 2013/14 ESERCIZIO n. 2 Krugman, Obstfeld e Melitz, Capitolo 4: Problemi n. 2, 3, 4, 5 e 6 (pp. 101 103) Problema 3 domanda d): Calcolate Discutete gli
Esercitazione 10 marzo 2010 Cap. 6, 7, 8 Multiple Choice Cap. 6
 Esercitazione 10 marzo 2010 Cap. 6, 7, 8 Multiple Choice Cap. 6 1. La disponibilità a pagare di Peppe per l acquisto di un CD musicale è 12 euro. Questo significa che: a. 12 euro è il prezzo di mercato
Esercitazione 10 marzo 2010 Cap. 6, 7, 8 Multiple Choice Cap. 6 1. La disponibilità a pagare di Peppe per l acquisto di un CD musicale è 12 euro. Questo significa che: a. 12 euro è il prezzo di mercato
L IRPEF. L imposta sul reddito in Italia
 L IRPEF L imposta sul reddito in Italia 1 1 L IRPEF Imposta personale e progressiva Assicura un gettito elevato Permette di realizzare obiettivi di redistribuzione del reddito E uno strumento di stabilizzazione
L IRPEF L imposta sul reddito in Italia 1 1 L IRPEF Imposta personale e progressiva Assicura un gettito elevato Permette di realizzare obiettivi di redistribuzione del reddito E uno strumento di stabilizzazione
La finanza regionale
 La finanza regionale 1. Il sistema di finanziamento delle Regioni, in particolar modo quello delle Regioni a Statuto ordinario, ha subito nell ultimo decennio notevoli mutamenti, che hanno comportato la
La finanza regionale 1. Il sistema di finanziamento delle Regioni, in particolar modo quello delle Regioni a Statuto ordinario, ha subito nell ultimo decennio notevoli mutamenti, che hanno comportato la
MONOPOLIO. Monopolio: mercato nel quale vi è un solo offerente (Monopsonio: mercato nel quale vi è un solo compratore)
 MONOPOLIO Monopolio: mercato nel quale vi è un solo offerente (Monopsonio: mercato nel quale vi è un solo compratore) Monopolio e fallimento del mercato: in realtà ogni volta che in un mercato operano
MONOPOLIO Monopolio: mercato nel quale vi è un solo offerente (Monopsonio: mercato nel quale vi è un solo compratore) Monopolio e fallimento del mercato: in realtà ogni volta che in un mercato operano
MACROECONOMIA Del ( VERSIONE A) COGNOME NOME DOCENTE 1) A B C D
 MACROECONOMIA Del 10.06.2015( VERSIONE A) COGNOME NOME MATRICOLA DOCENTE 1) A B C D 2) A B C D 3) A B C D 4) A B C D 5) A B C D 6) A B C D 7) A B C D 8) A B C D 9) A B C D 10) A B C D 11) A B C D 12) A
MACROECONOMIA Del 10.06.2015( VERSIONE A) COGNOME NOME MATRICOLA DOCENTE 1) A B C D 2) A B C D 3) A B C D 4) A B C D 5) A B C D 6) A B C D 7) A B C D 8) A B C D 9) A B C D 10) A B C D 11) A B C D 12) A
Lezioni di Microeconomia
 Lezioni di Microeconomia Lezione 8 I Costi Lezione 8: I costi Slide 1 Introduzione La tecnologia di produzione dell impresa definisce e misura la relazione tra input e output Data la tecnologia di produzione
Lezioni di Microeconomia Lezione 8 I Costi Lezione 8: I costi Slide 1 Introduzione La tecnologia di produzione dell impresa definisce e misura la relazione tra input e output Data la tecnologia di produzione
ECONOMIA APPLICATA ALL INGEGNERIA (Docente: Prof. Ing. Donato Morea)
 ESERCIZIO n. 1 - La produzione ed i costi di produzione (1 ) Un impresa utilizza una tecnologia descritta dalla seguente funzione di produzione: I prezzi dei fattori lavoro e capitale sono, rispettivamente,
ESERCIZIO n. 1 - La produzione ed i costi di produzione (1 ) Un impresa utilizza una tecnologia descritta dalla seguente funzione di produzione: I prezzi dei fattori lavoro e capitale sono, rispettivamente,
COSTO DI PRODUZIONE I COSTI DI PRODUZIONE CLASSIFICAZIONE COSTI
 COSTO DI PRODUZIONE I COSTI DI PRODUZIONE INSIEME DEI COSTI DI UTILIZZAZIONE DEI FATTORI IMPIEGATI IN UN DATO PROCESSO PRODUTTIVO O PER ALLESTIRE UN DATO PRODOTTO Economia Aziendale Milena Serra Corso
COSTO DI PRODUZIONE I COSTI DI PRODUZIONE INSIEME DEI COSTI DI UTILIZZAZIONE DEI FATTORI IMPIEGATI IN UN DATO PROCESSO PRODUTTIVO O PER ALLESTIRE UN DATO PRODOTTO Economia Aziendale Milena Serra Corso
Teoremi fondamentali dell economia del benessere
 Teoremi fondamentali dell economia del benessere La concorrenza è socialmente efficiente? E possibile affermare che la concorrenza (perfetta) è socialmente efficiente secondo una determinata nozione di
Teoremi fondamentali dell economia del benessere La concorrenza è socialmente efficiente? E possibile affermare che la concorrenza (perfetta) è socialmente efficiente secondo una determinata nozione di
Il sistema fiscale. Le imposte sui redditi da lavoro: incidenza
 Il sistema fiscale Le imposte sui redditi da lavoro: incidenza Le imposte sui redditi da lavoro: incidenza Le imposte sui redditi da lavoro si applicano al lavoratore (contribuente di diritto) ma possono
Il sistema fiscale Le imposte sui redditi da lavoro: incidenza Le imposte sui redditi da lavoro: incidenza Le imposte sui redditi da lavoro si applicano al lavoratore (contribuente di diritto) ma possono
Dossier 6 La situazione delle famiglie con riguardo agli affitti e ai mutui per la casa
 Dossier 6 La situazione delle famiglie con riguardo agli affitti e ai mutui per la casa Audizione del Presidente dell Istituto nazionale di statistica, Luigi Biggeri presso le Commissioni riunite V Commissione
Dossier 6 La situazione delle famiglie con riguardo agli affitti e ai mutui per la casa Audizione del Presidente dell Istituto nazionale di statistica, Luigi Biggeri presso le Commissioni riunite V Commissione
Come sviluppare un progetto d impresa. Presentato da: dr.ssa Patrizia Andreani
 1 Come sviluppare un progetto d impresa Presentato da: dr.ssa Patrizia Andreani 2 L azienda come sistema L azienda è un sistema: aperto (input output); dinamico (si adatta alle mutevoli situazioni esterne);
1 Come sviluppare un progetto d impresa Presentato da: dr.ssa Patrizia Andreani 2 L azienda come sistema L azienda è un sistema: aperto (input output); dinamico (si adatta alle mutevoli situazioni esterne);
Capitolo 1: La macroeconomia come scienza. homepage: https://sites.google.com/site/minnitianto77/teaching/macroeconomia
 Antonio Minniti Professore Associato Dipartimento di Scienze Economiche Università degli Studi di Bologna Piazza Scaravilli 2 40126 Bologna tel: +39 051 2098486 e-mail: antonio.minniti@unibo.it homepage:
Antonio Minniti Professore Associato Dipartimento di Scienze Economiche Università degli Studi di Bologna Piazza Scaravilli 2 40126 Bologna tel: +39 051 2098486 e-mail: antonio.minniti@unibo.it homepage:
SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI DI FINE CAPITOLO 1
 SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI DI FINE CAPITOLO 1 1-1 L affermazione di Emerson riflette la natura del problema economico, dato dal tentativo di soddisfare desideri illimitati attraverso l impiego di risorse
SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI DI FINE CAPITOLO 1 1-1 L affermazione di Emerson riflette la natura del problema economico, dato dal tentativo di soddisfare desideri illimitati attraverso l impiego di risorse
Obiettivi delle prossime due lezioni
 Le scelte pubbliche Obiettivi delle prossime due lezioni Diversamente dalle decisioni di spesa per i beni privati, determinate dal sistema dei prezzi, le decisioni di spesa per i beni pubblici sono determinate
Le scelte pubbliche Obiettivi delle prossime due lezioni Diversamente dalle decisioni di spesa per i beni privati, determinate dal sistema dei prezzi, le decisioni di spesa per i beni pubblici sono determinate
EQUILIBRIO DI MERCATO, POLITICHE ECONOMICHE E BENESSERE
 EQUILIBRIO DI MERCATO, POLITICHE ECONOMICHE E BENESSERE CONTROLLO dei PREZZI Vi sono situazioni in cui il principio di efficienza si scontra con quello di equità. Considerazioni di tipo normativo possono
EQUILIBRIO DI MERCATO, POLITICHE ECONOMICHE E BENESSERE CONTROLLO dei PREZZI Vi sono situazioni in cui il principio di efficienza si scontra con quello di equità. Considerazioni di tipo normativo possono
Capitolo 1 Introduzione
 Capitolo 1 Introduzione Oggetto del corso In questo corso ci occuperemo delle attività di prelievo e di spesa esercitate dal settore pubblico, attività che vengono spesso designate con il termine di finanze
Capitolo 1 Introduzione Oggetto del corso In questo corso ci occuperemo delle attività di prelievo e di spesa esercitate dal settore pubblico, attività che vengono spesso designate con il termine di finanze
Economia del Settore Pubblico
 Economia del Settore Pubblico Emanuela Randon Lezione 1 a.a. 2010-2011 Febbraio 2011 1 PRESENTAZIONE DEL CORSO aspetti organizzativi testo di riferimento modalità di valutazione obiettivi e struttura del
Economia del Settore Pubblico Emanuela Randon Lezione 1 a.a. 2010-2011 Febbraio 2011 1 PRESENTAZIONE DEL CORSO aspetti organizzativi testo di riferimento modalità di valutazione obiettivi e struttura del
Capitolo 4 Domanda individuale e domanda di mercato. Robert H. Frank Microeconomia - 5 a Edizione Copyright The McGraw-Hill Companies, srl
 Capitolo 4 Domanda individuale e domanda di mercato GLI EFFETTI DELLE VARIAZIONI DI PREZZO La curva prezzo-consumo per l abitazione rappresenta i panieri ottimali corrispondenti a tutti i possibili prezzi
Capitolo 4 Domanda individuale e domanda di mercato GLI EFFETTI DELLE VARIAZIONI DI PREZZO La curva prezzo-consumo per l abitazione rappresenta i panieri ottimali corrispondenti a tutti i possibili prezzi
CAPITOLO 9. La concorrenza perfetta
 CAPITOLO 9 La concorrenza perfetta 1 Mercati di concorrenza perfetta Un mercato di concorrenza perfetta è composto da imprese che producono beni identici e che vendono allo stesso prezzo. Il volume di
CAPITOLO 9 La concorrenza perfetta 1 Mercati di concorrenza perfetta Un mercato di concorrenza perfetta è composto da imprese che producono beni identici e che vendono allo stesso prezzo. Il volume di
ESERCITAZIONE 3: Produzione e costi
 MICROECONOMIA CEA A.A. 00-00 ESERCITAZIONE : Produzione e costi Esercizio (non svolto in aula ma utile): Rendimenti di scala Determinare i rendimenti di scala delle seguenti funzioni di produzione: a)
MICROECONOMIA CEA A.A. 00-00 ESERCITAZIONE : Produzione e costi Esercizio (non svolto in aula ma utile): Rendimenti di scala Determinare i rendimenti di scala delle seguenti funzioni di produzione: a)
SIMULAZIONE PROVA DI ECONOMIA POLITICA (PRIMA PARTE DEL PROGRAMMA: CAPP. 2,4,5,7,21) ANNO ACCADEMICO 2011/2012
 SIMULAZIONE PROVA DI ECONOMIA POLITICA (PRIMA PARTE DEL PROGRAMMA: CAPP. 2,4,5,7,21) ANNO ACCADEMICO 2011/2012 La prova d esame completa comprende 6 domande a risposta multipla più 4 esercizi articolati
SIMULAZIONE PROVA DI ECONOMIA POLITICA (PRIMA PARTE DEL PROGRAMMA: CAPP. 2,4,5,7,21) ANNO ACCADEMICO 2011/2012 La prova d esame completa comprende 6 domande a risposta multipla più 4 esercizi articolati
il costo in contabilità generale
 il costo in contabilità generale costi di acquisto di fattori produttivi e valori di diversa natura (tributi, permute, apporti, ammortamenti, ecc.) C.E. (-) valori classificati per origine costo calcolato
il costo in contabilità generale costi di acquisto di fattori produttivi e valori di diversa natura (tributi, permute, apporti, ammortamenti, ecc.) C.E. (-) valori classificati per origine costo calcolato
Capitolo 1 La macroeconomia come scienza. Mankiw, MACROECONOMIA, Zanichelli editore 2004 Capitolo 1: La macroeconomia come scienza 1
 Capitolo 1 La macroeconomia come scienza 1 Il percorso L oggetto di studio della macroeconomia: Quali sono i problemi importanti? I modelli macroeconomici: Che cosa sono Come si usano A che cosa servono
Capitolo 1 La macroeconomia come scienza 1 Il percorso L oggetto di studio della macroeconomia: Quali sono i problemi importanti? I modelli macroeconomici: Che cosa sono Come si usano A che cosa servono
1. Come si vive e lavora in Umbria: il posizionamento della regione nell ultimo decennio
 Estratto dal capitolo 1 della Relazione sullo stato di attuazione del programma di governo e sull amministrazione regionale RESOCONTO DI LEGISLATURA (Pubblicata nel S.S. del B.U.R. n. 10 del3 marzo 2010)
Estratto dal capitolo 1 della Relazione sullo stato di attuazione del programma di governo e sull amministrazione regionale RESOCONTO DI LEGISLATURA (Pubblicata nel S.S. del B.U.R. n. 10 del3 marzo 2010)
Indice. Presentazione. Capitolo 1
 Presentazione XIII Capitolo 1 Capitolo 2 Il sistema economico: i soggetti e le interdipendenze 1 1. Il sistema economico 1 2. La teoria economica 3 3. Un modello economico disaggregato: i comportamenti
Presentazione XIII Capitolo 1 Capitolo 2 Il sistema economico: i soggetti e le interdipendenze 1 1. Il sistema economico 1 2. La teoria economica 3 3. Un modello economico disaggregato: i comportamenti
Capitolo 17 Imposte personali e comportamenti individuali
 Capitolo 17 Imposte personali e comportamenti individuali In Italia, nell ultimo decennio, le aliquote e gli scaglioni dell imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati più volte modificati con
Capitolo 17 Imposte personali e comportamenti individuali In Italia, nell ultimo decennio, le aliquote e gli scaglioni dell imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati più volte modificati con
Mercati, domanda e offerta
 Mercati, domanda e offerta La Microeconomia La Microeconomia si interessa del comportamento economico delle unità individuali e della loro interazione all interno dei mercati: Consumatori/Famiglie Imprese/Banche
Mercati, domanda e offerta La Microeconomia La Microeconomia si interessa del comportamento economico delle unità individuali e della loro interazione all interno dei mercati: Consumatori/Famiglie Imprese/Banche
Lezioni di Economia Politica
 Università degli Studi ROMA TRE Facoltà di Giurisprudenza Lezioni di Economia Politica I principi fondamentali dell economia e gli strumenti per lo studio Giovanni Nicola De Vito - 2010 Microeconomia area
Università degli Studi ROMA TRE Facoltà di Giurisprudenza Lezioni di Economia Politica I principi fondamentali dell economia e gli strumenti per lo studio Giovanni Nicola De Vito - 2010 Microeconomia area
Federalismo fiscale: un confronto internazionale
 Federalismo fiscale: un confronto internazionale 1. Il tema del federalismo fiscale assume un rilievo sempre maggiore nel dibattito istituzionale e riveste un ruolo centrale nelle agende politiche di tutti
Federalismo fiscale: un confronto internazionale 1. Il tema del federalismo fiscale assume un rilievo sempre maggiore nel dibattito istituzionale e riveste un ruolo centrale nelle agende politiche di tutti
Capitolo cinque. La teoria del commercio internazionale. Una visione d insieme sulle teorie del commercio internazionale
 Capitolo cinque La teoria del commercio internazionale Una visione d insieme sulle teorie del commercio internazionale 5-3 Si ha libero scambio quando un governo non cerca di influenzare, con contingentamenti
Capitolo cinque La teoria del commercio internazionale Una visione d insieme sulle teorie del commercio internazionale 5-3 Si ha libero scambio quando un governo non cerca di influenzare, con contingentamenti
Indice della lezione. Incertezza e rischio: sinonimi? Le Ipotesi della Capital Market Theory UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA FACOLTA DI ECONOMIA
 UNIVERSIT DEGLI STUDI DI PRM FCOLT DI ECONOMI Indice della lezione Corso di Pianificazione Finanziaria Introduzione al rischio Rischio e rendimento per titoli singoli La Teoria di Portafoglio di Markowitz
UNIVERSIT DEGLI STUDI DI PRM FCOLT DI ECONOMI Indice della lezione Corso di Pianificazione Finanziaria Introduzione al rischio Rischio e rendimento per titoli singoli La Teoria di Portafoglio di Markowitz
IL QUADRO DELLA FISCALITÀ LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA
 IL QUADRO DELLA FISCALITÀ LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA Parma, 15 giugno 2013 Le entrate dei Comuni della provincia di Parma La finanza locale sta vivendo un periodo di profonda trasformazione e incertezza,
IL QUADRO DELLA FISCALITÀ LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA Parma, 15 giugno 2013 Le entrate dei Comuni della provincia di Parma La finanza locale sta vivendo un periodo di profonda trasformazione e incertezza,
Economia Politica (Mod I) Nota integrativa n. 4
 Economia Politica (Mod I) Nota integrativa n. 4 Premessa Studiando la curva di offerta e di domanda di un bene abbiamo visto che venditori e consumatori hanno la necessità di incontrarsi per vendere e
Economia Politica (Mod I) Nota integrativa n. 4 Premessa Studiando la curva di offerta e di domanda di un bene abbiamo visto che venditori e consumatori hanno la necessità di incontrarsi per vendere e
