LA MICRODUREZZA DELLA CELESTINA
|
|
|
- Damiano Abate
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, 89 (1982) pagg , ff. 2, tabb. 7. M. FRANZINI, M. TROYSI, A. CECCHINI C) LA MICRODUREZZA DELLA CELESTINA Riassunto - Le impronte di microdurezza Vickers eseguite sulla celestina si presentano sistematicamente deformate assumendo la forma di un rombo. Tale comportamento sembra imputabile al sistema di sfaldatura di questo minerale per cui,l'impronta sarebbe già deformata quando il penetratore è abbassato. Vengono riportati i dati Vickers e Knoop ottenuti su 6 campioni di celestina osservando come, anche in questo caso, sia difficile trovare una relazione tra i due tipi di penetratore. Abstract - Celestine microhardness. Vickers microhardness indentations, performed on celestine crystals, appear systematicaliy deformed according to a rhombic shape. Such a feature is probably related to the cleavage system oe the minerai and then the indentation is to be regarded as already deformed when the indenter is stili into the crystal. Vickers and Knoop microhardness data on six celestine samples are reported; they reveal the difficulty to find a clear relationship between Vickers and Knoop indenters for this minerai too. Key words - Celestine, Microhardness, Vickers, Knoop. 1 - PREMESSA In questa nota vengono riportati ed esaminati i dati di microdurezza Vickers e Knoop ottenuti su alcuni campioni di celestina. Le impronte Vickers eseguite su questo minerale appaiono sistematicamente deformate assumendo forma rombica. Si è ritenuto opportuno analizzare tale comportamento oltre che fornire dati accurati sul valore delle microdurezze Vickers e Knoop delle celestine. (") Dipartimento di Scienze della Terra dell'università di Pisa.
2 146 F RANZI NI M. - TROYSI A. - CECCHINI A. 2 - I CAMPIONI STUDIATI Sono stati presl m esame 6 campioni di celestina, tutti provenienti dal Museo di Mineralogia e Petrografia dell'università di Pisa; le loro caratteristiche morfologiche sono descritte in tabella 1. TABELLA Camp i one (L Co llez i one l ocalità Carattcl';stichc morfologichc Castrogl 0vanni Bav i era Ski lla Sicilia Crotone Crista l lo i nco lore. ad abito prisrnatico. con dil:'.cnsione mi" ss i ma di clrca 2 cm. Forma presente: Cr istallo di colore azzurro, abito pris~ tico. con dimens i one mass i ma di circa e.5 cm. Forme presc!nti: lod I} ; PO I ). Cr istallo i ncolore. ad ab i to prismati co. con dimensione massima di c'irca 1.3 cm. Forma presente: foll }. Cr istallo incolore. ad abito prisrnatico. con dimensione massima di circa 0.5 cm. Forma presente: {Oon. Cristall o incol ore. ad abito prisma.tico, con di mensione mass i ma di c,i rea 1.9 cm. Forma presente: ID I n Girge nti Cr is t il l,l o i nco lore, ild ilbito pr isma t ico. con di mensione mass i ma di circa 0.8 C!'l, FOnni! presente: I DATI RACCOLTI La metodologia di misura utilizzata è descritta in FRANZINI, TROYSI e CECCHINI (1981). Le impronte ottenute sui vari campioni sono ben definite e perfettamente misurabili. Raramente si osservano, per pesi superiori a 200 grammi, fratture che tuttavia non impediscono la corretta misurazione delle diagonali. I lati delle impronte Vickers appaiono quasi rettilinei con deboli concavità secondo l'orientazione dell'impronta. Nelle tabelle 2 e 3 vengono riportati i valori delle diagonali Vickers e Knoop misurate per i singoli pesi in orientazione a (diagonale dell'impronta - diagonale lunga per l'impronta Knoop - parallela al piano di simmetria sulla faccia) e nella orientazione b (diagonale ruotata di 45 rispetto all'orientazione a). Le impronte Vickers sono sistematicamente deformate nella orientazione a assumendo sempre l'aspetto di un rombo anziché di un quadrato_ Effetti simili di deformazione (con rapporto delle diagonali diverso da 1: 7) compaiono anche nelle impronte Knoop in orientazione «a» od in orientazione a questa perpendicolare (orientazione c). A causa della forma propria di rombo allungato delle impronte Knoop il fenomeno non è altrettanto facilmente
3 LA M ICRODU REZZA DELLA CELESTINA 1<!-1 TABELLA 2 Campione Fo,"", Orienta zione l} IDOl} a b a SIt b , a I b a b , b a b a , ~ b '--- TABELLA 3 Campione Forllld Oricnt azionc : looli nol ~ : R R notabile ma risulta ben evidente misurando ambedue le diagonali di questo tipo di impronte. Nonostante le deformazioni ora descritte le misure risultano altamente riproducibili con deviazioni standard dei valori riportati nelle tabb. 2 e 3 (medie di 4 misure) di 0.4 e 1IJ.m rispettivamente per dati Vickers e dati Knoop. Nelle tabelle 4 e 5 vengono riportati i valori di microdurezza estrapolata (HVE e HKE) e del ritiro elastico ((THVE e (THKE) calcolati secondo quanto suggerito da FRANZINI e TROYSI (1979) nonché, in tab. 4, i valori HV 1, HV 2, (T, PI ricavati utilizzando il modello proposto da FRANZINI, TROYSI e CECCHINI (1981).
4 148 FRANZINI M. - TROYSI A. - CECCHINI A. T ABELLA 4 Campione Forma Oricntazione HVE... ds HVC HV I HV 2 (j" P I I :, 116 I S. io I b , IIS b 12' :101:, b :, :001: 5 \011: i, b IIS ' IO' , 12' b , b ' a h ' TABELLA 5 Campione Forma Ori entaz i one!lke.. ds HKC I a I ~ b \loh a :'31 b , b !O11 1, : \ , b , b a b l'i , ~ 2.44 b DISCUSSIONE DEI DATI I valori HVE e HKE delle tabb. 4 e 5 sono contenuti in un ristretto intervallo di valori mettendo in evidenza che la microdurezza alla penetrazione della celestina è sostanzialmente uniforme in campioni e orientazioni diverse. Fanno eccezione i dati (J e HVE del campione n. 6 i cui valori anomali sono tuttavia imputabili alla sola misura eseguita con un carico di 500 g che fornisce un dato nettamente in contrasto con quanto ottenuto sugli altri campioni.
5 LA M ICRODUREZZA DELLA CELESTINA 149 Anche i valori di O" per la durezza Vickers (con la solita eccezione del campione n. 6) sono abbastanza simili come d'altronde risulta anche dalla constatazione che, per questo minerale, i valori di HV loo sono piuttosto costanti: la loro variazione è compresa fra 134 e 161 Km/mm 2 I valori medi delle coppie di valori HKE nelle orientazioni a e b sono assai simili ai corrispondenti valori medi delle coppie HVE con la tendenza ad essere leggermente superiori. Questo comportamento è coerente con quanto si è osservato in altri minerali a bassa durezza (FRANZINI, TROYSI e CECCHINI, 1982). Le variazioni di microdurezza in funzione del carico risultano sufficientemente ben interpretate dal modello di ritiro elastico proposto da Franzini e Troysi per i valori Knoop come risulta dai valori osservati della deviazione standard di HKC (colonna 3 tab. 5). Sulla base dell'errore di misura (si veda per il calcolo FRANZINI e TROYSI, 1980) si nota che la deviazione standard calcolata di HKC è di circa 2. Per i dati Vickers invece il valore calcolato di circa 1.7 risulta notevolmente più piccolo dei valori osservati della d.s. di HVC (colonna 3 tab. 4). In realtà, se si eccettua il campione n. 6, non ci sono prove del tutto conclusive che le variazioni della microdurezza Vickers con il carico debbano, nella celestina, essere interpretate con il modello proposto da Franzini, Troysi e Cecchini. Nella tabella 4 sono stati quindi riportati i valori HVI, HV2, 0", PI secondo il modello citato anche se è opinione degli Autori che un modello di ritiro elastico sia sufficientemente accurato per descrivere il comportamento della celestina. Nella figura 1 sono rappresentate, esagerandone l'effetto, le deformazioni sistematiche osservate nella forma dell'impronta Vickers in orientazione a sulle diverse facce cristalline studiate. La forma dell'impronta è coerente con la simmetria della faccia; nella tabella n. 6 sono dati, per il campione 4, i valori della diagonale (di) - valore medio di quattro misure indipendenti - parallela allo spigolo [100] e di qqella perpendicolare allo spigolo stesso (d 2). Per queste due serie di misure si possono calcolare separatamente i valori di O" e di HVE (rispettivamente HVEI-O"I e HVE2-0"2). Si ottengono due valori di O" sostanzialmente uguali, il ritiro elastico cioè assume gli stessi valori nelle due direzioni ortogonali considerate e se ne può perv.mto concludere che la deformazione osservata dell'impronta nùn è dovuta ad. una anisotropia
6 150 FRANZINI M. - TROYSr A. - CECCHINI A. 011 o 101 o 201 o Fig. 1 dell'elasticità residua dei mezzo sulla faccia cristallina presa in esame. Come dati di confronto sono state eseguite misure Knoop in orientazione c (diagonale lunga ortogonale alla orientazione a). L'anallsi di queste misure ha portato a calcolare ritiri elastici per l'orientazione c da 2 a 5 volte più grandi di quelli calcolati per l'orientazione a, mettendo ancora una volta in evidenza come sia difficile confrontare il comportamento della microdurezza Vickers con quello della Knoop. Nell'ultima colonna della tabella 6 sono dati i valori (rapp.) del rapporto tra le diagonali misurate aumentate del valore di 0"; è da notare che si ottengono dei rapporti abbastanza costanti il cui valore medio definisce la deformazione dell'impronta priva degli
7 LA MICRODUREZZA DELLA CELESTINA 151 effetti del ritiro elastico cioè la deformazione dell'impronta nel momento in cui il penetratore è abbassato. Gli stessi calcoli sono stati effettuati per gli altri campioni (assumendo sempre d! < d 2 ); il valore del rapporto fra le diagonali, come prima definito, è dato nella tabella 7 dalla quale appare come la deformazione dipenda sostanzialmente dalla faccia sulla quale sia stata eseguita!'impronta. TABELLA 6 Peso in 9 di d 2 rapp. 15 ~ , ì HVE 1 HVEZ 0'1 0'2 ds HVC1 ds HVCZ TABELLA 7 Campione Fo"", HVE 1 IlVEZ "' 1 "'2 ds HVC1 ds UVC2 rapp. 4 tooll t001} LI) 1 t20ù toll} {Oll} {Oll} DOl} L'analisi dei dati porta quindi a concludere che, nella celestina, l'impronta di microdurezza Vickers non è quadrata già nel momento in cui il penetrato re è inserito nel minerale secondo lo schema della figura n. 2. Una situazione analoga a quella della celestina risulta descritta nella letteratura soltanto da F. Gottardi per la calcite ed imputata a effetti di geminazione meccanica notoriamente facili in quest'ultimo minerale.
8 152 FRANZINI M. - TROYSI A. - CECCHINI A. VICKERS " " " \ " \ " \ 10 O Fig. 2 Non siamo in grado di dare una esauriente spiegazione dei meccanismi che nella celestina producono gli effetti osservati; una ipotesi possibile potrebbe essere che la causa prima sia da ricercarsi nei molteplici sistemi di sfaldatura propri di questo minerale. Con riferimento in particolare alla faccia (001) del campione 4 (nel quale il fenomeno risulta più evidente) si può osservare come la sezione dell'impronta su questo piano sia un rombo con angolo interno di circa 105 misurato direttamente sull'impronta con l'ausilio di un tavolino girevole montato sul microdurimetro, di circa 102 calcolato dalla misura delle diagonali (tab. 2), di circa calcolato dal valore 1.20 del rapporto dato in tabella 7 cioè relativo ipoteticamente all'impronta nel momento in cui il penetratore è inserito nel minerale. Questi valori sono da confrontare con l'angolo di formato dalle tracce di sfaldatura. Impronte eseguite su campioni di baritina e di anglesite hanno
9 LA MICRODUREZZA DELLA CELESTINA 153 mostrato, per uguali orientazioni, le stesse deformazioni sistematiche descritte nella celestina confermando l'interpretazione prima suggerita. 5 - CONCLUSIONI Le impronte Vickers di microdurezza alla penetrazione nella celestina presentano una deformazione sistematica, l'entità della quale dipende dall'orientazione del piano cristallino saggiato ed è condizionata probabilmente dalla geometria dei sistemi di sfaldatura propri di questo minerale. Nonostante tali deformazioni i valori di microdurezza sono ben riproducibili, costanti in campioni diversi, poco dipendenti dalla orientazione e dal tipo di penetrazione. Gli intervalli di valori osservati sono rispettivamente Kg/mm2 per HVE e Kg/mm2 per HKE. Secondo la relazione proposta da FRANZINI, TROYSI e CECCHINI (1982) i valori di microdurezza alla penetrazione della celestina corrisponderebbero a valori Mohs compresi fra 3.6 e 3.9. BIBLIOGRAFIA FRANZINI M., TROYSI M. (1979) - Macrohardness derivation from microhardness measurements. Rend. Acc. Naz. Lincei, Serie VIII, 65, FRANZINI M., TROYSI M. (1979) - L'effetto del ritiro elastico dell'impronta nelle misure di microdurezza alla penetrazione. II. Discussione ed interpretazione dei dati. Rend. Acc. Naz. Lincei, Serie VIII, 66, FRANZINI M., TROYSI M., CECCHINI A. (1981) - La variazione della microdurezza alla pene trazione in funzione del carico di misura. Rend. Acc. Naz. Lincei, in corso di stampa. FRANZINI M., TROYSI M., CECCHINI A. (1981) - La microdurezza della fluorite. Rend. Acc. Naz. Lincei, in corso di stampa. FRANZINI M., TROYSI M., CECCHINI A. (1982) - Una serie di minerali come termini di riferimento per la microdurezza alla penetrazione. Alti Soc. Tosc. SC. Nat., in corso di stampa. (ms. preso il 16 dicembre 1982; ult. bozze il lo luglio 1983)
I materiali. I materiali. Introduzione al corso. Tecnologia di produzione I materiali. La misura della durezza
 I materiali I materiali Introduzione al corso Tecnologia di produzione I materiali Le prove meccaniche distruttive Prove non distruttive La meccanica dei materiali 006 Politecnico di Torino 1 Obiettivi
I materiali I materiali Introduzione al corso Tecnologia di produzione I materiali Le prove meccaniche distruttive Prove non distruttive La meccanica dei materiali 006 Politecnico di Torino 1 Obiettivi
DUREZZA Nelle prime prove scala empirica qualitativa Mohs
 DUREZZA È la misura della resistenza opposta da un materiale alla deformazione plastica, ovvero a un penetratore o incisore. Nelle prime prove di durezza si usavano minerali naturali, la cui durezza era
DUREZZA È la misura della resistenza opposta da un materiale alla deformazione plastica, ovvero a un penetratore o incisore. Nelle prime prove di durezza si usavano minerali naturali, la cui durezza era
UNA SERIE DI MINERALI COME TERMINI DI RIFERIMENTO PER LA MICRODUREZZA ALLA PENETRAZIONE
 Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, 89 (1982) pagg. 27-45, 1. 1, tabb. 8. M. FRANZINI, M. TROYSI, A. CECCHINI ('"') UNA SERIE DI MINERALI COME TERMINI DI RIFERIMENTO PER LA MICRODUREZZA ALLA PENETRAZIONE
Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, 89 (1982) pagg. 27-45, 1. 1, tabb. 8. M. FRANZINI, M. TROYSI, A. CECCHINI ('"') UNA SERIE DI MINERALI COME TERMINI DI RIFERIMENTO PER LA MICRODUREZZA ALLA PENETRAZIONE
NYLON-CARBON DUREZZA & TRAZIONE
 NYLON-CARBON DUREZZA & TRAZIONE D R. F L A V I A N A C A L I G N A NO D R. M A S S I M O L O R U S S O D R. I G N A Z I O R O P P O L O N Y LO N - C A R BON PROVE DI DUREZZA E DI TRAZIONE INTRODUZIONE
NYLON-CARBON DUREZZA & TRAZIONE D R. F L A V I A N A C A L I G N A NO D R. M A S S I M O L O R U S S O D R. I G N A Z I O R O P P O L O N Y LO N - C A R BON PROVE DI DUREZZA E DI TRAZIONE INTRODUZIONE
INDAGINI CON MICRODUROMETRO VICKERS SU TRALICCIO PORTA ANTENNE TV E RADIO LOC. COLMA MARUCOLO DI ARTOGNE MONTECAMPIONE (BS)
 INDAGINI CON MICRODUROMETRO VICKERS SU TRALICCIO PORTA ANTENNE TV E RADIO LOC. COLMA MARUCOLO DI ARTOGNE MONTECAMPIONE (BS) PROVA N. 3560/VR 21 luglio 2009 Committente: Tecnico Interno: Relatore: XXXXXXXXXXX
INDAGINI CON MICRODUROMETRO VICKERS SU TRALICCIO PORTA ANTENNE TV E RADIO LOC. COLMA MARUCOLO DI ARTOGNE MONTECAMPIONE (BS) PROVA N. 3560/VR 21 luglio 2009 Committente: Tecnico Interno: Relatore: XXXXXXXXXXX
Durezza e prova di durezza
 Durezza Durezza e prova di durezza La durezza è una misura della resistenza di un metallo alla deformazione (plastica) permanente Procedura generale: Premere il penetratore, che è più duro del metallo,
Durezza Durezza e prova di durezza La durezza è una misura della resistenza di un metallo alla deformazione (plastica) permanente Procedura generale: Premere il penetratore, che è più duro del metallo,
SISTEMI DI PRODUZIONE
 SISTEMI DI PRODUZIONE Dario Antonelli Lezione A4 Introduzione alla lezione Cosa caratterizza uno strumento di misura? Quali sono i principali strumenti di misura usati in azienda? Come si misura la durezza?
SISTEMI DI PRODUZIONE Dario Antonelli Lezione A4 Introduzione alla lezione Cosa caratterizza uno strumento di misura? Quali sono i principali strumenti di misura usati in azienda? Come si misura la durezza?
Indice moduli. Indice lezioni del modulo A 15/02/2013. Sistemi di Produzione. A: I materiali B: Formatura. C: Deformazione.
 Sistemi di Produzione Dario Antonelli DIGEP Politecnico di Torino Indice moduli A: I materiali B: Formatura C: Deformazione D: Taglio E: Processi non convenzionali Indice lezioni del modulo A Introduzione
Sistemi di Produzione Dario Antonelli DIGEP Politecnico di Torino Indice moduli A: I materiali B: Formatura C: Deformazione D: Taglio E: Processi non convenzionali Indice lezioni del modulo A Introduzione
Assumendo 1 u = 1 cm, calcola il perimetro e l area del quadrilatero ABCD.
 Esercizio 1a Disegna un piano cartesiano ortogonale ed in esso inserisci i punti che seguono, poi uniscili nell ordine dato: Secondo te che tipo di quadrilatero hai ottenuto? Perché? Quali sono le sue
Esercizio 1a Disegna un piano cartesiano ortogonale ed in esso inserisci i punti che seguono, poi uniscili nell ordine dato: Secondo te che tipo di quadrilatero hai ottenuto? Perché? Quali sono le sue
LE PROVE DI DUREZZA SUI MATERIALI METALLICI 1
 asdf LE PROVE DI DUREZZA SUI MATERIALI METALLICI 21 September 2011 Le prove di durezza sui materiali metallici sono prove meccaniche atte ad attestarne, per l'appunto, la durezza. Partiamo da alcuni interrogativi
asdf LE PROVE DI DUREZZA SUI MATERIALI METALLICI 21 September 2011 Le prove di durezza sui materiali metallici sono prove meccaniche atte ad attestarne, per l'appunto, la durezza. Partiamo da alcuni interrogativi
LA PROVA DI COMPRESSIONE
 LA PROVA DI COMPRESSIONE La prova di compressione viene eseguita comprimendo un provino di forma cilindrica fra due superfici piane e parallele. In molte lavorazioni per deformazione plastica (stampaggio,
LA PROVA DI COMPRESSIONE La prova di compressione viene eseguita comprimendo un provino di forma cilindrica fra due superfici piane e parallele. In molte lavorazioni per deformazione plastica (stampaggio,
16/03/2016 SEZIONI SOTTILI
 SEZIONI SOTTILI Metodologia Come si ottiene una sezione sottile di una roccia; Quali sono gli strumenti per studiare una sezione sottile; Principi base di ottica mineralogica; Come si descrivono i minerali;
SEZIONI SOTTILI Metodologia Come si ottiene una sezione sottile di una roccia; Quali sono gli strumenti per studiare una sezione sottile; Principi base di ottica mineralogica; Come si descrivono i minerali;
tra le due facce del campione perpendicolari all asse y. Il campo elettrico E H
 EFFETTO HALL Mario Gervasio, Marisa Michelini, Lorenzo Santi Unità di Ricerca in Didattica della Fisica, Università di Udine Obiettivi: Misurare il coefficiente di Hall su campioni metallici ed a semiconduttore.
EFFETTO HALL Mario Gervasio, Marisa Michelini, Lorenzo Santi Unità di Ricerca in Didattica della Fisica, Università di Udine Obiettivi: Misurare il coefficiente di Hall su campioni metallici ed a semiconduttore.
TRACCIA DI STUDIO. Indici di dispersione assoluta per misure quantitative
 TRACCIA DI STUDIO Un indice di tendenza centrale non è sufficiente a descrivere completamente un fenomeno. Gli indici di dispersione assolvono il compito di rappresentare la capacità di un fenomeno a manifestarsi
TRACCIA DI STUDIO Un indice di tendenza centrale non è sufficiente a descrivere completamente un fenomeno. Gli indici di dispersione assolvono il compito di rappresentare la capacità di un fenomeno a manifestarsi
Esercizi di Probabilità e Statistica
 Esercizi di Probabilità e Statistica parte 1 Massimo Guerriero Ettore Benedetti Indice Esercizi Presentazione dei dati Misure di sintesi numerica Probabilità Distribuzioni teoriche di probabilità Distribuzione
Esercizi di Probabilità e Statistica parte 1 Massimo Guerriero Ettore Benedetti Indice Esercizi Presentazione dei dati Misure di sintesi numerica Probabilità Distribuzioni teoriche di probabilità Distribuzione
SEZIONI LUCIDE SOTTILI O ULTRASOTTILI PER LO STUDIO AL MICROSCOPIO OTTICO DELLE ROCCE CARBONATICHE
 Atti Soe. Tose. Sci. Nat., Mem., Serie A, 90 (1983) pagg. 9-13, 1 fig. A. BERTAGNINI, M. FRANZINI, C. GRATZIU, M. SPAMPINATO (*) SEZIONI LUCIDE SOTTILI O ULTRASOTTILI PER LO STUDIO AL MICROSCOPIO OTTICO
Atti Soe. Tose. Sci. Nat., Mem., Serie A, 90 (1983) pagg. 9-13, 1 fig. A. BERTAGNINI, M. FRANZINI, C. GRATZIU, M. SPAMPINATO (*) SEZIONI LUCIDE SOTTILI O ULTRASOTTILI PER LO STUDIO AL MICROSCOPIO OTTICO
Prof. Anna Paola Ercolani (Università di Roma) Lez Indicatori di dispersione
 Consentono di descrivere la variabilità all interno della distribuzione di requenza tramite un unico valore che ne sintetizza le caratteristiche CAMPO DI VARIAZIONE DIFFERENZA INTERQUARTILE SCOSTAMENTO
Consentono di descrivere la variabilità all interno della distribuzione di requenza tramite un unico valore che ne sintetizza le caratteristiche CAMPO DI VARIAZIONE DIFFERENZA INTERQUARTILE SCOSTAMENTO
INVALSI 2017: I RISULTATI DEL PIEMONTE
 INVALSI 2017: I RISULTATI DEL PIEMONTE a cura dell Osservatorio sul Sistema formativo piemontese SISFORM realizzato da IRES Piemonte e Regione Piemonte ARTICOLO 2/2017 di Luisa Donato Chi ha partecipato
INVALSI 2017: I RISULTATI DEL PIEMONTE a cura dell Osservatorio sul Sistema formativo piemontese SISFORM realizzato da IRES Piemonte e Regione Piemonte ARTICOLO 2/2017 di Luisa Donato Chi ha partecipato
Durezza. La geometria che caratterizza l indentatore determina il particolare tipo di prova
 Durezza Obiettivo della lezione: definire le modalità delle prove di durezza La durezza di un materiale è definita come la pressione di equilibrio che la superficie del solido riesce a sopportare a seguito
Durezza Obiettivo della lezione: definire le modalità delle prove di durezza La durezza di un materiale è definita come la pressione di equilibrio che la superficie del solido riesce a sopportare a seguito
Errori di misura Teoria
 Errori di misura Teoria a misura operazione di misura di una grandezza fisica, anche se eseguita con uno strumento precisissimo e con tecniche e procedimenti accurati, è sempre affetta da errori. Gli errori
Errori di misura Teoria a misura operazione di misura di una grandezza fisica, anche se eseguita con uno strumento precisissimo e con tecniche e procedimenti accurati, è sempre affetta da errori. Gli errori
Proprietà fisiche dei minerali osservabili a scala macroscopica
 Proprietà fisiche dei minerali osservabili a scala macroscopica Proprietà definibili mediante esame visuale Forma cristallina e abito Concrescimenti, geminazioni e striature Stato di aggregazione Lucentezza,
Proprietà fisiche dei minerali osservabili a scala macroscopica Proprietà definibili mediante esame visuale Forma cristallina e abito Concrescimenti, geminazioni e striature Stato di aggregazione Lucentezza,
Misure di dispersione (o di variabilità)
 08/04/014 Misure di dispersione (o di variabilità) Range Distanza interquartile Deviazione standard Coefficiente di variazione Misure di dispersione 7 8 9 30 31 9 18 3 45 50 x 9 range31-74 x 9 range50-941
08/04/014 Misure di dispersione (o di variabilità) Range Distanza interquartile Deviazione standard Coefficiente di variazione Misure di dispersione 7 8 9 30 31 9 18 3 45 50 x 9 range31-74 x 9 range50-941
SCHEDA 1. Con un pennarello segnate due punti sulla sfera, appoggiata sulla sua base.
 SCHEDA 1 GRUPPO........ Con un pennarello segnate due punti sulla sfera, appoggiata sulla sua base. 1) Disegnate la linea di minima distanza che unisce i due punti sulla superficie sferica. Provate con
SCHEDA 1 GRUPPO........ Con un pennarello segnate due punti sulla sfera, appoggiata sulla sua base. 1) Disegnate la linea di minima distanza che unisce i due punti sulla superficie sferica. Provate con
La matrice delle correlazioni è la seguente:
 Calcolo delle componenti principali tramite un esempio numerico Questo esempio numerico puó essere utile per chiarire il calcolo delle componenti principali e per introdurre il programma SPAD. IL PROBLEMA
Calcolo delle componenti principali tramite un esempio numerico Questo esempio numerico puó essere utile per chiarire il calcolo delle componenti principali e per introdurre il programma SPAD. IL PROBLEMA
Le sezioni piane del cubo
 Le sezioni piane del cubo Versione provvisoria 11 dicembre 006 1 Simmetrie del cubo e sezioni speciali Sezioni speciali si presentano in corrispondenza di piani perpendicolari agli assi di simmetria del
Le sezioni piane del cubo Versione provvisoria 11 dicembre 006 1 Simmetrie del cubo e sezioni speciali Sezioni speciali si presentano in corrispondenza di piani perpendicolari agli assi di simmetria del
Esercizi in preparazione all esame di. Laboratorio del corso di Principi di Informatica. Prof.sse M. Anselmo e R. Zizza. a.a.
 Esercizi in preparazione all esame di Laboratorio del corso di Principi di Informatica Prof.sse M. Anselmo e R. Zizza a.a. 2012/13 NOTA: E necessario salvare il file come .xlsx e inserire
Esercizi in preparazione all esame di Laboratorio del corso di Principi di Informatica Prof.sse M. Anselmo e R. Zizza a.a. 2012/13 NOTA: E necessario salvare il file come .xlsx e inserire
Classificazione Sigla identificazione Foglio 1 di 9 Prog. CNT Ris. III Arch R-0078 TITOLO
 in convenzione con Classificazione Sigla identificazione Foglio 1 di 9 Prog. CNT Ris. III Arch. +5 080101-R-0078 TITOLO DETERMINAZIONE DELLE DIMENSIONI, DELLO SPESSORE DEI SETTI E DELLE PARETI, DELLA PLANARITA
in convenzione con Classificazione Sigla identificazione Foglio 1 di 9 Prog. CNT Ris. III Arch. +5 080101-R-0078 TITOLO DETERMINAZIONE DELLE DIMENSIONI, DELLO SPESSORE DEI SETTI E DELLE PARETI, DELLA PLANARITA
Prepararsi alla Prova di matematica
 Scuola Media E. Fermi Prepararsi alla Prova di matematica Prove d esame di matematica Prof. Vincenzo Loseto 2013/ 2014 PROVA NUMERO 1 QUESITO 1 In un triangolo rettangolo la somma di un cateto e dell ipotenusa
Scuola Media E. Fermi Prepararsi alla Prova di matematica Prove d esame di matematica Prof. Vincenzo Loseto 2013/ 2014 PROVA NUMERO 1 QUESITO 1 In un triangolo rettangolo la somma di un cateto e dell ipotenusa
GIUSTIFICAZIONE TEORICA DELLA FORMULA DI PETRY MEDIANTE L ANALISI DIMENSIONALE
 M. G. BUSATO GIUSTIFICAZIONE TEORICA DELLA FORMULA DI PETRY MEDIANTE L ANALISI DIMENSIONALE NOTA TECNICA MGBSTUDIO.NET SOMMARIO La formula di Petry è una formula semiempirica che consente di stimare,
M. G. BUSATO GIUSTIFICAZIONE TEORICA DELLA FORMULA DI PETRY MEDIANTE L ANALISI DIMENSIONALE NOTA TECNICA MGBSTUDIO.NET SOMMARIO La formula di Petry è una formula semiempirica che consente di stimare,
3 Geometria delle masse e momento di 2 ordine 3.3 Ellisse centrale d inerzia e nocciolo centrale d inerzia
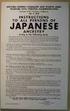 3 Geometria delle masse e momento di ordine ESERCIZI SVOLTI Considerata la sezione rappresentata in figura, calcolare i raggi d inerzia massimo e minimo, tracciare l ellisse d inerzia e il nocciolo centrale
3 Geometria delle masse e momento di ordine ESERCIZI SVOLTI Considerata la sezione rappresentata in figura, calcolare i raggi d inerzia massimo e minimo, tracciare l ellisse d inerzia e il nocciolo centrale
LABORATORIO DI CIRCUITI ELETTRICI Nozioni generali e guida agli esperimenti. Rappresentazione grafica dei risultati sperimentali
 LABORATORIO DI CIRCUITI ELETTRICI Nozioni generali e guida agli esperimenti Rappresentazione grafica dei risultati sperimentali Uno strumento molto utile per comunicare e leggere risultati sperimentali
LABORATORIO DI CIRCUITI ELETTRICI Nozioni generali e guida agli esperimenti Rappresentazione grafica dei risultati sperimentali Uno strumento molto utile per comunicare e leggere risultati sperimentali
RELAZIONE SULLA RESTITUZIONE DEI DATI INVALSI ANNO SCOLASTICO 2015/2016
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 SANT AGATA de GOTI Viale Vittorio Emanuele III - 82019 Sant Agata de Goti (BN) Tel./Fax 0823/953048 e-mail: bnic827002@istruzione.it - pec: bnic827002@pec.istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 SANT AGATA de GOTI Viale Vittorio Emanuele III - 82019 Sant Agata de Goti (BN) Tel./Fax 0823/953048 e-mail: bnic827002@istruzione.it - pec: bnic827002@pec.istruzione.it
Costruzioni geometriche. ( Teoria pag , esercizi 141 )
 Costruzioni geometriche. ( Teoria pag. 81-96, esercizi 141 ) 1) Costruzione con squadra e riga. a) Rette parallele. Ricorda ; due rette sono parallele quando.... oppure quando hanno la stessa. Matematicamente
Costruzioni geometriche. ( Teoria pag. 81-96, esercizi 141 ) 1) Costruzione con squadra e riga. a) Rette parallele. Ricorda ; due rette sono parallele quando.... oppure quando hanno la stessa. Matematicamente
ANALISI DELLE PRESTAZIONI DI ASSORBIMENTO ACUSTICO DI TENDAGGI IN CAMPO DIFFUSO E PER INCIDENZA NORMALE
 Associazione Italiana di Acustica 43 Convegno Nazionale Alghero, 25-27 maggio 216 ANALISI DELLE PRESTAZIONI DI ASSORBIMENTO ACUSTICO DI TENDAGGI IN CAMPO DIFFUSO E PER INCIDENZA NORMALE Nicola Granzotto
Associazione Italiana di Acustica 43 Convegno Nazionale Alghero, 25-27 maggio 216 ANALISI DELLE PRESTAZIONI DI ASSORBIMENTO ACUSTICO DI TENDAGGI IN CAMPO DIFFUSO E PER INCIDENZA NORMALE Nicola Granzotto
GEOMETRIA ANALITICA
 GEOMETRIA ANALITICA matematica@blogscuola.it LE COORDINATE CARTESIANE Quando si vuole fissare un sistema di coordinate cartesiane su una retta r, è necessario considerare: un punto O detto origine; un
GEOMETRIA ANALITICA matematica@blogscuola.it LE COORDINATE CARTESIANE Quando si vuole fissare un sistema di coordinate cartesiane su una retta r, è necessario considerare: un punto O detto origine; un
GEOMETRIA ANALITICA Prof. Erasmo Modica
 ISTITUTO PROVINCIALE DI CULTURA E LINGUE NINNI CASSARÀ SEZIONE DISTACCATA DI CEFALÙ CLASSE V C GEOMETRIA ANALITICA Prof. Erasmo Modica LE COORDINATE CARTESIANE Quando si vuole fissare un sistema di coordinate
ISTITUTO PROVINCIALE DI CULTURA E LINGUE NINNI CASSARÀ SEZIONE DISTACCATA DI CEFALÙ CLASSE V C GEOMETRIA ANALITICA Prof. Erasmo Modica LE COORDINATE CARTESIANE Quando si vuole fissare un sistema di coordinate
Esistono due tipologie tipo di frattura: duttile e fragile. Nel vetro si parla di frattura fragile (che avviene per propagazione veloce e instabile
 Esistono due tipologie tipo di frattura: duttile e fragile. Nel vetro si parla di frattura fragile (che avviene per propagazione veloce e instabile di un difetto). 1 2 3 4 La resistenza teorica di un materiale
Esistono due tipologie tipo di frattura: duttile e fragile. Nel vetro si parla di frattura fragile (che avviene per propagazione veloce e instabile di un difetto). 1 2 3 4 La resistenza teorica di un materiale
Costruzioni geometriche. (Teoria pag , esercizi )
 Costruzioni geometriche. (Teoria pag. 81-96, esercizi 141-153 ) 1) Costruzione con squadra e riga. a) Rette parallele. Ricorda: due rette sono parallele quando.... oppure quando hanno la stessa. Matematicamente
Costruzioni geometriche. (Teoria pag. 81-96, esercizi 141-153 ) 1) Costruzione con squadra e riga. a) Rette parallele. Ricorda: due rette sono parallele quando.... oppure quando hanno la stessa. Matematicamente
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE.
 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE. Indirizzo: MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA Materia: Tecnologia meccanica di processo e di prodotto Docente: Prof. Maugeri Agatino PROVE SUI MATERIALI Acireale 07/03/2016
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE. Indirizzo: MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA Materia: Tecnologia meccanica di processo e di prodotto Docente: Prof. Maugeri Agatino PROVE SUI MATERIALI Acireale 07/03/2016
DISTRIBUZIONE NORMALE (1)
 DISTRIBUZIONE NORMALE (1) Nella popolazione generale molte variabili presentano una distribuzione a forma di campana, bene caratterizzata da un punto di vista matematico, chiamata distribuzione normale
DISTRIBUZIONE NORMALE (1) Nella popolazione generale molte variabili presentano una distribuzione a forma di campana, bene caratterizzata da un punto di vista matematico, chiamata distribuzione normale
Quadrilateri. Il Parallelogramma
 Il Parallelogramma 2. Fai clic su Ic3 e scegli Retta per due punti : disegna la retta a. 3. Fai clic su Ic2 e scegli Nuovo Punto : fai clic fuori dalla retta a 4. Fai clic su Ic4 e scegli Retta parallela
Il Parallelogramma 2. Fai clic su Ic3 e scegli Retta per due punti : disegna la retta a. 3. Fai clic su Ic2 e scegli Nuovo Punto : fai clic fuori dalla retta a 4. Fai clic su Ic4 e scegli Retta parallela
La nuova lega di palladio a 950 è stata studiata con particolare attenzione per offrire le migliori caratteristiche alla lavorazione meccanica.
 La nuova lega di palladio a 950 è stata studiata con particolare attenzione per offrire le migliori caratteristiche alla lavorazione meccanica. Le sue proprietà più importanti sono qui riassunte: Elevata
La nuova lega di palladio a 950 è stata studiata con particolare attenzione per offrire le migliori caratteristiche alla lavorazione meccanica. Le sue proprietà più importanti sono qui riassunte: Elevata
Criteri di Valutazione della scheda (solo a carattere indicativo)
 Criteri di Valutazione della scheda (solo a carattere indicativo) Previsioni - A Sono state fatte le previsioni e discussi i valori attesi insieme al ragionamento con cui sono stati calcolati? E stata
Criteri di Valutazione della scheda (solo a carattere indicativo) Previsioni - A Sono state fatte le previsioni e discussi i valori attesi insieme al ragionamento con cui sono stati calcolati? E stata
Proprietà meccaniche. elasticità. resistenza. densità di legami chimici forza del legame
 Proprietà meccaniche elasticità r 0 resistenza densità di legami chimici forza del legame Anche le proprietà meccaniche dipendono sostanzialmente dai legami chimici presenti nel materiale. La curva che
Proprietà meccaniche elasticità r 0 resistenza densità di legami chimici forza del legame Anche le proprietà meccaniche dipendono sostanzialmente dai legami chimici presenti nel materiale. La curva che
In un triangolo altezza mediana bisettrice asse Proprietà di angoli e lati di un triangolo
 In un triangolo si dice altezza relativa a un lato il segmento di perpendicolare al lato condotta dal vertice opposto. Si dice mediana relativa a un lato il segmento che unisce il punto medio del lato
In un triangolo si dice altezza relativa a un lato il segmento di perpendicolare al lato condotta dal vertice opposto. Si dice mediana relativa a un lato il segmento che unisce il punto medio del lato
C6. Quadrilateri - Esercizi
 C6. Quadrilateri - Esercizi DEFINIZIONI E COSTRUZIONI 1) Dato il seguente quadrilatero completa al posto dei puntini. I lati AB e BC sono I lati AB e CD sono I lati AD e sono consecutivi I lati AD e sono
C6. Quadrilateri - Esercizi DEFINIZIONI E COSTRUZIONI 1) Dato il seguente quadrilatero completa al posto dei puntini. I lati AB e BC sono I lati AB e CD sono I lati AD e sono consecutivi I lati AD e sono
INVALSI 2015: I RISULTATI DEL PIEMONTE Sintesi estratta dal rapporto INVALSI 2015
 INVALSI 2015: I RISULTATI DEL PIEMONTE Sintesi estratta dal rapporto INVALSI 2015 a cura dell Osservatorio sul sistema formativo piemontese ARTICOLO 3/2015 Chi ha partecipato ai test Invalsi? SOMMARIO
INVALSI 2015: I RISULTATI DEL PIEMONTE Sintesi estratta dal rapporto INVALSI 2015 a cura dell Osservatorio sul sistema formativo piemontese ARTICOLO 3/2015 Chi ha partecipato ai test Invalsi? SOMMARIO
IEA TIMSS ADVANCED 2015
 Presentazione Indagine internazionale IEA TIMSS ADVANCED 2015 PRINCIPALI RISULTATI ITALIA GRADO 13 - Quinto anno scuola secondaria di secondo grado Roma, 6 dicembre 2016 L'indagine TIMSS Advanced (Trends
Presentazione Indagine internazionale IEA TIMSS ADVANCED 2015 PRINCIPALI RISULTATI ITALIA GRADO 13 - Quinto anno scuola secondaria di secondo grado Roma, 6 dicembre 2016 L'indagine TIMSS Advanced (Trends
La statistica. Elaborazione e rappresentazione dei dati Gli indicatori statistici. Prof. Giuseppe Carucci
 La statistica Elaborazione e rappresentazione dei dati Gli indicatori statistici Introduzione La statistica raccoglie ed analizza gruppi di dati (su cose o persone) per trarne conclusioni e fare previsioni
La statistica Elaborazione e rappresentazione dei dati Gli indicatori statistici Introduzione La statistica raccoglie ed analizza gruppi di dati (su cose o persone) per trarne conclusioni e fare previsioni
SIMULAZIONE TEST INVALSI
 SIMULAZIONE TEST INVALSI AREE POLIGONI Disegna nel piano quadrettato un rettangolo che abbia la stessa area del rettangolo ABCD, ma perimetro maggiore. Osserva il rettangolo. Sul lato DC segna il punto
SIMULAZIONE TEST INVALSI AREE POLIGONI Disegna nel piano quadrettato un rettangolo che abbia la stessa area del rettangolo ABCD, ma perimetro maggiore. Osserva il rettangolo. Sul lato DC segna il punto
L AREA DELLE PRINCIPALI FIGURE DELLA GEOMETRIA PIANA
 L AREA DELLE PRINCIPALI FIGURE DELLA GEOMETRIA PIANA Le formule per il calcolo dell area delle principali figure della geometria piana sono indispensabili per poter proseguire con lo studio della geometria.
L AREA DELLE PRINCIPALI FIGURE DELLA GEOMETRIA PIANA Le formule per il calcolo dell area delle principali figure della geometria piana sono indispensabili per poter proseguire con lo studio della geometria.
Misure di dispersione (o di variabilità)
 14/1/01 Misure di dispersione (o di variabilità) Range Distanza interquartile Deviazione standard Coefficiente di variazione Misure di dispersione 7 8 9 30 31 9 18 3 45 50 x = 9 range=31-7=4 x = 9 range=50-9=41
14/1/01 Misure di dispersione (o di variabilità) Range Distanza interquartile Deviazione standard Coefficiente di variazione Misure di dispersione 7 8 9 30 31 9 18 3 45 50 x = 9 range=31-7=4 x = 9 range=50-9=41
Istituto comprensivo di Carignano Scuola secondaria di I grado B. Alfieri Analisi dei dati INVALSI - A.S
 Istituto comprensivo di Carignano Scuola secondaria di I grado B. Alfieri Analisi dei dati INVALSI - A.S. 2014-2015 La tabella sottostante riporta i punteggi ottenuti nella prova di italiano dalle quattro
Istituto comprensivo di Carignano Scuola secondaria di I grado B. Alfieri Analisi dei dati INVALSI - A.S. 2014-2015 La tabella sottostante riporta i punteggi ottenuti nella prova di italiano dalle quattro
I poliedri SMS E. MAJORANA ROMA CLASSI 3F 3 H
 I poliedri SMS E. MAJORANA ROMA CLASSI 3F 3 H Cosa è un poliedro? Definizioni: Un poliedro è la parte di spazio delimitata da poligoni posti su piani diversi in modo tale che ogni lato sia comune a due
I poliedri SMS E. MAJORANA ROMA CLASSI 3F 3 H Cosa è un poliedro? Definizioni: Un poliedro è la parte di spazio delimitata da poligoni posti su piani diversi in modo tale che ogni lato sia comune a due
Misure di velocità con la guidovia a cuscino d aria (1)
 Misure di velocità con la guidovia a cuscino d aria (1) Obiettivo: Riprodurre un moto con velocità costante utilizzando la guidovia a cuscino d aria. Ricavare la tabella oraria e il grafico orario (grafico
Misure di velocità con la guidovia a cuscino d aria (1) Obiettivo: Riprodurre un moto con velocità costante utilizzando la guidovia a cuscino d aria. Ricavare la tabella oraria e il grafico orario (grafico
Solai e solette con armatura incrociata: comportamento e calcolo
 Solai e solette con armatura incrociata: comportamento e calcolo Consideriamo la piastra di figura a riferita a un sistema di assi cartesiani x e y, e in particolare le due strisce ortogonali t x e t y
Solai e solette con armatura incrociata: comportamento e calcolo Consideriamo la piastra di figura a riferita a un sistema di assi cartesiani x e y, e in particolare le due strisce ortogonali t x e t y
Soluzione esercizi Gara Matematica 2009
 Soluzione esercizi Gara Matematica 009 ( a cura di Stefano Amato, Emanuele Leoncini e Alessandro Martinelli) Esercizio 1 In una scacchiera di 100 100 quadretti, Carlo colora un quadretto di rosso, poi
Soluzione esercizi Gara Matematica 009 ( a cura di Stefano Amato, Emanuele Leoncini e Alessandro Martinelli) Esercizio 1 In una scacchiera di 100 100 quadretti, Carlo colora un quadretto di rosso, poi
Significatività ed analisi degli errori
 Significatività ed analisi degli errori Quanto il valore sperimentale è vicino al valore vero? Campioni replicati: si esclude a priori che venga eseguita una sola misurazione Quanto il valore sperimentale
Significatività ed analisi degli errori Quanto il valore sperimentale è vicino al valore vero? Campioni replicati: si esclude a priori che venga eseguita una sola misurazione Quanto il valore sperimentale
Statistica 1 A.A. 2015/2016
 Corso di Laurea in Economia e Finanza Statistica 1 A.A. 2015/2016 (8 CFU, corrispondenti a 48 ore di lezione frontale e 24 ore di esercitazione) Prof. Luigi Augugliaro 1 / 27 Numeri indici e rapporti statistici
Corso di Laurea in Economia e Finanza Statistica 1 A.A. 2015/2016 (8 CFU, corrispondenti a 48 ore di lezione frontale e 24 ore di esercitazione) Prof. Luigi Augugliaro 1 / 27 Numeri indici e rapporti statistici
Condizioni e tendenze del sistema produttivo siciliano
 Condizioni e tendenze del sistema produttivo siciliano 1. Le imprese attive Alla fine del 2011, in Sicilia erano attive poco meno di 381.000 imprese (le registrate erano oltre 463.000), in contrazione
Condizioni e tendenze del sistema produttivo siciliano 1. Le imprese attive Alla fine del 2011, in Sicilia erano attive poco meno di 381.000 imprese (le registrate erano oltre 463.000), in contrazione
Classifichiamo i poligoni
 Geometria La parola geometria significa misura (metria) della terra (geo). La geometria si occupa dello studio della misura e della forma degli oggetti disposti nello spazio. Le idee primitive (che vengono
Geometria La parola geometria significa misura (metria) della terra (geo). La geometria si occupa dello studio della misura e della forma degli oggetti disposti nello spazio. Le idee primitive (che vengono
Statistica Descrittiva Soluzioni 6. Indici di variabilità, asimmetria e curtosi
 ISTITUZIONI DI STATISTICA A A 2007/2008 Marco Minozzo e Annamaria Guolo Laurea in Economia del Commercio Internazionale Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese Università degli Studi di Verona
ISTITUZIONI DI STATISTICA A A 2007/2008 Marco Minozzo e Annamaria Guolo Laurea in Economia del Commercio Internazionale Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese Università degli Studi di Verona
EQUAZIONE DELLA RETTA
 EQUAZIONE DELLA RETTA EQUAZIONE DEGLI ASSI L equazione dell asse x è 0. L equazione dell asse y è 0. EQUAZIONE DELLE RETTE PARALLELE AGLI ASSI L equazione di una retta r parallela all asse x è cioè è uguale
EQUAZIONE DELLA RETTA EQUAZIONE DEGLI ASSI L equazione dell asse x è 0. L equazione dell asse y è 0. EQUAZIONE DELLE RETTE PARALLELE AGLI ASSI L equazione di una retta r parallela all asse x è cioè è uguale
Statistica - metodologie per le scienze economiche e sociali S. Borra, A. Di Ciaccio - McGraw Hill
 - metodologie per le scienze economiche e sociali S. Borra, A. Di Ciaccio - McGraw Hill Es. Soluzione degli esercizi del capitolo 8 home - indice In base agli arrotondamenti effettuati nei calcoli, si
- metodologie per le scienze economiche e sociali S. Borra, A. Di Ciaccio - McGraw Hill Es. Soluzione degli esercizi del capitolo 8 home - indice In base agli arrotondamenti effettuati nei calcoli, si
Le proprietà dei poligoni regolari. La similitudine tra figure piane. Il contenuto delle schede della sezione C e della scheda D1.
 D3 Le piramidi Che cosa imparerai Che cosa devi sapere Imparerai a costruire vari tipi di piramidi e ne scoprirai un importante proprietà. Le proprietà dei poligoni regolari. La similitudine tra figure
D3 Le piramidi Che cosa imparerai Che cosa devi sapere Imparerai a costruire vari tipi di piramidi e ne scoprirai un importante proprietà. Le proprietà dei poligoni regolari. La similitudine tra figure
Sistemi cristallini 1
 Sistemi cristallini Esercizio Calcolare la densità atomica definita come il rapporto tra il numero di atomi e il volume unitario per ) il litio sapendo che la distanza tra i centri dei primi vicini è R
Sistemi cristallini Esercizio Calcolare la densità atomica definita come il rapporto tra il numero di atomi e il volume unitario per ) il litio sapendo che la distanza tra i centri dei primi vicini è R
Φ D 2 L. k > 0. M O=A s. sistema (che è rappresentato in figura ). Infine, vogliamo calcolare le reazioni vincolari sul sistema.
 Esercizio 1. Un sistema materiale è costituito da una lamina piana omogenea di massa M e lato L e da un asta AB di lunghezza l e massa m. La lamina scorre con un lato sull asse x ed è soggetta a una forza
Esercizio 1. Un sistema materiale è costituito da una lamina piana omogenea di massa M e lato L e da un asta AB di lunghezza l e massa m. La lamina scorre con un lato sull asse x ed è soggetta a una forza
Determina il terzo vertice A di un triangolo di cui. l ortocentro
 La Retta Esercizi Esercizio 6. Determina il terzo vertice A di un triangolo di cui sono noti due vertici ; 1, 1; e l ortocentro ;. Soluzione 1 Analizziamo il problema ragionando, per semplicità, su un
La Retta Esercizi Esercizio 6. Determina il terzo vertice A di un triangolo di cui sono noti due vertici ; 1, 1; e l ortocentro ;. Soluzione 1 Analizziamo il problema ragionando, per semplicità, su un
INVALSI 2016: I RISULTATI DEL PIEMONTE
 INVALSI 2016: I RISULTATI DEL PIEMONTE Sintesi estratta dal rapporto INVALSI 2016 a cura dell Osservatorio sul Sistema formativo piemontese SISFORM realizzato da IRES Piemonte e Regione Piemonte ARTICOLO
INVALSI 2016: I RISULTATI DEL PIEMONTE Sintesi estratta dal rapporto INVALSI 2016 a cura dell Osservatorio sul Sistema formativo piemontese SISFORM realizzato da IRES Piemonte e Regione Piemonte ARTICOLO
STATISTICHE DESCRITTIVE Parte II
 STATISTICHE DESCRITTIVE Parte II INDICI DI DISPERSIONE Introduzione agli Indici di Dispersione Gamma Differenza Interquartilica Varianza Deviazione Standard Coefficiente di Variazione introduzione Una
STATISTICHE DESCRITTIVE Parte II INDICI DI DISPERSIONE Introduzione agli Indici di Dispersione Gamma Differenza Interquartilica Varianza Deviazione Standard Coefficiente di Variazione introduzione Una
Misure di campi magnetici: bobine di Helmholtz e solenoidi
 Misure di campi magnetici: bobine di Helmholtz e solenoidi - S.S., 12 Settembre 2007 - Per il calcolo del campo magnetico prodotto da una corrente che fluisce in un circuito di forma nota è utile servirsi
Misure di campi magnetici: bobine di Helmholtz e solenoidi - S.S., 12 Settembre 2007 - Per il calcolo del campo magnetico prodotto da una corrente che fluisce in un circuito di forma nota è utile servirsi
SCHEMA RIASSUNTIVO SUI QUADRILATERI
 SCHEMA RIASSUNTIVO SUI QUADRILATERI ( a cura della prof.sa Carmelisa Destradis ) SI CHIAMA QUADRILATERO UNA FIGURA PIANA CON QUATTRO LATI E QUATTRO ANGOLI. LA SOMMA DEGLI ANGOLI INTERNI DI QUALUNQUE QUADRILATERO
SCHEMA RIASSUNTIVO SUI QUADRILATERI ( a cura della prof.sa Carmelisa Destradis ) SI CHIAMA QUADRILATERO UNA FIGURA PIANA CON QUATTRO LATI E QUATTRO ANGOLI. LA SOMMA DEGLI ANGOLI INTERNI DI QUALUNQUE QUADRILATERO
Cristallochimica. Mineralogia 1
 Cristallochimica Mineralogia 1 Isomorfismo 1) Dimensione degli ioni vicarian8 2) Carica degli ioni 3) Temperatura e pressione 4) Grado di simmetria della stru@ura Soluzioni solide complete: olivine, plagioclasi,
Cristallochimica Mineralogia 1 Isomorfismo 1) Dimensione degli ioni vicarian8 2) Carica degli ioni 3) Temperatura e pressione 4) Grado di simmetria della stru@ura Soluzioni solide complete: olivine, plagioclasi,
GEOLOGIA (studio della litosfera) Essa si divide in MINERALOGIA (studio dei minerali) e PETROGRAFIA ( studio delle rocce)
 GEOLOGIA (studio della litosfera) Essa si divide in MINERALOGIA (studio dei minerali) e PETROGRAFIA ( studio delle rocce) I MINERALI I minerali sono sostanze solide omogenee, inorganiche, esprimibili mediante
GEOLOGIA (studio della litosfera) Essa si divide in MINERALOGIA (studio dei minerali) e PETROGRAFIA ( studio delle rocce) I MINERALI I minerali sono sostanze solide omogenee, inorganiche, esprimibili mediante
TOPOGRAFIA 2013/2014. Prof. Francesco-Gaspare Caputo
 TOPOGRAFIA 2013/2014 L operazione di misura di una grandezza produce un numero reale che esprime il rapporto della grandezza stessa rispetto a un altra, a essa omogenea, assunta come unità di misura. L
TOPOGRAFIA 2013/2014 L operazione di misura di una grandezza produce un numero reale che esprime il rapporto della grandezza stessa rispetto a un altra, a essa omogenea, assunta come unità di misura. L
Studio delle oscillazioni del pendolo semplice e misura dell accelerazione di gravita g.
 Studio delle oscillazioni del pendolo semplice e misura dell accelerazione di gravita g. Abstract (Descrivere brevemente lo scopo dell esperienza) In questa esperienza vengono studiate le proprieta del
Studio delle oscillazioni del pendolo semplice e misura dell accelerazione di gravita g. Abstract (Descrivere brevemente lo scopo dell esperienza) In questa esperienza vengono studiate le proprieta del
la velocità degli uccelli è di circa (264:60= 4.4) m/s)
 QUESTIONARIO 1. Si sa che certi uccelli, durante la migrazione, volano ad un altezza media di 260 metri. Un ornitologa osserva uno stormo di questi volatili, mentre si allontana da lei in linea retta,
QUESTIONARIO 1. Si sa che certi uccelli, durante la migrazione, volano ad un altezza media di 260 metri. Un ornitologa osserva uno stormo di questi volatili, mentre si allontana da lei in linea retta,
Cosa puoi dire del quadrilatero ABCD? Come sono i lati, le diagonali, gli angoli?
 Dal parallelogramma al rombo (fase 1 e 2) Fase 1 Disegna due circonferenze concentriche c e c di centro O; disegna su c un punto A e su c un punto B; traccia la retta r passante per i punti A e O, chiama
Dal parallelogramma al rombo (fase 1 e 2) Fase 1 Disegna due circonferenze concentriche c e c di centro O; disegna su c un punto A e su c un punto B; traccia la retta r passante per i punti A e O, chiama
Analisi dati termometrici
 Analisi dati termometrici REPORT FEBBRAIO 2016 Pagina 1 di 9 Elaborazione temperature medie mensili Metodologia Al fine di valutare le variazioni delle condizioni climatiche intervenute nel regime termico
Analisi dati termometrici REPORT FEBBRAIO 2016 Pagina 1 di 9 Elaborazione temperature medie mensili Metodologia Al fine di valutare le variazioni delle condizioni climatiche intervenute nel regime termico
3.2. Individuazione dell area di interesse ai fini della modellistica diffusionale
 Capitolo 3 Caratterizzazione delle sorgenti pag. 53 3.2. Individuazione dell area di interesse ai fini della modellistica diffusionale 3.2.1. Metodologia di individuazione dell area Ai fini dell individuazione
Capitolo 3 Caratterizzazione delle sorgenti pag. 53 3.2. Individuazione dell area di interesse ai fini della modellistica diffusionale 3.2.1. Metodologia di individuazione dell area Ai fini dell individuazione
Elementi di Statistica
 Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Ingegneria Informatica Informatica ed Elementi di Statistica 3 c.f.u. Anno Accademico 2010/2011 Docente: ing. Salvatore Sorce Elementi di Statistica Statistica
Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Ingegneria Informatica Informatica ed Elementi di Statistica 3 c.f.u. Anno Accademico 2010/2011 Docente: ing. Salvatore Sorce Elementi di Statistica Statistica
3 :
 COMPITI VACANZE 0 MATEMATICA CLASSE SECONDA Espressioni con le frazioni......... 0. Numeri decimali. Dopo aver stabilito che numero decimale puoi ottenere (osservando il denominatore), determina il numero
COMPITI VACANZE 0 MATEMATICA CLASSE SECONDA Espressioni con le frazioni......... 0. Numeri decimali. Dopo aver stabilito che numero decimale puoi ottenere (osservando il denominatore), determina il numero
Strumentazione e misura su sorgenti, e. valutazione dei livelli di esposizione
 Strumentazione e misura su sorgenti, e valutazione dei livelli di esposizione Andrea Guasti U.O.C. Fisica Sanitaria Azienda Ospedaliera Universitaria Senese G.TOCI G.TOCI G.TOCI G.TOCI G.TOCI G.TOCI
Strumentazione e misura su sorgenti, e valutazione dei livelli di esposizione Andrea Guasti U.O.C. Fisica Sanitaria Azienda Ospedaliera Universitaria Senese G.TOCI G.TOCI G.TOCI G.TOCI G.TOCI G.TOCI
DESCRITTIVE, TEST T PER IL CONFRONTO DELLE MEDIE DI CAMPIONI INDIPENDENTI.
 Corso di Laurea Specialistica in Biologia Sanitaria, Universita' di Padova C.I. di Metodi statistici per la Biologia, Informatica e Laboratorio di Informatica (Mod. B) Docente: Dr. Stefania Bortoluzzi
Corso di Laurea Specialistica in Biologia Sanitaria, Universita' di Padova C.I. di Metodi statistici per la Biologia, Informatica e Laboratorio di Informatica (Mod. B) Docente: Dr. Stefania Bortoluzzi
Analisi dati termometrici
 Analisi dati termometrici REPORT APRILE 2015 Pagina 1 di 9 Elaborazione temperature medie mensili Metodologia Al fine di valutare le variazioni delle condizioni climatiche intervenute nel regime termico
Analisi dati termometrici REPORT APRILE 2015 Pagina 1 di 9 Elaborazione temperature medie mensili Metodologia Al fine di valutare le variazioni delle condizioni climatiche intervenute nel regime termico
CAPITOLO 2 RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE DEI DATI
 VERO FALSO CAPITOLO 2 RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE DEI DATI V F 1. Una tabella base di frequenza contiene 2 colonne: una per i valori delle variabili d interesse e un altra per il numero delle volte che i
VERO FALSO CAPITOLO 2 RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE DEI DATI V F 1. Una tabella base di frequenza contiene 2 colonne: una per i valori delle variabili d interesse e un altra per il numero delle volte che i
Esercitazioni di statistica
 Esercitazioni di statistica Boxplot e numeri indici Stefania Spina Universitá di Napoli Federico II stefania.spina@unina.it 14 Ottobre 014 Stefania Spina Esercitazioni di statistica 1/37 Definizioni La
Esercitazioni di statistica Boxplot e numeri indici Stefania Spina Universitá di Napoli Federico II stefania.spina@unina.it 14 Ottobre 014 Stefania Spina Esercitazioni di statistica 1/37 Definizioni La
VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO PER INCIDENZA DIFFUSA UTILIZZANDO UNA SORGENTE SONORA DI POTENZA NOTA
 Associazione Italiana di Acustica 38 Convegno Nazionale Rimini, 08-10 giugno 2011 VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO PER INCIDENZA DIFFUSA UTILIZZANDO UNA SORGENTE SONORA DI POTENZA NOTA Paolo
Associazione Italiana di Acustica 38 Convegno Nazionale Rimini, 08-10 giugno 2011 VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO PER INCIDENZA DIFFUSA UTILIZZANDO UNA SORGENTE SONORA DI POTENZA NOTA Paolo
Uno spazio per lo spazio.
 Uno spazio per lo spazio. Il gruppo di matematica del Laboratorio Franco Conti ha lavorato quest anno nella direzione di ripensare l insegnamento della geometria dello spazio, unendo la riflessione teorica
Uno spazio per lo spazio. Il gruppo di matematica del Laboratorio Franco Conti ha lavorato quest anno nella direzione di ripensare l insegnamento della geometria dello spazio, unendo la riflessione teorica
quadrilatero generico parallelogramma rombo rettangolo quadrato
 Pavimentare 1. Quali forme di quadrilateri puoi costruire? Schizza tutte le forme possibili e scrivi il loro nome. 2. Cosa rappresentano i piccoli punti rossi sui lati del quadrilatero? 3. a) Costruisci
Pavimentare 1. Quali forme di quadrilateri puoi costruire? Schizza tutte le forme possibili e scrivi il loro nome. 2. Cosa rappresentano i piccoli punti rossi sui lati del quadrilatero? 3. a) Costruisci
Emissione 5 25/11/2011 Approvazione DCRB Pagina 1 di 8
 Emissione 5 25/11/2011 Approvazione DCRB Pagina 1 di 8 PROGRAMMA DI VEQ PER A. Organizzazione del Programma MATERIALI DI CONTROLLO: sono costituiti da matrici naturali di origine umana e sono spediti ai
Emissione 5 25/11/2011 Approvazione DCRB Pagina 1 di 8 PROGRAMMA DI VEQ PER A. Organizzazione del Programma MATERIALI DI CONTROLLO: sono costituiti da matrici naturali di origine umana e sono spediti ai
ESERCITAZIONE 1 ESTENSIMETRIA
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI FACOLTA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DIPARTIMENTO DI MECCANICA, CHIMICA E MATERIALI CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA ESERCITAZIONE 1 ESTENSIMETRIA Relazione del
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI FACOLTA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DIPARTIMENTO DI MECCANICA, CHIMICA E MATERIALI CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA ESERCITAZIONE 1 ESTENSIMETRIA Relazione del
11.4 Chiusura transitiva
 6 11.4 Chiusura transitiva Il problema che consideriamo in questa sezione riguarda il calcolo della chiusura transitiva di un grafo. Dato un grafo orientato G = hv,ei, si vuole determinare il grafo orientato)
6 11.4 Chiusura transitiva Il problema che consideriamo in questa sezione riguarda il calcolo della chiusura transitiva di un grafo. Dato un grafo orientato G = hv,ei, si vuole determinare il grafo orientato)
Confronto tra lo Specchio Lineare ed i collettori solari termici standard
 Confronto tra lo Specchio Lineare ed i collettori solari termici standard Isomorph srl Luglio 2011 1. Introduzione In questa nota si descrive il confronto tra un collettore tradizionale piano, un tubo
Confronto tra lo Specchio Lineare ed i collettori solari termici standard Isomorph srl Luglio 2011 1. Introduzione In questa nota si descrive il confronto tra un collettore tradizionale piano, un tubo
Conoscenze. 2. Segna il completamento esatto. a. L area della superficie laterale di un prisma si calcola utilizzando la seguente formula:
 Conoscenze 1. Completa. a. Un prisma è un... limitato da due...e... e da tanti...quanti sono i lati del... b. Un prisma è retto se... c. Un prisma è regolare se... d. L altezza di un prima è la... 2. Segna
Conoscenze 1. Completa. a. Un prisma è un... limitato da due...e... e da tanti...quanti sono i lati del... b. Un prisma è retto se... c. Un prisma è regolare se... d. L altezza di un prima è la... 2. Segna
PROIEZIONI ORTOGONALI: SEZIONI CONICHE
 www.aliceappunti.altervista.org PROIEZIONI ORTOGONALI: SEZIONI CONICHE 1) PREMESSA: Il cono è una superficie generata da una retta con un estremo fisso e l altro che ruota. La retta prende il nome di GENERATRICE.
www.aliceappunti.altervista.org PROIEZIONI ORTOGONALI: SEZIONI CONICHE 1) PREMESSA: Il cono è una superficie generata da una retta con un estremo fisso e l altro che ruota. La retta prende il nome di GENERATRICE.
TEORIA DEGLI ERRORI DI MISURA, IL CALCOLO DELLE INCERTEZZE
 TEORIA DEGLI ERRORI DI MISURA, IL CALCOLO DELLE INCERTEZZE Errore di misura è la differenza fra l indicazione fornita dallo strumento e la dimensione vera della grandezza. Supponendo che la grandezza vera
TEORIA DEGLI ERRORI DI MISURA, IL CALCOLO DELLE INCERTEZZE Errore di misura è la differenza fra l indicazione fornita dallo strumento e la dimensione vera della grandezza. Supponendo che la grandezza vera
PAROLE CHIAVE Accuratezza, Accuracy, Esattezza, PRECISIONE, Precision, Ripetibilità, Affidabilità, Reliability, Scarto quadratico medio (sqm), Errore
 PAROLE CHIAVE Accuratezza, Accuracy, Esattezza, PRECISIONE, Precision, Ripetibilità, Affidabilità, Reliability, Scarto quadratico medio (sqm), Errore medio, Errore quadratico medio (eqm), Deviazione standard,
PAROLE CHIAVE Accuratezza, Accuracy, Esattezza, PRECISIONE, Precision, Ripetibilità, Affidabilità, Reliability, Scarto quadratico medio (sqm), Errore medio, Errore quadratico medio (eqm), Deviazione standard,
LE COORDINATE CARTESIANE
 CORSO ZERO DI MATEMATICA per Ing. Chimica e Ing. delle Telecomunicazioni GEOMETRIA ANALITICA Prof. Erasmo Modica erasmo@galois.it LE COORDINATE CARTESIANE Quando si vuole fissare un sistema di coordinate
CORSO ZERO DI MATEMATICA per Ing. Chimica e Ing. delle Telecomunicazioni GEOMETRIA ANALITICA Prof. Erasmo Modica erasmo@galois.it LE COORDINATE CARTESIANE Quando si vuole fissare un sistema di coordinate
Capitolo 12. Suggerimenti agli esercizi a cura di Elena Siletti. Esercizio 12.1: Suggerimento
 Capitolo Suggerimenti agli esercizi a cura di Elena Siletti Esercizio.: Suggerimento Per verificare se due fenomeni sono dipendenti in media sarebbe necessario confrontare le medie condizionate, in questo
Capitolo Suggerimenti agli esercizi a cura di Elena Siletti Esercizio.: Suggerimento Per verificare se due fenomeni sono dipendenti in media sarebbe necessario confrontare le medie condizionate, in questo
