Identificazione e intervento precoce per i disturbi di apprendimento: un'analisi della ricerca scientifica. Sergio Di Sano
|
|
|
- Liliana Chiesa
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Convegno DSA: lo stato dell arte. Istituzioni, didattica, riabilitazione e utenza a confronto Vasto Marina, 27 febbraio 2013 Identificazione e intervento precoce per i disturbi di apprendimento: un'analisi della ricerca scientifica Sergio Di Sano Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche
2 1. Lingue trasparenti e lingue opache ARGOMENTI 2. Ruolo degli aspetti visivi e dell attenzione 3. Identificazione precoce e intervento
3 Lingue trasparenti e lingue opache Argomenti Sviluppo della lettura in inglese Sviluppo della lettura in italiano Difficoltà di lettura Esistono tipi diversi di dislessia in ortografie regolari Esiste un deficit fonologico comune per la dislessia? La lettura nei bambini italiani con deficit di lettura
4 Lingue opache e trasparenti Variazioni nel grado di trasparenza dell ortografia Applicazione delle regole di conversione grafemafonema Lingue opache Inglese, francese, danese, ebraico Lingue trasparenti Finlandese, tedesco, italiano, spagnolo Esempio: omofoni non omografi Inglese: here (qui) e hear (sentire) Italiano: hanno e anno
5 Lingue opache e trasparenti Parole lette correttamente a fine prima (Seymour et al. 2003) Lingue a ortografia regolare: 95-98% Lingue irregolari Inglese: 34% Danese: 71% Francese: 79%
6 Sviluppo della lettura in inglese Nei primi anni i bambini di lingua inglese fanno molti errori di decodifica La competenza fonologica risulta essenziale per la riduzione degli errori Errori immaturi (tirare a indovinare da pochi indizi): per un anno e più
7 Sviluppo della lettura in italiano A fine prima i bambini leggono correttamente il 90% delle parole La lettura è lenta ci vogliono anni per migliorare la velocità di lettura Questo aumento di velocità è dovuto al ricorso alle conoscenza lessicali Fin dalla seconda emerge un effetto lessicalità Maggiore velocità (e meno errori) per le parole rispetto alle non parole (Tressoldi, 1996)
8 Sviluppo della lettura in italiano Altri effetti riscontrati nei bambini piccoli in Italia (Barca et al. 2007) Effetto di frequenza Effetto di immaginabilità Effetto di età di acquisizione Questi effetti: influenze lessicali sulla lettura Anche nelle lingue trasparenti si sfruttano ben presto le conoscenze lessicali per rendere la lettura più fluida La scarsa variabilità degli errori Indice di velocità è una misura più sensibile rispetto al numero di errori
9 La difficoltà di lettura Studi per la lingua inglese Due vie Lessicale Sublessicale Due tipi di dislessia Dislessia fonologica Dislessia superficiale Deficit prevalente di origine fonologica per la dislessia
10 La difficoltà di lettura: due domande Esistono anche per le lingue trasparenti profili diversi di dislessia, es. superficiale e fonologica? Il disturbo di lettura è interpretabile in chiave prettamente fonologica?
11 Esistono anche per le lingue trasparenti profili diversi di dislessia? In italiano non ci sono parole adatte (irregolari, omofoni non omografi) per individuare gli errori lessicali Compiti: l ira/lira oppure l ago/lago In italiano non ci sono dati che dimostrano una dissociazione tra componenti lessicali e non lessicali Es. caduta selettiva alle non parole
12 Hendriks e Kolk (1997) Esistono anche per le lingue trasparenti profili diversi di dislessia? Se si fornisce l istruzione di leggere velocemente Dislessici fonologici Se si fornisce l istruzione di leggere accuratamente Dislessici superficiali
13 Il disturbo di lettura è interpretabile in chiave prettamente fonologica? Un marcatore della difficoltà fonologica Difficoltà a leggere le non parole Nelle lingue trasparenti, i bambini con difficoltà di lettura hanno problemi con le non parole? non più di quanto accade per i lettori abili
14 Il disturbo di lettura è interpretabile in chiave prettamente fonologica? I pazienti dislessici cadono in prove di tipo fonologico e di metafonologico? Ci sono bambini dislessici che non cadono in queste prove Bambini che cadono in questa prove senza essere dislessici (Angelelli et al. 2004) I deficit fonologici e metafonologici sono associati con un disturbo pregresso del linguaggio Ma non specificamente con un deficit di lettura (Brizzolara et al. 2006)
15 I dislessici italiani La lettura può essere accurata o quasi La velocità risulta in genere carente Ricerche su bambini italiani con deficit di lettura (Paizi et al. 2010) Movimenti oculari (saccadi): normolettori Variano in base all ampiezza della parola successiva La maggior parte delle parole è fissata una volta sola Le parole grammaticali (funtori) spesso non vengono fissate L attenzione è in genere posta sulle parole contenuto
16 La partita Џ molto combattuta perchћ le due squadre tentano di vincere fino all'ultimo minuto. Era l'ultima giornata del campionato e il risultato era molto importante per la classifica finale. La partita Џ molto combattuta perchћ le due squadre tentano di vincere fino all'ultimo minuto. Era l'ultima giornata del campionato e il risultato era molto importante per la classifica finale.
17
18 Se si analizzano i tempi di reazione vocale Nei dislessici, effetti più grandi di lunghezza della parola
19 elem 2 elem 3 elem N=9 dislessici 3ª elementare lettere
20 I dislessici italiani Analizzano porzioni piccole di parole Ricerche su bambini italiani con deficit di lettura (Paizi et al. 2010) Sono influenzati dalla lunghezza della parola Questo vuol dire che usano la via sublessicale? In realtà, i dislessici italiani usano gli stessi meccanismi di facilitazione lessicale dei normolettori (Paizi et al. 2010)
21 Nei dislessici presenza di effetti di Lessicalità (es casa vs cusa) Frequenza (cavallo vs coralllo) Vicinanza ortografica, Ricerche su bambini italiani con deficit di lettura (Paizi et al. 2010) Sensibilità alle variazioni contestuali, ma solo per parole a bassa frequenza (es, giglio) Capacità di usare unità lessicali di lettura quali i morfemi (es. donnista vs dennosta) (Burani et al.2002)
22 Per quale ragione i dislessici italiani hanno tempi di lettura molto più lenti dei normolettori? La differenza può essere legata alle prime fasi di elaborazione percettiva (prelessicale) dello stimolo linguistico Zoccolotti et al. (2006) Lettura a tempo di stimoli di diversa lunghezza in quattro condizioni Immediatamente Dopo 500ms Dopo 1 sec Dopo 2 sec Con l aumentare del tempo si riduce il divario con i normolettori e anche l effetto lunghezza
23 2. Ruolo degli aspetti visivi e dell attenzione Ipotesi del sistema visivo magnocellulare Analisi percettiva di stimoli in movimento Ipotesi del crowding (affollamento visivo)
24
25 Ipotesi visive Ipotesi del crowding (affollamento visivo) Difficoltà a riconoscere uno stimolo bersaglio circondato da stimoli vicini Una lettere in una posizione periferica è leggibile se abbastanza grande e se accanto a essa non ci sono altre lettere a una distanza critica I bambini con dislessia sarebbero sensibili all interazione tra lettere Il disturbo sarebbe di tipo percettivo e si collocherebbe a un livello prelinguistico
26
27
28
29 Franceschini et al bambini con dislessia (età media 10 anni) 10 bambini sono stati addestrati per 12 ore in totale, con i videogiochi d'azione (AVG). Ci sono stati 9 sessioni di 80 minuti (con una pausa nel mezzo) all'interno di due settimane. I videogiochi erano minigiochi selezionati in base alle loro caratteristiche tra quelle che compongono i Rabbids Wii videogioco Rayman Raving
30
31 Franceschini et al bambini sono stati addestrati per 12 ore in totale, con il videogiochi non-di-azione giochi Ci sono stati 9 sessioni di 80 minuti (con una pausa nel mezzo) all'interno di due settimane. I videogiochi erano minigiochi selezionati in base alle loro caratteristiche tra quelle che compongono i Rabbids Wii videogioco Rayman Raving
32 Franceschini et al 2013 Tutti i partecipanti sono stati testati sulla loro lettura, fonologica e le capacità attentive, prima e dopo l'allenamento videogiochi. Solo i videogiochi di azione hanno migliorato l attenzione visiva spaziale focalizzata e distribuita (sistema di orientamento) nei bambini con dislessia Solo i videogiochi di azione hanno migliorato anche l attenzione temporale cross-modale (sistema di allarme) nei bambini con dislessia
33 Cambiamenti nei due gruppi Sill/Sec gain text NAVGp AVGp NAVGp AVGp Sill/Sec gain pseudo-words NAVGp AVGp
34 3. Identificazione precoce e intervento Argomenti Lavori longitudinali Effetto Matthew
35 Fattori genetici e ambientali L obiettivo delle ricerche sulla dislessia è quella di aiutare i bambini con gravi difficoltà di lettura. A tal fine risulta importante identificare precocemente i bambini a rischio (Lyytinen et al., 2008) Sappiamo che la dislessia non è un fenomeno unitario ma ci si arriva attraverso diverse strade che per lo più coinvolgono difficoltà linguistiche.
36 Fattori genetici e ambientali I fattori genetici (Rutter et al (1997) possono interagire con quelli ambientali in tre modi Ambiente passivo creato dai geni (genitore) Ambiente evocativo dovuto ai geni (le caratteristiche ereditate dal bambino) Ambiente attivo (esperienze e ambienti creati dal bambino in funzione del suo patrimonio genetico
37 lo studio longitudinale Jyväskylä (Finlandia) della dislessia (JLD) Lo studio JLD ha seguito, per più di 10 anni a partire dalla nascita, lo sviluppo di Bambini a rischio per la dislessia (R) Controlli non a rischio (NR) Poi alla fine della terza è stata fatta la diagnosi di dislessia Il 50% dei bambini nati da un genitore con la dislessia evidenziavano rilevanti difficoltà di lettura nei primi tre anni di scuola Circa il 30% risulta dislessico
38 lo studio longitudinale Jyväskylä (Finlandia) della dislessia (JLD) Molfese et al (2008), in uno studio longitudinale riporta che 38% di bambini finlandesi con storia familiare di dislessia sviluppavano disturbi di lettura 12% di bambini senza storia familiare di dislessia (conosciuta) avevano disturbi di lettura
39 Vellutino et al (2006) lo studio longitudinale Jyväskylä (Finlandia) della dislessia (JLD) Effetti di un intervento precoce su bambini identificati come potenzialmente «a rischio» di dislessia all inizio del kindergarten Un intervento precoce basato su attività in piccolo gruppo Consapevolezza dello stampato Consapevolezza fonologica Associazione lettera-suono Benefici sulle abilità precoci e sul successivo sviluppo della lettura
40 Molfese e Molfese (2002) lo studio longitudinale Jyväskylä (Finlandia) della dislessia (JLD) Influenza dei fattori sociali e familiari Pratiche di parenting Attività familiari Linguaggio parlato a casa Esposizione a libri e riviste Status socio-economico Questi fattori non causano la dislessia ma possono esacerbarla
41 lo studio longitudinale Jyväskylä (Finlandia) della dislessia (JLD) L identificazione precoce è possibile anche se bambini diversi seguono strade diverse Lyytinen et al (2006) Approccio «mixture modelling» Esaminare bambini con traiettorie simili
42 lo studio longitudinale Jyväskylä (Finlandia) della dislessia (JLD) Le misure di linguaggio/alfabetizzazione sono stata raggruppate in sette domini di abilità Abilità recettive Abilità di linguaggio espressivo Abilità di morfologia flessiva Memoria Recupero efficiente di parole dalla memoria Conoscenza di lettere Consapevolezza fonologica
43 lo studio longitudinale Jyväskylä (Finlandia) della dislessia (JLD) In questo modo sono stati estratti quattro percorsi (o traiettorie) di sviluppo: Declino della fonologia (11R 2NR) Disfluente (11R 1NR) Lento nella velocità di denominazione Tipico (38R 47NR) Sviluppo relativamente positivo Inatteso (33R e 34NR ) Forti sviluppo nelle abilità linguistiche precoci
44 lo studio longitudinale Jyväskylä (Finlandia) della dislessia (JLD) I bambini che risultavano dislessici a fine II erano 43 (35 bambini, pari al 33%, per il gruppo a rischio. Lo studio ha individuato diversi indici precoci che predicono lo sviluppo successivo nelle abilità di lettura Categorizzazione dei suoni Gioco simbolico Esperienza di lettura condivisa Linguaggio espressivo e recettivo Abilità fonologiche Abilità nella morfologia flessiva
45 lo studio longitudinale Jyväskylä (Finlandia) della dislessia (JLD) A partire dai 3 anni le abilità fonologiche predicono le difficoltà di lettura altrettanto quanto quelle linguistiche (Puolakanaho et al. 2004) In uno studio successivo Le abilità di accuratezza in lettura e scrittura in seconda sono previste per il 50% della varianza dalle abilità linguistiche e fonologiche a 3, 4 e 5 anni Le abilità di fluenza in lettura e scrittura in seconda sono previste per il 30% della varianza dalle abilità linguistiche e fonologiche insieme con quelle di denominazione di lettere
46 lo studio longitudinale Jyväskylä (Finlandia) della dislessia (JLD) Lyytinen et al (2003) le madri dei bambini non a rischio si impegnavano di più nel gioco simbolico con il figlio all età di 14, 18 e 30 mesi e questo contribuiva al suo sviluppo del linguaggio
47 lo studio longitudinale Jyväskylä (Finlandia) della dislessia (JLD) I bambini non a rischio che a 14 e 24 mesi si impegnavano maggiormente nella lettura condivisa poi ne beneficiavano nel successivo sviluppo del linguaggio e nella conoscenza delle lettere. I bambini che avevano un maggiore interesse per la lettura erano quelli ai quali si leggeva di più e avevano migliori abilità linguistiche a 14 e 24 mesi (Lyytinen et al., 1998)
48 lo studio longitudinale Jyväskylä (Finlandia) della dislessia (JLD) L influenza dell ambiente di alfabetizzazione a casa e dell interesse per l alfabetizzazione sullo sviluppo della consapevolezza fonologica (Torppa et al, 2007) Più il bambino si impegna nella lettura condivisa con i genitori Maggiore il suo interesse per la lettura Più rapido il suo sviluppo del vocabolario Migliore la consapevolezza fonologica
49 lo studio longitudinale Jyväskylä (Finlandia) della dislessia (JLD) L apprendimento dell associazione letterasuono a 3-5 anni e la conoscenza delle lettere a 5 anni, è l indice più predittivo delle abilità di lettura, soprattutto quando combinato con misure di denominazione rapida (RAN) (Lyytinen, 2007).
50 lo studio longitudinale Jyväskylä (Finlandia) della dislessia (JLD) Knight et al (2009) fin dai tre anni di età, possiamo notare problemi nello sviluppo Linguaggio orale Consapevolezza fonologica Abilità motorie Questi bambini sono a rischio per lo sviluppo delle abilità di lettura Alcuni comunque diventeranno dislessici Altri comunque beneficeranno da un intervento precoce
51 lo studio longitudinale Jyväskylä (Finlandia) della dislessia (JLD) I bambini di status sociale più basso hanno un ridotto vocabolario, e questo è predittivo di una prestazione in lettura più bassa in terza (Hart e Risley, 2003) L approccio RTI Identificazione Intervento
52
53
54 Effetto Matthew per la lettura
55 Effetto Matthew nella lettura Stanovich (1986) I bambini che leggono meglio e hanno un vocabolario migliore leggeranno di più e quindi impareranno più parole e quindi leggeranno ancora meglio I bambini che apprendono presto le abilità connesse alla lettura sono avvantaggiati nell'acquisire in futuro ulteriori abilità Le difficoltà nell'apprendere la lettura entro il terzo o quarto anno di istruzione scolastica comportano problemi nell'acquisire ulteriori capacità. Effetto di accumulo delle differenze: Effetto ventaglio (Fan effect): la distanza tra i più bravi e i meno bravi cresce con il tempo
56 Stanovich (1986) Matthew effects in reading: Some consequences of individual differences in the acquisition of literacy Effetti della lettura sullo sviluppo cognitivo sulle relazioni che avviano i processi di acquisizione legati alla lettura Relazioni reciproche Influenza causali bidirezionali tra abilità di lettura ed efficienza dei processi cognitivi Correlazione organismo-ambiente Organismi che partono da una diversa condizione di vantaggio sono esposti in misura diversa a stimolazioni ambientali di diversa qualità
57 Stanovich (1986) Matthew effects in reading: Some consequences of individual differences in the acquisition of literacy Meccanismi che determinano nello sviluppo delle abilità di lettura schemi del tipo: I ricchi diventano sempre più ricchi I poveri diventano sempre più poveri
58 Stanovich (1986) Obiettivo Indagare la relazione tra processi cognitivi e abilità di lettura La relazione tra processi cognitivi e abilità di lettura potrebbe Basarsi su processi di causazione reciproca Modificarsi nel corso del tempo
59 Stanovich (1986) Un modello di sviluppo delle differenze nella lettura Il meccanismo primario specifico alla base che consente lo sviluppo delle prime abilità di lettura è la consapevolezza fonologica Variazioni iniziali nella consapevolezza fonologica possono facilitare/ostacolare le prime fasi di sviluppo della lettura D altra parte, l acquisizione della lettura di per sé facilita la consapevolezza fonologica La consapevolezza fonologica è fondamentale per l acquisizione del principio alfabetico (corrispondenza grafema-fonema)
60 Stanovich (1986) La mancata acquisizione del principio alfabetico può avere effetti a catena negativi Mancanza di pratica Abilità di decodifica deficitarie Esperienze di lettura poco gratificanti Scarso coinvolgimento nelle attività di lettura Al contrario, il lettore abile Procede rapidamente nel migliorare le abilità di decodifica Acquisisce gli automatismi dello stadio ortografico
61 Stanovich (1986) La lettura di per sé rappresenta un fattore che contribuisce in misura rilevante allo sviluppo di molte abilità linguistiche e cognitive
62 Stanovich (1986) I ricchi diventano sempre più ricchi Relazione reciproca tra comprensione della lettura e sviluppo del vocabolario Lo sviluppo del vocabolario facilita la comprensione della lettura che rappresenta di per sé un meccanismo fondamentale per la crescita del vocabolario (che a sua volta consente una lettura più efficiente) Fenomeno di «vantaggio cumulativo» La variabile mediatrice è rappresentata dall esperienza di lettura
63 Stanovich (1986) I ricchi diventano sempre più ricchi Differente grado di esposizione alla lettura per individui con un diverso grado di abilità Gli individui selezionano il loro ambiente Correlazione organismo-ambiente: individui diversi selezionano ambienti diversi Bambini che diventano più bravi nel leggere selezionano ambienti che conducono a una crescita maggiore delle abilità di lettura
64 Stanovich (1986) I ricchi diventano sempre più ricchi A un certo punto, questi effetti sulla lettura finiscono per generalizzarsi e influenzare i processi che sottostanno una gamma più ampia di compiti e abilità
65 McNamara et (2005) A LONGITUDINAL STUDY OF EARLY IDENTIFICATION MARKERS FOR CHILDREN AT-RISK FOR READING DISABILITIES: THE MATTHEW EFFECT AND THE CHALLENGE OF OVER-IDENTIFICATION Obiettivi dello studio Valutare l efficacia di uno strumento per identificare bambini a rischio per le abilità di lettura Identificare bambini a rischio nell ultimo anno della scuola materna Verificare se rimangono «a rischio» nel primo anno della primaria
66 McNamara et (2005) Obiettivi 1.esaminare se lo strumento di screening per l ultimo anno della scuola dell infanzia consente di prevedere con precisione le difficoltà nella lettura di parola in prima elementare 2.indagare l'effetto Matteo (Stanovich. 1986), o se i bambini identificati come a rischio nella scuola materna risultavano cadere ancora più dietro rispetto ai loro coetanei in prima. 3.esaminare la questione di un eccesso di identificazione quando si implementa un protocollo di screening per la 4.Discutere il processo di un progetto di ricerca basato sulla scuola
67 Metodo Partecipanti 514 (in origine 548) bambini ultimo anno della scuola dell infanzia Canada, lingua inglese Misure Età Consapevolezza fonologica Comprensione corrispondenza lettera-suono Somministrazione Mese di maggio durata di 15 minuti Somministratore: insegnante di classe McNamara et (2005)
68 McNamara et (2005) Risultati Relazioni trasversali: correlazione tra misure di consapevolezza fonologica e misure di associazione lettera-suono per i bambini di kindergarten e per quelli di prima Relazioni longitudinali: i bambini che vanno bene al kindergarten vanno bene anche in prima e viceversa per quelli che vanno male Le relazioni longitudinali tra le misure sono più deboli di quelle trasversali
69 McNamara et (2005) Risultati L analisi fattoriale sulle abilità di prelettura evidenzia due fattori Comprensione delle lettere Consapevolezza fonologica (1) Le abilità di pre-lettura predicono le abilità di lettura negli anni successivi? Uso della regressione stepwise La comprensione dell associazione lettera-suono rappresenta il predittore più forte Sia l associazione lettera-suono che la consapevolezza fonologica spiegano una varianza unica significativa
70 McNamara et (2005) Risultati (2) Si riscontra un effetto Matthew in prima? Analisi fattoriale in prima ed estrazione di due fattori analoghi a quelli per il kindergarten Le stesse variabili al kindergarten e in prima sono tra loro moderatamente correlate Si conferma l effetto Matthew
71 Kindergarten Children s Growth Trajectories in Reading and Mathematics: Who Falls Increasingly Behind? Obiettivi Morgan et al (2011) Analizzare le traiettorie di crescita nel successo scolastico dei bambini dell ultimo anno dell infanzia nella lettura e matematica Determinare se le traiettorie di crescita dei bambini con difficoltà di apprendimento (LD) o problemi di linguaggio parlato (SLI) sono coerenti con un modello del ciclo di sviluppo cumulativo con un modello del ciclo di sviluppo compensativo
72 Kindergarten Children s Growth Trajectories in Reading and Mathematics: Who Falls Increasingly Behind? Risultati Sia LD e bambini SLI mostravano livelli più bassi di lettura alla scuola materna rispetto ai bambini tipici Tuttavia, e nei successivi 5 anni di scuola elementare, solo i bambini con SLI rimanevano dietro ai coetanei tipici nella loro crescita capacità di lettura. Per la matematica, invece, Morgan et al (2011) i bambini con LD, ma non quelli con SLI, rimanevano dietro rispetto ai bambini tipici nella loro crescita nell abilità matematica. Il modello «i poveri diventano sempre più poveri» vale però sia per la lettura sia per la matematica per alcuni sottogruppi della popolazione, di basso status socio-economico
73 McNamara et al (2011) A Longitudinal Study of Kindergarten Children At Risk for Reading Disabilities: The Poor Really Are Getting Poorer Obiettivo Esplorare gli effetti Matthew nella lettura nel contesto di un protocollo di screening per l ultimo anno della scuola dell infanzia, sviluppato e implementato dagli insegnanti di classe Ipotesi I bambini identificati nel kindergarten per le scarse capacità fonologiche esperiranno un divario crescente significativo tra loro stessi e i compagni classe al progredire dalla prima alla terza
74 McNamara et al (2011) Effetto Matthew I bambini con difficoltà precoci nella consapevolezza fonologica sono più lenti nella decodifica di parole e di conseguenza sono meno esposti al vocabolario e hanno minore opportunità di essere impegnati nella pratica di lettura. Di conseguenza si riduce la motivazione a impegnarsi in attività legate alla pratica di lettura Nei successivi anni della scuola primaria il divario nei punteggi di prestazione alla lettura tra loro e i compagni cresce esponenzialmente
75 McNamara et al (2011) Effetto Matthew: effetti di diffusione a ventaglio (fan-spread) I problemi dei bambini, inizialmente specifici per l area della consapevolezza fonologica si diffondono per investire le aree Lettura a livello di parole Fluenza di lettura Comprensione
76 McNamara et al (2011) Metodo Partecipanti 382 bambini kindergarten canadesi Misure indipendenti kindergarten Età in mesi Identità dei fonemi Parole in rima Fusione fonemica
77 McNamara et al (2011) Metodo Misure dipendenti classi dalla I alla III Lettura di parole (Word identification): decodifica Lettura di non parole (Word attack): decodifica Lettura di brano (Reading fluency): fluenza (parole corrette lette in un minuto) Procedura Somministrazione individuale Tutte le prove somministrate a maggio Somministrate dagli insegnanti di classe adeguatamente formati
78 McNamara et al (2011) Risultati e discussione (1) i bambini con consapevolezza fonologica scadente cadono sempre più dietro rispetto ai compagni della stessa classe nella lettura con il passaggio da una classe alla successiva?
79 McNamara et al (2011) Risultati e discussione Definizione dei bambini con deficit nella consapevolezza fonologica Al di sotto del 25mo centile in un punteggio composito di consapevolezza fonologica basato sulle tre misure considerate
80 McNamara et al (2011) Risultati e discussione Schema di classificazione dei bambini: Scadenti (<25mo percentile) Medi (tra il 25mo e il 75mo percentile) Bravi (sopra il 75mo percentile)
81 McNamara et al (2011) Risultati e discussione Lettura di non parole La differenza tra gruppi di bambini con competenza fonologica bassa, media e alta aumenta al crescere della classe?
82 McNamara et al (2011) Risultati e discussione Lettura di non parole (Word Attack) In prima, differenze significative tra i gruppi, eta quadrato = 0,24 (ampiezza dell effetto o effect size) In seconda, differenze significative tra i gruppi, eta quadrato = 0,26 In terza, differenze significative tra i gruppi, eta quadrato = 0,36
83 McNamara et al (2011) Risultati e discussione Lettura di parole (Word Identification) In prima, differenze significative tra i gruppi, eta quadrato = 0,21 (ampiezza dell effetto o effect size) In seconda, differenze significative tra i gruppi, eta quadrato = 0,31 In seconda, differenze significative tra i gruppi, eta quadrato = 0,34
Ne esistono diverse e spesso contrastanti
 Ne esistono diverse e spesso contrastanti Una persona che nella quotidianità usa due o più lingue (Grosjean 1989) Chi ha competenze, anche minime, nelle due diverse lingue, in comprensione e/o produzione
Ne esistono diverse e spesso contrastanti Una persona che nella quotidianità usa due o più lingue (Grosjean 1989) Chi ha competenze, anche minime, nelle due diverse lingue, in comprensione e/o produzione
Prerequisiti linguistici e scrittura
 Prerequisiti linguistici e scrittura Paola Viterbori Polo Bozzo Università di Genova Scrittura come attività complessa Codifica (Alfabetizzazione o Literacy) Attività linguistica di trasformazione del
Prerequisiti linguistici e scrittura Paola Viterbori Polo Bozzo Università di Genova Scrittura come attività complessa Codifica (Alfabetizzazione o Literacy) Attività linguistica di trasformazione del
INDICATORI NEUROCOGNITIVI PRECOCI DELLA DISLESSIA EVOLUTIVA. Andrea Facoetti & Co
 INDICATORI NEUROCOGNITIVI PRECOCI DELLA DISLESSIA EVOLUTIVA Andrea Facoetti & Co Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova, ITALIA Unità di Neuropsicologia Evolutiva, Istituto Scientifico
INDICATORI NEUROCOGNITIVI PRECOCI DELLA DISLESSIA EVOLUTIVA Andrea Facoetti & Co Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova, ITALIA Unità di Neuropsicologia Evolutiva, Istituto Scientifico
Disturbi specifici di apprendimento Raccomandazioni cliniche
 Disturbi specifici di apprendimento Raccomandazioni cliniche Padova, 11.05.2012 G. Tarter 1 Raccomandazioni per attivare un trattamento riabilitativo Quali i criteri per stabilire se un trattamento ha
Disturbi specifici di apprendimento Raccomandazioni cliniche Padova, 11.05.2012 G. Tarter 1 Raccomandazioni per attivare un trattamento riabilitativo Quali i criteri per stabilire se un trattamento ha
DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali) La legge 170/2010 Il DM 12 luglio 2011 e Linee Guida
 DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali) La legge 170/2010 Il DM 12 luglio 2011 e Linee Guida Strumenti di screening e osservazione Alcuni strumenti IPDA Questionario
DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali) La legge 170/2010 Il DM 12 luglio 2011 e Linee Guida Strumenti di screening e osservazione Alcuni strumenti IPDA Questionario
apprendimento: Disturbo della lettura (DISLESSIA):
 Disturbi dell apprendimento apprendimento: Diagnosi differenziale A. normali variazioni nei risultati scolastici B. difficoltà scolastiche dovute a mancanza di opportunità, insegnamento scadente, fattori
Disturbi dell apprendimento apprendimento: Diagnosi differenziale A. normali variazioni nei risultati scolastici B. difficoltà scolastiche dovute a mancanza di opportunità, insegnamento scadente, fattori
IL MONDO DELLE PAROLE
 IL MONDO DELLE PAROLE Percorso formativo, di ricerca-azione e laboratorio rivolto agli insegnanti, per la valutazione delle abilità linguistiche e visuo-spaziali nei bambini iscritti all ultimo anno della
IL MONDO DELLE PAROLE Percorso formativo, di ricerca-azione e laboratorio rivolto agli insegnanti, per la valutazione delle abilità linguistiche e visuo-spaziali nei bambini iscritti all ultimo anno della
IPDA. Questionario Osservativo per L IDENTIFICAZIONE. PRECOCE delle DIFFICOLTA di APPRENDIMENTO Terreni et al, 2002
 IPDA Questionario Osservativo per L IDENTIFICAZIONE PRECOCE delle DIFFICOLTA di APPRENDIMENTO Terreni et al, 2002 Cos è L IPDA è la prima fase di un progetto di intervento per ridurre il problema delle
IPDA Questionario Osservativo per L IDENTIFICAZIONE PRECOCE delle DIFFICOLTA di APPRENDIMENTO Terreni et al, 2002 Cos è L IPDA è la prima fase di un progetto di intervento per ridurre il problema delle
PROTOCOLLO DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE E MONITORAGGIO DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
 PROTOCOLLO DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE E MONITORAGGIO DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA DI SCREENING Istituto Comprensivo Statale Rita Levi-Montalcini SUISIO PREMESSA La legge 8 ottobre, n
PROTOCOLLO DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE E MONITORAGGIO DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA DI SCREENING Istituto Comprensivo Statale Rita Levi-Montalcini SUISIO PREMESSA La legge 8 ottobre, n
I SISTEMI DI LETTURA E LE DISLESSIE
 I SISTEMI DI LETTURA E LE DISLESSIE L alessia senza agrafia -Disturbo di lettura senza altri disturbi concomitanti -I pazienti scrivono senza essere capaci di leggere quello che hanno scritto Interpretazione
I SISTEMI DI LETTURA E LE DISLESSIE L alessia senza agrafia -Disturbo di lettura senza altri disturbi concomitanti -I pazienti scrivono senza essere capaci di leggere quello che hanno scritto Interpretazione
Istituzioni di linguistica a.a Federica Da Milano
 Istituzioni di linguistica a.a.2014-2015 Federica Da Milano federica.damilano@unimib.it I processi di lettura, scrittura e calcolo nell età adulta La lettura: la capacità di leggere stringhe di lettere
Istituzioni di linguistica a.a.2014-2015 Federica Da Milano federica.damilano@unimib.it I processi di lettura, scrittura e calcolo nell età adulta La lettura: la capacità di leggere stringhe di lettere
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO e la motivazione dell intervento precoce
 TUTTI A BORDO! PROGETTO IRIDE DI INTERCETTAZIONE PRECOCE IN RETE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO e la motivazione dell intervento precoce Dr.ssa Campioni Annamaria
TUTTI A BORDO! PROGETTO IRIDE DI INTERCETTAZIONE PRECOCE IN RETE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO e la motivazione dell intervento precoce Dr.ssa Campioni Annamaria
Effetto della morfologia sull accuratezza in scrittura: uno studio in bambini normolettori e con dislessia
 Effetto della morfologia sull accuratezza in scrittura: uno studio in bambini normolettori e con dislessia Paola Angelelli*, +Chiara Valeria Marinelli e **Cristina Burani *Università del Salento; +Università
Effetto della morfologia sull accuratezza in scrittura: uno studio in bambini normolettori e con dislessia Paola Angelelli*, +Chiara Valeria Marinelli e **Cristina Burani *Università del Salento; +Università
Diagnosi e ruoli dei vari attori coinvolti nell ottica di un lavoro di rete DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
 Diagnosi e ruoli dei vari attori coinvolti nell ottica di un lavoro di rete DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CONDIZIONI CLINICHE EVOLUTIVE DISLESSIA/LETTURA (intesa come abilità di decodifica del testo)
Diagnosi e ruoli dei vari attori coinvolti nell ottica di un lavoro di rete DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CONDIZIONI CLINICHE EVOLUTIVE DISLESSIA/LETTURA (intesa come abilità di decodifica del testo)
PROGETTO SCREENING a.s. 2010-2011
 PROGETTO SCREENING a.s. 2010-2011 Definizione, criteri diagnostici ed eziologia DSA=DISTURBI EVOLUTIVI E SPECIFICI DI APPRENDIMENTO Disturbi delle abilità scolastiche: Dislessia Disortografia Discalculia
PROGETTO SCREENING a.s. 2010-2011 Definizione, criteri diagnostici ed eziologia DSA=DISTURBI EVOLUTIVI E SPECIFICI DI APPRENDIMENTO Disturbi delle abilità scolastiche: Dislessia Disortografia Discalculia
I disturbi specifici dell apprendimento: dall identificazione precoce agli interventi di recupero. Autore: Letizia Moretti Editing : Enrica Ciullo
 I disturbi specifici dell apprendimento: dall identificazione precoce agli interventi di recupero Autore: Letizia Moretti Editing : Enrica Ciullo Corso Dsa - I disturbi specifici dell apprendimento: dall
I disturbi specifici dell apprendimento: dall identificazione precoce agli interventi di recupero Autore: Letizia Moretti Editing : Enrica Ciullo Corso Dsa - I disturbi specifici dell apprendimento: dall
COMITATO PROMOTORE (AID) M. Marchiori, R. Iozzino, E. Savelli, C. Termine, C. Turello
 COMITATO PROMOTORE (AID) M. Marchiori, R. Iozzino, E. Savelli, C. Termine, C. Turello Associazione Culturale Pediatri Associazione Federativa Nazionale Ottici Optometristi Associazione Italiana Ortottisti
COMITATO PROMOTORE (AID) M. Marchiori, R. Iozzino, E. Savelli, C. Termine, C. Turello Associazione Culturale Pediatri Associazione Federativa Nazionale Ottici Optometristi Associazione Italiana Ortottisti
dr.ssa Paola Cavalcaselle psicologa
 Screening delle capacità di lettoscrittura per la rilevazione precoce di alunni a rischio di difficoltà di apprendimento nelle prime due classi della scuola primaria dr.ssa Paola Cavalcaselle psicologa
Screening delle capacità di lettoscrittura per la rilevazione precoce di alunni a rischio di difficoltà di apprendimento nelle prime due classi della scuola primaria dr.ssa Paola Cavalcaselle psicologa
I^ GIORNATA DI FORMAZIONE
 Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale I^ GIORNATA DI FORMAZIONE Regione MARCHE ASCOLI PICENO San Benedetto del Tronto MARTEDI 20 MARZO 2007 PIANO
Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale I^ GIORNATA DI FORMAZIONE Regione MARCHE ASCOLI PICENO San Benedetto del Tronto MARTEDI 20 MARZO 2007 PIANO
PROGETTO DI IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEL RISCHIO DIFFICOLTA DI LETTOSCRITTURA IN ETA PRESCOLARE
 PROGETTO DI IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEL RISCHIO DIFFICOLTA DI LETTOSCRITTURA IN ETA PRESCOLARE Dicembre 2015 C/o Centro Commerciale Azzurro II piano Via M. Moretti, 23 apprendiamorsm@gmail.com Progetto
PROGETTO DI IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEL RISCHIO DIFFICOLTA DI LETTOSCRITTURA IN ETA PRESCOLARE Dicembre 2015 C/o Centro Commerciale Azzurro II piano Via M. Moretti, 23 apprendiamorsm@gmail.com Progetto
Interventi precoci: le prove di efficacia
 Nati per Leggere. Trieste 16 maggio 2009 Interventi precoci: le prove di efficacia Giorgio Tamburlini IRCCS Burlo Garofolo Apporti cognitivo-relazionali competenze rete neuronale Vocabolario 94 92 90 88
Nati per Leggere. Trieste 16 maggio 2009 Interventi precoci: le prove di efficacia Giorgio Tamburlini IRCCS Burlo Garofolo Apporti cognitivo-relazionali competenze rete neuronale Vocabolario 94 92 90 88
Il disordine fonologico: valutazione e trattamento - I e II livello
 Il disordine fonologico: valutazione e trattamento - I e II livello Roma 14 e 15 ottobre 2 e 3 dicembre 2017 Sede Hotel Il Cantico Via del Cottolengo 50 Docente: Vaquer Maria Luisa Patrizia Obiettivi:
Il disordine fonologico: valutazione e trattamento - I e II livello Roma 14 e 15 ottobre 2 e 3 dicembre 2017 Sede Hotel Il Cantico Via del Cottolengo 50 Docente: Vaquer Maria Luisa Patrizia Obiettivi:
Strumenti a supporto della valutazione dell apprendimento. Sara Zaccaria Ordine degli Psicologi della Toscana 26 maggio 2016
 Strumenti a supporto della valutazione dell apprendimento Sara Zaccaria Ordine degli Psicologi della Toscana 26 maggio 2016 Apprendimento e scuola dell infanzia La Legge 170, 8 ottobre 2010 sottolinea
Strumenti a supporto della valutazione dell apprendimento Sara Zaccaria Ordine degli Psicologi della Toscana 26 maggio 2016 Apprendimento e scuola dell infanzia La Legge 170, 8 ottobre 2010 sottolinea
Marco Piccinno Introduzione generale ai Disturbi specifici dell apprendimento e alla Dislessia
 Marco Piccinno Introduzione generale ai Disturbi specifici dell apprendimento e alla Dislessia Il Disturbi specifici dell apprendimento (DSA) rappresentano dei deficit che insistono a carico delle funzioni
Marco Piccinno Introduzione generale ai Disturbi specifici dell apprendimento e alla Dislessia Il Disturbi specifici dell apprendimento (DSA) rappresentano dei deficit che insistono a carico delle funzioni
Un Software per il potenziamento delle abilità di lettura e scrittura
 OTTOVOLANTE Un Software per il potenziamento delle abilità di lettura e scrittura *G. STELLA *G. CAIAZZO - *G. ZANZURINO * Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia San Marino 19/09/2008 Progetto
OTTOVOLANTE Un Software per il potenziamento delle abilità di lettura e scrittura *G. STELLA *G. CAIAZZO - *G. ZANZURINO * Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia San Marino 19/09/2008 Progetto
Trattamento diretto e indiretto dei DSA
 Trattamento diretto e indiretto dei DSA Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema Giacomo Stella IRIDE e AID Giacomo.stella@sosdislessia.it APPRENDIMENTO ESPLICITO (o Dichiarativo)
Trattamento diretto e indiretto dei DSA Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema Giacomo Stella IRIDE e AID Giacomo.stella@sosdislessia.it APPRENDIMENTO ESPLICITO (o Dichiarativo)
Difficoltà e Disturbo: quale relazione negli apprendimenti scolastici. Marzia L. Bizzaro
 Difficoltà e Disturbo: quale relazione negli apprendimenti scolastici Marzia L. Bizzaro Università Milano-Bicocca, 15 novembre 2010 Disabilità: limitazione o perdita (conseguente a menomazione) delle capacità
Difficoltà e Disturbo: quale relazione negli apprendimenti scolastici Marzia L. Bizzaro Università Milano-Bicocca, 15 novembre 2010 Disabilità: limitazione o perdita (conseguente a menomazione) delle capacità
Il disordine fonologico: valutazione e trattamento. 1 e 2 livello.
 Il disordine fonologico: valutazione e trattamento. 1 e 2 livello. Lecce 1 livello 24-25 settembre 2 livello 15-16 ottobre 2010 Sede : Grand Hotel Europa Viale Europa Docente Vaquer Maria Luisa Patrizia
Il disordine fonologico: valutazione e trattamento. 1 e 2 livello. Lecce 1 livello 24-25 settembre 2 livello 15-16 ottobre 2010 Sede : Grand Hotel Europa Viale Europa Docente Vaquer Maria Luisa Patrizia
Lauro Mengheri, Psicologo clinico e Psicoterapeuta Pesidente Ordine degli Psicologi della Toscana
 SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), il 29 settembre 2010, ha approvato il seguente disegno di
SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), il 29 settembre 2010, ha approvato il seguente disegno di
LABORATORIO Corso di Pedagogia speciale Prof.ssa Zappaterra IV anno GRUPPO 1 23 settembre :00/19:00 Dr.ssa Lucia Donata Nepi
 Scuola di Studi Umanistici e della Formazione CdS in Scienze della Formazione Primaria! LABORATORIO Corso di Pedagogia speciale Prof.ssa Zappaterra IV anno GRUPPO 1 23 settembre 2015 16:00/19:00 Dr.ssa
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione CdS in Scienze della Formazione Primaria! LABORATORIO Corso di Pedagogia speciale Prof.ssa Zappaterra IV anno GRUPPO 1 23 settembre 2015 16:00/19:00 Dr.ssa
Il disordine fonologico: valutazione e trattamento. 1 livello. Docente Vaquer Maria Luisa Patrizia. Obiettivi:
 Il disordine fonologico: valutazione e trattamento. 1 livello. Firenze 7 e 8 maggio 2011 Grand Hotel Cavour Via del Proconsolo 3 Docente Vaquer Maria Luisa Patrizia Obiettivi: Nella pratica clinica relativa
Il disordine fonologico: valutazione e trattamento. 1 livello. Firenze 7 e 8 maggio 2011 Grand Hotel Cavour Via del Proconsolo 3 Docente Vaquer Maria Luisa Patrizia Obiettivi: Nella pratica clinica relativa
la dislessia evolutiva si eredita Genetica della dislessia Ogni generazione Ha un dislessico: il Genitore Trasmette al figlio
 Genetica della dislessia Cecilia Marino Unità di Psicopatologia dell età evolutiva Istituto Scientifico Eugenio Medea Associazione La Nostra Famiglia Bosisio Parini, Lecco, Italia la dislessia evolutiva
Genetica della dislessia Cecilia Marino Unità di Psicopatologia dell età evolutiva Istituto Scientifico Eugenio Medea Associazione La Nostra Famiglia Bosisio Parini, Lecco, Italia la dislessia evolutiva
VISUO SPAZIALI MAURIZIO GAMBARI BERIO 03/04/2011
 VISUO SPAZIALI MAURIZIO GAMBARI BERIO 03/04/2011 DEFINIZIONE I deficit visusopazaili si possono definire come disordini che determinano un'erronea stima degli aspetti spaziali fra diversi oggetti che riguardano
VISUO SPAZIALI MAURIZIO GAMBARI BERIO 03/04/2011 DEFINIZIONE I deficit visusopazaili si possono definire come disordini che determinano un'erronea stima degli aspetti spaziali fra diversi oggetti che riguardano
Obiettivo/i educativi formativi complessivi dell attività formativa
 NEUROPSICOLOGIA DEL DISTURBO DI APPRENDIMENTO DELLA SCRITTURA: LA VALUTAZIONE E LA RIABILITAZIONE Roma 26 e 27 maggio 23 e 24 giugno 2012 Sede Villa Eur Parco dei Pini P.le M. Champagnat, 2 Relatori Dott.ssa
NEUROPSICOLOGIA DEL DISTURBO DI APPRENDIMENTO DELLA SCRITTURA: LA VALUTAZIONE E LA RIABILITAZIONE Roma 26 e 27 maggio 23 e 24 giugno 2012 Sede Villa Eur Parco dei Pini P.le M. Champagnat, 2 Relatori Dott.ssa
APPRENDIMENTO DELLA LETTO-SCRITTURA. 4 settembre 2014 Alessandra Scabia
 APPRENDIMENTO DELLA LETTO-SCRITTURA 4 settembre 2014 Alessandra Scabia L apprendimento della letto-scrittura presuppone l acquisizione di: competenze fonologiche: produzione di tutti i suoni, ripetizioni
APPRENDIMENTO DELLA LETTO-SCRITTURA 4 settembre 2014 Alessandra Scabia L apprendimento della letto-scrittura presuppone l acquisizione di: competenze fonologiche: produzione di tutti i suoni, ripetizioni
Un modello organizzativo autogestito
 26 Marzo 2012 Progetto sperimentale di individuazione precoce dei DSA nella prima classe della Scuola Primaria Un modello organizzativo autogestito Responsabile della formazione: Dott.ssa Barbara Peroni
26 Marzo 2012 Progetto sperimentale di individuazione precoce dei DSA nella prima classe della Scuola Primaria Un modello organizzativo autogestito Responsabile della formazione: Dott.ssa Barbara Peroni
TUTTI A BORDO! PROGETTO IRIDE DI INTERCETTAZIONE PRECOCE IN RETE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA
 TUTTI A BORDO! PROGETTO IRIDE DI INTERCETTAZIONE PRECOCE IN RETE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2013-14 ISTITUTO COMPRENSIVO BADIA POLESINE - ROVIGO Badia Polesine 3 dicembre 2013 Francesca
TUTTI A BORDO! PROGETTO IRIDE DI INTERCETTAZIONE PRECOCE IN RETE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2013-14 ISTITUTO COMPRENSIVO BADIA POLESINE - ROVIGO Badia Polesine 3 dicembre 2013 Francesca
DISTIURBI SPECIFICI DELL APPRENDIMENTO DSA. Dott.sa Pastena Nicolina Università Salerno
 DISTIURBI SPECIFICI DELL APPRENDIMENTO DSA 1 DISTURBI SPECIFICI DELL APPRENDIMENTO (DSA) Sono disturbi funzionali che derivano da una peculiare architettura neuropsicologica del soggetto. Provocano difficoltà
DISTIURBI SPECIFICI DELL APPRENDIMENTO DSA 1 DISTURBI SPECIFICI DELL APPRENDIMENTO (DSA) Sono disturbi funzionali che derivano da una peculiare architettura neuropsicologica del soggetto. Provocano difficoltà
Come leggono i bambini dislessici? Rachele Fanari
 Come leggono i bambini dislessici? Rachele Fanari Evidenze dai bambini italiani con sviluppo tipico In uno studio longitudinale abbiamo osservato un gruppo di bambini dalla fine della scuola dell infanzia
Come leggono i bambini dislessici? Rachele Fanari Evidenze dai bambini italiani con sviluppo tipico In uno studio longitudinale abbiamo osservato un gruppo di bambini dalla fine della scuola dell infanzia
Anna Maria Antonucci AIRIPA Puglia..aiutamia capire!
 .aiutamia capire! In premessa Stasera siamo qui per Anziché considerare il processo con cui si conquista la conoscenza, come un fenomeno isolato che si produce all interno della testa, bisognerebbe vederla
.aiutamia capire! In premessa Stasera siamo qui per Anziché considerare il processo con cui si conquista la conoscenza, come un fenomeno isolato che si produce all interno della testa, bisognerebbe vederla
PREREQUISITI AGLI APPRENDIMENTI SCOLASTICI NELLA SCUOLA DELL INFANZIA: UN QUESTIONARIO OSSERVATIVO PER GENITORI E INSEGNANTI
 PREREQUISITI AGLI APPRENDIMENTI SCOLASTICI NELLA SCUOLA DELL INFANZIA: UN QUESTIONARIO OSSERVATIVO PER GENITORI E INSEGNANTI Scuola di Medicina di Torino Dipartimento di Scienze Chirurgiche Corso di Laurea
PREREQUISITI AGLI APPRENDIMENTI SCOLASTICI NELLA SCUOLA DELL INFANZIA: UN QUESTIONARIO OSSERVATIVO PER GENITORI E INSEGNANTI Scuola di Medicina di Torino Dipartimento di Scienze Chirurgiche Corso di Laurea
Il peso epidemiologico
 Le disabilità dell apprendimento Umberto Balottin, Cristiano Termine Cattedra di Neuropsichiatria Infantile Università degli Studi dell Insubria Unità Operativa di Neuropsichiatria dell Infanzia e Adolescenza
Le disabilità dell apprendimento Umberto Balottin, Cristiano Termine Cattedra di Neuropsichiatria Infantile Università degli Studi dell Insubria Unità Operativa di Neuropsichiatria dell Infanzia e Adolescenza
Progetto IPDA Prevenire le difficoltà d apprendimento a partire dall'ultimo anno della Scuola d Infanzia
 Progetto IPDA Prevenire le difficoltà d apprendimento a partire dall'ultimo anno della Scuola d Infanzia L INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DEI PREREQUISITI Il profilo del bambino ottenuto dall applicazione
Progetto IPDA Prevenire le difficoltà d apprendimento a partire dall'ultimo anno della Scuola d Infanzia L INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DEI PREREQUISITI Il profilo del bambino ottenuto dall applicazione
Le difficoltà di apprendimento e l intervento di aiuto APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA
 Le difficoltà di apprendimento e l intervento di aiuto APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA COSA SONO LA LETTURA E LA SCRITTURA? Come si colloca la funzione della scrittura all interno dei sistemi di comunicazione?
Le difficoltà di apprendimento e l intervento di aiuto APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA COSA SONO LA LETTURA E LA SCRITTURA? Come si colloca la funzione della scrittura all interno dei sistemi di comunicazione?
LALLO PROGETTO: GIOCHI LINGUISTICI E FONOLOGICI BAMBINI GRANDI SCUOLA DELL INFANZIA COLLODI CASETTE ANNO SCOLASTICO 2013/14
 LALLO PROGETTO: GIOCHI LINGUISTICI E FONOLOGICI BAMBINI GRANDI SCUOLA DELL INFANZIA COLLODI CASETTE ANNO SCOLASTICO 2013/14 PROGETTO: GIOCHI LINGUISTICI E FONOLOGICI GIOCHIAMO CON LE PAROLE E I SUONI DELLE
LALLO PROGETTO: GIOCHI LINGUISTICI E FONOLOGICI BAMBINI GRANDI SCUOLA DELL INFANZIA COLLODI CASETTE ANNO SCOLASTICO 2013/14 PROGETTO: GIOCHI LINGUISTICI E FONOLOGICI GIOCHIAMO CON LE PAROLE E I SUONI DELLE
 Livello di lettura di due deviazioni standard inferiore alla media Quoziente intellettivo (QI) nella norma Assenza di cause neurologiche e/o sensoriali Interferenza significativa con l apprendimento scolastico
Livello di lettura di due deviazioni standard inferiore alla media Quoziente intellettivo (QI) nella norma Assenza di cause neurologiche e/o sensoriali Interferenza significativa con l apprendimento scolastico
Istituto Comprensivo Nord 1 Brescia. Progetto D.S.A.
 Istituto Comprensivo Nord 1 Brescia Progetto D.S.A. Test CMF Valutazione delle abilità di scrittura Giovanardi Rossi e Malaguti BVSCO Velocità scrittura CMF di Marotta, Ronchetti, Trasciani, Vicari EDIZIONI
Istituto Comprensivo Nord 1 Brescia Progetto D.S.A. Test CMF Valutazione delle abilità di scrittura Giovanardi Rossi e Malaguti BVSCO Velocità scrittura CMF di Marotta, Ronchetti, Trasciani, Vicari EDIZIONI
Patologia del linguaggio in età evolutiva
 Patologia del linguaggio in età evolutiva U.O. e Cattedra di Neuropsichiatria Infantile Dipartimento di Scienze Neurologiche e della Visione Sezione di Neuroscienze dello Sviluppo IRCCS G. Gaslini Disturbi
Patologia del linguaggio in età evolutiva U.O. e Cattedra di Neuropsichiatria Infantile Dipartimento di Scienze Neurologiche e della Visione Sezione di Neuroscienze dello Sviluppo IRCCS G. Gaslini Disturbi
Le competenze metafonologiche: attività, giochi metalinguistici e fonologici per favorire il loro sviluppo. Relatrice: Maria Angela Berton
 Le competenze metafonologiche: attività, giochi metalinguistici e fonologici per favorire il loro sviluppo Relatrice: Maria Angela Berton IL LINGUAGGIO VERBALE E UNO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE COME SI
Le competenze metafonologiche: attività, giochi metalinguistici e fonologici per favorire il loro sviluppo Relatrice: Maria Angela Berton IL LINGUAGGIO VERBALE E UNO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE COME SI
Dott.ssa Cristina Potente
 9 Novembre 2015 - Genova Problematiche nella diagnosi della discalculia e nell intervento didattico con studenti discalculici alla luce dei risultati di una sperimentazione. Dott.ssa Cristina Potente c.potente@centroleonardo.net
9 Novembre 2015 - Genova Problematiche nella diagnosi della discalculia e nell intervento didattico con studenti discalculici alla luce dei risultati di una sperimentazione. Dott.ssa Cristina Potente c.potente@centroleonardo.net
FONOLOGIA DEL LINGUAGGIO E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA SCRITTA R.A. 2011/2012
 1 FONOLOGIA DEL LINGUAGGIO E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA SCRITTA R.A. 2011/2012 Badia Polesine 25 ottobre 2011 Francesca Zanella, Logopedista, Formatore A.I.D., Referente tecnico del progetto 2 ARGOMENTI
1 FONOLOGIA DEL LINGUAGGIO E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA SCRITTA R.A. 2011/2012 Badia Polesine 25 ottobre 2011 Francesca Zanella, Logopedista, Formatore A.I.D., Referente tecnico del progetto 2 ARGOMENTI
Osservazioni e strumenti
 Osservazioni e strumenti Centro di Consulenza Psicologica e Pedagogica L Albero Bianco via Matteo degli Organi, 213 Prato 0574/24684 alberobianco@alicecoop.it Prerequisiti per la lettura Sistema di analisi
Osservazioni e strumenti Centro di Consulenza Psicologica e Pedagogica L Albero Bianco via Matteo degli Organi, 213 Prato 0574/24684 alberobianco@alicecoop.it Prerequisiti per la lettura Sistema di analisi
I precursori della lettura e della scrittura
 I precursori della lettura e della scrittura Scuola dell infanzia e primaria: una rilevazione comune Anno scolastico 2015/16 Lo strumento di rilevazione Il portfolio della prima alfabetizzazione Il portfolio
I precursori della lettura e della scrittura Scuola dell infanzia e primaria: una rilevazione comune Anno scolastico 2015/16 Lo strumento di rilevazione Il portfolio della prima alfabetizzazione Il portfolio
I DISTURBI DELL APPRENDIMENTO IN ETA SCOLARE: VALUTAZIONE ED INTERVENTO ( M-PSI/04) CFU 4 LEZIONE: DISLESSIA E DISTURBI DELLA SCRITTURA
 UNIVERSITÀ G. D ANNUNZIO DI CHIETI FACOLTÀ DI PSICOLOGIA CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE I DISTURBI DELL APPRENDIMENTO IN ETA SCOLARE: VALUTAZIONE ED INTERVENTO ( M-PSI/04) CFU 4 LEZIONE:
UNIVERSITÀ G. D ANNUNZIO DI CHIETI FACOLTÀ DI PSICOLOGIA CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE I DISTURBI DELL APPRENDIMENTO IN ETA SCOLARE: VALUTAZIONE ED INTERVENTO ( M-PSI/04) CFU 4 LEZIONE:
IDENTIFICAZIONE PRECOCE DI BAMBINI CON RITARDO DI LINGUAGGIO
 Milano, 10 Novembre 2011 Corso di Laurea in Logopedia IDENTIFICAZIONE PRECOCE DI BAMBINI CON RITARDO DI LINGUAGGIO PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DELLO SCREENING DEL LINGUAGGIO NELL ASL DELLA PROVINCIA DI
Milano, 10 Novembre 2011 Corso di Laurea in Logopedia IDENTIFICAZIONE PRECOCE DI BAMBINI CON RITARDO DI LINGUAGGIO PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DELLO SCREENING DEL LINGUAGGIO NELL ASL DELLA PROVINCIA DI
L analisi degli errori nei disturbi evolutivi della scrittura
 L analisi degli errori nei disturbi evolutivi della scrittura Dr.ssa Federica Riva U.O. Neurologia dello Sviluppo Servizio per i disordini del linguaggio e dell apprendimento Fondazione IRCCS Istituto
L analisi degli errori nei disturbi evolutivi della scrittura Dr.ssa Federica Riva U.O. Neurologia dello Sviluppo Servizio per i disordini del linguaggio e dell apprendimento Fondazione IRCCS Istituto
Convegno Internazionale Imparare: questo è il problema San Marino 22-23 settembre 2000
 LA DISLESSIA E LO SVILUPPO: COSA CAMBIA E COSA RESTA. Giacomo Stella, Claudia Nicoletti Centro Regionaled Dis. Co.Li. Asl Città di Bologna Università di Urbino Convegno Internazionale Imparare: questo
LA DISLESSIA E LO SVILUPPO: COSA CAMBIA E COSA RESTA. Giacomo Stella, Claudia Nicoletti Centro Regionaled Dis. Co.Li. Asl Città di Bologna Università di Urbino Convegno Internazionale Imparare: questo
Differenze individuali nella competenza linguistica dei bambini bilingui figli di immigrati
 Differenze individuali nella competenza linguistica dei bambini bilingui figli di immigrati Maja Roch, Elena Florit, Ughetta Moscardino & M. Chiara Levorato Università di Padova dpss.psy.unipd.it/lablas
Differenze individuali nella competenza linguistica dei bambini bilingui figli di immigrati Maja Roch, Elena Florit, Ughetta Moscardino & M. Chiara Levorato Università di Padova dpss.psy.unipd.it/lablas
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI SCREENING
 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI SCREENING Dott.ssa Isabella Bellagamba Psicologa psicoterapeuta dell età evolutiva isabellabellagamba@libero.it www.psicoterapiainfanziaeadolescenza.it COSA VUOL DIRE SCREENING!
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI SCREENING Dott.ssa Isabella Bellagamba Psicologa psicoterapeuta dell età evolutiva isabellabellagamba@libero.it www.psicoterapiainfanziaeadolescenza.it COSA VUOL DIRE SCREENING!
Argomenti trattati: Pomeriggio (x chi è sopravvissuto alla mattina ovviamente) Disturbi ortografici e dislessia: è una vera causa? Il sistema visivo;
 Argomenti trattati: Pomeriggio (x chi è sopravvissuto alla mattina ovviamente) Disturbi ortografici e dislessia: è una vera causa? Il sistema visivo; Forma visiva della parola; La segregazione grafemica;
Argomenti trattati: Pomeriggio (x chi è sopravvissuto alla mattina ovviamente) Disturbi ortografici e dislessia: è una vera causa? Il sistema visivo; Forma visiva della parola; La segregazione grafemica;
I disturbi specifici dell apprendimento
 I disturbi specifici dell apprendimento DIFFICOLTA DI APPRENDIMENTO Basso rendimento scolastico causato da una bassa potenzialità intellettiva Basso livello socioculturale Particolari caratteristiche familiari
I disturbi specifici dell apprendimento DIFFICOLTA DI APPRENDIMENTO Basso rendimento scolastico causato da una bassa potenzialità intellettiva Basso livello socioculturale Particolari caratteristiche familiari
3 LEZIONE. I MODELLI DI APPRENDIMENTO DELLA LETTURA E LA DISLESSIA: DALLO SCREENING PRECOCE ALLA DIAGNOSI
 3 LEZIONE. I MODELLI DI APPRENDIMENTO DELLA LETTURA E LA DISLESSIA: DALLO SCREENING PRECOCE ALLA DIAGNOSI Introduzione L obiettivo di questo capitolo e dei prossimi, è quello di comprendere ed analizzare
3 LEZIONE. I MODELLI DI APPRENDIMENTO DELLA LETTURA E LA DISLESSIA: DALLO SCREENING PRECOCE ALLA DIAGNOSI Introduzione L obiettivo di questo capitolo e dei prossimi, è quello di comprendere ed analizzare
Istituto Sicurezza Sociale
 R e p u b b l i c a d i S a n M a r i n o Istituto Sicurezza Sociale Dipartimento del Servizio Sociosanitario, Salute Mentale e Cure Primarie U.O.C. del Servizio Minori 9 Convegno Internazionale Imparare:
R e p u b b l i c a d i S a n M a r i n o Istituto Sicurezza Sociale Dipartimento del Servizio Sociosanitario, Salute Mentale e Cure Primarie U.O.C. del Servizio Minori 9 Convegno Internazionale Imparare:
disturbi dell apprendimento e.. promlebi di lisdessia
 Incontri di confronto tra docenti Marzo 2008 disturbi dell apprendimento e.. promlebi di lisdessia 1 2 Disagio scolastico Disagio scolastico è in forte crescita parallelamente al progredire del grado scolastico,
Incontri di confronto tra docenti Marzo 2008 disturbi dell apprendimento e.. promlebi di lisdessia 1 2 Disagio scolastico Disagio scolastico è in forte crescita parallelamente al progredire del grado scolastico,
DSA:dal PDP alla Programmazione degli interventi. Prof.ssa Chiara Stella Ciardo maggio 2012
 DSA:dal PDP alla Programmazione degli interventi Prof.ssa Chiara Stella Ciardo 08-09-11 maggio 2012 1 Introduzione ELEMENTI IMPRESCINDIBILI IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO LA PROGRAMMAZIONE degli interventi
DSA:dal PDP alla Programmazione degli interventi Prof.ssa Chiara Stella Ciardo 08-09-11 maggio 2012 1 Introduzione ELEMENTI IMPRESCINDIBILI IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO LA PROGRAMMAZIONE degli interventi
Cosa si intende per produzione del testo?
 1 Cosa si intende per produzione del testo? A partire dagli anni 80 si matura la consapevolezza che la produzione di un testo scritto sia un processo principalmente cognitivo: anche gli aspetti grafo-motori
1 Cosa si intende per produzione del testo? A partire dagli anni 80 si matura la consapevolezza che la produzione di un testo scritto sia un processo principalmente cognitivo: anche gli aspetti grafo-motori
Neuropsicologia dei disturbi dell apprendimento della scrittura: la valutazione e la riabilitazione
 Neuropsicologia dei disturbi dell apprendimento della scrittura: la valutazione e la riabilitazione Roma 17 18 e 19 aprile 2015 Sede: Villa Eur Parco dei Pini P.le M. Champagnat, 2 Docenti: Giovanni Masciarelli
Neuropsicologia dei disturbi dell apprendimento della scrittura: la valutazione e la riabilitazione Roma 17 18 e 19 aprile 2015 Sede: Villa Eur Parco dei Pini P.le M. Champagnat, 2 Docenti: Giovanni Masciarelli
Modelli di valutazione e intervento nei disturbi dell espressione scritta
 Modelli di valutazione e intervento nei disturbi dell espressione scritta Barbara Arfé Università degli Studi di Padova In collaborazione con: Eleonora Pizzoccaro Anna Merella Elisa Cona M.R Russo Centro
Modelli di valutazione e intervento nei disturbi dell espressione scritta Barbara Arfé Università degli Studi di Padova In collaborazione con: Eleonora Pizzoccaro Anna Merella Elisa Cona M.R Russo Centro
Uno sguardo alle diff f ifcoltà t s colas a titche
 Uno sguardo alle difficoltà scolastiche UNO STUDENTE ITALIANO SU CINQUE, INCONTRA, NELLA SUA CARRIERA SCOLASTICA, UN MOMENTO DI PARTICOLARE DIFFICOLTA NEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO DOVUTO A CAUSE DIVERSE
Uno sguardo alle difficoltà scolastiche UNO STUDENTE ITALIANO SU CINQUE, INCONTRA, NELLA SUA CARRIERA SCOLASTICA, UN MOMENTO DI PARTICOLARE DIFFICOLTA NEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO DOVUTO A CAUSE DIVERSE
IL MONDO DELLE PAROLE & INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ DI LETTO-SCRITTURA
 IL MONDO DELLE PAROLE & INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ DI LETTO-SCRITTURA Avvio indagine sulle difficoltà di apprendimento (98/99) Presupposti: Aumento esponenziale delle segnalazioni di bambini
IL MONDO DELLE PAROLE & INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ DI LETTO-SCRITTURA Avvio indagine sulle difficoltà di apprendimento (98/99) Presupposti: Aumento esponenziale delle segnalazioni di bambini
Valutazione e intervento didattico nell apprendimento della lettura e della scrittura. Belluno, ottobre dicembre 2011.
 Valutazione e intervento didattico nell apprendimento della lettura e della scrittura Belluno, ottobre dicembre 2011 Michela Cendron Centro Regionale Specializzato per i Disturbi dell Apprendimento ULSS20
Valutazione e intervento didattico nell apprendimento della lettura e della scrittura Belluno, ottobre dicembre 2011 Michela Cendron Centro Regionale Specializzato per i Disturbi dell Apprendimento ULSS20
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
 DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO dott.ssa Silvia Ceccaroli dott.ssa Nicoletta Staffa Associazione Strategicamente Insieme PROGETTO «IMPARARE E» Comune di Cervia 1 incontro 08.09.2016 DISTURBI SPECIFICI
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO dott.ssa Silvia Ceccaroli dott.ssa Nicoletta Staffa Associazione Strategicamente Insieme PROGETTO «IMPARARE E» Comune di Cervia 1 incontro 08.09.2016 DISTURBI SPECIFICI
WPPSI-III. La Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence -Terza Edizione (WPPSI III) è uno strumento clinico di somministrazione individuale
 La Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence -Terza Edizione Dott.ssa Tiziana Serra WPPSI- La Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence -Terza Edizione (WPPSI III) è uno strumento
La Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence -Terza Edizione Dott.ssa Tiziana Serra WPPSI- La Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence -Terza Edizione (WPPSI III) è uno strumento
Lo sviluppo neurale e la plasticità
 Convegno nazionale Musica è apprendimento Parma, 28-29 Ottobre 2016 L effetto della pratica musicale sulle competenze cognitive degli alunni: abilità cognitive di base (attenzione e memoria), letto-scrittura
Convegno nazionale Musica è apprendimento Parma, 28-29 Ottobre 2016 L effetto della pratica musicale sulle competenze cognitive degli alunni: abilità cognitive di base (attenzione e memoria), letto-scrittura
Progetto La scuola fa bene a tutti
 c/o Centro Civico Aldo Masanello Via Paganini 30035 Mirano (VE) Piazza dei Martiri, 1/2 40121 Bologna www.dislessia.it Recapito corrispondenza Via Belluno, 18 30035 Mirano (VE) Tel. 041431896 Mail: venezia@dislessia.it
c/o Centro Civico Aldo Masanello Via Paganini 30035 Mirano (VE) Piazza dei Martiri, 1/2 40121 Bologna www.dislessia.it Recapito corrispondenza Via Belluno, 18 30035 Mirano (VE) Tel. 041431896 Mail: venezia@dislessia.it
La Dislessia Evolutiva
 La Dislessia Evolutiva Dislessia Evolutiva (DE) Disabilità specifica dell apprendimento di origine neurobiologica. Si manifesta quando un bambino non sviluppa, o sviluppa con molta difficoltà, la capacità
La Dislessia Evolutiva Dislessia Evolutiva (DE) Disabilità specifica dell apprendimento di origine neurobiologica. Si manifesta quando un bambino non sviluppa, o sviluppa con molta difficoltà, la capacità
1): SCREENING POSTURALE
 1): SCREENING POSTURALE Il presente progetto è rivolto alle classi V della scuola primaria e al primo anno della scuola secondaria di primo grado. La fascia d età considerata, dal punto di vista auxologico,
1): SCREENING POSTURALE Il presente progetto è rivolto alle classi V della scuola primaria e al primo anno della scuola secondaria di primo grado. La fascia d età considerata, dal punto di vista auxologico,
Guida alla compilazione del Piano Glottodidattico Personalizzato Michele Daloiso
 Guida alla compilazione del Piano Glottodidattico Personalizzato 1 SCHEDA 5 Guida alla compilazione del Piano Glottodidattico Personalizzato Michele Daloiso Il Ministero dell Istruzione, dell Università
Guida alla compilazione del Piano Glottodidattico Personalizzato 1 SCHEDA 5 Guida alla compilazione del Piano Glottodidattico Personalizzato Michele Daloiso Il Ministero dell Istruzione, dell Università
. RETE ISTITUTI SCOLASTICI del VALDARNO PROGETTO SCREENING DSA VALDARNO
 . RETE ISTITUTI SCOLASTICI del VALDARNO SCUOLE ASSOCIATE: Liceo Scientifico Varchi Montevarchi (AR) Istituto Comprensivo Bucine (AR) I.C. "Don L. Milani " Pian di Scò ( AR ) I.C. D. Alighieri Castelnuovo
. RETE ISTITUTI SCOLASTICI del VALDARNO SCUOLE ASSOCIATE: Liceo Scientifico Varchi Montevarchi (AR) Istituto Comprensivo Bucine (AR) I.C. "Don L. Milani " Pian di Scò ( AR ) I.C. D. Alighieri Castelnuovo
Diagnosi precoce ed evoluzione della Dislessia dall età scolare al termine della scolarizzazione
 Diagnosi precoce ed evoluzione della Dislessia dall età scolare al termine della scolarizzazione Marina Silvestrini Logopedista Unità Operativa Disturbi dello Sviluppo Distretto 2 - ASL 3 Sommario - Dislessia
Diagnosi precoce ed evoluzione della Dislessia dall età scolare al termine della scolarizzazione Marina Silvestrini Logopedista Unità Operativa Disturbi dello Sviluppo Distretto 2 - ASL 3 Sommario - Dislessia
BES e profili funzionali: ingredienti, ricette e nouvelle cousine
 Paola Bonifacci Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna paola.bonifacci@unibo.it BES e profili funzionali: ingredienti, ricette e nouvelle cousine Normativa sui BES (2013) BES DISABILITA' DISTURBI
Paola Bonifacci Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna paola.bonifacci@unibo.it BES e profili funzionali: ingredienti, ricette e nouvelle cousine Normativa sui BES (2013) BES DISABILITA' DISTURBI
Progetto La scuola fa bene a tutti
 Progetto La scuola fa bene a tutti Individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento Associazione Italiana Dislessia PREMESSA Il Progetto LA SCUOLA FA BENE A TUTTI è stato messo a punto nel 1999
Progetto La scuola fa bene a tutti Individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento Associazione Italiana Dislessia PREMESSA Il Progetto LA SCUOLA FA BENE A TUTTI è stato messo a punto nel 1999
Lo sviluppo linguistico nei primi anni di vita
 Università di Genova Polo M.T. Bozzo Lo sviluppo linguistico nei primi anni di vita Paola Viterbori Il ritardo di linguaggio il ritardo di linguaggio è un rallentamento nell acquisizione delle normali
Università di Genova Polo M.T. Bozzo Lo sviluppo linguistico nei primi anni di vita Paola Viterbori Il ritardo di linguaggio il ritardo di linguaggio è un rallentamento nell acquisizione delle normali
Il ruolo decisivo della competenza metafonologica degli alunni nella fase alfabetica della scrittura : riferimenti teorici e operativi
 Il ruolo decisivo della competenza metafonologica degli alunni nella fase alfabetica della scrittura : riferimenti teorici e operativi Luciana Ventriglia Docente Specializzata in Pedagogia clinica Presidente
Il ruolo decisivo della competenza metafonologica degli alunni nella fase alfabetica della scrittura : riferimenti teorici e operativi Luciana Ventriglia Docente Specializzata in Pedagogia clinica Presidente
La lettura come processo di decodifica. Di Giacomo Dallari
 La lettura come processo di decodifica. Di Giacomo Dallari Leggere significa attivare dei meccanismi molto complessi che richiedono l intervento di una serie di abilità e di processi articolati e cooperativi.
La lettura come processo di decodifica. Di Giacomo Dallari Leggere significa attivare dei meccanismi molto complessi che richiedono l intervento di una serie di abilità e di processi articolati e cooperativi.
PROGETTO "MONITORAGGIO APPRENDIMENTO" CLASSI PRIME E SECONDE
 A. s. 2014/2015 Istituto Comprensivo di Volta Mantovana PROGETTO "MONITORAGGIO APPRENDIMENTO" CLASSI PRIME E SECONDE Progetto promosso da: CTS di San Giorgio UST di Mantova Finalizzato a: identificare
A. s. 2014/2015 Istituto Comprensivo di Volta Mantovana PROGETTO "MONITORAGGIO APPRENDIMENTO" CLASSI PRIME E SECONDE Progetto promosso da: CTS di San Giorgio UST di Mantova Finalizzato a: identificare
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
 ISTITUTO COMPRENSIVO Nico Pinna Parpaglia POZZOMAGGIORE Via San Pietro, 37/a - 07018 (SS) - tel. 079/801093 - fax 079/800157 C.F. 80008250906 - e-mail ssic80200l@istruzione.it PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
ISTITUTO COMPRENSIVO Nico Pinna Parpaglia POZZOMAGGIORE Via San Pietro, 37/a - 07018 (SS) - tel. 079/801093 - fax 079/800157 C.F. 80008250906 - e-mail ssic80200l@istruzione.it PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
Istituto Comprensivo Statale di Poppi
 Istituto Comprensivo Statale di Poppi PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO SCUOLA SECONDARIA ISTITUZIONE SCOLASTICA: ANNO SCOLASTICO: ALUNNO:. 1. Dati generali Nome e cognome Data di nascita Classe Insegnante
Istituto Comprensivo Statale di Poppi PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO SCUOLA SECONDARIA ISTITUZIONE SCOLASTICA: ANNO SCOLASTICO: ALUNNO:. 1. Dati generali Nome e cognome Data di nascita Classe Insegnante
Risultati di un training combinato di lettura e ritmo per la riabilitazione della dislessia
 Convegno La musica nello sviluppo delle abilità linguistiche 22 Ottobre 2016 Bosisio Parini (LC) Risultati di un training combinato di lettura e ritmo per la riabilitazione della dislessia Alice Cancer
Convegno La musica nello sviluppo delle abilità linguistiche 22 Ottobre 2016 Bosisio Parini (LC) Risultati di un training combinato di lettura e ritmo per la riabilitazione della dislessia Alice Cancer
DSA E DISPRASSIA Deficit delle Funzioni Esecutive Deficit della Memoria di Lavoro Lentezza Esecutiva difficoltà emotive
 DSA E DISPRASSIA Nella nostra pratica clinica, sempre più frequentemente osserviamo casi di bambini con un deficit prassico-motorio in età prescolare, che presentano delle Difficoltà di Apprendimento in
DSA E DISPRASSIA Nella nostra pratica clinica, sempre più frequentemente osserviamo casi di bambini con un deficit prassico-motorio in età prescolare, che presentano delle Difficoltà di Apprendimento in
CORSO AGGIUNTIVO PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE PER GLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP NELLA SCUOLA A.A. 2014/15. Dr.ssa Giusy Gallo
 LINGUAGGI VERBALI CORSO AGGIUNTIVO PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE PER GLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA A.A. 2014/15 Dr.ssa Giusy Gallo Quarta lezione Sviluppo
LINGUAGGI VERBALI CORSO AGGIUNTIVO PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE PER GLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA A.A. 2014/15 Dr.ssa Giusy Gallo Quarta lezione Sviluppo
Indice. Introduzione. Il razionale sotteso all evoluzione delle Scale WISC Introduzione 3 Bambini e realtà clinica 5. L evoluzione degli strumenti 15
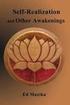 Indice Introduzione XIII Parte prima Il razionale sotteso all evoluzione delle Scale WISC Introduzione 3 Bambini e realtà clinica 5 Quali modelli psicopatologici per i bambini 5 Un modo diverso di considerare
Indice Introduzione XIII Parte prima Il razionale sotteso all evoluzione delle Scale WISC Introduzione 3 Bambini e realtà clinica 5 Quali modelli psicopatologici per i bambini 5 Un modo diverso di considerare
Scuola e Scrittura: è sempre facile imparare? Lavorare sulla scrittura: presentazione di alcuni percorsi
 Scuola e Scrittura: è sempre facile imparare? Giornata di studio Genova, 30 ottobre 2015 Lavorare sulla scrittura: presentazione di alcuni percorsi Emilia Restani (Pedagogista) iltimone@libero.it PRESENTAZIONE
Scuola e Scrittura: è sempre facile imparare? Giornata di studio Genova, 30 ottobre 2015 Lavorare sulla scrittura: presentazione di alcuni percorsi Emilia Restani (Pedagogista) iltimone@libero.it PRESENTAZIONE
Elementi desunti dalla diagnosi. Elementi desunti dalla diagnosi
 PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO DSA ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA ANNO SCOLASTICO: Nome e Cognome Tipologia Data di nascita Presenza di certificazione di Disturbo Specifico
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO DSA ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA ANNO SCOLASTICO: Nome e Cognome Tipologia Data di nascita Presenza di certificazione di Disturbo Specifico
Piano Didattico Personalizzato
 1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A. STRADELLA - NEPI - Anno Scolastico... Scuola...... Classe... 2 A)
1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A. STRADELLA - NEPI - Anno Scolastico... Scuola...... Classe... 2 A)
Ciclo di incontri con operatori scolastici: struttura
 Ciclo di incontri con operatori scolastici: struttura 1. Incontri teorico/pratici: tutti gli insegnanti 2. Incontri pratici: gruppo tecnico Ciclo di incontri con operatori scolastici: gli argomenti 1.
Ciclo di incontri con operatori scolastici: struttura 1. Incontri teorico/pratici: tutti gli insegnanti 2. Incontri pratici: gruppo tecnico Ciclo di incontri con operatori scolastici: gli argomenti 1.
Studi italiani sul trattamento della dislessia evolutiva
 v.16/9/2010 Studi italiani sul trattamento della dislessia evolutiva Patrizio Tressoldi Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova Obiettivi dello studio: -Riportare i risultati dei trattamenti
v.16/9/2010 Studi italiani sul trattamento della dislessia evolutiva Patrizio Tressoldi Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova Obiettivi dello studio: -Riportare i risultati dei trattamenti
Dal disegno al tratto grafico. Costruire le abilità grafo motorie in continuità tra la scuola dell infanzia e la scuola materna
 Comune di Pistoia, Servizio Educazione e Cultura 13 marzo 2015 Dal disegno al tratto grafico. Costruire le abilità grafo motorie in continuità tra la scuola dell infanzia e la scuola materna Ciro Ruggerini
Comune di Pistoia, Servizio Educazione e Cultura 13 marzo 2015 Dal disegno al tratto grafico. Costruire le abilità grafo motorie in continuità tra la scuola dell infanzia e la scuola materna Ciro Ruggerini
La vocazione professionale e la carriera accademica. Report della prima fase di ricerca
 La vocazione professionale e la carriera accademica Report della prima fase di ricerca 1 Obiettivi dell indagine Il focus della nostra ricerca è la vocazione professionale: l esperienza di una passione
La vocazione professionale e la carriera accademica Report della prima fase di ricerca 1 Obiettivi dell indagine Il focus della nostra ricerca è la vocazione professionale: l esperienza di una passione
5 LEZIONE. LA DISGRAFIA: INSEGNARE A SCRIVERE BENE
 5 LEZIONE. LA DISGRAFIA: INSEGNARE A SCRIVERE BENE La scrittura Come abbiamo più volte ripetuto, la scrittura è un abilità altamente complessa che include livelli diversi, dal motorio al concettuale, che
5 LEZIONE. LA DISGRAFIA: INSEGNARE A SCRIVERE BENE La scrittura Come abbiamo più volte ripetuto, la scrittura è un abilità altamente complessa che include livelli diversi, dal motorio al concettuale, che
