TEST PER GLI STUDENTI
|
|
|
- Salvatore Poggi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 TEST PER GLI STUDENTI Domande a scelta multipla a supporto del manuale Daft R., Organizzazione aziendale, quinta edizione, Apogeo, Milano, 2013.
2 CAP 1. ORGANIZZAZIONI E TEORIA ORGANIZZATIVA 1. Un sistema aperto: a. Deve interagire con l ambiente per sopravvivere. b. Non si adatta all ambiente. c. È autonomo d. Rende più efficace l organizzazione attraverso un accurata progettazione interna. 2. Con il termine "organizzazione" si intende: a. Un entità guidata da obiettivi che vengono definiti dai sui membri e raggiunti attraverso una pianificazione strategica. b. Un entità con confini identificabili e permanenti. c. Un entità sociale guidata da obiettivi, progettata come sistema di attività deliberatamente strutturato e coordinato che interagisce con l ambiente esterno. d. Un azienda che svolge attività professionali e contribuisce alla sua società attraverso l'impiego di persone. 3. Le organizzazioni esistono per svolgere tutte le seguenti attività tranne: a. Mettere insieme risorse per raggiungere gli obiettivi e i risultati desiderati. b. Creare un ambiente stabile ed immutabile. c. Facilitare l innovazione. d. Creare valore per azionisti, clienti e dipendenti. 4. Quale delle seguenti definizioni descrive le caratteristiche interne di un organizzazione? a. Dimensioni contestuali. b. Analisi delle contingenze. c. Dinamiche organizzative. d. Dimensioni strutturali. 5. Lo Scientific management era: a. Sostenuto da Henri Fayol. b. Uno sviluppo degli studi di Hawthorne che avevano portato alla conclusione che le persone raggiungono 1
3 risultati migliori in un ambiente in cui i compiti sono chiaramente specificati e definiti. c. Basato sull efficacia piuttosto che sull efficienza. d. Efficace nell incrementare l output, in parte attraverso l uso di sistemi di incentivi. 6. Il grado in cui i compiti organizzativi vengono suddivisi tra posizioni lavorative separate viene indicato come: a. Formalizzazione. b. Specializzazione. c. Professionalità. d. Centralizzazione. 7. Gli elementi chiave di un organizzazione sono a. I suoi edifici e le sue politiche. b. Le persone e le loro relazioni. c. I profitti. d. Gli impianti di produzione. 8. è il grado in cui un organizzazione raggiunge i suoi obiettivi. a. Efficacia. b. Efficienza. c. Strategia organizzativa. d. Soddisfazione degli stakeholder. 9. si riferisce alla quantità di risorse impiegate per raggiungere gli obiettivi dell organizzazione a. Approccio degli stakeholder. b. Efficacia. c. Efficienza. d. Gestione delle risorse. 2
4 10. Il termine contingenza esprime il fatto che: a. Le organizzazioni dovrebbero essere strutturate in maniera indefinita. b. La struttura di management è determinata dall epoca o periodo. c. Una cosa dipende da altre cose, così come la struttura dipende dall ambiente. d. Il gruppo chiave di lavoratori dovrebbe essere composto da laureati. CAP 2. STRATEGIA, PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA ED EFFICACIA 1. Le scelte che i top manager fanno relativamente agli obiettivi, strategie e progettazione organizzativa hanno un forte impatto su: a. Redditività aziendale. b. Efficienza organizzativa. c. Efficacia organizzativa. d. Quota di mercato. 2. Il termine missione indica: a. Obiettivi operativi. b. Linee guida decisionali. c. Obiettivi ufficiali. d. Standard di performance. 3. Un piano per l interazione con l ambiente competitivo volto a raggiungere gli obiettivi organizzativi è: a. La strategia. b. Il progetto. c. La cultura. d. La struttura. 3
5 4. Gli obiettivi ufficiali forniscono, mentre gli obiettivi operativi e le strategie forniscono. a. Obiettivi misurabili, legittimità. b. Legittimità, direzione ai dipendenti. c. Direzione ai dipendenti, linee guida per le decisioni. d. Linee guida per le decisioni, legittimità. 5. I modelli per la formulazione di strategie organizzative includono: a. La tipologia di Perrow ed il modello di Porter. b. Il modello di Daft e la tipologia di Pfeiffer. c. Il modello di Porter e la tipologia di Miles e Snow. d. La tipologia di Bowerman ed il modello di Miles e Snow. 6. L approccio basato sulle risorse enfatizza: a. Gli input nelle organizzazioni. b. Gli output delle organizzazioni. c. Il conseguimento della redditività. d. L efficace funzionamento dei processi interni. 7. Secondo il modello delle strategie competitive di Porter, quale strategia dovrebbe perseguire un azienda che ha un vantaggio competitivo di costi bassi e un ambito competitivo ristretto? a. Leadership di costo. b. Differenziazione. c. Leadership di costo focalizzata. d. Differenziazione focalizzata. 4
6 8. Quale delle seguenti, fra le tipologie strategiche di Miles and Snow, si adatta meglio con forti capacità di ricerca, una struttura decentrata, ed un enfasi sulla flessibilità? a. Impresa reattiva. b. Leadership di costo. c. Impresa esploratrice. d. Impresa analitica. 9. Quale delle seguenti affermazioni è vera rispetto all approccio degli obiettivi? a. Una completa misurazione dell efficacia dovrebbe considerare contemporaneamente diversi obiettivi, poiché l elevato raggiungimento di un obiettivo potrebbe voler dire il basso raggiungimento di un altro. b. La definizione delle priorità richiede che solo un obiettivo per volta venga raggiunto. c. Non c è spazio per la valutazione soggettiva del raggiungimento degli obiettivi nelle organizzazioni di oggi. d. L obiettivo più comune nelle aziende oggi ha a che fare con lo sviluppo del management. 10. Quale delle seguenti espressioni indica qualcosa che l organizzazione fa particolarmente bene rispetto ai suoi concorrenti? a. Obiettivo operativo. b. Obiettivo organizzativo. c. Competenza distintiva. d. Balanced score card. CAP 3. ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 1. Quale delle seguenti affermazioni è vera rispetto alle informazioni all interno delle organizzazioni? a. Le informazioni dovrebbero fluire orizzontalmente, ma non verticalmente. b. Le informazioni dovrebbero fluire verticalmente, ma non orizzontalmente. c. L organizzazione dovrebbe essere progettata per soddisfare le esigenze informative. d. Non è possibile dare alle persone troppe informazioni. 5
7 2. Quale fra questi non è un meccanismo strutturale usato per ottenere collegamenti verticali? a. Regole e piani. b. Task forces. c. Sistemi informativi verticali. d. Riporto gerarchico. 3. significa che l autorità decisionale è assegnata ai livelli inferiori dell organizzazione. a. Processo decisionale accentrato. b. Collegamenti orizzontali. c. Processo decisionale decentrato. d. Collegamenti verticali. 4. I meccanismi di collegamento orizzontale: a. Provocano nei dipendenti un senso di confusione per l assenza di un unità di comando. b. Devono essere aggiunti alle strutture divisionali per il coordinamento tra aree funzionali. c. Dovrebbero essere evitati poiché confondono i collegamenti verticali. d. Permettono alle persone che lavorano in unità organizzative differenti di scambiarsi informazioni e coordinarsi. 5. Quale fra i seguenti è un comitato temporaneo composto da rappresentanti di ogni unità interessata da un problema? a. Top management team. b. Team virtual. c. Task force. d. Team funzionale. 6. Quale fra i seguenti NON è un punto di forza di una struttura funzionale? a. Facilita le economie di scala all interno delle unità funzionali. b. È da preferire in presenza di un solo prodotto o pochi prodotti. c. Permette lo sviluppo di conoscenze e capacità approfondite. d. Porta alla soddisfazione del cliente perché le responsabilità sul prodotto e i punti di contatto sono chiari. 6
8 7. Un azienda che voglia mantenere una struttura funzionale ma sta avendo difficoltà di coordinamento tra unità funzionali a causa della crescita: a. Dovrebbe instaurare collegamenti orizzontali. b. Dovrebbe abbandonare la struttura funzionale per una a matrice. c. Potrebbe abolire i ruoli di collegamento. d. Dovrebbe aggiungere altre unità funzionali. 8. La struttura per prodotto o divisionale: a. Non è indicata in caso di rapidi cambiamenti in un ambiente instabile. b. Accentra il processo decisionale. c. Facilita l integrazione e la standardizzazione tra linee di prodotto. d. Permette alle unità di adattarsi a differenze di prodotto, geografiche, di clientela. 9. La struttura a matrice: a. Mantiene sempre rapporti di duplice autorità. b. Dovrebbe essere considerata solo in un ambiente stabile. c. È progettata per essere utilizzata all interno di una burocrazia. d. E conosciuta per la sua qualità di centralizzazione delle decisioni chiave per il controllo. 10. Nella struttura orizzontale: a. I process owner hanno la responsabilità di ogni processo chiave nella sua interezza. b. Poiché i membri di un team vengono riconosciuti come esperti solo in una singola area, la formazione interfunzionale che caratterizza altre forme organizzative è limitata. c. I confine tra le unità sono chiaramente definiti per garantire l expertise funzionale. d. Se l'organizzazione si è radicata in una rigida struttura verticale e gerarchica, è pronta per una immediata e rapida implementazione della struttura orizzontale. CAP 4. L AMBIENTE ESTERNO 1. L ambiente di un organizzazione include tutti i seguenti elementi eccetto: a. Mercato del lavoro. 7
9 b. Città, stati, leggi. c. Concorrenti. d. Processi produttivi. 2. I settori dell ambiente che non hanno un impatto diretto sulle attività quotidiane di un organizzazione ma la influenzano indirettamente sono chiamati: a. Ambiente generale. b. Contesto internazionale. c. Ambiente di riferimento. d. Area di influenza. 3. La valutazione dell incertezza ambientale di un organizzazione si basa principalmente sull analisi di due dimensioni, che sono: a. Il bisogno di ottenere informazioni sull ambiente e il bisogno di ottenere risorse dall ambiente. b. Il numero di settori e la nicchia organizzativa. c. Il grado di turbolenza e la quantità di risorse disponibili. d. Differenziazione ed integrazione. 4. In quale tipo di ambiente l organizzazione incontra il massimo grado di incertezza? a. Complesso, stabile. b. Complesso, instabile. c. Semplice, instabile. d. Semplice, stabile. 5. La diversità degli orientamenti cognitivi ed emotivi tra i manager di differenti unità funzionali e nella struttura formale tra tali unità è chiamata: a. Integrazione. b. Dipendenza da risorse. c. Cooptazione. d. Differenziazione. 8
10 6. è la qualità del coordinamento tra unità. a. Differenziazione. b. Integrazione. c. Incertezza. d. Cooptazione. 7. Le organizzazioni in ambienti in rapido mutamento tendono ad avere processi di management. a. Differenziato. b. Meccanico. c. Organico. d. Dipendente. 8. Quale delle seguenti NON è una caratteristica dei processi di management meccanici? a. La conoscenza e il controllo relativi ai compiti sono accentrati ai vertici dell organizzazione. b. I compiti sono rigidamente definiti. c. C è una rigida gerarchia di autorità e controllo. d. La comunicazione è orizzontale. 9. Ognuno dei seguenti, eccetto, sono modi in cui un alta-moderata incertezza ambientale influenza le caratteristiche organizzative. a. Struttura meccanica: formale, centralizzata. b. Pochi ruoli di integrazione. c. Orientamento alla pianificazione; risposta rapida. d. Poche unità organizzative, molte attività di confine. 10. significa che le organizzazioni dipendono dall ambiente, ma cercano di ottenere il controllo sulle risorse per minimizzare tale loro dipendenza. a. Integrazione. b. Dipendenza dalle risorse. c. Processo organico. 9
11 d. Cooptazione. CAP 5. RELAZIONI INTERORGANIZZATIVE 1. Un sistema formato dalle interazioni di una comunità di organizzazioni e dei loro rispettivi ambienti è chiamato: a. Relazioni interorganizzative. b. Ecosistema organizzativo c. Network collaborativi. d. Ambiente istituzionale. 2. Quale fra i seguenti NON appartiene al modello delle relazioni interorganizzative? a. Ecologia delle popolazioni. b. Istituzionalismo. c. Network collaborativo. d. Competizione condivisa. 3. Quale teoria sostiene che le organizzazioni cercano di minimizzare la loro dipendenza da altre organizzazioni riguardo l acquisizione di risorse importanti e di influenzare l ambiente per ottenere la disponibilità di tali risorse? a. Teoria interorganizzativa. b. Teoria economica classica. c. Teoria della dipendenza dalle risorse. d. Teoria della domanda. 4. In quale delle seguenti prospettive le aziende si uniscono allo scopo di diventare maggiormente concorrenziali e di condividere risorse scarse? a. Network collaborativo. b. Dipendenza dalle risorse. c. Ecologia delle popolazioni. d. Istituzionalismo. 10
12 5. Quale delle seguenti non è una delle principali motivazioni che spingono verso la collaborazione interorganizzativa? a. Condivisione dei rischi quando si entra in nuovi mercati. b. Intraprendere nuovi e onerosi programmi riducendo i costi. c. Migliorare la posizione dell organizzazione in determinati settori o tecnologie. d. Fattori interpersonali. 6. Un assunto di base dell approccio dell ecologia delle popolazioni è che: a. Le competenze manageriali rappresentano il fattore più importante nella sopravvivenza delle organizzazioni. b. L ambiente determina quali organizzazioni sopravvivono e quali muoiono. c. I principi dell evoluzione non sono applicabili alle organizzazioni perché il più adattato non sopravvive. d. Una comunità di organizzazioni è un sistema chiuso. 7. Cosa è composto da norme e valori propri dei diversi stakeholder? a. Ambiente istituzionale. b. Nicchia di mercato. c. Ecosistema organizzativo. d. Isomorfismo istituzionale. 8. Cosa è definito come la percezione che le azioni di un organizzazione sono desiderabili, opportune e appropriate nel contesto del sistema ambientale di norme, valori e credenze? a. Strategia generalista. b. Legittimità. c. Nicchia. d. Network collaborativo. 9. Un esempio di forza mimetica è: a. Reengineering. b. Standard contabili. c. Controllo dell inquinamento. 11
13 d. Formazione consulenziale. 10. Un evento di forza coercitiva è: a. Professionalità. b. Certificazione. c. Visibilità delle innovazioni. d. Legge. CAP 6. PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA PER L AMBIENTE INTERNAZIONALE 1. Quale fra i seguenti NON è uno dei principali fattori che spingono le aziende verso l espansione internazionale? a. Fattori di produzione a basso costo. b. Minor numero di canali distributivi. c. Economie di scala. d. Economie di gamma. 2. si riferisce al numero e alla varietà dei prodotti e servizi offerti da un azienda, e al numero e alla varietà delle regioni, dei paesi e dei mercati da essa serviti. a. Economie di scala. b. Mercato potenziale. c. Gamma. d. Fase di sviluppo. 3. Nello stadio dello sviluppo internazionale, si verifica un esplosione del business con il decollo delle attività internazionali. a. Globale. b. Domestico. c. Multinazionale. d. Internazionale. 12
14 4. Quale fra queste opera in maniera realmente globale e l intero mondo è il suo mercato di riferimento? a. Azienda multidomestica. b. Azienda nazionale. c. Agenzia governativa. d. Azienda globale. 5. Nello stadio, l unità dedicata all export è stata sostituita da una divisione internazionale e sono state assunte persone specializzate per gestire le attività rivolte all estero per quanto riguarda vendite, servizi e magazzini. a. Domestico. b. Internazionale. c. Globale. d. Multinazionale. 6. La struttura globale per prodotto lavora meglio quando le divisioni si occupano di prodotti che: a. Sono tecnologicamente dissimili. b. Possono essere standardizzati per tutti i mercati. c. Sono obsoleti in una nazione ma non in un altra. d. Sono economici e facili da produrre. 7. La struttura globale divisionale geografica: a. E molto utile per nuove linee di prodotto. b. Funziona bene per i prodotti con rapida evoluzione delle tecnologie. c. Funziona meglio se vi sono esigenze simili per il prodotto in tutti i paesi. d. Presenta difficoltà nelle attività di pianificazione su scala globale. 8. La struttura globale a matrice: a. Aumenta il coordinamento orizzontale, ma diminuisce il coordinamento verticale. b. Funziona al meglio quando la pressione sui processi decisionali bilancia gli interessi relativi sia alla standardizzazione di prodotto sia alla localizzazione geografica. c. Aumenta il coordinamento verticale, ma diminuisce il coordinamento orizzontale. 13
15 d. È tipica nelle aziende che hanno raggiunto lo stadio internazionale nel processo di espansione internazionale. 9. sono tipiche degli ambienti altamente instabili. a. Strutture ibride. b. Strutture globali geografiche. c. Strutture globali a matrice. d. Strutture transnazionali. 10. Il modello, costituisce l esempio migliore sia in termini di complessità organizzativa, comprendendo un gran numero di unità diverse, sia in termini di coordinamento organizzativo, prevedendo meccanismi per integrare le varie parti. a. Trasformativo. b. Transnazionale. c. Globale. d. Multidomestico. CAP 7. TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE MANIFATTURIERA E PER I SERVIZI 1. La è il processo di lavoro che è direttamente correlato alla missione dell organizzazione. a. Core technology. b. Tecnologia di mediazione. c. Tecnologia di concatenamento. d. Tecnologia ausiliaria. 2. La classificazione di Woodward basata sul sistema di produzione (in tre gruppi di tecnologie di base) era basata su una scala che misurava: a. L ampiezza del controllo gerarchico. b. L interdipendenza dei compiti. c. La complessità tecnica del processo manifatturiero. d. La varietà ed analizzabilità dei compiti in ogni unità. 14
16 3. Quale delle seguenti tecnologie di produzione rappresenta un passo ulteriore rispetto alla meccanizzazione e alla standardizzazione che caratterizzano una linea di assemblaggio? a. Processo continuo. b. Grandi lotti. c. Complessità tecnica. d. Piccoli lotti. 4. Quale dei seguenti sistemi mette in rete componenti della produzione manifatturiera che operavano precedentemente in maniera isolata? a. Sistemi a processo continuo. b. Sistemi manifatturieri flessibili. c. Sistemi tecnologici avanzati. d. Sistemi computerizzati. 5. Il cuore della non sono le macchine, ma il coinvolgimento dei lavoratori. a. Personalizzazione di massa. b. Produzione flessibile. c. Produzione snella. d. Standardizzazione. 6. Le caratteristiche delle tecnologie per i servizi sono tutte le seguenti tranne: a. Sono accettabili tempi di risposta lunghi. b. Labor- and knowledge-intensive. c. L interazione con il cliente è generalmente alta. d. La qualità è percepita e difficile da misurare. 7. A quale dei seguenti aspetti è più interessato Perrow? a. Due dimensioni della tecnologia: varietà e analizzabilità. b. Due tipi di struttura che sembrano stabilire quale tecnologia sia migliore. c. Due aspetti dell'ambiente che richiedono una particolare struttura. 15
17 d. Due tipi di struttura che sembrano stabilire quale ambiente dovrebbe essere attuato. 8. è il livello più alto di interdipendenza ed esiste quando l output dell operazione A costituisce l input dell operazione B e l output dell operazione B costituisce a sua volta l input dell operazione A. a. Interdipendenza reciproca. b. Interdipendenza generica. c. Interdipendenza sequenziale. d. Interdipendenza routinaria. 9. Quale delle seguenti espressioni indica che la mansione offre un livello maggiore di responsabilità, di riconoscimento e di opportunità per la crescita e lo sviluppo? a. Arricchimento della mansione. b. Rotazione delle mansioni. c. Progettazione della mansione. d. Semplificazione delle mansioni 10. Lo scopo dell approccio dei sistemi socio-tecnici è: a. Applicare la teoria dell allargamento della mansione. b. Fornire management qualificato all organizzazione in un ambiente turbolento. c. Offrire il sistema IT più avanzato disponibile per massimizzare la competitività organizzativa. d. Combinare le necessità delle persone con la necessità di efficienza tecnica nella progettazione della mansione. CAP 8. TECNOLOGIE DELL INFORMAZIONE, CONTROLLO E COORDINAMENTO 1. Quale fra le seguenti categorie è tipicamente interessata a problemi ben definiti riguardanti l operatività e la produzione? a. Top management. b. Management di primo livello. c. Dipendenti. d. Integratori full-time. 16
18 2. I sistemi che automatizzano le transazioni routinarie e giornaliere come le vendite o gli acquisti dai fornitori sono chiamati: a. Transaction processing systems. b. Sistemi di analisi automatizzata. c. Inventory control systems. d. Sistema di supporto alle decisioni. 3. L utilizzo di grandi database che riuniscono tutti i dati relativi all azienda e permettono agli utenti di accedere direttamente ai dati, creare report e ottenere risposte a interrogazioni di tipo what-if vengono chiamati: a. Data mining. b. Data processing. c. Transaction processing systems. d. Data warehousing. 4. permette di compiere una sofisticata analisi dei dati di un impresa allo scopo di migliorare il processo decisionale strategico. a. Data warehousing. b. Data mining. c. Transaction processing. d. Business intelligence. 5. Qual è il più alto livello di applicazione delle tecnologie? a. Controllo interno. b. Applicazioni esterne per nuove forme di business. c. Arma strategica. d. Networking. 6. Quale fra i seguenti è un sistema interattivo di decisione progettato per aiutare i manager di tutti i livelli a prendere decisioni mediante database integrati in cui possono essere poste una serie di domande del tipo what-if? a. Sistema di supporto alle decisioni. 17
19 b. Transaction processing systems. c. Sistema informativo di gestione. d. Enterprise resource planning. 7. Quale fra i seguenti è un sistema di controllo di gestione generale che bilancia le tradizionali misurazioni di tipo finanziario con misure operative legate ai fattori critici di successo dell azienda? a. Benchmarking. b. Balanced scorecard. c. Management control system. d. Six Sigma. 8. Quale fra le seguenti NON è una prospettiva della balanced scorecard? a. Performance finanziaria. b. Capacità dell organizzazione di apprendere e crescere. c. Servizio ai clienti. d. Controllo qualità. 9. è lo sforzo sistematico di trovare, organizzare e rendere disponibile il capitale intellettuale di un azienda e di alimentare una cultura di apprendimento continuo e condivisione della conoscenza di modo che le attività organizzative possano costruire sulle conoscenze già acquisite. a. ERP. b. Six Sigma. c. Knowledge management. d. Benchmarking. 10. Un aspetto importante nell integrated enterprise è: a. Six Sigma. b. Networking. c. Sistemi di supply chain management. d. Intranet. 18
20 CAP 9. DIMENSIONI ORGANIZZATIVE, CICLO DI VITA E DECLINO 1. Le organizzazioni di grandi dimensioni possiedono tutte le seguenti caratteristiche tranne: a. Gerarchia verticale. b. Complessità. c. Economie di scala. d. Ricerca della nicchia. 2. Quale caratteristica, fra le seguenti è propria delle organizzazioni di piccole dimensioni? a. Meccaniche. b. Complesse. c. Portata globale. d. Ricerca della nicchia. 3. In quale stadio del ciclo di vita di un organizzazione vengono stabilite le unità organizzative, insieme a una gerarchia di autorità, alla definizione dei compiti e ad una prima divisione del lavoro? a. Imprenditoriale. b. Formalizzazione. c. Collettività. d. Elaborazione. 4. Quali fra le seguenti caratteristiche è riconducibile allo stadio della formalizzazione nel ciclo di vita di un organizzazione? a. Comunicazione meno frequente e più formale. b. La direzione generale comincia ad interessarsi di strategia e pianificazione. c. Vengono implementati sistemi di incentivi basati sui profitti per i manager. d. Tutte le precedenti. 5. Quale delle seguenti NON è una dimensione della burocrazia secondo Weber? a. Regole e procedure. b. Specializzazione e divisione del lavoro. 19
21 c. Gerarchia dell autorità. d. Formazione dei dipendenti. 6. Regole e procedure standard, come teorizzato da Weber, dovevano: a. Aiutare i manager a tenere una linea dura con i dipendenti svogliati. b. Mantenere i manager nella loro posizione di controllo e potere. c. Permettere di eseguire le attività organizzative in modo prevedibile e routinario. d. Punire chiunque oltrepassi i limiti. 7. L autorità è basata sulla devozione nei confronti del carattere esemplare o dell eroismo di una persona fisica e dell ordine da questa stabilito. a. Razionale-legale. b. Tradizionale. c. Carismatica. d. Informale. 8. consiste nell uso di fattori sociali, come i valori condivisi, l impegno, le tradizioni e le opinioni, per controllare il comportamento. a. Controllo di mercato. b. Controllo burocratico. c. Controllo tradizionale. d. Controllo di clan. 9. Quale fra le seguenti NON è una delle cause del declino organizzativo? a. Vulnerabilità. b. Aumento del prezzo dei prodotti. c. Declino ambientale o competizione. d. Atrofia organizzativa. 20
22 10. Nelle fasi di ridimensionamento, queste tecniche possono agevolare tale processo ed alleviare la tensione dei dipendenti che lasciano l azienda e di quelli che vi rimangono, eccetto: a. Aiutare i sopravvissuti a prosperare. b. Aumentare la comunicazione, non diminuirla. c. Fornire assistenza ai lavoratori licenziati. d. Lasciare che i lavoratori affrontino la situazione da soli e a modo loro. CAP 10. CULTURA ORGANIZZATIVA E VALORI ETICI 1. La cultura organizzativa: a. Solitamente è in forma scritta. b. Fornisce ai membri un senso di identità. c. Genera commitment per incrementare la quota di mercato. d. Tutte le precedenti. 2. si riferisce a come l organizzazione raggiunge gli obiettivi e si relaziona con entità esterne. a. Adattamento interno. b. Cultura della missione. c. Integrazione interna. d. Adattamento esterno. 3. Quale tipo di cultura esiste in un ambiente stabile con un focus strategico esterno? a. Adattiva. b. Burocratica. c. Di clan. d. Della missione. 4. La cultura è caratterizzata da è caratterizzata da un focus strategico sull ambiente esterno che si traduce in flessibilità e cambiamento allo scopo di soddisfare le necessità dei clienti. a. Adattiva. 21
23 b. Della missione. c. Di clan. d. Burocratica. 5. La cultura ha un focus interno e un orientamento coerente con un ambiente stabile. a. Organica. b. Di clan. c. Tradizionale. d. Burocratica. 6. Lo sviluppo di è la manifestazione di problemi comuni, obiettivi ed esperienze condivise dai membri di un gruppo, di un reparto o di un altra unità organizzativa. a. Learning organization. b. Comitati etici. c. Sottoculture. d. Linee guida etiche. 7. Nelle learning organization le persone condividono una cultura organizzativa forte caratterizzata dall idea che: a. Il tutto è più importante delle singole parti e i confini tra le parti sono ridotti al minimo. b. Rigidità e stabilità sono la chiave della redditività a lungo termine c. Deve essere garantito l impiego a vita per i lavoratori di tutti i livelli d. Lo status quo non deve mai essere messo in discussione. 8. consiste in principi che guidano le decisioni e i comportamenti dei manager in merito al fatto che essi siano giusti o sbagliati sotto l aspetto morale. a. Etica manageriale. b. Responsabilità sociale. c. Codice etico. d. Cultura organizzativa. 22
24 9. è un estensione del concetto di etica manageriale e si riferisce al dovere da parte del management di effettuare scelte e intraprendere iniziative che contribuiscano al benessere e all interesse di tutti gli stakeholder dell organizzazione. a. Norma di legge. b. Leadership basata sui valori. c. Responsabilità sociale d impresa. d. Adattamento esterno. 10. Un rapporto tra il leader e gli altri membri del gruppo fondato su ideali condivisi e fortemente interiorizzati che sono difesi e applicati dal leader viene definito: a. Cultura della missione. b. Leadership basata sui valori. c. Cultura di clan. d. Leadership domestica. CAP 11. INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO 1. Le quattro tipologie strategiche di cambiamento includono le seguenti categorie tranne: a. Tecnologia. b. Prodotti e servizi. c. Strategia e struttura. d. Stadio del ciclo di vita. 2. L adozione di un concetto o di un comportamento che è nuovo per il settore, il mercato o l ambiente generale relativi a un organizzazione viene definito: a. Approccio ambidestro. b. Approccio duale. c. Cambiamento di strategia e struttura. d. Innovazione organizzativa. 23
25 3. si verifica quando i membri dell organizzazione utilizzano effettivamente una nuova idea, tecnica o comportamento. a. Coordinamento. b. Valutazione. c. Formulazione. d. Implementazione. 4. Con approccio ambidestro si intende: a. L implementazione di strutture e processi di gestione che siano appropriati sia per la creazione dell innovazione, sia per la sua implementazione. b. L introduzione di parti di una nuova procedura mantenendo contemporaneamente parti della vecchia procedura. c. L assenza di collegamenti interfunzionali fra varie unità. d. Il coinvolgimento di personale altamente specializzato per implementare il cambiamento. 5. L imprenditorialità aziendale interna: a. Tenta di liberare l energia creativa di tutti i dipendenti. b. Di solito si traduce in un minor numero, anche se di qualità superiore, di innovazioni. c. Sostituirà le unità creative ed i venture team. d. Porta all idea dei champion intellettuali che sono i supervisori del processo produttivo. 6. Tre componenti chiave della progettazione organizzativa per l ottenimento di un innovazione di prodotto sono: a. Specializzazione, ruoli di confine e coordinamento orizzontale. b. Formalizzazione, gerarchia e struttura organica. c. Specializzazione, formalizzazione e standardizzazione. d. Processi duali, supporto del top management e cambiamento incrementale. 7. implica l estensione della ricerca e commercializzazione di nuovi prodotti al di là dei confini dell organizzazione, e addirittura al di là delle frontiere del comparto. a. Innovazione aperta. 24
26 b. Innovazione organizzativa. c. Intervento su grandi gruppi. d. Monitoraggio tecnologico. 8. Le organizzazioni possono essere viste come dotate di due nuclei: a. Nucleo gestionale; nucleo flessibile. b. Nucleo tecnico; nucleo gestionale. c. Nucleo adattabile; nucleo tecnico. d. Nucleo innovativo; nucleo gestionale. 9. Quale delle seguenti NON è una forza per il cambiamento culturale? a. Learning organization. b. Diversità della forza lavoro. c. Intervento su grandi gruppi. d. Reengineering e organizzazione orizzontale. 10. si concentra sugli aspetti umani e sociali dell organizzazione come strumenti per migliorare la capacità dell organizzazione di adattarsi e risolvere i problemi. a. Innovazione organizzativa. b. Cambiamento organizzativo. c. Processo di cambiamento. d. Sviluppo organizzativo. CAP 12. PROCESSI DECISIONALI 1. In quale stadio del processo decisionale si prendono in considerazione i possibili percorsi di azione e si sceglie e si realizza un alternativa? a. Stadio del consenso sul problema. b. Stadio della identificazione del problema. c. Stadio della soluzione del problema. 25
27 d. Stadio della generazione del problema. 2. Le sono ripetitive e ben definite, ed esistono procedure per la risoluzione del problema. a. Decisioni programmate. b. Decisioni incrementali. c. Decisioni non programmate. d. Decisioni irrazionali. 3. L approccio decisionale razionale coinvolge tutti i seguenti step tranne: a. Definire il problema. b. Valutare le alternative. c. Implementare un alternativa per testare la sua fattibilità. d. Diagnosticare il problema. 4. Le decisioni intuitive vengono prese facendo uso di: a. Logica. b. Giudizio. c. Ragionamento esplicito. d. Approccio sistematico. 5. L approccio decisionale delle scienze manageriali è un eccellente strumento quando: a. I problemi non sono analizzabili e il consenso sul problema è alto. b. I problemi sono analizzabili e quando le variabili possono essere identificate e misurate. c. La conoscenza della soluzione è bassa e il consenso sul problema è basso. d. La conoscenza della soluzione è bassa e i problemi non possono essere strutturati logicamente. 6. Il modello Carnegie di processo decisionale organizzativo afferma che le decisioni organizzative: a. Coinvolgono pochi manager a causa della semplicità con cui le decisioni sono prese. b. Si basano su coalizioni per la scelta finale. 26
28 c. Evita la trappola della ricerca per problemi. d. Si basano su coalizioni solo ai livelli inferiori di management. 7. Il modello del processo decisionale incrementale enfatizza: a. Fattori politici. b. Fattori sociali. c. Sequenza strutturata di attività nel processo decisionale. d. Processi intuitivi. 8. Quali fra le seguenti sono caratteristiche delle anarchie organizzate? a. Problemi chiaramente definiti, tecnologia non chiara e turnover. b. Tecnologia non chiara, turnover e preferenze problematiche. c. Cambiamento lento, ambiente non burocratico e turnover. d. Rapido cambiamento, obiettivi ambigui e turnover. 9. Nel modello del contenitore dei rifiuti: a. Le soluzioni possono essere proposte anche quando i problemi non esistono. b. Le scelte possono essere fatte solo per risolvere i problemi. c. Vengono risolti molti problemi. d. Le decisioni organizzative sono ordinate. 10. L accordo tra i manager sulla natura di un problema o di un opportunità e su quali obiettivi e risultati perseguire è definito: a. Processo decisionale organizzativo. b. Ricerca per problemi. c. Anarchia organizzata. d. Consenso sul problema 27
29 CAP 13. CONFLITTO, POTERE E POLITICA 1. è il comportamento che si verifica tra gruppi di un organizzazione quando i partecipanti si identificano con un gruppo e hanno la percezione che un altro gruppo possa bloccare il raggiungimento (o le attese di raggiungimento) dei loro obiettivi. a. Incompatibilità di obiettivi. b. Conflitto intergruppo. c. Conflitto politico. d. Differenziazione. 2 Quando gli obiettivi sono allineati, c è una differenziazione minima, le unità sono caratterizzate da interdipendenza generica e le risorse sembrano abbondanti, I manager possono utilizzare di organizzazione. a. Un modello politico. b. Il potere di riferimento. c. L autorità formale. d. Un modello razionale. 3. è la capacità di una persona o di un unità in un organizzazione di influenzare altre persone per conseguire i risultati desiderati. a. Cooperazione. b. Collaborazione. c. Potere. d. Posizione personale. 4. Il potere legittimo deriva da: a. Posizione formale nell organizzazione. b. Capacità o conoscenze. c. Caratteristiche personali. d. Risorse controllate dai manager. 28
30 5. Relativamente al potere, il concetto di autorità formale: a. È più limitata nell ambito di applicazione. b. È un termine ombrello che racchiude tutti i tipi di potere. c. Indica la stessa cosa. d. È maggiormente dipendente dalla personalità. 6. Le fonti principali di potere verticale sono tutte le seguenti tranne: a. Controllo delle premesse decisionali. b. Centralità nella rete. c. Posizione formale. d. Manipolazione. 7. significa condivisione e delega di potere o autorità ai subordinati all interno di un organizzazione. a. Empowerment. b. Confronto. c. Dipendenza. d. Fonte di potere. 8. Le contingenze strategiche si riferiscono a: a. Eventi e attività essenziali per l ottenimento degli obiettivi organizzativi. b. Fattori ambientali che hanno un influenza indiretta sul raggiungimento degli obiettivi organizzativi. c. Piani strategici alternativi per gestire possibili cambiamenti ambientali. d. Concorrenti che possono danneggiare la posizione dell organizzazione. 9. è un meccanismo per raggiungere il consenso quando l incertezza è alta e c è disaccordo sugli obiettivi o sulle priorità del problema. a. Potere. b. Autorità. c. Politica. d. Premessa decisionale. 29
31 10. La strategia di negoziazione vincere-vincere: a. Usa le minacce. b. Trova accordi creativi che soddisfino entrambi i gruppi. c. Incoraggia ogni gruppo a perseguire risultati individuali. d. Comunica rigidità. TEST GENERALE 1. Ognuna delle seguenti è un punto di forza della struttura organizzativa divisionale, eccetto: a. Permette alle unità di adattarsi a differenze di prodotto, geografiche, di clientela. b. Genera un alto grado di coordinamento tra le funzioni. c. Accentra il processo decisionale. d. È da preferire in organizzazioni di grandi dimensioni con molti prodotti. 2. Una barriera organizzativa al cambiamento è: a. Evitare l incertezza. b. Paura di perdere. c. Rischio troppo basso. d. Eccessiva attenzione ai costi. 3. significa che i membri sviluppano un identità collettiva e sanno come lavorare insieme in maniera efficace. a. Adattamento esterno. b. Socializzazione. c. Integrazione interna. d. Identità culturale. 4. I settori dell ambiente che hanno un impatto diretto sull organizzazione sono chiamati: a. Ambiente di riferimento. b. Ambiente generale. 30
32 c. Unità cuscinetto. d. Ambiente internazionale. 5. Quale fra le seguenti strategie indica che la progettazione del prodotto, la produzione e la strategia di marketing sono standardizzate in tutto il mondo? a. Strategia di globalizzazione. b. Strategia di standardizzazione. c. Strategia multi domestica. d. Strategia transnazionale. 6. Tra le cinque componenti base di un organizzazione individuate da Mintzberg rientrano tutte le seguenti tranne una. Quale? a. Staff di supporto. b. Linea intermedia. c. Tecno-struttura. d. Infrastruttura IT. 7. Quale tra i seguenti gruppi di tecnologie di base si basa molto sull apporto umano e non è altamente automatizzato? a. Produzione a grandi lotti. b. Personalizzazione di massa. c. Produzione a processo continuo. d. Produzione a piccoli lotti. 8. L impatto dell information technology sulla progettazione organizzativa include: a. Organizzazioni più grandi. b. Strutture organizzative decentrate. c. Difficoltà nel coordinamento interno ed esterno d. Diminuzione del livello di partecipazione dei dipendenti. 31
33 9. Quale delle seguenti NON è una delle cinque forze di Porter? a. Minaccia di nuovi entranti. b. Potere dei dipendenti. c. Potere dei fornitori. d. Minaccia di prodotti sostitutivi. 10. Quale fra le seguenti NON è una strategia di controllo organizzativo? a. Tecnico. b. Di clan. c. Di mercato. d. Burocratico. 11. è difficile da misurare poiché non è definito dall organigramma. a. Contingenze strategiche. b. Potere orizzontale. c. Dipendenza. d. Premessa decisionale. 12. Un azienda che usa diffusamente un sistema computerizzato nel suo processo di produzione, partendo dalla progettazione passando attraverso l'ordine automatico delle materie prime fino ad arrivare alla gestione della distribuzione, quale tipo di modello decisionale organizzativo starebbe utilizzando? a. Modello del contenitore dei rifiuti. b. Modello del processo decisionale incrementale. c. Modello Carnegie. d. Approccio delle scienze manageriali. 13. Flussi, transazioni e collegamenti relativamente durevoli, che hanno luogo tra due o più organizzazioni sono definiti: a. Intranet. b. Relazioni interorganizzative. c. Dipendenza dalle risorse. 32
34 d. Ambiente istituzionale. SOLUZIONI CAPITOLO 1 CAPITOLO 2 CAPITOLO 3 DOMANDA RISPOSTA DOMANDA RISPOSTA DOMANDA RISPOSTA 1 A 1 C 1 C 2 C 2 C 2 B 3 B 3 A 3 C 4 D 4 B 4 D 5 D 5 C 5 C 6 B 6 A 6 D 7 B 7 C 7 A 8 A 8 C 8 D 9 C 9 A 9 A 10 C 10 C 10 A CAPITOLO 4 CAPITOLO 5 CAPITOLO 6 DOMANDA RISPOSTA DOMANDA RISPOSTA DOMANDA RISPOSTA 1 D 1 B 1 B 2 A 2 D 2 C 3 A 3 C 3 C 4 B 4 A 4 D 5 D 5 D 5 B 6 B 6 B 6 B 7 C 7 A 7 D 8 D 8 B 8 B 9 A 9 A 9 A 10 B 10 D 10 B 33
35 CAPITOLO 7 CAPITOLO 8 CAPITOLO 9 DOMANDA RISPOSTA DOMANDA RISPOSTA DOMANDA RISPOSTA 1 A 1 B 1 D 2 C 2 A 2 D 3 A 3 D 3 C 4 B 4 D 4 D 5 C 5 C 5 D 6 A 6 A 6 C 7 A 7 B 7 C 8 A 8 D 8 D 9 A 9 C 9 B 10 D 10 C 10 D CAPITOLO 10 CAPITOLO 11 CAPITOLO 12 DOMANDA RISPOSTA DOMANDA RISPOSTA DOMANDA RISPOSTA 1 B 1 D 1 C 2 D 2 D 2 A 3 D 3 D 3 C 4 A 4 A 4 B 5 D 5 A 5 B 6 C 6 A 6 B 7 A 7 A 7 C 8 A 8 B 8 B 9 C 9 C 9 A 10 B 10 D 10 D CAPITOLO 13 TEST GENERALE DOMANDA RISPOSTA DOMANDA RISPOSTA 1 B 1 C 2 D 2 D 3 C 3 C 34
36 4 A 4 A 5 A 5 A 6 D 6 D 7 A 7 D 8 A 8 B 9 C 9 B 10 B 10 A 11 B 12 D 13 B 35
Corso di ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
 Corso di ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Il corso fornisce le competenze necessarie per svolgere un analisi approfondita dell organizzazione di un azienda al fine di individuare le strategie e le azioni da implementare
Corso di ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Il corso fornisce le competenze necessarie per svolgere un analisi approfondita dell organizzazione di un azienda al fine di individuare le strategie e le azioni da implementare
CAPITOLO 6. Progettazione organizzativa per l ambiente internazionale
 CAPITOLO 6 Progettazione organizzativa per l ambiente internazionale Agenda Motivi dell espansione globale Stadi dell espansione globale Alleanze strategiche internazionali Espansione globale e struttura
CAPITOLO 6 Progettazione organizzativa per l ambiente internazionale Agenda Motivi dell espansione globale Stadi dell espansione globale Alleanze strategiche internazionali Espansione globale e struttura
Gestione e organizzazione aziendale le strutture organizzative per l'internazionalizzazione
 Gestione e organizzazione aziendale le strutture organizzative per l'internazionalizzazione 6 Facoltà di Economia Sede di Treviglio Giancarlo Traini Maggio 2012 il programma N data giorno ora tema capitolo
Gestione e organizzazione aziendale le strutture organizzative per l'internazionalizzazione 6 Facoltà di Economia Sede di Treviglio Giancarlo Traini Maggio 2012 il programma N data giorno ora tema capitolo
CAPITOLO CAPIT 0 Cultura organizzativa e valori ganizza etici
 CAPITOLO 10 Cultura organizzativa e valori etici Agenda Cultura organizzativa Cultura e progettazione Cultura e performance Valori etici nelle organizzazioni Responsabilità sociale d impresa Formare cultura
CAPITOLO 10 Cultura organizzativa e valori etici Agenda Cultura organizzativa Cultura e progettazione Cultura e performance Valori etici nelle organizzazioni Responsabilità sociale d impresa Formare cultura
CAPITOLO 8. Tecnologie per il controllo, il social business e i big data ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
 CAPITOLO 8 Tecnologie per il controllo, il social business e i big data 1 Agenda Evoluzione dell Information Technology I sistemi di controllo Sistemi di controllo a feedback IT e coordinamento interno
CAPITOLO 8 Tecnologie per il controllo, il social business e i big data 1 Agenda Evoluzione dell Information Technology I sistemi di controllo Sistemi di controllo a feedback IT e coordinamento interno
Lezione 10 Cultura organizzativa e valori etici ORGANIZZAZIONE AZIENDALE CAPITOLO 10. Cultura organizzativa e valori etici.
 CAPITOLO 10 Cultura organizzativa e valori etici 1 Agenda Cultura organizzativa Cultura e progettazione Cultura e performance Valori etici nelle organizzazioni Responsabilità sociale d impresa Formare
CAPITOLO 10 Cultura organizzativa e valori etici 1 Agenda Cultura organizzativa Cultura e progettazione Cultura e performance Valori etici nelle organizzazioni Responsabilità sociale d impresa Formare
L organizzazione. disposizione ed alla combinazione delle risorse da. necessarie per l ordinato svolgimento della gestione.
 L organizzazione Prospettiva allargata aspetti connessi alla disposizione ed alla combinazione delle risorse da impiegare nella gestione d impresa Prospettiva ristretta definire compiti, individuare responsabilità
L organizzazione Prospettiva allargata aspetti connessi alla disposizione ed alla combinazione delle risorse da impiegare nella gestione d impresa Prospettiva ristretta definire compiti, individuare responsabilità
Le parti dell organizzazione
 Le parti dell organizzazione Nucleo operativo: addetti al sistema operativo Vertice strategico: soggetti in posizione di responsabilità (componente direzionale) Linea intermedia: manager collocati tra
Le parti dell organizzazione Nucleo operativo: addetti al sistema operativo Vertice strategico: soggetti in posizione di responsabilità (componente direzionale) Linea intermedia: manager collocati tra
CAPITOLO CAPIT Dimensioni organizzativ ganizza e tiv, cic , cic o di vita e declino
 CAPITOLO 9 Dimensioni organizzative, ciclo di vita e declino Agenda Dimensioni:grande vs piccolo Ciclo di vita organizzativo Caratteristiche organizzative e ciclo di vita Burocrazia e controllo Burocrazia
CAPITOLO 9 Dimensioni organizzative, ciclo di vita e declino Agenda Dimensioni:grande vs piccolo Ciclo di vita organizzativo Caratteristiche organizzative e ciclo di vita Burocrazia e controllo Burocrazia
Struttura organizzativa. Teoria organizzativa. Valutare un'organizzazione. Struttura organizzativa
 Teoria organizzativa Struttura organizzativa Studia il funzionamento delle organizzazioni e come influenzano e vengono influenzate dall'ambiente in cui operano Per ogni organizzazione la struttura più
Teoria organizzativa Struttura organizzativa Studia il funzionamento delle organizzazioni e come influenzano e vengono influenzate dall'ambiente in cui operano Per ogni organizzazione la struttura più
CAPITOLO 4. L ambiente esterno
 CAPITOLO 4 L ambiente esterno Agenda L ambiente dell organizzazione Influenze ambientali Incertezza ambientale Approccio tradizionali Differenziazione ed integrazione Management meccanico ed organico La
CAPITOLO 4 L ambiente esterno Agenda L ambiente dell organizzazione Influenze ambientali Incertezza ambientale Approccio tradizionali Differenziazione ed integrazione Management meccanico ed organico La
Organizzazione aziendale a. a. 2018/2019 1
 Organizzazione aziendale a. a. 2018/2019 1 TECNOLOGIA & ORGANIZZAZIONE Taylor (1911) Scientific Management Il processo di st andardizzazione degli strumenti e dei procedimenti è la tecnologia che permette
Organizzazione aziendale a. a. 2018/2019 1 TECNOLOGIA & ORGANIZZAZIONE Taylor (1911) Scientific Management Il processo di st andardizzazione degli strumenti e dei procedimenti è la tecnologia che permette
CAPITOLO 4. Ambiente esterno
 CAPITOLO 4 1 Esempio di ambiente di una organizzazione (a) Concorrenti, dimensione del settore e competività, settori collegati (b) Fornitori, produttori, beni immobili, servizi (c) Mercato del lavoro,
CAPITOLO 4 1 Esempio di ambiente di una organizzazione (a) Concorrenti, dimensione del settore e competività, settori collegati (b) Fornitori, produttori, beni immobili, servizi (c) Mercato del lavoro,
Economia e direzione delle imprese
 Economia e direzione delle imprese Le condizioni organizzative per l implementazione delle strategie CONTENUTI Sistemi organizzativi aziendali e vantaggio competitivo La progettazione organizzativa Le
Economia e direzione delle imprese Le condizioni organizzative per l implementazione delle strategie CONTENUTI Sistemi organizzativi aziendali e vantaggio competitivo La progettazione organizzativa Le
Lezione 12 Processi decisionali ORGANIZZAZIONE AZIENDALE CAPITOLO 12. Processi decisionali.
 CAPITOLO 12 Processi decisionali 1 Agenda Le decisioni organizzative Processo decisionale individuale Processo decisionale organizzativo Modello contingente del processo decisionale Circostanze decisionali
CAPITOLO 12 Processi decisionali 1 Agenda Le decisioni organizzative Processo decisionale individuale Processo decisionale organizzativo Modello contingente del processo decisionale Circostanze decisionali
CAPITOLO 1. Organizzazioni e progettazione organizzativa ORGANIZAZIONE AZIENDALE. Lezione 1 Organizzazioni e progettazione organizzativa
 CAPITOLO 1 Organizzazioni e progettazione organizzativa 1 Agenda Le sfide organizzative Cos è un organizzazione L importanza delle organizzazioni Le dimensioni organizzative Risultati di performance ed
CAPITOLO 1 Organizzazioni e progettazione organizzativa 1 Agenda Le sfide organizzative Cos è un organizzazione L importanza delle organizzazioni Le dimensioni organizzative Risultati di performance ed
Le macro strutture organizzative «di base» e «modificate»
 Le macro strutture organizzative «di base» e «modificate» Corso di Progettazione Organizzativa Università Tor Vergata Anno Accademico 2018/2019 1 Le strutture organizzative di base Tre tipi fondamentali:
Le macro strutture organizzative «di base» e «modificate» Corso di Progettazione Organizzativa Università Tor Vergata Anno Accademico 2018/2019 1 Le strutture organizzative di base Tre tipi fondamentali:
Le 5 configurazioni. 1. Una tassonomia delle organizzazioni 2. Una sintesi delle correlazioni tra i diversi parametri di progettazione
 Le 5 configurazioni 1. Una tassonomia delle organizzazioni 2. Una sintesi delle correlazioni tra i diversi parametri di progettazione La Struttura semplice Coordinamento Supervisione diretta Parte fondamentale
Le 5 configurazioni 1. Una tassonomia delle organizzazioni 2. Una sintesi delle correlazioni tra i diversi parametri di progettazione La Struttura semplice Coordinamento Supervisione diretta Parte fondamentale
Corso di Organizzazione Aziendale
 Corso di Organizzazione Aziendale Alberto Francesconi a.a. 2010-2011 1 UN MODELLO DI PROGETTAZIONE DELL ASSETTO ORGANIZZATIVO D IMPRESA Ambiente Cultura Obiettivi e strategia Macro Struttura 1. Formalizzazione
Corso di Organizzazione Aziendale Alberto Francesconi a.a. 2010-2011 1 UN MODELLO DI PROGETTAZIONE DELL ASSETTO ORGANIZZATIVO D IMPRESA Ambiente Cultura Obiettivi e strategia Macro Struttura 1. Formalizzazione
La progettazione organizzativa. Tecnica Industriale e Commerciale 08/09
 La progettazione organizzativa Prospettiva Ritorniamo a occuparci di piccole, medie e grandi imprese Il tema trattato attiene alle scelte di organizzazione del lavoro del vertice (imprenditore e/o management)
La progettazione organizzativa Prospettiva Ritorniamo a occuparci di piccole, medie e grandi imprese Il tema trattato attiene alle scelte di organizzazione del lavoro del vertice (imprenditore e/o management)
Tecnologie per la produzione manifatturiera e per i servizi
 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 1 Tecnologie per la produzione manifatturiera e per i servizi 2 1 Processo di trasformazione di base per un azienda manifatturiera Organizzazione Risorse umane Contabilità R&S
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 1 Tecnologie per la produzione manifatturiera e per i servizi 2 1 Processo di trasformazione di base per un azienda manifatturiera Organizzazione Risorse umane Contabilità R&S
Meccanismi di Coordinamento
 Organizzazione Meccanismi di Coordinamento Divisione del lavoro nei vari compiti da eseguire Prof.ssa Enrica Gentile a.a. 2004-2005 Coordinamento di questi compiti per portare a termine l attività prof.ssa
Organizzazione Meccanismi di Coordinamento Divisione del lavoro nei vari compiti da eseguire Prof.ssa Enrica Gentile a.a. 2004-2005 Coordinamento di questi compiti per portare a termine l attività prof.ssa
La formalizzazione di Mintzberg
 Mintzberg Nozione di configurazione (o modello) = insieme coerente di variabili organizzative e di fattori contingenti L efficacia e l efficienza della progettazione organizzativa dipendono dalla coerenza
Mintzberg Nozione di configurazione (o modello) = insieme coerente di variabili organizzative e di fattori contingenti L efficacia e l efficienza della progettazione organizzativa dipendono dalla coerenza
CAPITOLO 12 Process i d i d i ec i ona ili
 CAPITOLO 12 Processi decisionali i Agenda Le decisioni organizzative Processo decisionale individuale Processo decisionale organizzativo Modello contingente del processo decisionale Circostanze decisionali
CAPITOLO 12 Processi decisionali i Agenda Le decisioni organizzative Processo decisionale individuale Processo decisionale organizzativo Modello contingente del processo decisionale Circostanze decisionali
CAPITOLO 2. Strategia, Progettazione Organizzativa ed Efficacia
 CAPITOLO 2 Strategia, Progettazione Organizzativa ed Efficacia Agenda Il Management Strategico Il progetto strategico Gli obiettivi operativi Strategia e struttura Fattori contingenti Misurare l efficacia
CAPITOLO 2 Strategia, Progettazione Organizzativa ed Efficacia Agenda Il Management Strategico Il progetto strategico Gli obiettivi operativi Strategia e struttura Fattori contingenti Misurare l efficacia
Innovazione e cambiamento
 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 1 Innovazione e cambiamento 2 1 Cause del cambiamento organizzativo 3 Cambiamento incrementale e radicale CAMBIAMENTO INCREMENTALE Consiste in una serie continua di progressi che
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 1 Innovazione e cambiamento 2 1 Cause del cambiamento organizzativo 3 Cambiamento incrementale e radicale CAMBIAMENTO INCREMENTALE Consiste in una serie continua di progressi che
ORGANIZZAZIONE E MANAGEMENT DELLE IMPRESE COOPERATIVE «Modulo Configurazioni Organizzative» A cura di: Alessandro Hinna
 ORGANIZZAZIONE E MANAGEMENT DELLE IMPRESE COOPERATIVE «Modulo Configurazioni Organizzative» A cura di: Alessandro Hinna H. Mintzberg Schema logico di esposizione 1. Ipotesi di partenza 2. L idea di configurazione
ORGANIZZAZIONE E MANAGEMENT DELLE IMPRESE COOPERATIVE «Modulo Configurazioni Organizzative» A cura di: Alessandro Hinna H. Mintzberg Schema logico di esposizione 1. Ipotesi di partenza 2. L idea di configurazione
Corrado Gatti, Antonio Renzi, Gianluca Vagnani, L impresa. I fondamenti. Copyright 2016 McGraw-Hill Education (Italy) srl
 Capitolo 4 Il contesto interno 4.1 Introduzione 4.2 L attività dell organizzazione 4.3 Le componenti del sistema organizzativo interno 4.3.1 Struttura 4.3.2 Persone 4.3.3 Incentivi 4.3.4 Cultura 4.3.5
Capitolo 4 Il contesto interno 4.1 Introduzione 4.2 L attività dell organizzazione 4.3 Le componenti del sistema organizzativo interno 4.3.1 Struttura 4.3.2 Persone 4.3.3 Incentivi 4.3.4 Cultura 4.3.5
Gestione e organizzazione aziendale considerazioni finali
 Gestione e organizzazione aziendale considerazioni finali 13 Facoltà di Economia Sede di Treviglio Giancarlo Traini Maggio 2012 il programma N data giorno ora tema capitolo 1 Introduzione 2 3/5 gio 14,30
Gestione e organizzazione aziendale considerazioni finali 13 Facoltà di Economia Sede di Treviglio Giancarlo Traini Maggio 2012 il programma N data giorno ora tema capitolo 1 Introduzione 2 3/5 gio 14,30
Contingentismo: i principi generali
 Contingentismo 1 Contingentismo: i principi generali L impresa deve adattare la propria configurazione organizzativa a fattori / condizioni di contesto la contingenza è il fattore (i fattori) di contesto
Contingentismo 1 Contingentismo: i principi generali L impresa deve adattare la propria configurazione organizzativa a fattori / condizioni di contesto la contingenza è il fattore (i fattori) di contesto
CAPITOLO 7. Tecnologie per la produzione manifatturiera e per i servizi ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
 CAPITOLO 7 Tecnologie per la produzione manifatturiera e per i servizi 1 Agenda Tecnologia e core technology Processi core ed ausiliari Tecnologia e struttura organizzativa Tecnologia core manifatturiera
CAPITOLO 7 Tecnologie per la produzione manifatturiera e per i servizi 1 Agenda Tecnologia e core technology Processi core ed ausiliari Tecnologia e struttura organizzativa Tecnologia core manifatturiera
INDICE. Prefazione... Pag. XIII CAPITOLO 1 LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA: UN INQUADRAMENTO
 INDICE Prefazione... Pag. XIII CAPITOLO 1 LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA: UN INQUADRAMENTO 1.1. Organizzazione e progettazione organizzativa... Pag. 1 1.2. Divisione del lavoro e coordinamento...» 5 1.3.
INDICE Prefazione... Pag. XIII CAPITOLO 1 LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA: UN INQUADRAMENTO 1.1. Organizzazione e progettazione organizzativa... Pag. 1 1.2. Divisione del lavoro e coordinamento...» 5 1.3.
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE LA FUNZIONE ORGANIZZATIVA PROF.SSA MIRELLA MIGLIACCIO
 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE LA FUNZIONE ORGANIZZATIVA PROF.SSA MIRELLA MIGLIACCIO Struttura della lezione - l organizzazione: una definizione -il processo di organizzazione: specializzazione e coordinamento
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE LA FUNZIONE ORGANIZZATIVA PROF.SSA MIRELLA MIGLIACCIO Struttura della lezione - l organizzazione: una definizione -il processo di organizzazione: specializzazione e coordinamento
C.so di Laurea STAG O (S.Severo)
 Corso di Economia Aziendale ed Estimo Rurale C.so di Laurea STAG O (S.Severo) Lezione n.4: a) Struttura, processi e meccanismi di governoi dell'azienda; b) Stima dei frutti pendenti; c) Espropriazioni
Corso di Economia Aziendale ed Estimo Rurale C.so di Laurea STAG O (S.Severo) Lezione n.4: a) Struttura, processi e meccanismi di governoi dell'azienda; b) Stima dei frutti pendenti; c) Espropriazioni
ORGANIZZARE LA GRU AA
 ORGANIZZARE LA GRU 1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA È uno degli strumenti che permettono di realizzare il coordinamento degli sforzi di un insieme di individui che mirano ad un determinato risultato La dimensione
ORGANIZZARE LA GRU 1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA È uno degli strumenti che permettono di realizzare il coordinamento degli sforzi di un insieme di individui che mirano ad un determinato risultato La dimensione
Lezione 12. Differenziazione e integrazione (Cap. 6 (2): pp , Decastri 2016)
 Lezione 12 Differenziazione e integrazione (Cap. 6 (2): pp. 161 181, Decastri 2016) Università degli Studi di Roma Tor Vergata Anno Accademico 2016/2017 1 Contenuti 1. Le impostazioni teoriche precedenti
Lezione 12 Differenziazione e integrazione (Cap. 6 (2): pp. 161 181, Decastri 2016) Università degli Studi di Roma Tor Vergata Anno Accademico 2016/2017 1 Contenuti 1. Le impostazioni teoriche precedenti
Organizzazione: teoria, progettazione e cambiamento
 Organizzazione: teoria, progettazione e cambiamento Edizione italiana a cura di G. Soda Capitolo 4 Problemi fondamentali di progettazione organizzativa Jones, Organizzazione Copyright 2007 Egea 4-1 Obiettivi
Organizzazione: teoria, progettazione e cambiamento Edizione italiana a cura di G. Soda Capitolo 4 Problemi fondamentali di progettazione organizzativa Jones, Organizzazione Copyright 2007 Egea 4-1 Obiettivi
L ambiente esterno e le relazioni interorganizzative
 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 1 L ambiente esterno e le relazioni interorganizzative 2 (a) Concorrenti, dimensione del settore e competività, settori collegati (b) Fornitori, produttori, beni immobili, servizi
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 1 L ambiente esterno e le relazioni interorganizzative 2 (a) Concorrenti, dimensione del settore e competività, settori collegati (b) Fornitori, produttori, beni immobili, servizi
LE STRATEGIE CAPITOLO 3
 LE STRATEGIE CAPITOLO 3 Breve riassunto della lezione scorsa La CREAZIONE DI VALORE V > CT - BN La CATENA DEL VALORE Il processo aziendale (o business process) è un insieme di attività interrelate, svolte
LE STRATEGIE CAPITOLO 3 Breve riassunto della lezione scorsa La CREAZIONE DI VALORE V > CT - BN La CATENA DEL VALORE Il processo aziendale (o business process) è un insieme di attività interrelate, svolte
FORME ORGANIZZATIVE E SISTEMI DIREZIONALI: I FONDAMENTALI DELL IMPLEMENTAZIONE DELLA STRATEGIA
 FORME ORGANIZZATIVE E SISTEMI DIREZIONALI: I FONDAMENTALI DELL IMPLEMENTAZIONE DELLA STRATEGIA 1 Strategia Implementazione La formulazione della strategia deve tener conto delle capacità dell organizzazione
FORME ORGANIZZATIVE E SISTEMI DIREZIONALI: I FONDAMENTALI DELL IMPLEMENTAZIONE DELLA STRATEGIA 1 Strategia Implementazione La formulazione della strategia deve tener conto delle capacità dell organizzazione
Corso di Economia e Gestione delle Imprese. Anno accademico
 1 Corso di Economia e Gestione delle Imprese Anno accademico 2017-2018 2 LEZIONE del 29.11 3 4 Processi di natura organizzativa Capitolo 9 (parte prima) 5 A cura di Maria Chiara di Guardo Obiettivi di
1 Corso di Economia e Gestione delle Imprese Anno accademico 2017-2018 2 LEZIONE del 29.11 3 4 Processi di natura organizzativa Capitolo 9 (parte prima) 5 A cura di Maria Chiara di Guardo Obiettivi di
Economia e gestione delle imprese
 Economia e gestione delle imprese Prof. Arturo Capasso 1 Argomenti Il ciclo direzionale La funzione organizzativa Struttura organizzativa Scelte di organizzazione Progettazione dell organizzazione Modelli
Economia e gestione delle imprese Prof. Arturo Capasso 1 Argomenti Il ciclo direzionale La funzione organizzativa Struttura organizzativa Scelte di organizzazione Progettazione dell organizzazione Modelli
Teorie organizzative, relazioni inter-organizzative e ambiente
 Teorie organizzative, relazioni inter-organizzative e ambiente Lo studio delle organizzazioni come disciplina Negli anni 60 si assiste ad un primo tentativo di raggruppamento di riflessioni organizzative
Teorie organizzative, relazioni inter-organizzative e ambiente Lo studio delle organizzazioni come disciplina Negli anni 60 si assiste ad un primo tentativo di raggruppamento di riflessioni organizzative
CONTRATTO PSICOLOGICO
 CONTRATTO PSICOLOGICO CONTRATTO PSICOLOGICO COS E IL CONTRATTO? Risulta centrale il concetto di reciprocazione L idea di fondo è che il rapporto tra individuo e organizzazione risponde alla norma di reciprocità
CONTRATTO PSICOLOGICO CONTRATTO PSICOLOGICO COS E IL CONTRATTO? Risulta centrale il concetto di reciprocazione L idea di fondo è che il rapporto tra individuo e organizzazione risponde alla norma di reciprocità
COMUNICAZIONE PER IL MANAGEMENT D IMPRESA
 COMUNICAZIONE PER IL MANAGEMENT D IMPRESA Funzioni e organizzazione aziendale (Prof A. Rocchi) Una possibile definizione OA L'organizzazione aziendale è l'insieme delle unità e dei processi lavorativi/produttivi
COMUNICAZIONE PER IL MANAGEMENT D IMPRESA Funzioni e organizzazione aziendale (Prof A. Rocchi) Una possibile definizione OA L'organizzazione aziendale è l'insieme delle unità e dei processi lavorativi/produttivi
La cultura e i valori etici
 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 1 La cultura e i valori etici 2 1 Esempi In SAS Institute i dipendenti sono rispettati e trattati da adutli accettano stipendi inferiori pur di rimanere centri educativi Montessori
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 1 La cultura e i valori etici 2 1 Esempi In SAS Institute i dipendenti sono rispettati e trattati da adutli accettano stipendi inferiori pur di rimanere centri educativi Montessori
La cultura e i valori etici
 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 1 La cultura e i valori etici 2 Esempi In SAS Institute i dipendenti sono rispettati e trattati da adutli accettano stipendi inferiori pur di rimanere centri educativi Montessori
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 1 La cultura e i valori etici 2 Esempi In SAS Institute i dipendenti sono rispettati e trattati da adutli accettano stipendi inferiori pur di rimanere centri educativi Montessori
Il sistema di pianificazione e controllo
 Il sistema di pianificazione e controllo Meccanismo operativo di ausilio all alta direzione per la corretta formulazione delle decisioni strategiche ed operative, al monitoraggio dei risultati e alla responsabilizzazione
Il sistema di pianificazione e controllo Meccanismo operativo di ausilio all alta direzione per la corretta formulazione delle decisioni strategiche ed operative, al monitoraggio dei risultati e alla responsabilizzazione
Paolo Depaoli. Supporti alle lezioni basate sul capitolo 8 del testo «La progettazione organizzativa» (a cura di Franco Isotta)
 http://it.123rf.com/photo_23991404_cerchio-da-simbolimusicali.html?fromid=bkvnlzzerkhmou9ys3juwwm1yje0ut09 Paolo Depaoli Supporti alle lezioni basate sul capitolo 8 del testo «La progettazione organizzativa»
http://it.123rf.com/photo_23991404_cerchio-da-simbolimusicali.html?fromid=bkvnlzzerkhmou9ys3juwwm1yje0ut09 Paolo Depaoli Supporti alle lezioni basate sul capitolo 8 del testo «La progettazione organizzativa»
Economia e Gestione delle Imprese. Seconda Unità Didattica: Risorse e Valore. Corso di Economia e Gestione delle Imprese Seconda Unità Didattica
 Economia e Gestione delle Imprese Seconda Unità Didattica: Risorse e Valore LA GESTIONE DELLE RISORSE DELL IMPRESA Le risorse dell impresa: definizioni e caratteristiche La catena del valore di Porter
Economia e Gestione delle Imprese Seconda Unità Didattica: Risorse e Valore LA GESTIONE DELLE RISORSE DELL IMPRESA Le risorse dell impresa: definizioni e caratteristiche La catena del valore di Porter
Università degli Studi di Roma Tor Vergata Facoltà di Lettere
 Università degli Studi di Roma Tor Vergata Facoltà di Lettere CORSO DI ECONOMIA AZIENDALE Lezione 5 L organizzazione: interdipendenze, meccanismi di coordinamento e configurazioni organizzative Dott. Fabio
Università degli Studi di Roma Tor Vergata Facoltà di Lettere CORSO DI ECONOMIA AZIENDALE Lezione 5 L organizzazione: interdipendenze, meccanismi di coordinamento e configurazioni organizzative Dott. Fabio
CAPITOLO CAPIT Organizzazioni e Teoria ganizzazioni e T Organizzativa
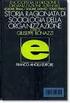 CAPITOLO 1 Organizzazioni e Teoria Organizzativa Agenda Cos è un organizzazione Le dimensioni organizzative La struttura organizzativa Le parti di un organizzazione Valutare un organizzazione Evoluzione
CAPITOLO 1 Organizzazioni e Teoria Organizzativa Agenda Cos è un organizzazione Le dimensioni organizzative La struttura organizzativa Le parti di un organizzazione Valutare un organizzazione Evoluzione
Schindler Navigator Book Definire gli obiettivi. Stabilire il percorso. Strategie di successo nel settore degli ascensori e delle scale mobili.
 Definire gli obiettivi. Stabilire il percorso. Strategie di successo nel settore degli ascensori e delle scale mobili. 2 Il nostro impegno Cari colleghi, il mercato globale degli ascensori e delle scale
Definire gli obiettivi. Stabilire il percorso. Strategie di successo nel settore degli ascensori e delle scale mobili. 2 Il nostro impegno Cari colleghi, il mercato globale degli ascensori e delle scale
Corso di Rivalidazione manageriale
 Organizzazione come sistema Corso di Rivalidazione manageriale Le organizzazioni sanitarie alla Luce della riforma Mario Faini 1 Progea Un organizzazione può essere letta come un sistema, comunicante con
Organizzazione come sistema Corso di Rivalidazione manageriale Le organizzazioni sanitarie alla Luce della riforma Mario Faini 1 Progea Un organizzazione può essere letta come un sistema, comunicante con
Il controllo economico e il ruolo del budget: aspetti organizzativi
 Capitolo 11 Il controllo economico e il ruolo del budget: aspetti organizzativi di Laura Zoni Il controllo economico e il ruolo del budget: aspetti organizzativi (Cap. 11) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Comprendere
Capitolo 11 Il controllo economico e il ruolo del budget: aspetti organizzativi di Laura Zoni Il controllo economico e il ruolo del budget: aspetti organizzativi (Cap. 11) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Comprendere
Elementi di Economica
 ISTITUTO TECNICO QUINTO ANNO GIORGIO PORCU www.thegiorgio.it Sommario Microstruttura Posizione individuale, Mansione, Compito, Ruolo Interdipendenza dei compiti Macrostruttura Unità Organizzativa Organigramma,
ISTITUTO TECNICO QUINTO ANNO GIORGIO PORCU www.thegiorgio.it Sommario Microstruttura Posizione individuale, Mansione, Compito, Ruolo Interdipendenza dei compiti Macrostruttura Unità Organizzativa Organigramma,
Organizzazione e struttura organizzativa
 Università degli Studi di Milano Bicocca Facoltà di Sociologia Corso di laurea in Servizio Sociale Anno Accademico 2008/09 Corso Organizzare un servizio Organizzazione e struttura organizzativa PAOLO ROSSI
Università degli Studi di Milano Bicocca Facoltà di Sociologia Corso di laurea in Servizio Sociale Anno Accademico 2008/09 Corso Organizzare un servizio Organizzazione e struttura organizzativa PAOLO ROSSI
Gestione e organizzazione aziendale l'organizzazione del lavoro
 Gestione e organizzazione aziendale l'organizzazione del lavoro 8 Facoltà di Economia Sede di Treviglio Giancarlo Traini Aprile - Giugno 2011 il programma N data giorno ora tema capitolo 1 Introduzione
Gestione e organizzazione aziendale l'organizzazione del lavoro 8 Facoltà di Economia Sede di Treviglio Giancarlo Traini Aprile - Giugno 2011 il programma N data giorno ora tema capitolo 1 Introduzione
Capitolo 6. Le forme organizzative semplici
 Capitolo 6 Le forme organizzative semplici Caratteristiche di base La forma organizzativa semplice si caratterizza per essere poco sviluppata: dal punto di vista della divisione del lavoro e della specializzazione
Capitolo 6 Le forme organizzative semplici Caratteristiche di base La forma organizzativa semplice si caratterizza per essere poco sviluppata: dal punto di vista della divisione del lavoro e della specializzazione
ORGANIZZAZIONE E MANAGEMENT DELLE IMPRESE COOPERATIVE Modulo introduttivo»
 ORGANIZZAZIONE E MANAGEMENT DELLE IMPRESE COOPERATIVE Modulo introduttivo» Parte prima e seconda A cura di: Alessandro Hinna Parte I: Breve introduzione al problema della organizzazione aziendale L organizzazione
ORGANIZZAZIONE E MANAGEMENT DELLE IMPRESE COOPERATIVE Modulo introduttivo» Parte prima e seconda A cura di: Alessandro Hinna Parte I: Breve introduzione al problema della organizzazione aziendale L organizzazione
Organizzazione Aziendale versione 1.0.0
 Organizzazione Aziendale versione 1.0.0 18 Aprile 2006 Indice 1 Organizzazione 1 1.1 Parti fondamentali...... 1 1.2 Meccanismi di coordinamento 2 1.3 Funzionamento dell'organizzazione............. 3 1.4
Organizzazione Aziendale versione 1.0.0 18 Aprile 2006 Indice 1 Organizzazione 1 1.1 Parti fondamentali...... 1 1.2 Meccanismi di coordinamento 2 1.3 Funzionamento dell'organizzazione............. 3 1.4
Gestione e organizzazione aziendale innovazione e cambiamento
 Gestione e organizzazione aziendale innovazione e cambiamento 10 Facoltà di Economia Sede di Treviglio Giancarlo Traini Maggio 2012 il programma N data giorno ora tema capitolo 1 Introduzione 2 3/5 gio
Gestione e organizzazione aziendale innovazione e cambiamento 10 Facoltà di Economia Sede di Treviglio Giancarlo Traini Maggio 2012 il programma N data giorno ora tema capitolo 1 Introduzione 2 3/5 gio
INDICE GENERALE. Prefazione... Pag. VII Indice generale...» XIII Indice delle tabelle...» XXI Indice delle figure...» XXIII
 INDICE GENERALE Prefazione.... Pag. VII Indice generale....» XIII Indice delle tabelle...» XXI Indice delle figure...» XXIII PARTE PRIMA ELEMENTI DI ECONOMIA DELL IMPRESA Capitolo Primo L IMPRESA E IL
INDICE GENERALE Prefazione.... Pag. VII Indice generale....» XIII Indice delle tabelle...» XXI Indice delle figure...» XXIII PARTE PRIMA ELEMENTI DI ECONOMIA DELL IMPRESA Capitolo Primo L IMPRESA E IL
ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE
 ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE LEZIONE 11 LA MACRO PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA Università degli Studi di Roma Tor Vergata Dott.ssa Danila Scarozza danila.scarozza@uniroma2.it AGENDA LA PROGETTAZIONE
ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE LEZIONE 11 LA MACRO PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA Università degli Studi di Roma Tor Vergata Dott.ssa Danila Scarozza danila.scarozza@uniroma2.it AGENDA LA PROGETTAZIONE
Organizzazione Aziendale
 Organizzazione Aziendale Introduzione, di Severino Salvemini Learning goal Definire il contenitore in cui agisce il comportamento Organizzativo: Caratteristiche delle imprese contemporanee Taylorismo Burocrazia
Organizzazione Aziendale Introduzione, di Severino Salvemini Learning goal Definire il contenitore in cui agisce il comportamento Organizzativo: Caratteristiche delle imprese contemporanee Taylorismo Burocrazia
Capitolo tredici. L organizzazione dell impresa internazionale. Caso di apertura: la Unilever
 EDITORE ULRICO HOEPLI MILANO Capitolo tredici L organizzazione dell impresa internazionale Caso di apertura: la Unilever 13-3 Una delle prime imprese multinazionali al mondo Organizzata in modo decentralizzato
EDITORE ULRICO HOEPLI MILANO Capitolo tredici L organizzazione dell impresa internazionale Caso di apertura: la Unilever 13-3 Una delle prime imprese multinazionali al mondo Organizzata in modo decentralizzato
Programmazione e controllo
 Programmazione e controllo IL SISTEMA DI CONTROLLO DIREZIONALE: BUDGETING 1 UN MODELLO DI RIFERIMENTO CONTROLLO DIREZIONALE 2 CONTROLLO DIREZIONALE: CIOE? C O N T R O L L O D I R E Z I O N A L E GUIDARE
Programmazione e controllo IL SISTEMA DI CONTROLLO DIREZIONALE: BUDGETING 1 UN MODELLO DI RIFERIMENTO CONTROLLO DIREZIONALE 2 CONTROLLO DIREZIONALE: CIOE? C O N T R O L L O D I R E Z I O N A L E GUIDARE
FORME ORGANIZZATIVE E SISTEMI DIREZIONALI. CAPITOLO SESTO Grant R. L analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino, Bologna,
 FORME ORGANIZZATIVE E SISTEMI DIREZIONALI CAPITOLO SESTO Grant R. L analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino, Bologna, 1999 1 FORME ORGANIZZATIVE E SISTEMI DIREZIONALI La formulazione della
FORME ORGANIZZATIVE E SISTEMI DIREZIONALI CAPITOLO SESTO Grant R. L analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino, Bologna, 1999 1 FORME ORGANIZZATIVE E SISTEMI DIREZIONALI La formulazione della
La gestione delle risorse umane
 Corso di Economia e gestione delle imprese e Marketing A.A. 2015-2016 Lezione 7 La gestione delle risorse umane La collocazione della funzione «Direzione del Personale» Funzione aziendale (allo stesso
Corso di Economia e gestione delle imprese e Marketing A.A. 2015-2016 Lezione 7 La gestione delle risorse umane La collocazione della funzione «Direzione del Personale» Funzione aziendale (allo stesso
Organizzazione e Innovazione Sociale. Terza lezione
 Organizzazione e Innovazione Sociale Corso di Laura in Sociologia Anno Accademico 2015-2016 II Semestre Terza lezione Walter Vesperi Innovazione e Startup http://startup.registroimprese.it/st artup/index.html
Organizzazione e Innovazione Sociale Corso di Laura in Sociologia Anno Accademico 2015-2016 II Semestre Terza lezione Walter Vesperi Innovazione e Startup http://startup.registroimprese.it/st artup/index.html
INDICE. Presentazione. pag. IL MARKETING MANAGEMENT
 Indice V INDICE Presentazione XI Capitolo 1 IL MARKETING MANAGEMENT 1. Finalità del capitolo 1 2. Gli obiettivi del marketing aziendale 2 2.1. Creare valore per il cliente e per l impresa, p. 2. 2.2. Il
Indice V INDICE Presentazione XI Capitolo 1 IL MARKETING MANAGEMENT 1. Finalità del capitolo 1 2. Gli obiettivi del marketing aziendale 2 2.1. Creare valore per il cliente e per l impresa, p. 2. 2.2. Il
Il Cambiamento e l Innovazione nella Professione: il Controllo Direzionale
 Il Cambiamento e l Innovazione nella Professione: il Controllo Direzionale I sistemi di controllo direzionale: progettazione, strumenti, organizzazione, ruoli Prof. Cattaneo Cristiana Bergamo, 7 Ottobre
Il Cambiamento e l Innovazione nella Professione: il Controllo Direzionale I sistemi di controllo direzionale: progettazione, strumenti, organizzazione, ruoli Prof. Cattaneo Cristiana Bergamo, 7 Ottobre
I meccanismi di coordinamento
 I meccanismi di coordinamento ADATTAMENTO RECIPROCO manager Il coordinamento avviene mediante la comunicazione informale Il controllo del lavoro resta nelle mani di coloro che lo eseguono analisti operatori
I meccanismi di coordinamento ADATTAMENTO RECIPROCO manager Il coordinamento avviene mediante la comunicazione informale Il controllo del lavoro resta nelle mani di coloro che lo eseguono analisti operatori
gestione delle imprese Prof. Arturo Capasso
 Economia e gestione delle imprese Prof. Arturo Capasso 1 Argomenti Il ciclo direzionale La funzione organizzativa Struttura organizzativa Scelte di organizzazione Progettazione dell organizzazione Modelli
Economia e gestione delle imprese Prof. Arturo Capasso 1 Argomenti Il ciclo direzionale La funzione organizzativa Struttura organizzativa Scelte di organizzazione Progettazione dell organizzazione Modelli
Il problema organizzativo E. Bracci Economia e Gestione di Impresa
 CdL Informatica Economia e gestione di impresa Docente: Enrico Bracci Il problema organizzativo Obiettivi del modulo 1. Come nasce il problema organizzativo 2. Un modello di analisi dell organizzazione
CdL Informatica Economia e gestione di impresa Docente: Enrico Bracci Il problema organizzativo Obiettivi del modulo 1. Come nasce il problema organizzativo 2. Un modello di analisi dell organizzazione
Le parti dell organizzazione
 Le parti dell organizzazione 1 1. Nucleo strategico 2. Linea intermedia 3. Nucleo operativo 4. Tecnostruttura 5. Staff 4 2 5 3 (H. Mintzberg) 1 STRUTTURE: LE TIPOLOGIE BASE STRUTTURA FUNZIONALE Strutture:
Le parti dell organizzazione 1 1. Nucleo strategico 2. Linea intermedia 3. Nucleo operativo 4. Tecnostruttura 5. Staff 4 2 5 3 (H. Mintzberg) 1 STRUTTURE: LE TIPOLOGIE BASE STRUTTURA FUNZIONALE Strutture:
Il dirigente Infermieristico. della struttura Organizzativa. Dr. Francesco Casile Coordinatore CID Regione Piemonte e Valle D Aosta
 Il dirigente Infermieristico ed il Team dei Coordinatori Infermieristici nella realizzazione della struttura Organizzativa delle Professioni sanitarie Dr. Francesco Casile Coordinatore CID Regione Piemonte
Il dirigente Infermieristico ed il Team dei Coordinatori Infermieristici nella realizzazione della struttura Organizzativa delle Professioni sanitarie Dr. Francesco Casile Coordinatore CID Regione Piemonte
Progettazione organizzativa
 organizzativa Definizione delle variabili organizzative in modo da creare le condizioni affinchè l'organizzazione possa perseguire gli obiettivi che si è prefissata L'organizzazione deve mantenere nel
organizzativa Definizione delle variabili organizzative in modo da creare le condizioni affinchè l'organizzazione possa perseguire gli obiettivi che si è prefissata L'organizzazione deve mantenere nel
Concetti generali e introduzione alla norma UNI EN ISO 9001/2008
 Concetti generali e introduzione alla norma UNI EN ISO 9001/2008 1 1. Qualità e SGQ 2 Cosa è la Qualità Qual è di qualità migliore? Una Fiat Panda Una Ferrari 3 Definizione di qualità: Il grado in cui
Concetti generali e introduzione alla norma UNI EN ISO 9001/2008 1 1. Qualità e SGQ 2 Cosa è la Qualità Qual è di qualità migliore? Una Fiat Panda Una Ferrari 3 Definizione di qualità: Il grado in cui
Come usare il piano organizzativo aziendale
 Come usare il piano organizzativo aziendale di Fabrizio Gritta Il piano organizzativo è uno strumento che può fornire un supporto nella progettazione organizzativa delle pmi. E uno schema formato da 7
Come usare il piano organizzativo aziendale di Fabrizio Gritta Il piano organizzativo è uno strumento che può fornire un supporto nella progettazione organizzativa delle pmi. E uno schema formato da 7
comunicazione integrata
 Dalla comunicazione per aree alla comunicazione integrata Università degli studi di Urbino La comunicazione entra nelle decisioni d impresa per risolvere in via reattiva o anticipativa i problemi di relazione
Dalla comunicazione per aree alla comunicazione integrata Università degli studi di Urbino La comunicazione entra nelle decisioni d impresa per risolvere in via reattiva o anticipativa i problemi di relazione
LA GESTIONE PROFESSIONALE DELLE RELAZIONI DI RUOLO
 LA GESTIONE PROFESSIONALE DELLE RELAZIONI DI RUOLO Essere una squadra è prima di tutto un modo di pensare 1. Lo scenario Nell attuale situazione caratterizzata da una crescente complessità e discontinuità
LA GESTIONE PROFESSIONALE DELLE RELAZIONI DI RUOLO Essere una squadra è prima di tutto un modo di pensare 1. Lo scenario Nell attuale situazione caratterizzata da una crescente complessità e discontinuità
CAP.7. Processi Strategici e le strategie di business
 CAP.7 Processi Strategici e le strategie di business Il modello concettuale C-P-C PROCESSI CAPACITA COMPETITIVITA Capacità imprenditoriali e capacità manageriali Capacità interpretative del contesto Processi
CAP.7 Processi Strategici e le strategie di business Il modello concettuale C-P-C PROCESSI CAPACITA COMPETITIVITA Capacità imprenditoriali e capacità manageriali Capacità interpretative del contesto Processi
Organizzazione aziendale Corso di Economia e Organizzazione aziendale
 Organizzazione aziendale Corso di Economia e Organizzazione aziendale prof. Barbara Scozzi bscozzi@poliba.it Cos è una organizzazione? Insieme di individui Esistenza obiettivo comune Divisione del lavoro/coordinamento
Organizzazione aziendale Corso di Economia e Organizzazione aziendale prof. Barbara Scozzi bscozzi@poliba.it Cos è una organizzazione? Insieme di individui Esistenza obiettivo comune Divisione del lavoro/coordinamento
INDICE GENERALE. Introduzione... Pag. VII Indice generale...» XI Indice delle tabelle...» XIX Indice delle figure...» XXI
 Introduzione... Pag. VII Indice generale....» XI Indice delle tabelle...» XIX Indice delle figure...» XXI PARTE PRIMA ELEMENTI DI ECONOMIA DELL IMPRESA Capitolo Primo IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 1. I concetti
Introduzione... Pag. VII Indice generale....» XI Indice delle tabelle...» XIX Indice delle figure...» XXI PARTE PRIMA ELEMENTI DI ECONOMIA DELL IMPRESA Capitolo Primo IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 1. I concetti
IL MODELLO CAF GENERALITA E STRUTTURA
 1 IL MODELLO CAF GENERALITA E STRUTTURA Il Modello CAF - Struttura 2 2 Il Modello CAF Lo sviluppo negli elementi di dettaglio 3 Le nove caselle rappresentano i criteri in base ai quali valutare il percorso
1 IL MODELLO CAF GENERALITA E STRUTTURA Il Modello CAF - Struttura 2 2 Il Modello CAF Lo sviluppo negli elementi di dettaglio 3 Le nove caselle rappresentano i criteri in base ai quali valutare il percorso
TENDENZE ATTUALI NELLA GESTIONE STRATEGICA
 TENDENZE ATTUALI NELLA GESTIONE STRATEGICA 1 Trasformazione dell ambiente esterno dell impresa Prima rivoluzione industriale Fine 19 Secolo Inghilterra Meccanicizzazione della produzione Seconda rivoluzione
TENDENZE ATTUALI NELLA GESTIONE STRATEGICA 1 Trasformazione dell ambiente esterno dell impresa Prima rivoluzione industriale Fine 19 Secolo Inghilterra Meccanicizzazione della produzione Seconda rivoluzione
Sistemi di valutazione delle performance. Nicola Castellano Università di Macerata
 Sistemi di valutazione delle performance Università di Macerata ncaste@unimc.it ncaste@ec.unipi.it La misurazione delle performance Strategic Control I processi di definizione degli obiettivi di fondo
Sistemi di valutazione delle performance Università di Macerata ncaste@unimc.it ncaste@ec.unipi.it La misurazione delle performance Strategic Control I processi di definizione degli obiettivi di fondo
CORSO COMUNICAZIONE D IMPRESA. PROF. GIAN PAOLO BONANI
 CORSO 2015-16 COMUNICAZIONE D IMPRESA PROF. GIAN PAOLO BONANI g.bonani@libero.it bonani 2013 1 Sessione 6 L impresa come sistema di knowledge e di funzioni bonani 2013 2 Cos è l impresa (azienda) Una risposta
CORSO 2015-16 COMUNICAZIONE D IMPRESA PROF. GIAN PAOLO BONANI g.bonani@libero.it bonani 2013 1 Sessione 6 L impresa come sistema di knowledge e di funzioni bonani 2013 2 Cos è l impresa (azienda) Una risposta
I REQUISITI INNOVATIVI DELLA ISO Alessandra Peverini Perugia 23 ottobre 2015
 I REQUISITI INNOVATIVI DELLA ISO 9001 Alessandra Peverini Perugia 23 ottobre 2015 Le principali novità 1. Le relazioni fra l Organizzazione ed il contesto interno ed esterno 2. Le aspettative delle parti
I REQUISITI INNOVATIVI DELLA ISO 9001 Alessandra Peverini Perugia 23 ottobre 2015 Le principali novità 1. Le relazioni fra l Organizzazione ed il contesto interno ed esterno 2. Le aspettative delle parti
La struttura organizzativa
 Corso di Economia e gestione delle imprese e Marketing (modulo B) Lezione 2 La struttura organizzativa La struttura organizzativa La struttura organizzativa è la risultante delle scelte mediante le quali
Corso di Economia e gestione delle imprese e Marketing (modulo B) Lezione 2 La struttura organizzativa La struttura organizzativa La struttura organizzativa è la risultante delle scelte mediante le quali
Università degli Studi di Napoli Parthenope. L area organizzativa. (Capitolo V)
 Università degli Studi di Napoli Parthenope L area organizzativa (Capitolo V) Sommario: 1. La funzione organizzativa 2. La struttura organizzativa 3. Gli organigrammi 4. Il modello gerarchico 5. Il modello
Università degli Studi di Napoli Parthenope L area organizzativa (Capitolo V) Sommario: 1. La funzione organizzativa 2. La struttura organizzativa 3. Gli organigrammi 4. Il modello gerarchico 5. Il modello
Organizzazione: teoria, progettazione e cambiamento
 Organizzazione: teoria, progettazione e cambiamento Edizione italiana a cura di G. Soda Capitolo 5 Progettare la struttura organizzativa: autorità e controllo Jones, Organizzazione Copyright 2007 Egea
Organizzazione: teoria, progettazione e cambiamento Edizione italiana a cura di G. Soda Capitolo 5 Progettare la struttura organizzativa: autorità e controllo Jones, Organizzazione Copyright 2007 Egea
L ambiente organizzativo e le risposte all incertezza ambientale
 e le risposte all incertezza ambientale Corso di Organizzazione Aziendale Obiettivi di apprendimento Bibliografia Etimologia e significato Definizione, riflessioni essenziali sul concetto e possibili distinzioni
e le risposte all incertezza ambientale Corso di Organizzazione Aziendale Obiettivi di apprendimento Bibliografia Etimologia e significato Definizione, riflessioni essenziali sul concetto e possibili distinzioni
Organizzazione: teoria, progettazione, cambiamento
 Organizzazione: teoria, progettazione, cambiamento Edizione italiana a cura di G. Soda Capitolo 1 Organizzazioni ed efficacia organizzativa: concetti di base 1-1 Concetti di base: refreshing con il capitolo
Organizzazione: teoria, progettazione, cambiamento Edizione italiana a cura di G. Soda Capitolo 1 Organizzazioni ed efficacia organizzativa: concetti di base 1-1 Concetti di base: refreshing con il capitolo
Innovazione e cambiamento. «dobbiamo cambiare per sopravvivere» B. JORDON Southwest Airlines
 Innovazione e cambiamento «dobbiamo cambiare per sopravvivere» B. JORDON Southwest Airlines Indicate quale è la vostra opinione in merito a ciascuno delle seguenti affermazioni: Per creare una azienda
Innovazione e cambiamento «dobbiamo cambiare per sopravvivere» B. JORDON Southwest Airlines Indicate quale è la vostra opinione in merito a ciascuno delle seguenti affermazioni: Per creare una azienda
La Competitive Intelligence
 La Alessandro De Nisco Università del Sannio Corso Strategico OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA LEZIONE APPROFONDIRE IL CONCETTO E GLI OBIETTIVI DELLA COMPETITIVE INTELLIGENCE (C.I.) ANALIZZARE LA SEQUENZA
La Alessandro De Nisco Università del Sannio Corso Strategico OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA LEZIONE APPROFONDIRE IL CONCETTO E GLI OBIETTIVI DELLA COMPETITIVE INTELLIGENCE (C.I.) ANALIZZARE LA SEQUENZA
