Indice. introduzione...
|
|
|
- Nicolo Romagnoli
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Indice introduzione xv 1 S.K.A. Square Kilometer Array Il radiotelescopio del futuro Il modello americano Il modello olandese Il modello australiano Il modello canadese Il modello cinese Il problema del rifasamento in SKA Il progetto italiano La Croce del Nord Il problema del rifasamento per la Croce del Nord Sistema attuale di rifasamento Upgrade ramo Nord Sud Rifasamento di antenne Gli interferometri Analisi nel dominio dei tempi Analisi nel dominio delle frequenze Sistemi a banda finita Phase Shifter Switched line phase shifter Loaded line phase shifter High pass low pass phase shifter
2 2.2.4 I Q vector modulator phase shifter Coupler phase shifter Circulator phase shifter Aspetti tecnologici e prestazioni Scelta effettuata Progetto del vector modulator Architettura di un vector modulator Splitter Attenuatori Indagine di mercato per l acquisto di power splitter Splitter Splitter Splitter Indagine di mercato per l acquisto di attenuatori Caratterizzazione dei power splitter Descrizione generale Splitter Splitter Splitter Attenuatori Indagine di mercato Simulazioni MATLAB Simulazione di un attenuatore digitale a 5 bit (LSB = 0.5dB) Simulazione di un attenuatore digitale a 5 bit (LSB = 1dB) Simulazione di un attenuatore digitale a 6 bit (LSB = 0.5dB) Simulazione di un attenuatore a Pin Diodes Caratterizzazione dell attenuatore a Pin Diodes
3 5 Prototipo di vector modulator Realizzazione pratica Conclusioni 112 A Parametri S 115 B Banco di misura 121 Bibliografia 124
4
5 Elenco delle figure 1 Antenna di Arecibo xviii 2 European VLBI Network xx 1.1 Antenna Gregoriana Rapid Prototipe Array Adaptive Antenna Demonstrator THEA: The Thousand Element Array Luneburg Lenses Principio di funzionamento del LAR Rappresentazione del FAST Principio di funzionamento del FAST Veduta aerea della Croce del Nord Puntamento allo zenit Sfasamento Cavo coassiale Dettaglio costruttivo Sistema degli oli Attuali Front End Nuovi Front End Interferometro semplice Interferometro multiplo Interferometro a due elementi Switched line phase shifter Loaded line phase shifter con carico parallelo Loaded line phase shifter con carico serie
6 2.7 High pass low pass phase shifter I Q vector modulator phase shifter Coupler phase shifter Circulator phase shifter Architettura di un vector modulator Relazioni di fase Schema a blocchi Schema a splitter a due vie Circuiti attenuatori Attenuatore digitale Attenuatore analogico Schema identificativo delle porte di un power splitter Montaggio del dispositivo Parametri S relativi ad uno splitter 90 a T = 20 C Parametri S relativi ad uno splitter 90 a T = 20 C Parametri S relativi ad uno splitter 90 a T = 20 C Variazione del parametro S 11 al variare della temperatura T Variazione del parametro S 21 al variare della temperatura T Variazione del parametro S 31 al variare della temperatura T Parametri S di uno splitter 180 a T = 20 C Parametri S di uno splitter 180 a T = 20 C Parametri S di uno splitter 180 a T = 20 C Variazione del parametro S 11 al variare della temperatura T Variazione del parametro S 21 al variare della temperatura T Variazione del parametro S 31 al variare della temperatura T Parametri S di uno splitter 0 a T = 20 C Parametri S di uno splitter 0 a T = 20 C Parametri S di uno splitter 0 a T = 20 C Variazione del parametro S 22 al variare della temperatura T Variazione del parametro S 33 al variare della temperatura T Variazione del parametro S 12 al variare della temperatura T Variazione del parametro S 13 al variare della temperatura T. 70
7 4.1 Curva di riferimento Simulazione attenuatore digitale 5 bit (LSB=0.5dB) Spostamenti del vettore S Simulazione attenuatore digitale 5 bit (LSB=1dB) Errore intorno ai Simulazione attenuatore digitale 6 bit (LSB=0.5dB) Selezione di quei punti che minimizzano l errore di ampiezza Rappresentazione grafica dell errore di ampiezza Rappresentazione grafica dell errore di fase Rappresentazione grafica dell errore di fase Rappresentazione grafica dell errore di ampiezza Rappresentazione grafica dell errore di ampiezza Rappresentazione grafica dell errore di fase Relazione di controllo del P I Simulazione Pin Diodes Minimo errore di ampiezza Errore di fase Minimo errore di fase Errore di ampiezza Minimi errori di ampiezza Minimi errori di fase Montaggio attenuatore Parametro S11 a T costante Parametro S21 a T costante Parametro S21 a tensione costante Parametro S21 a tensione costante Realizzazione pratica di un vector modulator Introduzione di uno sfasamento di Variazione del parametro S Variazione del parametro S A.1 Onde incidenti e riflesse per una rete a due porte
8 B.1 Banco di misura allestito
9 Elenco delle tabelle 2.1 Differenti caratteristiche Selezione del quadrante di lavoro Elenco e descrizione delle specifiche degli splitter Elenco delle specifiche degli splitter Elenco delle specifiche degli splitter Elenco delle specifiche degli splitter Elenco e descrizione delle specifiche degli attenuatori Valori dei parametri S dello splitter 90 alla frequenza di 408MHz Valori dei parametri S degli splitter 180 alla frequenza di 408MHz Valori dei parametri S dello splitter 0 alla frequenza di 408MHz Elenco delle specifiche degli attenuatori Tabella riassuntiva dei valori RM S e dei valori massimi degli errori ottenuti dalle diverse simulazioni Valori dei parametri S misurati su un vector modulator alla frequenza di 408MHz
10
11 Introduzione Fino a circa cinquant anni fa tutto ciò che si poteva sapere sull Universo dipendeva dalle informazioni fornite dalle immagini ottiche. Il progresso tecnologico ha poi favorito il proliferare di nuove scienze che hanno permesso di ampliare le conoscenze dei fenomeni fisici. É nata così, con la prima scoperta nel 1931, la radioastronomia, disciplina che si occupa di studiare l Universo nella banda dello spettro elettromagnetico che va dalla decina di metri ai millimetri di lunghezza d onda. Un radiotelescopio funziona secondo gli stessi principi del telescopio ottico: c è una superficie che concentra il debole segnale proveniente dalla radiosorgente in un unico punto detto fuoco. In esso è poi trasformato in segnale elettrico, amplificato ed inviato agli stadi successivi. I problemi fondamentali che si presentano in radioastronomia sono la continua ricerca dell aumento di sensibilità e di risoluzione. Il primo dipende dalla superficie collettrice, infatti, anche se le potenze emesse dalle radiosorgenti sono enormi, ciò che giunge fino a noi è un segnale debolissimo, con potenze milioni di volte inferiori al watt. Di conseguenza, mediante un aumento dell area di raccolta si può aumentare la sensibilità. Il secondo consiste nella capacità di distinguere come separati due punti molto vicini tra loro. Ad esempio, se lo strumento non ha sufficiente potere risolutivo, stelle molto vicine potrebbero essere viste come una singola. In radioastronomia ciò che conta è il rapporto tra la lunghezza d onda con cui si lavora e il diametro dell antenna del radiotelescopio. Dati gli ordini di grandezza in gioco, si ottiene che si dovrebbero avere delle antenne di dimensioni enormi.
12 xviii Infatti per effettuare osservazioni ad una lunghezza d onda di 11 cm con una risoluzione di 1 primo di grado, si necessita di un paraboloide di circa 300 m di diametro. Se ci si rapporta alle lunghezze d onda del campo ottico applicando gli stessi principi, si raggiunge una risoluzione di 1 secondo di grado, quindi migliore della precedente, già con un diametro dell obbiettivo di 30 cm. Attualmente il più grande radiotelescopio è quello di Arecibo in Puerto Rico, una parabola di 305 m di diametro posta all interno di una depressione naturale di pari diametro. Figura 1: Antenna di Arecibo. La necessità di migliorare sensibilità e risoluzione ha comportato, storicamente, la realizzazione di antenne di dimensioni geometriche sempre maggiori. Questa crescita continua ha trovato termine intorno agli anni 70 con l introduzione della tecnica interferometrica. Un interferometro generico è costituito da due antenne che, orientate verso la stessa sorgente, raccolgono segnali, li amplificano e li inviano ad uno strumento che li elabora. Il potere risolutivo di un interferometro così fatto dipende dal rapporto fra la lunghezza d onda dei segnali in gioco e la distanza massima tra gli elementi dello stesso. Per aumentare la risoluzione, è sufficiente allontanare le parabole, il che, in campo ottico, equivale ad aumentare il diametro del telescopio.
13 xix Il VLA (Very Large Array) situato in New Mexico (USA) è costituito da 27 parabole di 25 m di diametro ciascuna che, disposte a Y lungo percorsi di 20 km permettono al sistema di operare a diverse risoluzioni. Nel sistema VLBI (Very Long Baseline Interferometry) si è eliminata la connessione fisica fra i radiotelescopi, che possono trovarsi così a migliaia di km di distanza. Il principio di funzionamento di questa rete consiste nell avere i diversi radiotelescopi sincronizzati tra di loro al milionesimo di secondo e fare in modo che puntino tutti simultaneamente lo stesso oggetto per lo stesso intervallo di tempo. In questo modo si registrano dati su supporti magnetici che, inviati ad un centro di correlazione, verranno opportunamente elaborati. Con questo sistema, il potere risolutivo, che dipende dalla distanza dei radiotelescopi più lontani fra loro, è limitato soltanto dalle dimensioni del nostro pianeta, ma, a tal proposito, si è già esteso il VLBI allo spazio con il lancio del satellite giapponese VSOP. L EVN (European VLBI Network) è un consorzio europeo, del quale fa parte anche l Italia, che comprende 10 paesi. I suoi radiotelescopi, che raggiungono anche diametri di 100 m, operano simultaneamente osservando gli oggetti secondo un programma redatto da un apposito comitato direttivo. Questa rete ha lo stesso potere risolutivo che avrebbe un radiotelescopio grande come tutta l Europa. L Italia partecipa al progetto con le sue due parabole di Medicina (Bologna) e Noto (Siracusa), alle quali se ne aggiungerà una terza che è tuttora in fase di realizzazione a Cagliari nell ambito del progetto SRT (Sardinia RadioTelescopes). Se negli anni settanta si è riusciti a dare una risposta positiva alla domanda di maggiore risoluzione, oggi si sta cercando di trovare una risposta alla richiesta di maggiore sensibilità con il progetto denominato SKA (Square Kilometer Array). SKA sarà un array interferometrico con un area massima prevista di un milione di metri quadrati. Tecnologie da adottare per realizzare la superfi-
14 xx Figura 2: European VLBI Network. cie di ricezione sono tuttora oggetto di discussione, ma si prevede di poterle realizzare con array di piccoli elementi secondari, o usando phased array, o ricevitori multifascio su grandi riflettori. Per realizzare SKA, istituti di ricerca di molti paesi sono all opera cercando di coniugare tra loro le esigenze tecnologiche e di costo. Il programma per la realizzazione dei vari prototipi di radiotelescopi sta evolvendo ed è previsto che vi sia una convergenza su un progetto unico nei prossimi anni. Anche l Italia, nella fattispecie l Istituto di Radioastronomia del C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Bologna, è interessata a fare parte del consorzio internazionale SKA. Per acquisire il know how indispensabile alla partecipazione, si è pensato di apportare un upgrade sostanziale al radiotelescopio Croce del Nord viste le molteplici similitudini con SKA.
15 xxi É proprio in questo contesto che va a posizionarsi il presente elaborato, nel quale si prenderà in considerazione la realizzazione di un phase shifter che permette l eliminazione totale dell attuale sistema di puntamento elettrico a kerosene del ramo Nord Sud, che diventa di anno in anno sempre più critico da utilizzare a causa della manutenzione che richiede. In letteratura sono presenti vari modelli di phase shifter, ma l attenzione verrà concentrata sulla realizzazione di un vector modulator. Il lavoro svolto si articola nel seguente modo: Il 1 capitolo è suddiviso in due parti. Nella prima parte viene data una descrizione generale di SKA, illustrando le idee concepite dagli istituti di ricerca coinvolti nel progetto. Nella seconda parte del capitolo si analizza la Croce del Nord, ponendo l attenzione sul sistema di rifasamento attuale. Nel 2 capitolo viene descritto il phase shifter dal punto di vista teorico e viene messo in evidenza il percorso che ha guidato verso la scelta del vector modulator. Nel 3 capitolo si analizzano i componenti fondamentali che contribuiscono alla realizzazione pratica del vector modulator. Il 4 capitolo è dedicato interamente agli attenuatori in quanto è necessario valutare alcune loro caratteristiche al fine di ottenere i risultati desiderati. Nel 5 capitolo si illustrano le fasi della realizzazione del prototipo e della sua caratterizzazione.
16
17 Capitolo 1 S.K.A. Square Kilometer Array 1.1 Il radiotelescopio del futuro SKA è un progetto internazionale 1 che ha come fine la realizzazione di un radiotelescopio astronomico con una superficie efficace di raccolta di un chilometro quadrato, cioè circa 100 volte più grande degli strumenti attuali. Questo strumento sarà talmente rivoluzionario, dal punto di vista tecnologico, che, per la sua realizzazione, richiederà collaborazione fra tutti gli istituti di radioastronomia ed univesità varie. Il progetto SKA è coordinato da un comitato internazionale (ISSC) 2 il quale ha adottato un piano di studi di 5 anni che permetterà di giungere ad un singolo progetto. Il tutto dovrebbe essere completato entro il Attualmente il progetto è concentrato sulla scelta dell antenna per la quale sono state elaborate varie tipologie: piccole antenne paraboliche; phased array piani; lenti sferiche; 1 I paesi partecipanti al gruppo di lavoro sono: Australia, Belgio, Canada, Cina, Repubblica Ceca, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Russia, Spagna, Svezia, Regno Unito e gli Stati Uniti d America 2 International Ska Steering Committee
18 2 S.K.A. Square Kilometer Array riflettori quasi piatti con ricevitore sferico sospeso in aria; un unica area di forma parabolica (simile all antenna di Arecibo). I primi tre progetti consistono di decine o centinaia di radiotelescopi raggruppati in insiemi di diverse dimensioni. Gli ultimi due invece prevedono la realizzazione di giganteschi riflettori curvi ancorati al terreno, ciascuno con ricevitori radio sospesi in aria, volti alla ricerca della maggiore area collettrice. La loro fisionomia ricorda quella di Arecibo in Puerto Rico che è tuttora la più grande antenna mai costruita Il modello americano Il modello statunitense per SKA prende la denominazione di ATA 3 ed è un progetto che nasce dalla collaborazione tra il SETI 4 Institute e il laboratorio di radioastronomia dell Università di Berkeley (California)[1]. Il progetto prevede la realizzazione di un prototipo d antenna di tipo Gregoriano (vedi Fig:1.1(a)). Figura 1.1: (a) Principio di funzionamento di un antenna Gregoriana; (b) Antenna Gregoriana per ATA. Essa consiste in un riflettore, o specchio, primario P a forma di paraboloide, e uno secondario E a forma di ellissoide. I due riflettori possiedono il fuoco 3 Allen Telescope Array 4 Search of Extra Terrestrial Intelligence
19 1.1 Il radiotelescopio del futuro 3 primario F1 in comune. Nel fuoco secondario F2 dell ellissoide viene posizionato il ricevitore. Il fronte d onda incidente viene riflesso dallo specchio primario su quello secondario il quale, a sua volta, lo convoglia sul ricevitore. L ATA, riportato in Fig:1.1(b), è costituito da uno specchio principale di 6.1 m di diametro e uno secondario di 2.4 m. La presenza di una protezione di metallo che collega le metà inferiore del riflettore secondario alla parte inferiore del primario, riduce notevolmente la quantità di radiazione rumorosa che l antenna raccoglie dal terreno circostante. L idea è quella di mettere assieme un array di queste antenne di 6 m di diametro, col risultato finale di ottenere una grande area collettrice che supera un telescopio di 100 m di diametro. Questo sistema è di facile gestione e alta integrabilità grazie alla ridotte dimensioni delle antenne. Tuttavia ha il grosso svantaggio di illuminare solo quella zona di cielo verso la quale sono orientate le parabole. Figura 1.2: Rapid Prototipe Array. Attualmente è stato realizzato un prototipo che prende il nome di RPA 5 che è mostrato in Fig:1.2. Esso è costituito da 7 di queste antenne e viene 5 Rapid Prototype Array
20 4 S.K.A. Square Kilometer Array utilizzato per collaudare il software e l hardware finora realizzati. In particolare si svilupperanno metodi per l elaborazione dei segnali, per la riduzione di interferenze, e per la calibrazione dello strumento stesso Il modello olandese Il progetto olandese portato avanti dalla NFRA 6 ha vissuto uno sviluppo che si è articolato in tre fasi: la realizzazione di un antenna dimostrativa denominata AAD 7, il concepimento di OSMA 8 e la nascita di THEA 9 [2]. La prima antenna, visibile in Fig:1.3, è stata realizzata per cercare di capire come le interferenze radio possono agire su di essa, ed è costituita da 8 elementi a microstrip integrati che formano un piccolo phased array. Figura 1.3: Adaptive Antenna Demonstrator. 6 Netherlands Foundation for Research in Astronomy, chiamata anche ASTRON : Stichting Astronomisch Onderzoek in Nederland 7 Adaptive Antenna Demonstrator 8 One Square Metre Array 9 THousand Element Array
21 1.1 Il radiotelescopio del futuro 5 OSMA invece è stata ottenuta collegando insieme 144 AAD in modo da realizzare un array di antenne che permette la formazione di un doppio fascio di puntamento guidato in modo digitale. Espandendo ulteriormente OSMA si è giunti a THEA che è costituito da 1024 AAD e permette di coprire il cielo con più fasci guidati anch essi in modo digitale (vedi Fig:1.4). Figura 1.4: THEA: The Thousand Element Array. La costruzione di un grande array di tanti THEA permette la realizzazione di area collettrice di un chilometro quadrato solo in modo virtuale, in quanto essa è tale solo quando i fasci sono puntati allo zenith. Inclinando in modo digitale i fasci ottengo infatti una area che è funzione dell angolo di puntamento e che è sicuramente minore di un chilometro quadrato Il modello australiano Il programma della CSIRO SKA 10 prevede l utilizzo di antenne tridimensionali sferiche, meglio note come Luneburg Lenses[3]. Questo tipo di antenne sono di vecchia concezione e sono già state utilizzate in ambito com- 10 Commonwealth Scientific & Industrial Research Organisation of SKA
22 6 S.K.A. Square Kilometer Array merciale e militare, ma mai in radioastronomia. Nelle Luneburg Lenses (Fig:1.5) il fuoco può essere posizionato, a seconda della frequenza e degli indici di rifrazione del materiale di cui è costituita, sia sulla superficie della lente sia in un punto esterno ad essa. Questo è un enorme vantaggio perchè permette la visione globale del cielo con una sola lente. Figura 1.5: Luneburg Lenses. I problemi associati all utilizzo delle Luneburg Lenses risiedono nell apparato ricevente (feed) in quanto il ricevitore, dovendo essere installato nel fuoco che non è fisso in una posizione, deve essere mobile. Rendendo mobile il feed si continua ad ottenere un solo fascio per ogni Luneburg Lenses, questione che può essere risolta installando più feed, ma che complica ulteriormente il sistema ricevente. Ulteriori svantaggi consistono nel fatto che il materiale solido col quale sono realizzate le Luneburg Lenses ha un peso elevato e alte perdite a radiofrequenza.
23 1.1 Il radiotelescopio del futuro Il modello canadese Il progetto condotto da NRCA 11 prende il nome di LAR 12 ed è costituito da gruppo di piani focali e da un grande phased array legato ad una piattaforma aerostatica[4]. Figura 1.6: Principio di funzionamento del LAR. Il grande riflettore principale, come è mostrato in Fig:1.6, è ottenuto impiegando una serie di pannelli piani controllati e aggiustati nei loro movimenti tramite il calcolatore. La superficie riflettente ottenuta ha un diametro di 200 m. Il phased array che costituisce il ricevitore, nel quale convergono i segnali, si trova su una piattaforma posizionata nel fuoco a 500 m di altezza. Il sistema è mantenuto in posizione da una struttura tensionata che 11 National Research Council of Astrophysics 12 Large Adaptive Reflector
24 8 S.K.A. Square Kilometer Array consiste di tre o più tiranti i quali, con un pallone aerostatico riempito di elio, mantengono sollevato il ricevitore. Si origina così una struttura in grado di resistere alla forza del vento. Il radiotelescopio viene guidato cambiando simultaneamente la lunghezza dei tiranti con dei verricelli in modo da ottenere una modifica della forma del riflettore. Questo comporta il cambiamento della posizione dalla quale si ricevono i dati. Il LAR offre la copertura di una notevole porzione di cielo, ma vi sono sicuramente dubbi e problemi legati alla gestione del sistema aerostatico Il modello cinese La strada proposta dal BAO 13 per la realizzazione di SKA è costruire un array di 30 unità di riflettori sferici ciascuno dei quali ha il diametro di circa 200 m[5]. Figura 1.7: Rappresentazione del FAST. Dato che ciascun riflettore dovrebbe essere posizionato all interno di conche naturali, a tal proposito, sono state individuate alcune zone opportune dove potere posizionare l array. Una di queste zone è stata denomina- 13 Beijing Astronomical Observatory
25 1.1 Il radiotelescopio del futuro 9 ta KARST 14 e all interno di essa è stato proposto di realizzarvi un primo prototipo. Esso consiste in un telescopio ad apertura sferica di 500 m di diametro denominato FAST 15 (vedi Fig:1.7). Il principio del FAST si basa sull avere a disposizione una semisfera di grosso raggio, ma di illuminare solo una piccola porzione di essa, in modo da renderla paragonabile al funzionamento di una parabola (vedi Fig:1.8). In questo modo, per inseguire la traccia dell oggetto che si osserva, la parte illuminata del riflettore sferico deve essere continuamente aggiustata mediante un controllo attivo sincrono col movimento del ricevitore. Figura 1.8: Principio di funzionamento del FAST. Con un diametro dell apertura sferica di 500 m e un raggio della superficie sferica di 300 m, il FAST sarà il radiotelescopio a singolo piatto più grande del mondo. 14 Kilometer square Area Radio Synthesis Telescope 15 Five hundred meter Aperture Spherical Telescope
26 10 S.K.A. Square Kilometer Array Il problema del rifasamento in SKA Dovendo realizzare una superficie collettrice di 1 milione di metri quadrati, è quasi certo che si debba ricorrere ad array di antenne, ma a questo punto ci si scontrerà con un problema di essenziale importanza: il fronte d onda giunge sulle antenne di un array in istanti temporali differenti, per cui è necessario individuare il modo per correlare i segnali in maniera opportuna onde evitare perdite di potenze. 1.2 Il progetto italiano Come già detto anche l Italia, con l Istituto di Radioastronomia del C.N.R. di Bologna, fa parte del consorzio SKA. La partecipazione del nostro paese consiste nel riversamento sul consorzio delle conoscenze che arriveranno da un up grade sostanziale al radiotelescopio Croce del Nord. L attuale tecnologia a disposizione permette un ammodernamento che lo pone ad un livello competitivo per la radioastronomia a bassa frequenza, cioè a frequenze minori di 500 MHz. Le esperienze che si potrebbero acquisire nell ammodernamento dell antenna e che potrebbero essere applicate direttamente a SKA sono: Impiego di fibre ottiche in array di antenne. Utilizzo di un grande numero di front end per l antenna e soluzione di tutti i problemi inerenti (stabilità in fase, alimentazione,... ). Algoritmi di calibrazione automatica. Utilizzo di sfasatori programmabili a radiofrequenza, per la formazione del beam primario d antenna in grandi array. Progettazione, sviluppo e implementazione di algoritmi per il beam forming a reiezione d interferenza. Utilizzo di sistemi di controllo e calcolo multinodale sia per la gestione del sistema che per il post processing di dati on line.
27 1.2 Il progetto italiano La Croce del Nord Il radiotelescopio Croce del Nord è il più grande strumento di transito meridiano esistente al mondo. Esso è costituito da due bracci disposti a T, variante della struttura a Croce di Mills che si trova in Australia, uno dei quali orientati in direzione Nord Sud e l altro in direzione Est Ovest. Il braccio Est Ovest è costituito da una sola antenna di superficie cilindro parabolica lunga 565 m e larga 35 m. Il braccio Nord Sud è costituito da 64 antenne cilindro paraboliche di lunghezza 23.5 m e larghezza 8 m, poste ad una distanza di 10 m l una dall altra, per una lunghezza totale di 630 m. Figura 1.9: Veduta aerea della Croce del Nord. Entrambi i bracci sono orientabili meccanicamente solo in direzione Nord Sud, per cui le sorgenti sono osservabili solo quando transitano sul meridiano per effetto della rotazione terrestre.
28 12 S.K.A. Square Kilometer Array Le frequenze di ricezione delle onde radio sono quelle comprese entro una banda di 2.7 MHz centrate sulla frequenza di 408 MHz (λ = 73.5 cm) Il problema del rifasamento per la Croce del Nord La conversione in tensione elettrica dell energia elettromagnetica che lo specchio convoglia sulla linea focale, è ottenuta mediante dipoli. Essi sono uniformemente allineati sia sul braccio Est Ovest sia su quello Nord Sud. Questa energia viene portata nella stanza centrale di elaborazione dei dati facendo in modo: di limitare il più possibile l attenuazione del segnale rispetto il rumore, amplificare cioè il segnale ricevuto fino a renderlo accettabile come ingresso per l elettronica costruita per la sua elaborazione. che i punti in fase di una superficie d onda risultino ancora in fase (come tensione elettrica) qualora si trovino all ingresso del blocco di elaborazione, o in eventuali punti intermedi della catena ove vengono a sommarsi. Figura 1.10: Posizioni relative fra le singole antenne di una sezione qualunque del ramo Nord Sud ed un fronte d onda elettromagnetica in ricezione, in condizione di puntamento allo zenith. Quest ultimo problema è particolarmente sentito nel ramo Nord Sud. Infatti, essendo la Croce del Nord uno strumento ad inseguimento di ra-
29 1.2 Il progetto italiano 13 diosorgenti che transitano sul meridiano terrestre, il fronte d onda giunge in momenti separati sulle 64 antenne. In dettaglio, se siamo nelle circostanze della Fig:1.10, abbiamo che i punti equifase (P1,..., P8), appartenenti alla stessa superficie d onda elettromagnetica, giungono in fase alle singole antenne, poichè i cammini (L1,..., L8) sono identici. Figura 1.11: Posizioni relative fra le singole antenne di una sezione qualunque del ramo Nord Sud ed un fronte d onda elettromagnetica in ricezione, in condizione di puntamento con declinazione δ. Nel caso fossimo invece nelle circostanze raffigurate dalla Fig:1.11 abbiamo che i punti (P1,..., P8) non arrivano in fase sulle antenne poichè i cammini in aria (L1,..., L8) sono diversi e in funzione del puntamento. La relazione che lega la declinazione, la differenza di cammino e la distanza tra le antenne è data dalla formula: L = D sin δ (1.1) dove:
30 14 S.K.A. Square Kilometer Array D è la distanza tra l antenna scelta e quella alla quale giunge per primo il fronte (ad esempio in Fig.1.11 la 4S); L è il cammino compiuto in più dal fronte d onda; δ è l angolo compreso tra lo zenith e la direzione di puntamento. I valori che può assumere sono compresi tra 45 e Sistema attuale di rifasamento Il sistema ideato per ritardare in modo continuo con il puntamento i segnali provenienti da due antenne del ramo Nord Sud, è molto semplice e sfrutta le proprietà di propagazione di una radiazione elettromagnetica all interno di un mezzo. Figura 1.12: Rappresentazione schematica di un cavo coassiale parzialmente riempito di dielettrico (parte tratteggiata). La velocità di propagazione di un segnale in un cavo coassiale vale V = 1/ ɛµ dove ɛ è la costante dielettrica e µ la permeabilità magnetica del materiale isolante interposto fra il conduttore centrale e quello esterno del cavo stesso. Se il segnale elettrico percorre un cavo coassiale di lunghezza fissa ma diviso in due zone, come illustrato in Fig:1.12, dove nella prima il dielettrico è l aria e nella seconda è un dielettrico di altro tipo, la velocità di propagazione nelle due zone sarà differente. Ciò comporta che il tempo t per percorrere l intero cavo sarà dato da:
31 1.2 Il progetto italiano 15 dove: t = L + K(L L 1) c (1.2) c è la velocità della luce nel vuoto; K è la costante che definisce il rallentamento della propagazione del segnale dove c è il dielettrico; L è la lunghezza del cavo; L 1 è la lunghezza della parte di cavo riempita col dielettrico. Al variare di L 1 varia il tempo di propagazione del segnale e quindi il ritardo. Figura 1.13: Rappresentazione del dettaglio costruttivo, ovvero la sezione del cavo coassiale realmente usato: si noti che sia lo schermo esterno che il conduttore interno sono di profilato a forma quadrata, per permettere il facile posizionamento dei 4 tubi per il kerosene. Il dielettrico scelto è il kerosene (ɛ r = 2) e, per motivi legati alla praticità, la linea coassiale è stata realizzata con dei conduttori di alluminio di
32 16 S.K.A. Square Kilometer Array sezione quadrata. Fra essi sono posizionati quattro tubi di sezione circolare contenenti kerosene ( vedi Fig:1.13). Figura 1.14: Si mostra il sistema degli oli per il recupero della fase ai diversi puntamenti in declinazione. La situazione raffigurata si ripete in modo analogo per tutti i gruppi di 8 antenne. Regolando l altezza dei cilindri nelle cabine degli oli si riesce ad ottenere la quantità voluta di cavo coassiale (sfasatore) riempito di kerosene. Il livello di kerosene in ogni cilindro uguaglia quello del liquido nel cavo relativo all antenna ad esso collegato. Il giusto ritardo per ogni linea viene inserito sfruttando un sistema idraulico, funzionante secondo il principio dei vasi comunicanti, e le linee che costituiscono il normale percorso che dovrebbe percorrere il segnale. La messa in fase dei segnali avviene in ogni gruppo di otto antenne, ne segue che tutte le prime antenne di ogni gruppo hanno il kerosene allo stesso livello, tutte le seconde antenne analogamente anche se diverso dalle prime e così di seguito per tutti gli 8 gruppi. La Fig:1.14 illustra come il semplice principio dei vasi comunicanti abbia permesso questa realizzazione. In una cabina è stato sistemato un serbatoio di kerosene che alimenta otto cilindri, ciascuno dei quali è collegato ad un antenna per ognuna delle otto sezioni del ramo Nord Sud. Alzando il cilindro si alza il livello del kerosene in un punto del sistema e quindi si costringe il serbatoio a fornire kerosene nei tubi fino a che il livello nei cavi coassiali di tutte le otto antenne ad esso collegate uguaglia quello del cilindro.
33 1.2 Il progetto italiano 17 Si mette ora in evidenza come a queste linee coassiali sia affidato il compito di compensare le fasi senza recuperare il ritardo temporale. Ciò produce inevitabilmente una perdita di coerenza, ossia una perdita di potenza, del segnale ricevuto che è possibile quantificare tramite la 1.3 (questa formula verrà ampiamente illustrata nel capitolo 2). dove: 1 sin πb t πb t (1.3) è la perdita di coerenza; B è la banda di frequenze; t è il tempo impiegato dall onda elettromagnetica per percorrere il tratto L ottenuto da 1.1 ( T massimo è ottenuto con δ = +45 ). Questa formula viene applicata al sistema composto dalle due antenne più lontane dello stesso gruppo di otto. Nel caso specifico della Croce del Nord considerando una B = 2.7MHz e un T medio 120ns, si ottiene 15%. Si noti come la perdita di coerenza non assume valori considerevoli, per cui l approssimazione di recuperare solo la fase risulta accettabile Upgrade ramo Nord Sud I lavori da compiere per migliorare il funzionamento del ramo Nord Sud della Croce del Nord sono parecchi, ma uno in particolare è quello che ci interessa, e riguarda la progettazione di nuovi front end per le antenne. Per comprendere la configurazione attuale facciamo riferimento alla Fig: 1.15 nella quale è rappresentato uno degli 8 canali, costituito da 8 antenne, che formano il ramo Nord Sud. Il segnale che viene prelevato dal lato della linea focale di un antenna, viene fatto passare attraverso il sistema rifasamento oli e sommato col segnale proveniente dall antenna vicina. In questo modo si genera una somma ad albero di natale che porta ad avere un unico
34 18 S.K.A. Square Kilometer Array Figura 1.15: Attuali Front End. segnale in fase all ingresso della cabina situata a lato, a metà tra la quarta e la quinta antenna. Nella cabina è situato il front end costituito da un pre amplificatore a basso rumore (Low Noise Amplifier LNA), da un filtro passa banda (Band Pass Filter BPF) e da un oscillatore locale (Local Oscillator LO) per la conversione in frequenza. La modifica che si nota immediatamente nel progetto della versione migliorata (vedi Fig:1.16) è l inserimento di un front end per ognuna della otto antenne costituenti un canale. Il nuovo front end verrebbe posizionato a metà dell antenna stessa per cercare di recuperare 0.4, 0.5 db di segnale
35 1.2 Il progetto italiano 19 che attualmente vengono persi nei 12 m che intercorrono tra il nodo centrale e l attuale connettore a lato linea. Il nuovo front end sarà realizzato da tre blocchi in cascata: un LNA, un vector modulator e un BPF. Le uscite delle antenne che costituiscono il canale saranno in fase e verranno sommate prima dell ingresso in cabina ove resterà esclusivamente il LO. Figura 1.16: Nuovi Front End. L introduzione di sfasatori tipo vector modulator permetterà di eliminare totalmente il sistema di sfasamento a kerosene.
36 20 S.K.A. Square Kilometer Array Affronteremo nel prossimo capitolo le varie soluzioni possibili per il recupero della fase, mettendo in evidenza i pro e i contro di ciascuna.
37 Capitolo 2 Rifasamento di antenne 2.1 Gli interferometri Come illustrato nel precedente capitolo, il ramo Nord Sud della Croce del Nord è un interferometro multiplo. Il principio di funzionamento è basato sulla teoria dell interferenza delle onde, in particolare sulla proprietà che due onde sommate in fase si rafforzano mentre sommate in opposizione si attenuano fino ad annullarsi nel caso peggiore. In realtà, in tutte le antenne avvengono fenomeni di interferenza, ma negli interferometri questi risultano più evidenti. Per comprendere il significato di questo principio, si comincerà dalla descrizione del funzionamento dell interferometro semplice. Si supponga di avere due antenne direttive, uguali e ugualmente puntate. A questa struttura è possibile applicare il principio di Kraus[8] secondo il quale il diagramma, ossia la descrizione grafica della direttività dell interferometro, è uguale al prodotto del diagramma di un interferometro ad antenne non direttive e del diagramma di una delle antenne che lo compongono. Sfruttando questo principio si ottiene un interferometro che ha una direttività elevata pur presentando un numero di lobi limitato (vedi Fig:2.1). Si comprende che i lobi si riducono ad uno soltanto quando le due antenne sono talmente vicine tra loro che le loro aree efficaci possono essere considerate contigue. Se ora si aggiunge una terza antenna centrale si ottiene la soppressione di alcuni lobi senza variare la larghezza di quelli rimasti. È intuitivo quindi
38 22 Rifasamento di antenne che se si prende un grande numero di antenne, al limite, si potrà ottenere un diagramma avente un singolo lobo, senza portare a contatto le antenne. Figura 2.1: Interferometro semplice. Se ora si considerano più antenne, si ottiene un interferometro multiplo (vedi Fig:2.2) il quale è costituito da antenne non direttive e uniformemente spaziate. Esso fornisce lobi le cui larghezze dipendono dalla distanza fra le antenne estreme e le cui spaziature sono funzione della distanza tra due antenne contigue. Anche in questo caso, aggiungendo antenne intermedie, si ottiene la soppressione di alcuni lobi, mentre quelli rimasti aumentano di ampiezza mantenendo la stessa larghezza. Come nel caso dell interferometro semplice, al limite, si potrà arrivare ad avere un singolo lobo senza portare a contatto le antenne. Per avere un segnale di uscita dall interferometro multiplo si richiedono dispositivi in grado di moltiplicare segnali a radiofrequenza. Moltiplicare segnali a radiofrequenza significa ottenere un segnale proporzionale al prodotto dei valori istantanei dei segnali di ingresso. In questo
39 2.1 Gli interferometri 23 modo il risultato dipende non solo dalle ampiezze dei segnali di input, ma anche dalle loro relazioni di fase. In particolare la fase deve essere costante, ossia la stessa per ogni elemento dell interferometro. Questo significa che i segnali devono essere coerenti tra loro. Figura 2.2: Interferometro multiplo. I segnali provenienti dalle radiosorgenti sono estremamente deboli: sostanzialmente possono essere paragonati a rumore e quindi ad un processo aleatorio.essi non possono perciò essere coerenti tra loro, a meno che non siano ricavati da onde elettromagnetiche emesse dalla stessa sorgente nello stesso istante. È per questo motivo che si inseriscono dei phase shifter nella catena dell interferometro. Procedendo in questo modo, i segnali ricevuti da due antenne dell interferometro risultano essere riferiti al medesimo segnale
40 24 Rifasamento di antenne proveniente dalla radiosorgente. Avendo brevemente descritto il principio di funzionamento dell interferometro è possibile procedere con una trattazione matematica del problema Analisi nel dominio dei tempi Si supponga di prendere un interferometro come mostrato in Fig:2.3. Si indichi con b la linea ideale che collega due antenne identiche (baseline). Si supponga di disporre di una radiosorgente monocromatica, puntiforme, a frequenza ν, posizionata nella direzione data dal vettore unitario s. Si prenda l antenna n 1 come riferimento. Figura 2.3: Geometria di un interferometro a due elementi. Il ritardo τ g è compensato dal ritardo τ i.
41 2.1 Gli interferometri 25 Le due antenne seguono la radiosorgente nei suoi movimenti, ma sull antenna n 2 il segnale giunge ritardato rispetto all antenna presa come riferimento. Il ritardo temporale τ g è di natura geometrica ed è quantificato dalla formula: τ g = b s c (2.1) dove con si indica il prodotto scalare e con c la velocità della luce nel vuoto. Il blocco τ i presente in Fig:2.3 inserisce un ritardo che può essere aggiunto per equalizzare il ritardo τ g del segnale. Si assuma per il momento che τ i sia nullo. La funzione di correlazione R xy (τ) tra due segnali è definita come la media temporale del prodotto dei due segnali, dei quali uno è ritardato della quantità τ: R xy (τ) = < x(t) y(t + τ) > (2.2) il risultato ha le dimensioni di una potenza. Nel caso specifico si sta trattando con radiosorgenti monocromatiche la cui energia emessa viene trasformata dall antenna in un segnale di tensione. Si consideri perciò un segnale x(t) presente all uscita dell antenna n 1 e un segnale y(t) presente all uscita dell antenna n 2. Essi assumono la forma del tipo: x(t) = v 1 cos (2πνt) (2.3) y(t) = v 2 cos [ ] 2πν(t τ) (2.4) Sviluppando il calcolo della funzione di correlazione R xy (τ) e considerando che i due segnali a radiofrequenza sono proporzionali all area efficace d antenna A( s) e al flusso S della sorgente, si ottiene:
42 26 Rifasamento di antenne Esprimendo τ g come in 2.1 si ha R xy (τ g ) = A( s) S cos (2πντ g ) (2.5) ( R xy (τ g ) = A( s) S cos 2πν ) b s c (2.6) Assumendo che b possa essere espressa in funzione della lunghezza d onda λ, si indichi per cui si ottiene: bλ = b λ (2.7) R xy (S) = A( s) S cos (2π b λ s) (2.8) Da quest ultima formula si può comprendere come il valore massimo di R xy ( s) si ottiene quando la direzione di osservazione è ortogonale alla baseline. Quando ciò non avviene subentra nella formula un fattore correttivo al ribasso proporzionale all angolo di puntamento Analisi nel dominio delle frequenze Esiste una strada alternativa e completamente equivalente con la quale potere analizzare un interferometro. Essa consiste nella descrizione del processo nel domino delle frequenze. La trasformata di Fourier della correlazione R xy (t) è il prodotto della trasformata di x(t) per il complesso coniugato di y(t). Il risultato S xy (ν), espresso dalla formula 2.9 è una densità spettrale di potenza: S xy (ν) = X(ν) Y (ν) (2.9) Considerando che x(t) e y(t) sono state ipotizzate come in 2.3 e 2.4, e ricordando alcune proprietà della trasformata di Fourier
43 2.1 Gli interferometri 27 { } [ ] F cos (2πν 0 t) = π δ (ν ν 0 ) + δ (ν + ν 0 ) (2.10) si può sviluppare la 2.9 ottenendo: { } F x(t t 0 ) = X(ν) e jνt 0 (2.11) ricordando la 2.1 e 2.7 si ottiene: S xy (ν) = A( s) S e j2πντg (2.12) S xy (ν) = A( s) S e j2π b λ s (2.13) Ovviamente le due rappresentazioni e le conclusioni che si possono trarre sono equivalenti Sistemi a banda finita Fino ad ora si è analizzato un interferometro che vede una sorgente puntiforme emettere un segnale monocromatico. In realtà le sorgenti hanno dimensioni finite e gli strumenti di analisi hanno tutti banda finita. Si ipotizzi quindi che il ricevitore abbia una banda passante g(ν) centrata sulla frequenza ν 0 e larga B. Si supponga che il segnale radio ricevuto sia un rumore gaussiano per cui la risposta alla 2.13 possa essere sommata su tutta la banda passante. Si assuma pure, per semplicità, che la direzione s di osservazione della sorgente sia normale alla baseline dell interferometro. Si ottiene così: < S xy (τ g ) > = + sviluppando la 2.14 con la 2.13 si ottiene: S xy (ν, s) g(ν) dν (2.14) < S xy (τ g ) > = ν0 + B 2 ν 0 B 2 A(ν, s) S(ν) e j2πν 0τ g dν (2.15) assumendo che area efficace e flusso abbiano variazioni lente nella banda passante si ottiene:
44 28 Rifasamento di antenne S xy (τ g ) = A(ν 0, s) S(ν 0 ) B e j2πν 0τ g sin (πbτ g ) πbτ g (2.16) Da quest ultima formula risulta chiaro che quando il ritardo di natura geometrica τ g diventa paragonabile con l inverso della banda 1 B, la risposta dell interferometro risulta essere notevolmente attenuata. Tutto ciò giustifica l introduzione del ritardo temporale di natura strumentale τ i. Esso, come si nota in Fig:2.3, viene inserito sulla linea di trasmissione che porta il segnale dall antenna n 1 al ricevitore, con lo scopo di compensare il ritardo geometrico presente sull antenna n 2. Nella equazione 2.16 compare il prodotto tra una funzione d area efficace d antenna e lo spettro di una sorgente. Esso viene assunto costante grazie all approssimazione di banda passante piatta. Tale approssimazione non influenza in modo significativo i risultati che si suppongono, di conseguenza, sufficientemente accurati. 2.2 Phase Shifter Il phase shifter è un dispositivo utilizzato per modificare la fase dei segnali. Ne esistono due categorie entrambe sviluppate per essere applicate ad array di antenne: phase shifter a ferrite e phase shifter a diodi. Il primo è un dispositivo passivo a due porte che produce una variazione di fase nei segnali a microonde, senza modificare la propria lunghezza fisica. Lo shift di fase è legato alla variazione di permeabilità magnetica dovuta al cambiamento del campo magnetico nel quale è immerso il dispositivo. Le modifiche desiderate del campo magnetico sono ottenute con circuiti di pilotaggio speciali che controllano la corrente che genera il campo magnetico. Un circuito di pilotaggio adeguato e ben realizzato permette di ottenere un controllo preciso del phase shifter a ferrite sopra un ampia gamma di fre-
45 2.2 Phase Shifter 29 quenze. I secondi utilizzano, come elementi di controllo, i diodi PN o i diodi Pin. I diodi PN permettono il controllo della fase in maniera continua e possono essere utilizzati per circuiti di bassa potenza. I diodi Pin consentono la variazione della fase in maniera discreta e sono preferibili quando le potenze in gioco sono più elevate. La scelta tra queste due categorie dipende dalla frequenza operativa e dalla potenza del segnale a radiofrequenza. Ad esempio, nelle applicazioni dove è importante tenere sotto controllo le perdite di potenza del segnale è conveniente utilizzare il phase shifter a ferrite. Nelle situazioni in cui sono importanti dimensioni e peso, allora è preferibile utilizzare phase shifter a diodi. Un phase shifter viene caratterizzato come un circuito a microonde mediante i seguenti parametri: Larghezza di banda; Perdita di inserzione; Adattamento in ingresso e in uscita; Deriva termica. Una breve descrizione di questi parametri verrà data in appendice A. Per applicazioni nel campo delle microonde, in generale, sono utilizzati i phase shifter a diodi. Quelli che qui verranno analizzati sono: Switched line; Loaded line;
46 30 Rifasamento di antenne High pass Low pass; I Q vector modulator; Coupler; Circulator. Di ciascun dispositivo viene fornita una breve descrizione Switched line phase shifter Il principio di funzionamento dello switched line phase shifter consiste nella modifica della lunghezza elettrica presente tra ingresso e uscita. Questo viene realizzato commutando il segnale su linee di diversa lunghezza. Come risultato si ottiene uno spostamento di fase del segnale di ingresso variabile linearmente con la frequenza, definito dalla formula 2.17 Φ = 2π λ l (2.17) Un phase shifter di questo tipo è composto da due switch a due vie e da due linee di diversa lunghezza (Fig:2.4). Figura 2.4: Switched line phase shifter. Se i due switch non funzionano in modo adeguato, si potrebbe verificare il passaggio di una parte del segnale per la linea non scelta, producendo un
47 2.2 Phase Shifter 31 grande errore sia di fase sia di ampiezza. Tale problema può essere risolto realizzando un adattamento di impedenza per la linea non interessata dal passaggio del segnale. È chiaro come le prestazioni di questo phase shifter dipendono fortemente dagli interruttori utilizzati. Essi introducono una perdita di inserzione costante, mentre la perdita dovuta alla differenza di lunghezza tra le linee può variare. Le dimensioni del circuito dipendono dallo shift di fase che si deve realizzare. ampia. La banda di frequenze sulla quale può operare il dispositivo è molto Loaded line phase shifter Il loaded line phase shifter sfrutta la capacità di una impedenza di carico di modificare le componenti riflessa e trasmessa del segnale. Se lo scopo è di modificare solo la fase del coefficiente di trasmissione si possono utilizzare due carichi puramente immaginari (Fig:2.5). Figura 2.5: Loaded line phase shifter con carico parallelo.
Corso di Radioastronomia 1
 Corso di Radioastronomia 1 Aniello (Daniele) Mennella Dipartimento di Fisica Programma del corso Parte 1- Introduzione e concetti di base Breve storia della radioastronomia La nascita della radioastronomia,
Corso di Radioastronomia 1 Aniello (Daniele) Mennella Dipartimento di Fisica Programma del corso Parte 1- Introduzione e concetti di base Breve storia della radioastronomia La nascita della radioastronomia,
Facoltà di Ingegneria Università di Parma. Antenne a Riflettore. A. Cucinotta 1
 Facoltà di Ingegneria Università di Parma Antenne a Riflettore A. Cucinotta 1 Antenne a Riflettore Le a. a bocca radiante sono a. che irradiano (o captano) potenza nello (dallo) spazio attraverso un apertura
Facoltà di Ingegneria Università di Parma Antenne a Riflettore A. Cucinotta 1 Antenne a Riflettore Le a. a bocca radiante sono a. che irradiano (o captano) potenza nello (dallo) spazio attraverso un apertura
MEZZI TRASMISSIVI. I mezzi trasmissivi sono suddivisi in tre categorie:
 MEZZI TRASMISSIVI Nelle reti l unità di misura della velocità di trasmissione è il bit per secondo (indicato con bps o con bit/s) e i suoi multipli (Kbps per migliaia, Mbps per milioni, Gbps per miliardi
MEZZI TRASMISSIVI Nelle reti l unità di misura della velocità di trasmissione è il bit per secondo (indicato con bps o con bit/s) e i suoi multipli (Kbps per migliaia, Mbps per milioni, Gbps per miliardi
Indice. Presentazione 1
 Presentazione 1 1 Perchè e come studiare i fenomeni elettromagnetici 3 1.1 Introduzione............................ 3 1.2 Approccio induttivo e deduttivo................. 6 1.3 Teorie per descrivere i
Presentazione 1 1 Perchè e come studiare i fenomeni elettromagnetici 3 1.1 Introduzione............................ 3 1.2 Approccio induttivo e deduttivo................. 6 1.3 Teorie per descrivere i
SENSIBILITÀ DI UN RICEVITORE NEL FUNZIONAMENTO A SINGOLA E DOPPIA RICEZIONE. ( )
 SENSIBILITÀ DI UN RICEVITORE NEL FUNZIONAMENTO A SINGOLA E DOPPIA RICEZIONE. (18-07-2015) Il segnale minimo che un ricevitore è in grado di rivelare dipende dal valore minimo del rapporto fra la potenza
SENSIBILITÀ DI UN RICEVITORE NEL FUNZIONAMENTO A SINGOLA E DOPPIA RICEZIONE. (18-07-2015) Il segnale minimo che un ricevitore è in grado di rivelare dipende dal valore minimo del rapporto fra la potenza
Antenne a microstriscia per applicazioni wireless
 Antenne a microstriscia per applicazioni wireless Annamaria Cucinotta annamaria.cucinotta@unipr.it http://www.tlc.unipr.it/cucinotta 1 Comunicazioni wireless Nell ambito delle comunicazioni wireless è
Antenne a microstriscia per applicazioni wireless Annamaria Cucinotta annamaria.cucinotta@unipr.it http://www.tlc.unipr.it/cucinotta 1 Comunicazioni wireless Nell ambito delle comunicazioni wireless è
INDICE. Capitolo 1 Introduzione 1. Capitolo 2 Rappresentazione di Fourier di segnali e sistemi 19. Capitolo 3 Modulazione d ampiezza 99
 INDICE Capitolo 1 Introduzione 1 1.1 Inquadramento storico 1 1.2 Applicazioni 4 1.3 Risorse principali e requisiti operativi 13 1.4 Teorie alla base dei sistemi di comunicazione 14 1.5 Osservazioni conclusive
INDICE Capitolo 1 Introduzione 1 1.1 Inquadramento storico 1 1.2 Applicazioni 4 1.3 Risorse principali e requisiti operativi 13 1.4 Teorie alla base dei sistemi di comunicazione 14 1.5 Osservazioni conclusive
RUMORE. i(t) Figure 1:
 UMOE 1) Nel circuito in fig. 1 è una resistenza rumorosa alla temperatura assoluta T e L è un induttanza. Si vuole determinare il valor quadratico medio della corrente i(t) che scorre all interno dell
UMOE 1) Nel circuito in fig. 1 è una resistenza rumorosa alla temperatura assoluta T e L è un induttanza. Si vuole determinare il valor quadratico medio della corrente i(t) che scorre all interno dell
Antenne e Collegamento Radio
 Antenne e Collegamento Radio Trasmissione irradiata Oltre ad essere guidato attraverso le linee di trasmissione, il campo elettromagnetico si può propagare nello spazio (radiazione) Anche la radiazione
Antenne e Collegamento Radio Trasmissione irradiata Oltre ad essere guidato attraverso le linee di trasmissione, il campo elettromagnetico si può propagare nello spazio (radiazione) Anche la radiazione
S. Montebugnoli Istituto di Radioastronomia (Bologna) Istituto Nazionale di Astrofisica http://www.ira.cnr.it
 Convegno Nazionale di Radioastronomia Amatoriale Trento 30-31 31 Ottobre 2004 S. Montebugnoli Istituto di Radioastronomia (Bologna) Istituto Nazionale di Astrofisica http://www.ira.cnr.it La radioastronomia
Convegno Nazionale di Radioastronomia Amatoriale Trento 30-31 31 Ottobre 2004 S. Montebugnoli Istituto di Radioastronomia (Bologna) Istituto Nazionale di Astrofisica http://www.ira.cnr.it La radioastronomia
Calcolo numerico per utilizzare i residui di udito
 Calcolo numerico per utilizzare i residui di udito Andrea Trucco, Ph.D. Dipartimento Ingegneria Biofisica ed Elettronica DIBE - Università di Genova trucco@ieee.org 1 Segnale audio Variazione della pressione
Calcolo numerico per utilizzare i residui di udito Andrea Trucco, Ph.D. Dipartimento Ingegneria Biofisica ed Elettronica DIBE - Università di Genova trucco@ieee.org 1 Segnale audio Variazione della pressione
POWER METER STRUMENTAZIONE. Realizziamo un ottimo misuratore di potenza dei segnali radio impiegabile sia al banco che sul campo. Prima puntata.
 76 STRUMENTAZIONE POWER METER Realizziamo un ottimo misuratore di potenza dei segnali radio impiegabile sia al banco che sul campo. Prima puntata. di FULVIO DE SANTIS U no strumento che non dovrebbe mancare
76 STRUMENTAZIONE POWER METER Realizziamo un ottimo misuratore di potenza dei segnali radio impiegabile sia al banco che sul campo. Prima puntata. di FULVIO DE SANTIS U no strumento che non dovrebbe mancare
Banco Educazionale Arra MT 1
 Banco Educazionale Arra MT 1 Descrizione Generale Il Sistema didattico Arra Microwave Modello MT-1, è stato progettato per realizzare Corsi di formazione teorica e pratica per Istituti Tecnici, Università
Banco Educazionale Arra MT 1 Descrizione Generale Il Sistema didattico Arra Microwave Modello MT-1, è stato progettato per realizzare Corsi di formazione teorica e pratica per Istituti Tecnici, Università
INTERFERENZA - DIFFRAZIONE
 INTERFERENZA - F. Due onde luminose in aria, di lunghezza d onda = 600 nm, sono inizialmente in fase. Si muovono poi attraverso degli strati di plastica trasparente di lunghezza L = 4 m, ma indice di rifrazione
INTERFERENZA - F. Due onde luminose in aria, di lunghezza d onda = 600 nm, sono inizialmente in fase. Si muovono poi attraverso degli strati di plastica trasparente di lunghezza L = 4 m, ma indice di rifrazione
Esempio di antenna a telaio, con spire rettangolari e circolari.
 ANTENNE A TELAIO LA QUAD di Giovanni G. Turco, ik0ziz Questo tipo di antenna fu realizzata da Clarence J. Moore, ingegnere, ed adottata per la prima volta a Quito, in Equator, oltre sessant anni fa, quando
ANTENNE A TELAIO LA QUAD di Giovanni G. Turco, ik0ziz Questo tipo di antenna fu realizzata da Clarence J. Moore, ingegnere, ed adottata per la prima volta a Quito, in Equator, oltre sessant anni fa, quando
MISURA DELLA VELOCITA DELLA LUCE
 MISURA DELLA VELOCITA DELLA LUCE La misura della velocità della luce (c=3x10 8 m/s) effettuata su distanze dell ordine del metro richiede la misura di intervalli di tempo brevissimi (~3x10-9 s). Il metodo
MISURA DELLA VELOCITA DELLA LUCE La misura della velocità della luce (c=3x10 8 m/s) effettuata su distanze dell ordine del metro richiede la misura di intervalli di tempo brevissimi (~3x10-9 s). Il metodo
1 INTRODUZIONE AL BEAMFORMING
 1 INTRODUZIONE AL BEAMFORMING Per Beamforming si intende la combinazione di segnali provenienti da un array di piccole antenne non direzionali in modo da formare una grande antenna direzionale che riceva
1 INTRODUZIONE AL BEAMFORMING Per Beamforming si intende la combinazione di segnali provenienti da un array di piccole antenne non direzionali in modo da formare una grande antenna direzionale che riceva
Corso di Fondamenti di Telecomunicazioni 1 - INTRODUZIONE
 Corso di Fondamenti di Telecomunicazioni 1 - INTRODUZIONE 1 Argomenti della lezione Definizioni: Sorgente di informazione Sistema di comunicazione Segnali trasmissivi determinati e aleatori Architettura
Corso di Fondamenti di Telecomunicazioni 1 - INTRODUZIONE 1 Argomenti della lezione Definizioni: Sorgente di informazione Sistema di comunicazione Segnali trasmissivi determinati e aleatori Architettura
Le infrastrutture astronomiche di nuova generazione: asset strategici per il futuro dell umanità
 Le infrastrutture astronomiche di nuova generazione: asset strategici per il futuro dell umanità 1 In fase di costruzione: E-ELT, il più grande telescopio al mondo 2 In fase di costruzione: SKA: Square
Le infrastrutture astronomiche di nuova generazione: asset strategici per il futuro dell umanità 1 In fase di costruzione: E-ELT, il più grande telescopio al mondo 2 In fase di costruzione: SKA: Square
LINEE DI TRASMISSIONE CON LTSPICE IV 1
 EdmondDantes LINEE DI TRASMISSIONE CON LTSPICE IV 28 December 2010 Generalità Nell accezione più generale, una linea di trasmissione è un sistema di due o più conduttori metallici separati da mezzi dielettrici
EdmondDantes LINEE DI TRASMISSIONE CON LTSPICE IV 28 December 2010 Generalità Nell accezione più generale, una linea di trasmissione è un sistema di due o più conduttori metallici separati da mezzi dielettrici
CANALE STAZIONARIO CANALE TEMPO INVARIANTE
 CANALE STAZIONARIO Si parla di un Canale Stazionario quando i fenomeni che avvengono possono essere modellati da processi casuali e le proprietà statistiche di tali processi sono indipendenti dal tempo.
CANALE STAZIONARIO Si parla di un Canale Stazionario quando i fenomeni che avvengono possono essere modellati da processi casuali e le proprietà statistiche di tali processi sono indipendenti dal tempo.
Richiami Teorici sulle barriere acustiche
 Le barriere acustiche rappresentano la soluzione più comune per la riduzione del rumore immesso da infrastrutture di trasporto verso i ricettori presenti nell area di territorio disturbata. Tali opere
Le barriere acustiche rappresentano la soluzione più comune per la riduzione del rumore immesso da infrastrutture di trasporto verso i ricettori presenti nell area di territorio disturbata. Tali opere
Sistemi di Telecomunicazione
 Sistemi di Telecomunicazione Caratterizzazione di doppi bipoli rumorosi Universita Politecnica delle Marche A.A. 2014-2015 A.A. 2014-2015 Sistemi di Telecomunicazione 1/13 Temperatura equivalente di rumore
Sistemi di Telecomunicazione Caratterizzazione di doppi bipoli rumorosi Universita Politecnica delle Marche A.A. 2014-2015 A.A. 2014-2015 Sistemi di Telecomunicazione 1/13 Temperatura equivalente di rumore
Corso di Laurea in Astronomia. Laurea Triennale DISPENSE DI ESPERIMENTAZIONI DI FISICA 2
 Corso di Laurea in Astronomia Laurea Triennale DISPENSE DI ESPERIMENTAZIONI DI FISICA A.A. 01-013 Indice 1 Introduzione 5 1.1 Indice di rifrazione.............................. 5 1. Riflessione e rifrazione............................
Corso di Laurea in Astronomia Laurea Triennale DISPENSE DI ESPERIMENTAZIONI DI FISICA A.A. 01-013 Indice 1 Introduzione 5 1.1 Indice di rifrazione.............................. 5 1. Riflessione e rifrazione............................
La teoria delle serie di Fourier dimostra che la maggior parte dei segnali e quindi di forme d onda può essere prodotta sommando assieme onde
 FILTRI La teoria delle serie di Fourier dimostra che la maggior parte dei segnali e quindi di forme d onda può essere prodotta sommando assieme onde sinusoidali Segnale sinusoidale rappresentato proiettando
FILTRI La teoria delle serie di Fourier dimostra che la maggior parte dei segnali e quindi di forme d onda può essere prodotta sommando assieme onde sinusoidali Segnale sinusoidale rappresentato proiettando
Fondamenti di Data Processing
 Fondamenti di Data Processing Vincenzo Suraci Automazione INTRODUZIONE AL DATA PROCESSING ACQUISIZIONE DATI SCHEMA COSTRUTTIVO SCHEDA INPUT OSCILLATORE A FREQUENZA COSTANTE BANDA PASSANTE ACCORDATA AL
Fondamenti di Data Processing Vincenzo Suraci Automazione INTRODUZIONE AL DATA PROCESSING ACQUISIZIONE DATI SCHEMA COSTRUTTIVO SCHEDA INPUT OSCILLATORE A FREQUENZA COSTANTE BANDA PASSANTE ACCORDATA AL
DISPOSITIVI PER VHF e MICROONDE
 ARI Sezione di Parma Conversazioni del 1 Venerdì del Mese DISPOSITIVI PER VHF e MICROONDE Venerdì, 3 marzo 2017, ore 21:15 Carlo, I4VIL HELICAL FILTER HELICAL BAND PASS FILTER - 100 MHz Risposta ampiezza
ARI Sezione di Parma Conversazioni del 1 Venerdì del Mese DISPOSITIVI PER VHF e MICROONDE Venerdì, 3 marzo 2017, ore 21:15 Carlo, I4VIL HELICAL FILTER HELICAL BAND PASS FILTER - 100 MHz Risposta ampiezza
Antenna Long Wire. 1 f
 Antenna Long Wire Principio della Long Wire Come lo dice il nome si tratta di un antenna basata su un lungo filo elettrico, ha la particolarità di essere di lunghezza superiore alle tradizionali antenne
Antenna Long Wire Principio della Long Wire Come lo dice il nome si tratta di un antenna basata su un lungo filo elettrico, ha la particolarità di essere di lunghezza superiore alle tradizionali antenne
Capitolo IX. Convertitori di dati
 Capitolo IX Convertitori di dati 9.1 Introduzione I convertitori di dati sono circuiti analogici integrati di grande importanza. L elaborazione digitale dei segnali è alternativa a quella analogica e presenta
Capitolo IX Convertitori di dati 9.1 Introduzione I convertitori di dati sono circuiti analogici integrati di grande importanza. L elaborazione digitale dei segnali è alternativa a quella analogica e presenta
1 Schemi alle differenze finite per funzioni di una variabile
 Introduzione In questa dispensa vengono forniti alcuni elementi di base per la soluzione di equazioni alle derivate parziali che governano problemi al contorno. A questo scopo si introducono, in forma
Introduzione In questa dispensa vengono forniti alcuni elementi di base per la soluzione di equazioni alle derivate parziali che governano problemi al contorno. A questo scopo si introducono, in forma
Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale
 Università degli Studi di Catania Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale Corso di TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA A.A. 20015/2016 Prof. Ing. Giuseppe
Università degli Studi di Catania Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale Corso di TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA A.A. 20015/2016 Prof. Ing. Giuseppe
INTRODUZIONE ALLE RETI. Tipologie di Rete. Perché una rete? Interconnessione di reti
 INTRODUZIONE ALLE RETI Tipologie di Rete Perché una rete? Condividere risorse utilizzo razionale di dispositivi costosi modularità della struttura affidabilità e disponibilità Comunicare tra utenti scambio
INTRODUZIONE ALLE RETI Tipologie di Rete Perché una rete? Condividere risorse utilizzo razionale di dispositivi costosi modularità della struttura affidabilità e disponibilità Comunicare tra utenti scambio
Il ruolo della RETE nel e-vlbi e in SKA. Mauro Nanni (INAF Ist. Radioastronomia))
 Il ruolo della RETE nel e-vlbi e in SKA Mauro Nanni (INAF Ist. Radioastronomia)) La sfida dell Astrofisica : Studio di fenomeni distanti miloni di anni luce Segnali Deboli e Confusi Piu deboli i segnali:
Il ruolo della RETE nel e-vlbi e in SKA Mauro Nanni (INAF Ist. Radioastronomia)) La sfida dell Astrofisica : Studio di fenomeni distanti miloni di anni luce Segnali Deboli e Confusi Piu deboli i segnali:
Antenne e Telerilevamento. Esame
 ESAME DEL 21/05/2001 ESERCIZIO 1 (10 punti) Si progetti un antenna filare a monopolo con top loading per la frequenza di 2 MHz, in modo che presenti una resistenza di irradiazione di 1 Ω. La distribuzione
ESAME DEL 21/05/2001 ESERCIZIO 1 (10 punti) Si progetti un antenna filare a monopolo con top loading per la frequenza di 2 MHz, in modo che presenti una resistenza di irradiazione di 1 Ω. La distribuzione
LABORATORIO DI ELETTRONICA OGGETTO: RILIEVO DELLA CURVA DI RISPOSTA IN FREQUENZA DI UN AMPLIFICATORE A BJT AC180 SCHEMA
 ALUNNO: Fratto Claudio CLASSE: IV B Informatico ESERCITAZIONE N : 5 LABORATORIO DI ELETTRONICA OGGETTO: RILIEVO DELLA CURVA DI RISPOSTA IN FREQUENZA DI UN AMPLIFICATORE A BJT AC180 SCHEMA DATI: VIn = 20mV
ALUNNO: Fratto Claudio CLASSE: IV B Informatico ESERCITAZIONE N : 5 LABORATORIO DI ELETTRONICA OGGETTO: RILIEVO DELLA CURVA DI RISPOSTA IN FREQUENZA DI UN AMPLIFICATORE A BJT AC180 SCHEMA DATI: VIn = 20mV
ONDE ELETTROMAGNETICHE
 Fisica generale II, a.a. 01/014 OND LTTROMAGNTICH 10.1. Si consideri un onda elettromagnetica piana sinusoidale che si propaga nel vuoto nella direzione positiva dell asse x. La lunghezza d onda è = 50.0
Fisica generale II, a.a. 01/014 OND LTTROMAGNTICH 10.1. Si consideri un onda elettromagnetica piana sinusoidale che si propaga nel vuoto nella direzione positiva dell asse x. La lunghezza d onda è = 50.0
GIOVE e l osservazione in banda radio
 GIOVE e l osservazione in banda radio CARATTERISTICHE DI GIOVE Diametro: 142.800 km Massa: 1,9 x 10^27 kg Densità: 1,3 kg/dm³ Distanza Minima dal Sole: 741.000.000 km Distanza Massima dal Sole: 817.000.000
GIOVE e l osservazione in banda radio CARATTERISTICHE DI GIOVE Diametro: 142.800 km Massa: 1,9 x 10^27 kg Densità: 1,3 kg/dm³ Distanza Minima dal Sole: 741.000.000 km Distanza Massima dal Sole: 817.000.000
Reti di Calcolatori a.a
 Analogico e digitale 2 Corso di laurea in Informatica Reti di Calcolatori a.a. 2007-2008 Prof. Roberto De Prisco Capitolo 3 Dati e segnali Per essere trasmessi i dati devono essere trasformati in segnali
Analogico e digitale 2 Corso di laurea in Informatica Reti di Calcolatori a.a. 2007-2008 Prof. Roberto De Prisco Capitolo 3 Dati e segnali Per essere trasmessi i dati devono essere trasformati in segnali
LASER PRINCIPI FISICI
 Corso di Tecnologie Speciali I LASER PRINCIPI FISICI Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale LASER Light Amplification
Corso di Tecnologie Speciali I LASER PRINCIPI FISICI Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale LASER Light Amplification
MISURA DELLA DISTANZA FOCALE DI UNA LENTE CONVERGENTE
 MISURA DELLA DISTANZA FOCALE DI UNA LENTE CONVERGENTE La distanza focale f di una lente convergente sottile è data dalla formula: da cui 1 f = 1 p + 1 q f = pq p + q dove p e q sono, rispettivamente, le
MISURA DELLA DISTANZA FOCALE DI UNA LENTE CONVERGENTE La distanza focale f di una lente convergente sottile è data dalla formula: da cui 1 f = 1 p + 1 q f = pq p + q dove p e q sono, rispettivamente, le
Illuminatori d'antenne paraboliche Misure con la strumentazione di laboratorio.
 A.R.I. Sezione di Parma Illuminatori d'antenne paraboliche Misure con la strumentazione di laboratorio. Venerdi,5 dicembre, ore 21 - Carlo, I4VIL GUIDE D ONDA Una guida d onda è un profilato, in genere,
A.R.I. Sezione di Parma Illuminatori d'antenne paraboliche Misure con la strumentazione di laboratorio. Venerdi,5 dicembre, ore 21 - Carlo, I4VIL GUIDE D ONDA Una guida d onda è un profilato, in genere,
Corso di Fondamenti di Telecomunicazioni
 Corso di Fondamenti di Telecomunicazioni 1 - INTRODUZIONE Prof. Giovanni Schembra 1 Argomenti della lezione Definizioni: Sorgente di informazione Sistema di comunicazione Segnali trasmissivi determinati
Corso di Fondamenti di Telecomunicazioni 1 - INTRODUZIONE Prof. Giovanni Schembra 1 Argomenti della lezione Definizioni: Sorgente di informazione Sistema di comunicazione Segnali trasmissivi determinati
2. Analisi in frequenza di segnali
 2.1 Serie di Fourier 2. Analisi in frequenza di segnali Secondo il teorema di Fourier, una funzione periodica y(t) è sviluppabile in una serie costituita da un termine costante A 0 e da una somma di infinite
2.1 Serie di Fourier 2. Analisi in frequenza di segnali Secondo il teorema di Fourier, una funzione periodica y(t) è sviluppabile in una serie costituita da un termine costante A 0 e da una somma di infinite
RIFASAMENTO DEI CARICHI
 RIFASAMENTO DEI CARICHI GENERALITÀ Nei circuiti in corrente alternata la potenza assorbita da un carico può essere rappresentata da due componenti: la componente attiva P che è direttamente correlata al
RIFASAMENTO DEI CARICHI GENERALITÀ Nei circuiti in corrente alternata la potenza assorbita da un carico può essere rappresentata da due componenti: la componente attiva P che è direttamente correlata al
Esercitazione 2: Strutture a 2 e 3 porte
 Esercitazione : trutture a e porte trutture a porte Isolatori L isolatore, idealmente dalle caratteristiche specificate in Fig. c), è un componente di grandissimo interesse allo scopo di disaccoppiare
Esercitazione : trutture a e porte trutture a porte Isolatori L isolatore, idealmente dalle caratteristiche specificate in Fig. c), è un componente di grandissimo interesse allo scopo di disaccoppiare
Corso di Radioastronomia 1
 Corso di Radioastronomia 1 Aniello (Daniele) Mennella Dipartimento di Fisica Quinta parte: interferometria Parte 5, Lezione 2 Interferometria a sintesi di apertura Il principio di ricostruzione dell immagine
Corso di Radioastronomia 1 Aniello (Daniele) Mennella Dipartimento di Fisica Quinta parte: interferometria Parte 5, Lezione 2 Interferometria a sintesi di apertura Il principio di ricostruzione dell immagine
ovvero la DC indesidrata più la componente continua dell onda quadra e tutte le sue armoniche. Da Fourier si pone: a 0 = 2 T
 1 Filtro passa banda Il segnale di interesse è una onda quadra da 0 ad A mentre il rumore è composto, oltre che da rumore bianco (equamente distribuito in frequenza), anche da una elevata componente in
1 Filtro passa banda Il segnale di interesse è una onda quadra da 0 ad A mentre il rumore è composto, oltre che da rumore bianco (equamente distribuito in frequenza), anche da una elevata componente in
I convertitori c.a.-c.a. possono essere suddivisi in tre categorie: convertitori a controllo di fase, cicloconvertitori, convertitori a matrice.
 Tra i vari tipi di convertitori monostadio, i convertitori c.a.-c.a. sono quelli che presentano il minore interesse applicativo, a causa delle notevoli limitazioni per quanto concerne sia la qualità della
Tra i vari tipi di convertitori monostadio, i convertitori c.a.-c.a. sono quelli che presentano il minore interesse applicativo, a causa delle notevoli limitazioni per quanto concerne sia la qualità della
DEFINIZIONE DI RADIANZA La radiazione è caratterizzata tramite la Radianza Spettrale, I (λ, θ, φ, T), definita come la densità di potenza per unità di
 SISTEMI PASSIVI Ogni corpo a temperatura T diversa da 0 K irradia spontaneamente potenza elettromagnetica distribuita su tutto lo spettro Attraverso un elemento da della superficie del corpo, fluisce p
SISTEMI PASSIVI Ogni corpo a temperatura T diversa da 0 K irradia spontaneamente potenza elettromagnetica distribuita su tutto lo spettro Attraverso un elemento da della superficie del corpo, fluisce p
Telescopi ed aberrazioni ottiche
 Centro Osservazione e Divulgazione Astronomica Siracusa Emanuele Schembri Telescopi ed aberrazioni ottiche Siracusa,, 30 aprile 2010 Definizione Le aberrazioni ottiche sono difetti apparenti del comportamento
Centro Osservazione e Divulgazione Astronomica Siracusa Emanuele Schembri Telescopi ed aberrazioni ottiche Siracusa,, 30 aprile 2010 Definizione Le aberrazioni ottiche sono difetti apparenti del comportamento
Esercizi di Ottica. Università di Cagliari Laurea Triennale in Biologia Corso di Fisica
 Università di Cagliari Laurea Triennale in Biologia Corso di Fisica Esercizi di Ottica 1. Un fascio di luce di lunghezza λ passa attraverso una fenditura rettangolare di larghezza a. La sua immagine viene
Università di Cagliari Laurea Triennale in Biologia Corso di Fisica Esercizi di Ottica 1. Un fascio di luce di lunghezza λ passa attraverso una fenditura rettangolare di larghezza a. La sua immagine viene
Modulazioni di ampiezza
 Modulazioni di ampiezza 1) Si consideri un segnale z(t) modulato in ampiezza con soppressione di portante dal segnale di informazione x(t): z(t) = Ax(t)cos(2πf 0 t) Il canale di comunicazione aggiunge
Modulazioni di ampiezza 1) Si consideri un segnale z(t) modulato in ampiezza con soppressione di portante dal segnale di informazione x(t): z(t) = Ax(t)cos(2πf 0 t) Il canale di comunicazione aggiunge
Officine Orbitali, primo livello di espansione civile nello spazio INAF-IRA, Bologna maggio 2018
 OFFICINE ORBITALI - Primo livello di espansione civile nello spazio" Ricerca della vita intelligente: pianeti extraterrestri e SETI STELIO MONTEBUGNOLI, IRA / INAF Tutti gli elementi che formarono l uomo
OFFICINE ORBITALI - Primo livello di espansione civile nello spazio" Ricerca della vita intelligente: pianeti extraterrestri e SETI STELIO MONTEBUGNOLI, IRA / INAF Tutti gli elementi che formarono l uomo
Profili di trasmissione dei filtri interferenziali del telescopio PSPT
 I.N.A.F Osservatorio Astronomico di Roma Profili di trasmissione dei filtri interferenziali del telescopio PSPT Mauro Centrone Fabrizio Giorgi Nota tecnica - 2003 1 Introduzione I filtri interferenziali
I.N.A.F Osservatorio Astronomico di Roma Profili di trasmissione dei filtri interferenziali del telescopio PSPT Mauro Centrone Fabrizio Giorgi Nota tecnica - 2003 1 Introduzione I filtri interferenziali
INTRODUZIONE ALLA FISICA PROF. FRANCESCO DE PALMA
 INTRODUZIONE ALLA FISICA PROF. FRANCESCO DE PALMA Sommario GRANDEZZE FISICHE... 3 UNITÀ DI MISURA... 3 PREFISSI... 5 ANALISI DIMENSIONALE... 5 CONVERSIONI DI UNITÀ... 6 SISTEMI DI COORDINATE... 7 I VETTORI...
INTRODUZIONE ALLA FISICA PROF. FRANCESCO DE PALMA Sommario GRANDEZZE FISICHE... 3 UNITÀ DI MISURA... 3 PREFISSI... 5 ANALISI DIMENSIONALE... 5 CONVERSIONI DI UNITÀ... 6 SISTEMI DI COORDINATE... 7 I VETTORI...
CAPITOLO 5. Spire frattali
 CPITOLO 5 Spire frattali Uno dei principali vantaggi della geometria frattale consiste nella possibilità di costruire strutture elettricamente lunghe in uno spazio limitato. In questo capitolo sarà descritto
CPITOLO 5 Spire frattali Uno dei principali vantaggi della geometria frattale consiste nella possibilità di costruire strutture elettricamente lunghe in uno spazio limitato. In questo capitolo sarà descritto
Guida alle esperienze di laboratorio
 LABORATORIO III Corso di Laurea in Fisica (Orientamento Generale) Guida alle esperienze di laboratorio Anno accademico 2008 09 (October 2, 2011) La descrizione di ogni esperienza è pensata come una scheda
LABORATORIO III Corso di Laurea in Fisica (Orientamento Generale) Guida alle esperienze di laboratorio Anno accademico 2008 09 (October 2, 2011) La descrizione di ogni esperienza è pensata come una scheda
MATERIALI PER LA DISCUSSIONE
 SETTORE TECNOLOGICO MATERIALI PER LA DISCUSSIONE ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ESITI DI APPRENDIMENTO Regolamento, Art. 5 comma 1 Nota: Le Competenze,
SETTORE TECNOLOGICO MATERIALI PER LA DISCUSSIONE ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ESITI DI APPRENDIMENTO Regolamento, Art. 5 comma 1 Nota: Le Competenze,
TEORIA E TECNICA RADAR CAPITOLO 1 SCOPO, EVOLUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL RADAR
 iii CAPITOLO 1 SCOPO, EVOLUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL RADAR 1.1 Tematiche affrontate: Rilevamento con sistemi attivi...1 1.2 Generalità sul radar e principio di funzionamento...3 1.3 Frequenze radar...5
iii CAPITOLO 1 SCOPO, EVOLUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL RADAR 1.1 Tematiche affrontate: Rilevamento con sistemi attivi...1 1.2 Generalità sul radar e principio di funzionamento...3 1.3 Frequenze radar...5
3 Rumore termico [PROAKIS, x6.5]
![3 Rumore termico [PROAKIS, x6.5] 3 Rumore termico [PROAKIS, x6.5]](/thumbs/74/70482050.jpg) 3 Rumore termico [PROAKIS, x6.5] Il rumore termico è una fonte di disturbo sempre presente qualità di trasmissione di un segnale attraverso dispositivi elettronici. La sua importanza è maggiore quanto
3 Rumore termico [PROAKIS, x6.5] Il rumore termico è una fonte di disturbo sempre presente qualità di trasmissione di un segnale attraverso dispositivi elettronici. La sua importanza è maggiore quanto
I raggi luminosi. Per secoli si sono contrapposti due modelli della luce. il modello ondulatorio (Christiaan Huygens)
 I raggi luminosi Per secoli si sono contrapposti due modelli della luce il modello corpuscolare (Newton) * la luce è un flusso di particelle microscopiche il modello ondulatorio (Christiaan Huygens) *
I raggi luminosi Per secoli si sono contrapposti due modelli della luce il modello corpuscolare (Newton) * la luce è un flusso di particelle microscopiche il modello ondulatorio (Christiaan Huygens) *
5 Lenti e Specchi. Formazione immagini Specchi Superfici rifrangenti Lenti sottili Lenti spessi Punti cardinali
 Laboratorio di didattica della Fisica (III modulo): Metodologie di insegnamento del Laboratorio di Ottica Formazione immagini Specchi Superfici rifrangenti Lenti sottili Lenti spessi Punti cardinali 5
Laboratorio di didattica della Fisica (III modulo): Metodologie di insegnamento del Laboratorio di Ottica Formazione immagini Specchi Superfici rifrangenti Lenti sottili Lenti spessi Punti cardinali 5
Ingegneria dei Sistemi Elettrici_6f
 Ingegneria dei Sistemi Elettrici_6f Guide d onda e cavità risonanti Sono state studiate le proprietà caratteristiche delle onde elettromagnetiche trasversali guidate da linee di trasmissione. Una delle
Ingegneria dei Sistemi Elettrici_6f Guide d onda e cavità risonanti Sono state studiate le proprietà caratteristiche delle onde elettromagnetiche trasversali guidate da linee di trasmissione. Una delle
Conversione analogico-digitale
 Corso di Laurea a Distanza in Ingegneria Elettrica Corso di Comunicazioni Elettriche Campionamento e quantizzazione A.A. 2004-05 Alberto Perotti DELEN-DAUIN Conversione analogico-digitale L elaborazione
Corso di Laurea a Distanza in Ingegneria Elettrica Corso di Comunicazioni Elettriche Campionamento e quantizzazione A.A. 2004-05 Alberto Perotti DELEN-DAUIN Conversione analogico-digitale L elaborazione
Filtri passivi Risposta in frequenza dei circuiti RC-RL-RLC
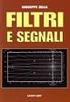 23. Guadagno di un quadripolo Filtri passivi isposta in frequenza dei circuiti C-L-LC In un quadripolo generico (fig. ) si definisce guadagno G il rapporto tra il valore d uscita e quello d ingresso della
23. Guadagno di un quadripolo Filtri passivi isposta in frequenza dei circuiti C-L-LC In un quadripolo generico (fig. ) si definisce guadagno G il rapporto tra il valore d uscita e quello d ingresso della
COMUNICAZIONI ELETTRICHE. Francesca VATTA
 COMUNICAZIONI ELETTRICHE Francesca VATTA Introduzione Nel corso di comunicazioni elettriche ci proponiamo di studiare i seguenti argomenti: 1. la trasmissione di un segnale da un punto a un altro dello
COMUNICAZIONI ELETTRICHE Francesca VATTA Introduzione Nel corso di comunicazioni elettriche ci proponiamo di studiare i seguenti argomenti: 1. la trasmissione di un segnale da un punto a un altro dello
Il blocco amplificatore realizza la funzione di elevare il livello (di tensione o corrente) del segnale (in tensione o corrente) in uscita da una
 l blocco amplificatore realizza la funzione di elevare il livello (di tensione o corrente) del segnale (in tensione o corrente) in uscita da una sorgente. Nel caso, come riportato in figura, il segnale
l blocco amplificatore realizza la funzione di elevare il livello (di tensione o corrente) del segnale (in tensione o corrente) in uscita da una sorgente. Nel caso, come riportato in figura, il segnale
INDICE OSCILLAZIONI CAPITOLO 1
 INDICE CAPITOLO 1 OSCILLAZIONI Compendio 1 1-1 Introduzione 2 1-2 Moti periodici e moti armonici 3 1-2-1 Moto oscillatorio armonico 4 1-3 Dinamica dell oscillatore armonico 6 1-3-1 Forze elastiche 7 1-3-2
INDICE CAPITOLO 1 OSCILLAZIONI Compendio 1 1-1 Introduzione 2 1-2 Moti periodici e moti armonici 3 1-2-1 Moto oscillatorio armonico 4 1-3 Dinamica dell oscillatore armonico 6 1-3-1 Forze elastiche 7 1-3-2
a.a. 2016/2017 Docente: Stefano Bifaretti
 a.a. 2016/2017 Docente: Stefano Bifaretti email: bifaretti@ing.uniroma2.it Gli schemi circuitali impiegati per la realizzazione dei convertitori statici sono molteplici. Infatti, la struttura del convertitore
a.a. 2016/2017 Docente: Stefano Bifaretti email: bifaretti@ing.uniroma2.it Gli schemi circuitali impiegati per la realizzazione dei convertitori statici sono molteplici. Infatti, la struttura del convertitore
Olimpiadi Italiane di Astronomia I TELESCOPI
 Olimpiadi Italiane di Astronomia Preparazione alla fase interregionale delle Olimpiadi Italiane di Astronomia I TELESCOPI By Giuseppe Cutispoto Telescopi Astronomici Lo studio dei corpi celesti è, in gran
Olimpiadi Italiane di Astronomia Preparazione alla fase interregionale delle Olimpiadi Italiane di Astronomia I TELESCOPI By Giuseppe Cutispoto Telescopi Astronomici Lo studio dei corpi celesti è, in gran
Componenti in corrente continua
 Ogni componente reale utilizzato in un circuito è la realizzazione approssimata di un elemento circuitale ideale. Nello studio dei sistemi in cc gli elementi più importanti sono : esistore Generatori campione
Ogni componente reale utilizzato in un circuito è la realizzazione approssimata di un elemento circuitale ideale. Nello studio dei sistemi in cc gli elementi più importanti sono : esistore Generatori campione
How to compute the sun vector for path planning
 How to compute the sun vector for path planning 1 Calcolo dell illuminazione delle celle solari Si consideri la Fig. 1. Il rover si sposta sulla mappa, variando nel tempo la sua posizione p = ( x y z )
How to compute the sun vector for path planning 1 Calcolo dell illuminazione delle celle solari Si consideri la Fig. 1. Il rover si sposta sulla mappa, variando nel tempo la sua posizione p = ( x y z )
MICHELSON. Interferometro. A.Guarrera, Liceo Galilei CT
 L INTERFEROMETRO DI MICHELSON 1 A.Guarrera, Liceo Galilei CT L interferometria è un metodo di misura molto preciso e molto sensibile che permette di determinare, ad esempio, variazioni di lunghezza, densità
L INTERFEROMETRO DI MICHELSON 1 A.Guarrera, Liceo Galilei CT L interferometria è un metodo di misura molto preciso e molto sensibile che permette di determinare, ad esempio, variazioni di lunghezza, densità
SEGNALE WIFI PRIETTATO A LUNGHE DISTANZE COSTRUIAMO L ANTENNA A BARATTOLO O CANTENNA
 SEGNALE WIFI PRIETTATO A LUNGHE DISTANZE COSTRUIAMO L ANTENNA A BARATTOLO O CANTENNA Opera a cura di Linus sotto Licenza - Introduzione La cosiddetta antenna a barattolo, nota anche come cantenna, è una
SEGNALE WIFI PRIETTATO A LUNGHE DISTANZE COSTRUIAMO L ANTENNA A BARATTOLO O CANTENNA Opera a cura di Linus sotto Licenza - Introduzione La cosiddetta antenna a barattolo, nota anche come cantenna, è una
Sistemi di Telecomunicazione
 Sistemi di Telecomunicazione Doppi bipoli rumorosi: esercizi ed esempi numerici Universita Politecnica delle Marche A.A. 2014-2015 A.A. 2014-2015 Sistemi di Telecomunicazione 1/15 Esempio 1 Il segnale
Sistemi di Telecomunicazione Doppi bipoli rumorosi: esercizi ed esempi numerici Universita Politecnica delle Marche A.A. 2014-2015 A.A. 2014-2015 Sistemi di Telecomunicazione 1/15 Esempio 1 Il segnale
Telescopi Astronomici
 Telescopi Astronomici Giuseppe Cutispoto INAF Osservatorio Astrofisico di Catania gcutispoto@oact.inaf.it Versione: 5 febbraio 2018 Lo studio dei corpi celesti è, in gran parte, basato sull analisi della
Telescopi Astronomici Giuseppe Cutispoto INAF Osservatorio Astrofisico di Catania gcutispoto@oact.inaf.it Versione: 5 febbraio 2018 Lo studio dei corpi celesti è, in gran parte, basato sull analisi della
DAC Digital Analogic Converter
 DAC Digital Analogic Converter Osserviamo lo schema elettrico riportato qui a lato, rappresenta un convertitore Digitale-Analogico a n Bit. Si osservino le resistenze che di volta in volta sono divise
DAC Digital Analogic Converter Osserviamo lo schema elettrico riportato qui a lato, rappresenta un convertitore Digitale-Analogico a n Bit. Si osservino le resistenze che di volta in volta sono divise
5 Misure del Canale Radio Indoor
 Parte V G. Reali: Misure del canale radio indoor. 5 Misure del Canale Radio Indoor 5.1 INTRODUZIONE Nel lavoro svolto l analisi delle prestazioni è stata effettuata utilizzando le risposte all impulso
Parte V G. Reali: Misure del canale radio indoor. 5 Misure del Canale Radio Indoor 5.1 INTRODUZIONE Nel lavoro svolto l analisi delle prestazioni è stata effettuata utilizzando le risposte all impulso
Laboratorio di Ottica, Spettroscopia, Astrofisica
 Università degli Studi di Palermo Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea in Fisica Progetto Lauree Scientifiche Laboratorio di Ottica, Spettroscopia, Astrofisica Antonio Maggio
Università degli Studi di Palermo Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea in Fisica Progetto Lauree Scientifiche Laboratorio di Ottica, Spettroscopia, Astrofisica Antonio Maggio
3. Le coordinate geografiche: latitudine e longitudine
 Introduzione 3. Le coordinate geografiche: latitudine e longitudine Ogni volta che vogliamo individuare un punto sulla superficie terrestre gli associamo due numeri, le coordinate geografiche: la latitudine
Introduzione 3. Le coordinate geografiche: latitudine e longitudine Ogni volta che vogliamo individuare un punto sulla superficie terrestre gli associamo due numeri, le coordinate geografiche: la latitudine
Filtro Passa Basso anti TVI per HF
 Angelo Protopapa - IK0VVG Filtro Passa Basso anti TVI per HF 1. Introduzione L idea di progettare e realizzare un filtro passa basso per applicazione TVI non rappresenta sicuramente il massimo dell originalità
Angelo Protopapa - IK0VVG Filtro Passa Basso anti TVI per HF 1. Introduzione L idea di progettare e realizzare un filtro passa basso per applicazione TVI non rappresenta sicuramente il massimo dell originalità
Magnitudini e Diagramma H-R Giuseppe Cutispoto
 Magnitudini e Diagramma H-R Giuseppe Cutispoto INAF Osservatorio Astrofisico di Catania gcutispoto@oact.inaf.it Versione: 4 febbraio 018 Magnitudine apparente La magnitudine apparente (m) di una stella
Magnitudini e Diagramma H-R Giuseppe Cutispoto INAF Osservatorio Astrofisico di Catania gcutispoto@oact.inaf.it Versione: 4 febbraio 018 Magnitudine apparente La magnitudine apparente (m) di una stella
Gli schemi circuitali impiegati per la realizzazione dei convertitori statici sono molteplici.
 Gli schemi circuitali impiegati per la realizzazione dei convertitori statici sono molteplici. Infatti, la struttura del convertitore risulta fortemente influenzata: dal tipo di sorgente primaria di alimentazione;
Gli schemi circuitali impiegati per la realizzazione dei convertitori statici sono molteplici. Infatti, la struttura del convertitore risulta fortemente influenzata: dal tipo di sorgente primaria di alimentazione;
Introduzione. Il rumore spesso e causato da sorgenti esterne al sistema elettronico che stiamo studiando:
 Introduzione Si definisce rumore, nel senso piu generale del termine, un qualsiasi disturbo che nasconde o interferisce con il segnale che stiamo misurando Il rumore spesso e causato da sorgenti esterne
Introduzione Si definisce rumore, nel senso piu generale del termine, un qualsiasi disturbo che nasconde o interferisce con il segnale che stiamo misurando Il rumore spesso e causato da sorgenti esterne
Ultra Wideband Systems
 Ultra Wideband Systems Definizione: si definisce Ultra Wideband (UWB) un sistema di radio comunicazione che abbia una banda assoluta (a -10 db) di almeno 500 MHz o, una banda relativa (*) a 0,25 Principio
Ultra Wideband Systems Definizione: si definisce Ultra Wideband (UWB) un sistema di radio comunicazione che abbia una banda assoluta (a -10 db) di almeno 500 MHz o, una banda relativa (*) a 0,25 Principio
6) Si considerino due polarizzatori ideali (il primo orientato in direzione verticale e il secondo in
 1) Un onda monocromatica polarizzata, con componenti del campo elettrico uguali a: E x = (1/2) 1/2 cos(kz - t) E y = (1/2) 1/2 sen(kz - t + /4), passa attraverso polarizzatori ideali, il primo orientato
1) Un onda monocromatica polarizzata, con componenti del campo elettrico uguali a: E x = (1/2) 1/2 cos(kz - t) E y = (1/2) 1/2 sen(kz - t + /4), passa attraverso polarizzatori ideali, il primo orientato
LARGE BINOCULAR TELESCOPE
 LARGE BINOCULAR TELESCOPE LBT: LARGE BINOCULAR TELESCOPE LBT, con i due specchi da 8.4 metri di diametro su un unica montatura meccanica, è il più grande telescopio esistente. La sua configurazione binoculare
LARGE BINOCULAR TELESCOPE LBT: LARGE BINOCULAR TELESCOPE LBT, con i due specchi da 8.4 metri di diametro su un unica montatura meccanica, è il più grande telescopio esistente. La sua configurazione binoculare
La corrente alternata
 La corrente alternata Corrente continua e corrente alternata Le correnti continue sono dovute ad un generatore i cui poli hanno sempre lo stesso segno e pertanto esse percorrono un circuito sempre nello
La corrente alternata Corrente continua e corrente alternata Le correnti continue sono dovute ad un generatore i cui poli hanno sempre lo stesso segno e pertanto esse percorrono un circuito sempre nello
Corso di Microonde Esercizi su Linee di Trasmissione
 Corso di Microonde Esercizi su Linee di Trasmissione Tema del 6.7.1999 Il carico resistivo R L è alimentato alla frequenza f =3GHz attraverso una linea principale di impedenza caratteristica Z 0 = 50 Ω
Corso di Microonde Esercizi su Linee di Trasmissione Tema del 6.7.1999 Il carico resistivo R L è alimentato alla frequenza f =3GHz attraverso una linea principale di impedenza caratteristica Z 0 = 50 Ω
PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE
 ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI" ALBA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CLASSE 4 H Disciplina: Telecomunicazioni Docenti:Linguanti Vincenzo Aizzi Marco PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE MODULI M 1 Trattamento
ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI" ALBA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CLASSE 4 H Disciplina: Telecomunicazioni Docenti:Linguanti Vincenzo Aizzi Marco PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE MODULI M 1 Trattamento
Scheda Tecnica e Progettazione di Gioacchino Minafò - IW9DQW. Tratto dal sito web
 Scheda Tecnica e Progettazione di Gioacchino Minafò - IW9DQW Il dispositivo che ha il compito di variare l intensità dei segnali all ingresso di un apparato radio o all uscita di un generatore di segnali
Scheda Tecnica e Progettazione di Gioacchino Minafò - IW9DQW Il dispositivo che ha il compito di variare l intensità dei segnali all ingresso di un apparato radio o all uscita di un generatore di segnali
3. (Da Veterinaria 2006) Perché esiste il fenomeno della dispersione della luce bianca quando questa attraversa un prisma di vetro?
 QUESITI 1 FENOMENI ONDULATORI 1. (Da Medicina 2008) Perché un raggio di luce proveniente dal Sole e fatto passare attraverso un prisma ne emerge mostrando tutti i colori dell'arcobaleno? a) Perché riceve
QUESITI 1 FENOMENI ONDULATORI 1. (Da Medicina 2008) Perché un raggio di luce proveniente dal Sole e fatto passare attraverso un prisma ne emerge mostrando tutti i colori dell'arcobaleno? a) Perché riceve
Campionamento e quantizzazione
 Corso di Laurea a Distanza in Ingegneria Elettrica Corso di Comunicazioni Elettriche Campionamento e quantizzazione A.A. 2008-09 Alberto Perotti DELEN-DAUIN Conversione analogico-digitale L elaborazione
Corso di Laurea a Distanza in Ingegneria Elettrica Corso di Comunicazioni Elettriche Campionamento e quantizzazione A.A. 2008-09 Alberto Perotti DELEN-DAUIN Conversione analogico-digitale L elaborazione
LE ANTENNE COME SORGENTI DI CAMPI ELETTROMAGNETICI AMBIENTALI
 Seminario tecnico di aggiornamento sulle procedure di valutazione dell impatto elettromagnetico degli impianti a radiofrequenza (telefonia mobile) LE ANTENNE COME SORGENTI DI CAMPI ELETTROMAGNETICI AMBIENTALI
Seminario tecnico di aggiornamento sulle procedure di valutazione dell impatto elettromagnetico degli impianti a radiofrequenza (telefonia mobile) LE ANTENNE COME SORGENTI DI CAMPI ELETTROMAGNETICI AMBIENTALI
Esame di FONDAMENTI DI AUTOMATICA (6 CFU) / CONTROLLI AUTOMATICI SOLUZIONE
 Esame di FONDAMENTI DI AUTOMATICA (6 CFU) / CONTROLLI AUTOMATICI Prova scritta 8 settembre 2017 SOLUZIONE ESERCIZIO 1. Si consideri il seguente circuito elettrico passivo: Applicando le leggi di Kirchhoff
Esame di FONDAMENTI DI AUTOMATICA (6 CFU) / CONTROLLI AUTOMATICI Prova scritta 8 settembre 2017 SOLUZIONE ESERCIZIO 1. Si consideri il seguente circuito elettrico passivo: Applicando le leggi di Kirchhoff
ANALISI E DESCRIZIONE DI UN CIRCUITO PER LA MODULAZIONE DIGITALE PSK
 CLASSE : V A E.T.A. 2008-2009 ALUNNO: Bovino Silvano ANALISI E DESCRIZIONE DI UN CIRCUITO PER LA MODULAZIONE DIGITALE PSK Le modulazioni digitali si definiscono tali poiché caratterizzate da segnale modulante
CLASSE : V A E.T.A. 2008-2009 ALUNNO: Bovino Silvano ANALISI E DESCRIZIONE DI UN CIRCUITO PER LA MODULAZIONE DIGITALE PSK Le modulazioni digitali si definiscono tali poiché caratterizzate da segnale modulante
Fisica II - CdL Chimica. Interferenza Coerenza Diffrazione Polarizzazione
 Interferenza Coerenza Diffrazione Polarizzazione Fenomeni interferenziali Interferenza: combinazione di onde identiche provenienti da diverse sorgenti che si sovrappongono in un punto dello spazio costruttiva
Interferenza Coerenza Diffrazione Polarizzazione Fenomeni interferenziali Interferenza: combinazione di onde identiche provenienti da diverse sorgenti che si sovrappongono in un punto dello spazio costruttiva
Fondazione onlus sservatorio stronomico di Tradate essier 13
 Fondazione onlus sservatorio stronomico di Tradate essier 13 Via ai Ronchi 21049 Tradate (VA) Cod. Fisc./P.I. 02880420126 Tel/fax: 0331 841900 Cell: 333-4585998 Email: foam13@foam13.it Internet: www.foam13.it
Fondazione onlus sservatorio stronomico di Tradate essier 13 Via ai Ronchi 21049 Tradate (VA) Cod. Fisc./P.I. 02880420126 Tel/fax: 0331 841900 Cell: 333-4585998 Email: foam13@foam13.it Internet: www.foam13.it
