Influenza sociale. Maggioranza, minoranza e autorità
|
|
|
- Modesto Poggi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Influenza sociale Maggioranza, minoranza e autorità
2 Alcune definizioni... Influenza sociale: processo in cui il destinatario (o bersaglio) modifica il proprio comportamento, le proprie idee o i propri sentimenti in conseguenza del comportamento delle idee o dei sentimenti espressi da altri (fonte o agente di influenza) (Mucchi Faina, 1996). Conformity Conformità: adattamento alla posizione della fonte. Conformismo: adeguamento passivo alle idee o opinioni degli altri. Norma sociale: è un modo largamente accettato di pensare, sentire e comportarsi, su cui gli appartenenti ad un gruppo concordano, considerandolo giusto ed appropriato (Smith & Mackie, 2004; vedi anche Thibaut & Kelley, 1959)
3 Valutare l efficacia dell influenza sociale: intensità e persistenza (Kelman, 1961; Kelman & Hamilton, 1989) Compiacenza: cambiamento temporaneo e solo apparente, dovuto alla capacità di controllo della fonte sul bersaglio. Identificazione: il bersaglio vuole instaurare una relazione soddisfacente con la fonte. La posizione della fonte è accettata sia in pubblico che in privato. L effetto dura finché il bersaglio è motivato a mantenere la relazione con la fonte. Interiorizzazione: effetto più profondo è duraturo. La fonte è ritenuta competente; le informazioni vengono integrate nel proprio sistema di valori e conoscenze. L effetto permane anche quando la fonte non è più presente.
4 Influenza sociale: accidentale vs. deliberata
5 L influenza accidentale Come nascono le norme sociali: l esperimento di Sherif (1936) L effetto autocinetico: Il partecipante è seduto in una stanza buia. Osserva un puntino luminoso che appare ad intervalli. Deve valutare l ampiezza del movimento. In realtà, il movimento è solo apparente.
6 Come nascono le norme sociali: l esperimento di Sherif (1936) Due fasi: I partecipanti sono esaminati individualmente. Nei giorni seguenti ripetono lo stesso compito in gruppi di tre persone. Risultati: Nella prima fase (ogni partecipante è solo nella stanza), i giudizi sono molto diversi; il range delle risposte va da 2 cm a circa 20 cm. Durante le sessioni di gruppo, i giudizi dei partecipanti tendono a convergere rapidamente: nasce una norma di gruppo.
7 Come nascono le norme sociali: l esperimento di Sherif (1936) Partecipante 1 Partecipante 2 Partecipante Sessione individuale Prima sessione di gruppo Seconda sessione di gruppo Terza sessione di gruppo L influenza della norma di gruppo dura nel tempo: dopo un anno, i partecipanti usano la stessa risposta, anche quando eseguono il compito individualmente (Rohrer et al., 1954; Stasson & Hawkes, 1995). In questo esperimento si osserva un influenza reciproca tra i partecipanti che, partendo da posizioni individuali diverse, creano una norma di gruppo comune.
8 L influenza accidentale: Facilitazione e inibizione sociale Nel 1898, Triplett osservò che i ciclisti correvano più velocemente in gruppo che da soli. Questo fenomeno è noto come facilitazione sociale: la mera presenza degli altri ci spinge a migliorare la nostra prestazione. In seguito, sono stati condotti numerosi studi con l obiettivo di confrontare la performance degli individui quando svolgono un compito da soli rispetto a quando svolgono lo stesso compito in gruppi. I risultati ottenuti erano misti: alcuni studi documentavano un miglioramento, altri un peggioramento della prestazione (inibizione sociale). Diverse spiegazioni sono state fornite per spiegare questi risultati contrastanti.
9 Facilitazione e inibizione sociale: la teoria dell impulso di Zajonc (1965) Zajonc sottolineò l importanza del tipo di compito. La mera presenza degli altri porta ad un miglioramento della prestazione in compiti semplici o ben appresi, ad un peggioramento in compiti complessi o percepiti come difficili. La presenza di altri, infatti, facilita l attivazione di risposte dominanti, ma inibisce le risposte nuove e/o complesse. Ma perché? La presenza di altri della stessa specie aumenta i livelli di arousal; si tratta di una risposta istintiva, innata, che aumenta la prontezza a rispondere a possibili azioni inaspettate degli altri. Questo determina un aumento delle risposte dominanti a scapito di quelle non dominanti. Zajonc ha dimostrato la sua tesi anche utilizzando scarafaggi come soggetti!
10 Facilitazione e inibizione sociale: l apprensione da valutazione (Cottrell, 1968) Secondo Cottrell, l aumento di arousal è appreso, non innato. Quando svolgiamo un compito alla presenza di altri, siamo consapevoli che la nostra prestazione sarà valutata. La consapevolezza di essere valutati è associata all anticipazione di risultati positivi o negativi. Aumenta, quindi, il livello di arousal, che determina l attivazione di risposte dominanti. Numerosi studi (condotti con esseri umani) hanno dimostrato che gli effetti di inibizione e facilitazione sociale sono ridotti quando le risposte possono essere fornite in privato o di fronte ad un pubblico che non giudica (ridotta salienza della valutazione)
11 Facilitazione e inibizione sociale: il conflitto di attenzione (Sanders, 1981) La presenza degli altri può produrre un conflitto tra prestare attenzione al compito e prestare attenzione agli altri. Il conflitto di attenzione aumenta l arousal, con la conseguente facilitazione delle risposte dominanti e inibizione delle risposte non dominanti. È necessario adottare un approccio integrativo per comprendere l effetto che la presenza di altre persone ha sulla performance
12 L influenza deliberata: l acquiescenza
13 L influenza deliberata: l acquiescenza L acquiescenza: il bersaglio acconsente ad una richiesta da parte della fonte, specificatamente nella forma di sottomissione. Ci sono tre principali tecniche per ottenere acquiescenza 1. Tecnica della porta in faccia: il richiedente inizia con una richiesta estrema che viene quasi sempre rifiutata (ad es., Mi presti 50 Euro?), per poi presentare la richiesta (più moderata) che aveva in mente dal principio (Mi presti 5 Euro?). Quando la fonte fa una concessione è normativo ricambiare, il bersaglio sente, cioè, di dover reciprocare. Motivazioni: desiderio di costruire e mantenere relazioni sociali, desiderio di vedersi come generosi.
14 L influenza deliberata: l acquiescenza 2. Tecnica del piede nella porta: il richiedente inizia con un piccolo favore, che viene quasi sempre concesso, per poi passare ad un favore più grande, collegato al primo. Motivazione: bisogno di coerenza 3. Tecnica del colpo basso: l acquiescenza viene ottenuta tenendo nascosti al bersaglio i reali costi della sua decisione; questi ultimi vengono svelati solo a posteriori, ma gli effetti dell acquiescenza permangono. La tecnica si basa sul principio secondo cui, una volta coinvolte in un corso di azione, le persone siano disponibili ad accettare un incremento dei costi dell azione stessa.
15 L influenza (deliberata) della maggioranza: l esperimento di Asch (1951) L esperimento di Sherif (effetto autocinetico) era caratterizzato da: Ambiguità Mancanza di strumenti Non esiste una sola risposta corretta Asch decide di verificare gli effetti di influenza del gruppo (la maggioranza) sul singolo individuo, in un contesto di giudizio oggettivo. Partecipanti: studenti universitari maschi Condizione sperimentale: in ogni sessione, 1 soggetto ingenuo e 8 collaboratori dello sperimentatore. Condizione di controllo: solo soggetti ingenui.
16 L influenza della maggioranza: l esperimento di Asch (1951) Giudizio percettivo: data una linea di riferimento e tre linee di confronto, si tratta di individuare quale linea di confronto ha la stessa lunghezza della linea di riferimento. La lunghezza delle linee varia tra 5 e 22 cm; la differenza tra la linea di riferimento e le linee di confronto sbagliate è in media di 2,5 cm. I partecipanti forniscono a turno la loro risposta: in ogni prova, il partecipante ingenuo è il penultimo a rispondere. I partecipanti effettuano 18 valutazioni. Nelle prime due prove, tutti danno la risposta corretta. Alla terza prova e in altre 11 prove critiche i collaboratori dello sperimentatore forniscono, in modo unanime e concorde, una risposta sbagliata. Nella condizione di controllo, i partecipanti eseguono lo stesso compito, ma non ci sono collaboratori dello sperimentatore. Es.: Linea di riferimento Linee di confronto a b c
17 L influenza della maggioranza: l esperimento di Asch (1951) Come si comportano i partecipanti veri? Nella condizione sperimentale 3 partecipanti su 4 (75%!) fornirono almeno1 risposta sbagliata. Il 50% dei partecipanti concordò con una risposta sbagliata in 6 o più prove. Complessivamente, circa un terzo delle risposte nelle prove cruciali (cioè, le prove in cui i collaboratori davano una risposta sbagliata), non si discostò dal giudizio erroneo della maggioranza. Nella condizione di controllo, in cui i partecipanti fornivano le loro risposte individualmente, il numero di errori era prossimo allo zero. I risultati sono sorprendenti, data la natura non ambigua del compito. L esperimento di Asch rappresenta una chiara dimostrazione del potere d influenza della maggioranza: i partecipanti si lasciano influenzare dal giudizio della maggioranza, nonostante tale giudizio sia contrario alla loro stessa percezione.
18 La maggioranza può produrre sia compiacenza che accettazione
19 Perché ci si conforma alle norme di gruppo? 1. Festinger (1950): costruzione sociale della realtà e obiettivi di gruppo. 2. Deutsch e Gerard (1955): influenza informativa vs. normativa. 3. Turner (1987): influenza informativa referente
20 Perché ci si conforma alle norme di gruppo? 1. Festinger (1950): la costruzione sociale della realta Nella nostra vita quotidiana, ci lasciamo guidare da un insieme di credenze personali: esse ci aiutano ad interpretare il mondo in cui viviamo e dirigono il nostro comportamento. Al fine di verificare la validità e la correttezza di tali credenze, e in assenza di informazioni oggettive, ci confrontiamo con gli altri: se gli altri sono d accordo con noi, possiamo dedurre che il nostro modo di vedere la realtà è corretto. Gli altri sono, in genere, membri dell ingroup. Viceversa, il disaccordo con gli altri produce incertezza e questa incertezza ci spinge a conformarci alla posizione del gruppo. Questo tipo di influenza è più probabile in situazioni nuove o ambigue (Brown, 2005)
21 Perché ci si conforma alle norme di gruppo? 1. Festinger (1950): gli obiettivi di gruppo Secondo Festinger, un altro fattore in grado di determinare l uniformità alle norme di gruppo è la presenza di obiettivi o scopi importanti. In questo caso, il consenso facilita la coordinazione degli sforzi individuali verso la meta comune.
22 Perche ci si conforma alle norme di gruppo? 2. Deutsch e Gerard (1955): influenza informativa vs. normativa. Influenza informativa: ci si conforma alla posizione degli altri perchè si crede che rifletta la realtà Festinger (1950). Influenza normativa: ci si conforma perché si desidera essere accettati dal gruppo, non considerati estranei o diversi; la norma del gruppo non è necessariamente ritenuta valida. È difficile spiegare il conformismo osservato nell esperimento di Asch come un effetto dell influenza informativa: il compito richiedeva un giudizio percettivo non ambiguo. I gruppi sperimentali non avevano un obiettivo comune. Inoltre, durante le interviste al termine della prova sperimentale, alcuni partecipanti dichiararono di essersi adeguati per non apparire ridicoli.
23 Perche ci si conforma alle norme di gruppo? 2. Deutsch e Gerard (1955): l esperimento. Viene usato lo stesso paradigma di Asch, con alcune modifiche. In ogni sessione: 1 soggetto ingenuo + 3 collaboratori dello sperimentatore. Stimoli presenti vs. assenti: il giudizio viene formulato mentre gli stimoli sono visibili o quando non sono più presenti (maggiore ambiguità) Faccia-a-faccia: i partecipanti sono visibili gli uni agli altri. Anonimato: i partecipanti sono anonimi, non si vedono gli uni con gli altri. Scopo di Gruppo: viene promessa una ricompensa ai gruppi con la migliore performance. Impegno: i partecipanti scrivono le proprie risposte prima di conoscere le risposte degli altri e prima di dire il loro giudizio ad alta voce; viene usato un foglio di carta che verrà gettato via (impegno privato A), una lavagnetta magica (impegno privato B), un foglio che viene firmato dal partecipante e consegnato allo sperimentatore (impegno pubblico).
24 Perche ci si conforma alle norme di gruppo? 2. Deutsch e Gerard (1955): l`esperimento. Numero medio di errori prodotti dall`influenza sociale nell`esperimento di Deutsch e Gerard
25 Perche ci si conforma alle norme di gruppo? 3. Turner (1987, 1991): influenza informativa referente. Secondo la teoria della categorizzazione di sé, quando le persone si identificano con un gruppo, adottano la posizione prototipica (normativa) del gruppo. Gli individui hanno bisogno di adottare posizioni che sono coerenti con la propria identità sociale; il disaccordo con altri categorizzati come simili a sé produce incertezza e spinge ad un influenza sociale reciproca. Questa posizione concilia l aspetto informativo e normativo dell influenza sociale
26 Minoranze e cambiamento sociale. Darwin e la teoria evoluzionistica L Impressionismo Secondo Moscovici le minoranze possono creare un conflitto nella posizione uniforme della maggioranza e introdurre così un innovazione. Tuttavia, il conflitto aumenta la tendenza al rifiuto della posizione minoritaria. Solo le minoranze coerenti possono produrre effetti di accettazione.
27 L influenza della minoranza: il paradigma blu/verde (Moscovici, Lage & Naffrechoux, 1969). Condizione sperimentale Minoranza coerente 4 soggetti ingenui + 2 collaboratori dello sperimentatore. L esperimento viene presentato come uno studio sulla percezione del colore: il compito dei partecipanti è quello di dire ad alta voce il colore di alcune diapositive e di valutarne l intensità luminosa (con una gradazione da 0 a 5). Materiale sperimentale: 6 diapositive blu di diversa intensità luminosa vengono presentate per 6 volte. Prima della prova critica viene somministrato un test di percezione visiva: le risposte dei collaboratori non possono essere attribuite a difetti o anomalie della capacità visiva. I partecipanti sono seduti in fila di fronte ad uno schermo e forniscono a turno la loro risposta: i 2 collaboratori rispondono verde in tutte le 36 prove. Condizione sperimentale: Minoranza non coerente La procedura è identica a quella della condizione minoranza coerente, ma i collaboratori non sono coerenti: in 24 prove rispondono verde e in 12 prove blu. Condizione di controllo (non ci sono collaboratori dello sperimentatore)
28 L influenza della minoranza: il paradigma blu/verde (Moscovici, Lage & Naffrechoux, 1969). Risultati. L 8.42% delle risposte dei partecipanti ingenui della condizione minoranza coerente è verde. Nel gruppo di controllo un solo partecipante dice verde 2 volte (0.25% del totale). Nella condizione in cui i collaboratori non sono coerenti, solo l 1.25% delle risposte è verde. Questi risultati dimostrano che una minoranza coerente è in grado di modificare le risposte dei membri della maggioranza.
29 L influenza della minoranza: il paradigma blu/verde (Moscovici, Lage & Naffrechoux, 1969). Secondo Moscovici, la posizione alternativa della minoranza crea incertezza e conflitto: il dubbio sollevato dalla minoranza apre un varco all interno dell uniformità di pensiero della maggioranza. Nel caso in cui la maggioranza non possa attribuire la diversità di posizione a particolari caratteristiche dei membri della minoranza (ad es., anomalie della percezione, diversità culturali, perseguimento di interessi particolari), essa è obbligata a valutare la validità della posizione minoritaria, al fine di accettarla o rifiutarla. Pertanto, è improbabile che un unico individuo dissidente o una minoranza categorizzata come outgroup siano in grado di esercitare la propria influenza sulla maggioranza. Una minoranza può influenzare una maggioranza solo se adotta uno stile di comportamento consistente; attraverso la tenacia e la persistenza la minoranza dimostra che la propria posizione non è casuale, ma ha lo stesso valore della posizione maggioritaria, e che non è disposta a cedere alle pressioni del gruppo.
30 L influenza della minoranza: alcune caratteristiche distintive. La minoranza deve Rappresentare un consenso alternativo Agire in modo coerente e persistere Essere categorizzata come parte dell ingroup.
31 L influenza della minoranza: alcune caratteristiche distintive. L influenza della minoranza produce effetti indiretti Moscovici e Personnaz (1980): le immagini consecutive Si riprende il paradigma sperimentale di Moscovici et al. (1969). Gli sperimentatori proiettano una serie di diapositive blu su uno schermo; i partecipanti eseguono due compiti: 1. valutano il colore della diapositiva e 2. valutano il colore dell immagine consecutiva. Cos è un immagine consecutiva? Se si fissa una figura colorata su sfondo bianco, quando la figura scompare o lo sguardo viene spostato su un altra superficie bianca, si vede apparire una figura che ha la stessa forma di quella precedente, ma colore complementare. Il colore complementare del blu è il giallo-arancio. Il colore complementare del verde è il rosso-porpora.
32
33
34 L influenza della minoranza: alcune caratteristiche distintive. L influenza della minoranza produce effetti indiretti Moscovici e Personnaz (1980): le immagini consecutive Metà dei partecipanti è esposto ad una fonte d influenza maggioritaria, l altra metà è esposta ad una fonte minoritaria. In ogni sessione ci sono un partecipante ingenuo e un collaboratore. L esperimento si articola in più fasi. Fase 1: I valutazione (base-line). I due partecipanti valutano per iscritto (in privato) il colore delle diapositive e delle rispettive immagini consecutive prima di essere esposti alla fonte di influenza. Fase 2: esposizione alla fonte. Dopo aver raccolto le risposte dei partecipanti, lo sperimentatore dice che il collaboratore ha sempre risposto verde e che la sua posizione è espressione di una posizione maggioritaria (81% della popolazione; condizione di influenza maggioritaria) o di una posizione minoritaria (19% della popolazione; condizione di influenza minoritaria). Fase 3: II valutazione. I partecipanti valutano le diapositive a voce alta: il collaboratore dice sempre verde. Fase 4: III valutazione. I partecipanti esprimono il loro giudizio in privato. Fase 5: IV valutazione. Il collaboratore con una scusa si allontana e i partecipanti forniscono il loro giudizio in assenza della fonte.
35 L influenza della minoranza: alcune caratteristiche distintive. L influenza della minoranza produce effetti indiretti Moscovici e Personnaz (1980): le immagini consecutive Ipotesi. Assumendo che la fonte minoritaria abbia un effetto indiretto sul bersaglio, i partecipanti esposti a tale fonte dovrebbero percepire l immagine consecutiva come rosso-porpora (colore complementare del verde); al contrario, i partecipanti esposti all influenza della maggioranza dovrebbero percepire l immagine consecutiva come giallo-arancio (colore complementare del blu). I risultati hanno confermato le ipotesi: per i partecipanti nella condizione di influenza minoritaria, la percezione dell immagine consecutiva era spostata verso il rosso-porpora. Lo spostamento, già significativo nella seconda e terza valutazione, è diventato più forte quando la fonte si assentava (IV valutazione).
36 L influenza della minoranza: alcune caratteristiche distintive. L effetto indiretto della fonte minoritaria è detto conversione (Moscovici 1980). Effetto trasposto (si manifesta su uno stimolo o problema diverso, ma collegato a quello su cui si è espressa la minoranza). Effetto ritardato. Si manifesta preferibilmente in privato (quando la fonte è assente e in condizioni di anonimato). Le minoranze suscitano attrazione (le persone autonome e anticonformiste sono oggetto di ammirazione) e diffidenza (gli individui non amano essere etichettati come diversi o devianti). Questo può indurre il bersaglio dell influenza minoritaria a mettere in atto strategie di occultamento, che causano gli effetti indiretti.
37 L influenza della minoranza: alcune caratteristiche distintive. L effetto di conversione può essere profondo, come dimostra l esperimento di Moscovici e Personnaz (1980), in cui si è trovato che la fonte minoritaria può influenzare il codice percettivo dei partecipanti. Secondo Moscovici, l influenza della maggioranza produce, invece, compiacenza (adesione pubblica alla posizione della maggioranza, non implica un cambiamento dell opinione o della percezione del bersaglio). Maggioranza e minoranza producono effetti diversi, poiché diversi sono i processi alla base. Processi diversi (Moscovici, 1976): maggioranza confronto vs. minoranza convalida
38 Influenza dell autorità e obbedienza Perché si obbedisce all autorità (Mucchi Faina, 1996)? 1. Desiderio di evitare punizioni. 2. Desiderio di ottenere ricompense. 3. Credenza che la fonte abbia il diritto morale di prescrivere un certo comportamento Tanto più l autorità è percepita come legittima, tanto maggiore sarà l obbedienza. Un certo grado di obbedienza è indispensabile per il funzionamento di ogni società: per questo motivo, l educazione all obbedienza inizia sin dalla nascita. L influenza dell autorità può produrre sia accettazione che compiacenza.
39 Crimini di obbedienza Abu Ghraib delitti che vengono commessi per obbedire all autorità. L olocausto
40 L obbedienza distruttiva: l esperimento di Milgram (1963). 40 Partecipanti: maschi, di diversa età e di diverso livello professionale, reclutati attraverso un annuncio. L esperimento era presentato come uno studio sulla memoria: si diceva che l obiettivo era di studiare l effetto delle punizioni sull apprendimento.
41 L obbedienza distruttiva: l esperimento di Milgram (1963). Ai partecipanti veniva assegnato il ruolo dell insegnante, mentre un collaboratore impersonava il ruolo dell allievo. L insegnante leggeva a voce alta delle coppie di parole, poi ripeteva la prima parola di ogni coppia insieme a quattro alternative di risposta; l allievo doveva indicare, premendo un interruttore, quale delle quattro alternative fosse originariamente associata alla prima parola.
42 L obbedienza distruttiva: l esperimento di Milgram (1963). L allievo sedeva su una finta sedia elettrica. Il ricercatore (l autorità) spiegava all insegnante che, ad ogni errore dell allievo, avrebbe dovuto infliggere una scossa elettrica di crescente intensità (le scosse erano simulate).
43 L obbedienza distruttiva: l esperimento di Milgram (1963). Quando l insegnante infliggeva la scossa da 300 volts, l allievo iniziava a battere contro il muro e smetteva di rispondere. Il ricercatore, sostenendo che si trattava di un errore, chiedeva di infliggere ulteriori scosse. Se l insegnante esitava, lo sperimentatore diventava progressivamente più autoritario La prego di continuare L esperimento richiede che lei continui È assolutamente necessario che lei continui Lei non ha altra scelta, deve continuare
44 L obbedienza distruttiva: l esperimento di Milgram (1963). Ben 26 partecipanti (65%) inflissero la scossa più grave (450 volts).
45 L obbedienza distruttiva: l esperimento di Milgram (1963). I partecipanti mostrarono, nel corso dell esperimento un notevole stato di agitazione/tensione. In effetti, questo esperimento ha suscitato notevoli critiche: non è etico sottoporre i partecipanti ad un simile stato di conflitto. Comunque, i risultati di Milgram hanno evidenziato l enorme impatto che l autorità può avere sul bersaglio dell influenza. I partecipanti presumibilmente persone normali erano state indotte da un ordine impartito dall autorità ad accanirsi con una vittima che si lamentava. I genocidi, i massacri, l accanimento contro vittime innocenti non sono necessariamente il frutto di sadismo e perversione individuale, ma possono essere anche il prodotto di un particolare contesto sociale.
46 Socializzazione di gruppo Relazione dinamica tra il gruppo e i suoi membri.
47 Il modello della socializzazione di gruppo di Levine e Moreland (1994) descrive il percorso temporale degli individui all interno dei gruppi. Il modello prevede tre processi: Valutazione Coinvolgimento Transizione di ruolo, attraverso tre ruoli principali: non membro, quasi-membro, membro a pieno titolo e si articola in 5 fasi: esplorazione, socializzazione, mantenimento, risocializzazione, ricordo.
48 Le transizioni di ruolo sono spesso accompagnate da riti di iniziazione Riti di iniziazione: procedure pubbliche che segnalano i trasferimenti dei membri del gruppo da un ruolo all altro. I riti di iniziazione dolorosi o imbarazzanti creano giudizi positivi sul gruppo e un maggior coinvolgimento da parte dei membri Dissonanza cognitiva
49 Il modello di Levine e Moreland
50 Struttura del gruppo Articolazione di un gruppo entro ruoli che si differenziano in base al prestigio (status).
51 Ruoli: modelli di comportamento che distinguono le differenti attività all interno del gruppo. Status: valutazione condivisa del prestigio di un ruolo o di chi occupa un ruolo in un gruppo; può anche essere una valutazione del prestigio di un gruppo in generale. Leader: membro del gruppo che occupa la posizione di status più elevata. I leader hanno potere e capacità di influenza di gran lunga superiori ai seguaci e ciò consente loro di stabilire le attività, definire l identità e mobilitare le persone al raggiungimento degli obiettivi comuni (Hogg, 2001). Leadership: processo di influenza sociale attraverso il quale un individuo ottiene e mobilita l aiuto degli altri nel raggiungimento di uno scopo collettivo (Chemers, 2001)
52 Identità sociale e leadership Hogg (2001) ha proposto un modello di leadership basato sulla teoria dell identità sociale. I gruppi forniscono alle persone un identità sociale. Quando l identità sociale è saliente, le persone fanno affidamento sulle norme di gruppo per guidare il proprio comportamento interiorizzazione del prototipo di gruppo. Il membro dell ingroup che meglio rappresenta gli attributi e le caratteristiche distintive dell ingroup, in contrasto con un outgroup rilevante, cioè il membro più prototipico del gruppo, è probabile che emerga come leader e che abbia la maggiore influenza all interno del gruppo. Più è saliente l appartenenza ad un gruppo, più è forte l identificazione, è più la prototipicità del leader rappresenta una caratteristica basilare della leadership efficace.
53 Identità sociale e leadership L esperimento di Hanis, Hogg e Duck (1997)
54 Devianza, esclusione e rifiuto Secondo il modello delle dinamiche soggettive di gruppo (Marquez et al., 2001), i membri marginali (devianti) sono considerati una minaccia al consenso normativo del gruppo e quindi all integrità del gruppo stesso. Un membro marginale è in genere disprezzato e può essere escluso dal gruppo. Ostracismo sociale: esclusione da un gruppo decisa di comune accordo. È un esperienza dolorosa e stressante, che provoca emozioni negative (specialmente tristezza e rabbia) e diminuisce l autostima, il controllo e la credenza che la propria esistenza abbia un significato. Williams ha studiato questo fenomeno utilizzando il paradigma del lancio della palla e cyberball, una sua evoluzione.
55 Domande guida Aleksei e Ivan lavorano per una grande multinazionale. Entrambi concordano sul fatto che molte condizioni del loro impiego sono oltre i limiti dello sfruttamento. Aleksei vorrebbe denunciare l azienda, ma Ivan esclama: Come possiamo sperare di vincere? Siamo solo due persone contro il sistema. Quali consigli dareste ai due dipendenti per incrementare le probabilità di successo? Una persona vi offre una somma di denaro per la vostra bici e voi pensate che sia adeguata e accettate di vendere la bici. Dopo aver controllato i suoi risparmi, il potenziale acquirente riduce la sua offerta del 15%, affermando di non poter andare oltre. Quale tecnica di influenza ha messo in atto? Attraverso quale principio opera? Durante il servizio militare al soldato Milkins viene chiesto di posizionare mine antiuomo in un area utilizzata da bambini piccoli come parco gioco. Nonostante l enorme angoscia che gli procura il pensiero di tale azione, egli constata che tutti gli uomini della sua unità stanno obbedendo all ordine. Come è probabile che si comporti il soldato? Quali pensieri e sentimenti accompagneranno le sue azioni?
Influenza sociale e processi di gruppo. Capitoli 10 e 11
 Influenza sociale e processi di gruppo Capitoli 10 e 11 Argomenti Norme sociali Conformismo Acquiescenza Facilitazione sociale Inibizione sociale Minoranze e cambiamento sociale L obbedienza all autorità
Influenza sociale e processi di gruppo Capitoli 10 e 11 Argomenti Norme sociali Conformismo Acquiescenza Facilitazione sociale Inibizione sociale Minoranze e cambiamento sociale L obbedienza all autorità
Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale a.a. 2011/2012 PSICOLOGIA SOCIALE E DI COMUNITÀ. Modulo di PSICOLOGIA SOCIALE E DEI GRUPPI
 Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale a.a. 2011/2012 PSICOLOGIA SOCIALE E DI COMUNITÀ Modulo di PSICOLOGIA SOCIALE E DEI GRUPPI L'influenza sociale Alessio Nencini alessio.nencini@univr.it 1
Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale a.a. 2011/2012 PSICOLOGIA SOCIALE E DI COMUNITÀ Modulo di PSICOLOGIA SOCIALE E DEI GRUPPI L'influenza sociale Alessio Nencini alessio.nencini@univr.it 1
L influenza sociale. Conformismo e forza della maggioranza
 Conformismo e forza della L influenza sociale Gli studi sul conformismo risalgono ai contributi di: Sherif (1935) Asch (1955) Sherif (1935): quali sono i meccanismi che in situazioni ambigue portano alla
Conformismo e forza della L influenza sociale Gli studi sul conformismo risalgono ai contributi di: Sherif (1935) Asch (1955) Sherif (1935): quali sono i meccanismi che in situazioni ambigue portano alla
La vocazione professionale e la carriera accademica. Report della prima fase di ricerca
 La vocazione professionale e la carriera accademica Report della prima fase di ricerca 1 Obiettivi dell indagine Il focus della nostra ricerca è la vocazione professionale: l esperienza di una passione
La vocazione professionale e la carriera accademica Report della prima fase di ricerca 1 Obiettivi dell indagine Il focus della nostra ricerca è la vocazione professionale: l esperienza di una passione
Per influenza sociale si intende un cambiamento che si verifica nei giudizi, nelle opinioni, e negli atteggiamenti di un individuo in seguito
 L'influenza sociale Per influenza sociale si intende un cambiamento che si verifica nei giudizi, nelle opinioni, e negli atteggiamenti di un individuo in seguito all'esposizione ai giudizi, alle opinioni
L'influenza sociale Per influenza sociale si intende un cambiamento che si verifica nei giudizi, nelle opinioni, e negli atteggiamenti di un individuo in seguito all'esposizione ai giudizi, alle opinioni
Psicologia Sociale (edizione 2010)
 Psicologia Sociale (edizione 2010) Prof. M. Ravenna - Università di Ferrara, a.a. 2012-13 Elliot Aronson Timothy D. Wilson Robin M. Akert Capitoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 - Scienze e tecnologie
Psicologia Sociale (edizione 2010) Prof. M. Ravenna - Università di Ferrara, a.a. 2012-13 Elliot Aronson Timothy D. Wilson Robin M. Akert Capitoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 - Scienze e tecnologie
La motivazione ad apprendere tra ricerca psicologica e senso comune
 La motivazione ad apprendere tra ricerca psicologica e senso comune Pietro Boscolo Università di Padova Conegliano, 12 febbraio 2009 Due definizioni di motivazione 1. processo dinamico mediante cui caratteristiche
La motivazione ad apprendere tra ricerca psicologica e senso comune Pietro Boscolo Università di Padova Conegliano, 12 febbraio 2009 Due definizioni di motivazione 1. processo dinamico mediante cui caratteristiche
Lezione 5 La cultura organizzativa (Cap. 6: pp , Decastri, 2016) Università degli Studi di Roma Tor Vergata a.a
 Lezione 5 La cultura organizzativa (Cap. 6: pp. 201-236, Decastri, 2016) Università degli Studi di Roma Tor Vergata a.a. 2015-2016 1 Contenuti 1. Premessa 2. La cultura organizzativa Il concetto e le definizioni
Lezione 5 La cultura organizzativa (Cap. 6: pp. 201-236, Decastri, 2016) Università degli Studi di Roma Tor Vergata a.a. 2015-2016 1 Contenuti 1. Premessa 2. La cultura organizzativa Il concetto e le definizioni
Indice: Strategie generali Strategie specifiche Ripetizione Metodi per aumentare la validità
 Controllo Indice: Strategie generali Strategie specifiche Ripetizione Metodi per aumentare la validità Definiremo il controllo come qualsiasi mezzo impiegato per eliminare le possibili minacce alla validità
Controllo Indice: Strategie generali Strategie specifiche Ripetizione Metodi per aumentare la validità Definiremo il controllo come qualsiasi mezzo impiegato per eliminare le possibili minacce alla validità
CAPITOLO CAPIT 0 Cultura organizzativa e valori ganizza etici
 CAPITOLO 10 Cultura organizzativa e valori etici Agenda Cultura organizzativa Cultura e progettazione Cultura e performance Valori etici nelle organizzazioni Responsabilità sociale d impresa Formare cultura
CAPITOLO 10 Cultura organizzativa e valori etici Agenda Cultura organizzativa Cultura e progettazione Cultura e performance Valori etici nelle organizzazioni Responsabilità sociale d impresa Formare cultura
LE BASI SOCIALI DEL COMPORTAMENTO
 LE BASI SOCIALI DEL COMPORTAMENTO L ORIGINE SITUAZIONALE DEL COMPORTAMENTO Situazionismo: tesi secondo cui Il comportamento umano dipende dalla situazione specifica in cui si svolge più che dall influenza
LE BASI SOCIALI DEL COMPORTAMENTO L ORIGINE SITUAZIONALE DEL COMPORTAMENTO Situazionismo: tesi secondo cui Il comportamento umano dipende dalla situazione specifica in cui si svolge più che dall influenza
Psicologia Sociale (edizione 2010)
 Psicologia Sociale (edizione 2010) Elliot Aronson Timothy D. Wilson Robin M. Akert Capitoli: 1, 2, 3, 4, 6, 7,10, 11 Prof. M. Ravennna - Università di Ferrara, a.a. 2011-12 Argomenti del corso 1. INTRODUZIONE
Psicologia Sociale (edizione 2010) Elliot Aronson Timothy D. Wilson Robin M. Akert Capitoli: 1, 2, 3, 4, 6, 7,10, 11 Prof. M. Ravennna - Università di Ferrara, a.a. 2011-12 Argomenti del corso 1. INTRODUZIONE
METODOLOGIA DELLA RICERCA IN PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO A.A APPUNTI DEL CORSO TENUTO DALLA Prof.Laura D Odorico N.3
 METODOLOGIA DELLA RICERCA IN PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO A.A. 2005-2006 APPUNTI DEL CORSO TENUTO DALLA Prof.Laura D Odorico N.3 Ricerche correlazionali In alcuni disegni di ricerca non c è una variabile
METODOLOGIA DELLA RICERCA IN PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO A.A. 2005-2006 APPUNTI DEL CORSO TENUTO DALLA Prof.Laura D Odorico N.3 Ricerche correlazionali In alcuni disegni di ricerca non c è una variabile
CAP. 8 PROCESSI DI GRUPPO
 CAP. 8 PROCESSI DI GRUPPO Il gruppo come esperienza umana fondamentale 1) CHE COSA E UN GRUPPO? Perché le persone si riuniscono in gruppi? I criteri che definiscono un gruppo La natura dei gruppi sociali:
CAP. 8 PROCESSI DI GRUPPO Il gruppo come esperienza umana fondamentale 1) CHE COSA E UN GRUPPO? Perché le persone si riuniscono in gruppi? I criteri che definiscono un gruppo La natura dei gruppi sociali:
LA GESTIONE PROFESSIONALE DELLE RELAZIONI DI RUOLO
 LA GESTIONE PROFESSIONALE DELLE RELAZIONI DI RUOLO Essere una squadra è prima di tutto un modo di pensare 1. Lo scenario Nell attuale situazione caratterizzata da una crescente complessità e discontinuità
LA GESTIONE PROFESSIONALE DELLE RELAZIONI DI RUOLO Essere una squadra è prima di tutto un modo di pensare 1. Lo scenario Nell attuale situazione caratterizzata da una crescente complessità e discontinuità
La categorizzazione sociale come chiave di volta del comportamento intergruppi
 Pensare i gruppi La categorizzazione sociale come chiave di volta del comportamento intergruppi lp5 Strumento per affrontare la realtà, semplificare e comprendere l ambiente Linguaggio e comunicazione
Pensare i gruppi La categorizzazione sociale come chiave di volta del comportamento intergruppi lp5 Strumento per affrontare la realtà, semplificare e comprendere l ambiente Linguaggio e comunicazione
I Questionari docenti, studenti, genitori
 I Questionari docenti, studenti, genitori 1 «Funzioni» dei questionari Esiti formativi, successo scolastico e indicazioni sulle possibili azioni di miglioramento PISTE INTERPRETATIVE Efficacia nella promozione
I Questionari docenti, studenti, genitori 1 «Funzioni» dei questionari Esiti formativi, successo scolastico e indicazioni sulle possibili azioni di miglioramento PISTE INTERPRETATIVE Efficacia nella promozione
La soddisfazione dei bisogni e la retribuzione
 La soddisfazione dei bisogni e la retribuzione La retribuzione è la forma di ricompensa a cui il lavoratore presta maggiore attenzione, ma non è certamente l'unica. Gratificazioni personali Autonomia Equità
La soddisfazione dei bisogni e la retribuzione La retribuzione è la forma di ricompensa a cui il lavoratore presta maggiore attenzione, ma non è certamente l'unica. Gratificazioni personali Autonomia Equità
Tecniche della comunicazione e relazione Dinamiche e tecniche di comunicazione
 Tecniche della comunicazione e relazione Dinamiche e tecniche di comunicazione La prima esperienza di relazione è quella che avviene tra il bambino e la madre (relazione diadica) Diade: entità composta
Tecniche della comunicazione e relazione Dinamiche e tecniche di comunicazione La prima esperienza di relazione è quella che avviene tra il bambino e la madre (relazione diadica) Diade: entità composta
L INTERAZIONE SOCIALE
 L INTERAZIONE SOCIALE L interazione tra individui è l oggetto della microsociologia, uno dei due livelli fondamentali dell analisi sociologica. Gli studiosi interessati a questa branca di analisi si occupano
L INTERAZIONE SOCIALE L interazione tra individui è l oggetto della microsociologia, uno dei due livelli fondamentali dell analisi sociologica. Gli studiosi interessati a questa branca di analisi si occupano
LE NORME SOCIALI. Cosa sono le norme sociali
 43 II LE NORME SOCIALI Rif: cap. 3 Speltini e Palmonari Cosa sono le norme sociali 44 Le nome costituiscono aspettative condivise rispetto al modo in cui dovrebbero comportarsi i membri del gruppo (Levine
43 II LE NORME SOCIALI Rif: cap. 3 Speltini e Palmonari Cosa sono le norme sociali 44 Le nome costituiscono aspettative condivise rispetto al modo in cui dovrebbero comportarsi i membri del gruppo (Levine
Un esempio. Ipotesi statistica: supposizione riguardante: un parametro della popolazione. la forma della distribuzione della popolazione
 La verifica delle ipotesi In molte circostanze il ricercatore si trova a dover decidere quale, tra le diverse situazioni possibili riferibili alla popolazione, è quella meglio sostenuta dalle evidenze
La verifica delle ipotesi In molte circostanze il ricercatore si trova a dover decidere quale, tra le diverse situazioni possibili riferibili alla popolazione, è quella meglio sostenuta dalle evidenze
Le ragioni dell apprendere
 Motivazione come variabile complessa 1 a Approccio comportamentista alla motivazione ed evoluzione 2 a La teoria degli obiettivi di riuscita 1 b Tre dimensioni nel concetto di motivazione ad apprendere
Motivazione come variabile complessa 1 a Approccio comportamentista alla motivazione ed evoluzione 2 a La teoria degli obiettivi di riuscita 1 b Tre dimensioni nel concetto di motivazione ad apprendere
per lo sviluppo di curricoli per competenze al triennio,
 Prima Bozza di lavoro creata da Silvia Faggioli IIs Aldini Valeriani Bologna per lo sviluppo di curricoli per competenze al triennio, asse scientifico tecnologico Asse scientifico tecnologico Triennio
Prima Bozza di lavoro creata da Silvia Faggioli IIs Aldini Valeriani Bologna per lo sviluppo di curricoli per competenze al triennio, asse scientifico tecnologico Asse scientifico tecnologico Triennio
Approccio cognitivista: Teoria dell equilibrio e dissonanza cognitiva
 Corso di Laurea in Scienze dell'educazione a.a. 2010/2011 PSICOLOGIA SOCIALE E DI COMUNITÀ Modulo di PSICOLOGIA SOCIALE E DEI GRUPPI Approccio cognitivista: Teoria dell equilibrio e dissonanza cognitiva
Corso di Laurea in Scienze dell'educazione a.a. 2010/2011 PSICOLOGIA SOCIALE E DI COMUNITÀ Modulo di PSICOLOGIA SOCIALE E DEI GRUPPI Approccio cognitivista: Teoria dell equilibrio e dissonanza cognitiva
Teorie sulla motivazione. Seminario sulle metodologie didattiche innovative Doretta Ardu Russell-Moro
 Teorie sulla motivazione Seminario sulle metodologie didattiche innovative Doretta Ardu Russell-Moro Il buon apprendente Le caratteristiche del buon apprendente (P.M. Lightbown, N. Spada, Howlanguagesare
Teorie sulla motivazione Seminario sulle metodologie didattiche innovative Doretta Ardu Russell-Moro Il buon apprendente Le caratteristiche del buon apprendente (P.M. Lightbown, N. Spada, Howlanguagesare
PSICOLOGIA SOCIALE E DI COMUNITA. Modulo di PSICOLOGIA SOCIALE E DEI GRUPPI IL PREGIUDIZIO. Lisa Pagotto
 PSICOLOGIA SOCIALE E DI COMUNITA Modulo di PSICOLOGIA SOCIALE E DEI GRUPPI IL PREGIUDIZIO Lisa Pagotto lisa.pagotto@unipd.it CHE COSA È IL PREGIUDIZIO? il pregiudizio è un antipatia fondata su una generalizzazione
PSICOLOGIA SOCIALE E DI COMUNITA Modulo di PSICOLOGIA SOCIALE E DEI GRUPPI IL PREGIUDIZIO Lisa Pagotto lisa.pagotto@unipd.it CHE COSA È IL PREGIUDIZIO? il pregiudizio è un antipatia fondata su una generalizzazione
Ravenna 2010 La comunicazione ambientale. La norma ISO 14063: Linee Guida per la Comunicazione Ambientale
 Ing. Alessandra Archetti CESQA Centro Studi Qualità Ambiente CURA Consorzio Universitario di Ricerca Applicata c/o Dipartimento di Processi Chimici dell Ingegneria Università di Padova tel +39 049 8275539/5536
Ing. Alessandra Archetti CESQA Centro Studi Qualità Ambiente CURA Consorzio Universitario di Ricerca Applicata c/o Dipartimento di Processi Chimici dell Ingegneria Università di Padova tel +39 049 8275539/5536
L influenza sociale. Federica Castellini Psicologia Sociale II AA 11 12
 L influenza sociale Coesione come esito dell influenza sociale Coesione non è né positiva né negativa Coesione non è sempre facilmente misurabile Coesione come attrazione interpersonale tra i membri di
L influenza sociale Coesione come esito dell influenza sociale Coesione non è né positiva né negativa Coesione non è sempre facilmente misurabile Coesione come attrazione interpersonale tra i membri di
Potere. Group dynamics Capitolo 8
 Potere Group dynamics Capitolo 8 L obbedienza distruttiva: l esperimento di Milgram (1963). 40 Partecipanti: maschi, di diversa età e di diverso livello professionale, reclutati attraverso un annuncio.
Potere Group dynamics Capitolo 8 L obbedienza distruttiva: l esperimento di Milgram (1963). 40 Partecipanti: maschi, di diversa età e di diverso livello professionale, reclutati attraverso un annuncio.
TOSSICODIPENDENZA ED ESCLUSIONE SOCIALE: GLI EFFETTI A LUNGO TERMINE DELLE SOSTANZE PSICOATTIVE SULLA PERCEZIONE DI OSTRACISMO
 TOSSICODIPENDENZA ED ESCLUSIONE SOCIALE: GLI EFFETTI A LUNGO TERMINE DELLE SOSTANZE PSICOATTIVE SULLA PERCEZIONE DI OSTRACISMO Tesi di Laurea di: VAILATI CANTA Debora BACKGROUND TEORICO DEFINIZIONE DI
TOSSICODIPENDENZA ED ESCLUSIONE SOCIALE: GLI EFFETTI A LUNGO TERMINE DELLE SOSTANZE PSICOATTIVE SULLA PERCEZIONE DI OSTRACISMO Tesi di Laurea di: VAILATI CANTA Debora BACKGROUND TEORICO DEFINIZIONE DI
7 Disegni sperimentali ad un solo fattore. Giulio Vidotto Raffaele Cioffi
 7 Disegni sperimentali ad un solo fattore Giulio Vidotto Raffaele Cioffi Indice: 7.1 Veri esperimenti 7.2 Fattori livelli condizioni e trattamenti 7.3 Alcuni disegni sperimentali da evitare 7.4 Elementi
7 Disegni sperimentali ad un solo fattore Giulio Vidotto Raffaele Cioffi Indice: 7.1 Veri esperimenti 7.2 Fattori livelli condizioni e trattamenti 7.3 Alcuni disegni sperimentali da evitare 7.4 Elementi
Cap. 7 Il conformismo
 Cap. 7 Il conformismo Nel capitolo precedente abbiamo considerato i processi attraverso i quali si possono modificare gli atteggiamenti delle persone (tramite comunicazione persuasiva) Abbiamo considerato
Cap. 7 Il conformismo Nel capitolo precedente abbiamo considerato i processi attraverso i quali si possono modificare gli atteggiamenti delle persone (tramite comunicazione persuasiva) Abbiamo considerato
EVENTI FUTURI EQUIPROBABILI Lezione n. 3
 EVENTI FUTURI EQUIPROBABILI Lezione n. 3 Finalità: Enunciare le definizioni maturate attraverso l esercitazione pratica. Verificare la corrispondenza tra ipotesi formulate e risultati sperimentali. Metodo:
EVENTI FUTURI EQUIPROBABILI Lezione n. 3 Finalità: Enunciare le definizioni maturate attraverso l esercitazione pratica. Verificare la corrispondenza tra ipotesi formulate e risultati sperimentali. Metodo:
Bagnasco, Barbagli, Cavalli, Corso di sociologia, Il Mulino, 2007 Capitolo VI. Identità e socializzazione. Identità e socializzazione
 Identità e socializzazione 1 Ogni società deve assicurare la propria continuità nel tempo. È necessario, quindi, che essa disponga di pratiche e istituzioni, atte a trasmettere almeno una parte del patrimonio
Identità e socializzazione 1 Ogni società deve assicurare la propria continuità nel tempo. È necessario, quindi, che essa disponga di pratiche e istituzioni, atte a trasmettere almeno una parte del patrimonio
Information summary: L intelligenza emotiva
 Information summary: L intelligenza emotiva - Copia ad esclusivo uso personale dell acquirente - Olympos Group srl Vietata ogni riproduzione, distribuzione e/o diffusione sia totale che parziale in qualsiasi
Information summary: L intelligenza emotiva - Copia ad esclusivo uso personale dell acquirente - Olympos Group srl Vietata ogni riproduzione, distribuzione e/o diffusione sia totale che parziale in qualsiasi
LA TEORIA DELLA CATEGORIZZAZIONE DI SÉ
 LA TEORIA DELLA CATEGORIZZAZIONE DI SÉ 1 Origini e sviluppo La Teoria della Categorizzazione di Sé (Self-Categorization Theory, SCT, Turner et al., 1987) nasce con l obiettivo di comprendere, spiegare
LA TEORIA DELLA CATEGORIZZAZIONE DI SÉ 1 Origini e sviluppo La Teoria della Categorizzazione di Sé (Self-Categorization Theory, SCT, Turner et al., 1987) nasce con l obiettivo di comprendere, spiegare
COMUNE DI ERBUSCO Area servizi alla Persona
 COMUNE DI ERBUSCO Area servizi alla Persona IL TAVOLO DI COMUNITA 2013-2014 LA CARTA EDUCATIVA DI ERBUSCO 2 QUADRIMESTRE ANNO SCOLASTICO 2012-2013 Il 26 Novembre 2012, presso il teatro comunale, era stata
COMUNE DI ERBUSCO Area servizi alla Persona IL TAVOLO DI COMUNITA 2013-2014 LA CARTA EDUCATIVA DI ERBUSCO 2 QUADRIMESTRE ANNO SCOLASTICO 2012-2013 Il 26 Novembre 2012, presso il teatro comunale, era stata
MOTIVAZIONE, AUTOSTIMA E CAPACITA DI SCELTA NELLE PERSONE ADULTE CON DISABILITA' COGNITIVA. Dott.ssa Stefania Mazotti
 MOTIVAZIONE, AUTOSTIMA E CAPACITA DI SCELTA NELLE PERSONE ADULTE CON DISABILITA' COGNITIVA Dott.ssa Stefania Mazotti Chi, tra gli ospiti, sa scegliere in queste situazioni? Scegliere un paio di scarpe
MOTIVAZIONE, AUTOSTIMA E CAPACITA DI SCELTA NELLE PERSONE ADULTE CON DISABILITA' COGNITIVA Dott.ssa Stefania Mazotti Chi, tra gli ospiti, sa scegliere in queste situazioni? Scegliere un paio di scarpe
RISULTATI PROVE INValSI a.s I.C. Civezzano
 RISULTATI PROVE INValSI a.s. 2011-2012 I.C. Civezzano Alcune premesse a) genesi delle prove La legislazione vigente attribuisce all INVALSI la competenza amministrativa a effettuare verifiche periodiche
RISULTATI PROVE INValSI a.s. 2011-2012 I.C. Civezzano Alcune premesse a) genesi delle prove La legislazione vigente attribuisce all INVALSI la competenza amministrativa a effettuare verifiche periodiche
Innovazione e Direzione delle Imprese AA ORGANIZZARE I PROCESSI DI INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CREATIVA
 Innovazione e Direzione delle Imprese AA. 2014-2015 ORGANIZZARE I PROCESSI DI INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CREATIVA Componential theory of Organizational Creativity (1) CONTESTO DI LAVORO Motivazione
Innovazione e Direzione delle Imprese AA. 2014-2015 ORGANIZZARE I PROCESSI DI INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CREATIVA Componential theory of Organizational Creativity (1) CONTESTO DI LAVORO Motivazione
COMUNICAZIONE D IMPRESA
 COMUNICAZIONE D IMPRESA - La Comunicazione d Impresa - Overview ALESSANDRA POGGIANI - COMUNICAZIONE D IMPRESA LA COMUNICAZIONE D'IMPRESA La comunicazione d impresa consiste principalmente in un attività
COMUNICAZIONE D IMPRESA - La Comunicazione d Impresa - Overview ALESSANDRA POGGIANI - COMUNICAZIONE D IMPRESA LA COMUNICAZIONE D'IMPRESA La comunicazione d impresa consiste principalmente in un attività
Statistica inferenziale. La statistica inferenziale consente di verificare le ipotesi sulla popolazione a partire dai dati osservati sul campione.
 Statistica inferenziale La statistica inferenziale consente di verificare le ipotesi sulla popolazione a partire dai dati osservati sul campione. Verifica delle ipotesi sulla medie Quando si conduce una
Statistica inferenziale La statistica inferenziale consente di verificare le ipotesi sulla popolazione a partire dai dati osservati sul campione. Verifica delle ipotesi sulla medie Quando si conduce una
PROGETTO: I COLORI DELLE EMOZIONI
 PROGETTO: I COLORI DELLE EMOZIONI L apprendimento nella scuola dell infanzia deve essere attivo, costruttivo e cooperativo e deve stimolare nei bambini la voglia di conoscere. Dai tre ai sei anni, infatti,
PROGETTO: I COLORI DELLE EMOZIONI L apprendimento nella scuola dell infanzia deve essere attivo, costruttivo e cooperativo e deve stimolare nei bambini la voglia di conoscere. Dai tre ai sei anni, infatti,
Intelligenza Emotiva e Leadership Efficace. Performance Technology Solutions 2014 Tutti i diritti riservati 1
 Intelligenza Emotiva e Leadership Efficace Performance Technology Solutions 2014 Tutti i diritti riservati 1 Evoluzione del concetto di Intelligenza Emotiva (IE) Gardner (1983) è stato il primo ad introdurre
Intelligenza Emotiva e Leadership Efficace Performance Technology Solutions 2014 Tutti i diritti riservati 1 Evoluzione del concetto di Intelligenza Emotiva (IE) Gardner (1983) è stato il primo ad introdurre
Ben-essere a scuola: l insegnante come base sicura. Rosalinda Cassibba Università degli Studi di Bari
 Ben-essere a scuola: l insegnante come base sicura Rosalinda Cassibba Università degli Studi di Bari Teoria dell attaccamento Legame emotivo con adulti significativi Radice di uno sviluppo psicologico
Ben-essere a scuola: l insegnante come base sicura Rosalinda Cassibba Università degli Studi di Bari Teoria dell attaccamento Legame emotivo con adulti significativi Radice di uno sviluppo psicologico
PSICOLOGIA DI GRUPPO (a cura della Dr.ssa Catia Terra)
 C E F O PSICOLOGIA DI GRUPPO (a cura della Dr.ssa Catia Terra) Una Comunità è un insieme di individui che condividono lo stesso ambiente fisico formando un GRUPPO riconoscibile, unito da vincoli organizzativi,
C E F O PSICOLOGIA DI GRUPPO (a cura della Dr.ssa Catia Terra) Una Comunità è un insieme di individui che condividono lo stesso ambiente fisico formando un GRUPPO riconoscibile, unito da vincoli organizzativi,
LA RICERCA SPERIMENTALE
 INSEGNAMENTO DI PEDAGOGIA SPERIMENTALE LEZIONE VI LA RICERCA SPERIMENTALE PROF. LUCIANO GALLIANI Indice 1 Le finalità della ricerca sperimentale...3 2 Le variabili e le loro relazioni...4 3 Il piano sperimentale
INSEGNAMENTO DI PEDAGOGIA SPERIMENTALE LEZIONE VI LA RICERCA SPERIMENTALE PROF. LUCIANO GALLIANI Indice 1 Le finalità della ricerca sperimentale...3 2 Le variabili e le loro relazioni...4 3 Il piano sperimentale
IL RUOLO DELLA CULTURA
 IL RUOLO DELLA CULTURA La frequenza e l intensitàdelle condotte aggressive varia, sia entro una stessa cultura, sia fra le diverse culture in rapporto a specifici eventi e cambiamenti sociali La cultura
IL RUOLO DELLA CULTURA La frequenza e l intensitàdelle condotte aggressive varia, sia entro una stessa cultura, sia fra le diverse culture in rapporto a specifici eventi e cambiamenti sociali La cultura
Gestione classe. Maurizio Gentile. Studio di Psicologia Formazione Anno scolastico Classe e competenze
 SPF SPF Gestione classe Maurizio Gentile Studio di Psicologia Formazione www.successoformativo.it www.lumsa.it Anno scolastico Classe e competenze 2 SPF Incontro del 10/04 1. Introduzione 2. Pensa condividi
SPF SPF Gestione classe Maurizio Gentile Studio di Psicologia Formazione www.successoformativo.it www.lumsa.it Anno scolastico Classe e competenze 2 SPF Incontro del 10/04 1. Introduzione 2. Pensa condividi
BISOGNI E PULSIONI (1 di 2)
 ISTINTI (2 di 3) Il primo a parlare di istinto fu James (1890) che lo considerava come la facoltà di agire in modo da produrre certi effetti finali senza aver preveduto e senza previa educazione ad agire
ISTINTI (2 di 3) Il primo a parlare di istinto fu James (1890) che lo considerava come la facoltà di agire in modo da produrre certi effetti finali senza aver preveduto e senza previa educazione ad agire
Lezione 9 22 marzo 2010
 Lezione 9 22 marzo 2010 Prossime lezioni Venerdì 26 marzo Lunedì 12 aprile Concetti visti Consumer behavior Stimolo, risposta Processo decisionale di acquisto Fasi Criteri Consideration set o evoked set
Lezione 9 22 marzo 2010 Prossime lezioni Venerdì 26 marzo Lunedì 12 aprile Concetti visti Consumer behavior Stimolo, risposta Processo decisionale di acquisto Fasi Criteri Consideration set o evoked set
Alofosfati. La prima tecnologia applicata che genera un colore primario ed un colore lampade fluorescenti alofosfati
 Perché questa guida? Tra le moderne sorgenti luminose, le lampade fluorescenti lineari, comunemente chiamate neon, sono quelle di gran lunga più impiegate per l illuminazione professionale di interni in
Perché questa guida? Tra le moderne sorgenti luminose, le lampade fluorescenti lineari, comunemente chiamate neon, sono quelle di gran lunga più impiegate per l illuminazione professionale di interni in
Guida alla lettura L editore ringrazia Prefazione all edizione italiana
 indice Guida alla lettura L editore ringrazia Prefazione all edizione italiana XIV XVI XVII Prefazione alla seconda edizione 3 Prefazione alla prima edizione 5 Ringraziamenti dell editore 7 Capitolo 1
indice Guida alla lettura L editore ringrazia Prefazione all edizione italiana XIV XVI XVII Prefazione alla seconda edizione 3 Prefazione alla prima edizione 5 Ringraziamenti dell editore 7 Capitolo 1
Emozioni e stati d animo
 Emozioni e stati d animo Alcune definizioni Affetto: ampia gamma di sentimenti che le persone provano Emozioni: intensi sentimenti rivolti a qualcuno o a qualcosa Stati d animo: sentimenti meno intensi
Emozioni e stati d animo Alcune definizioni Affetto: ampia gamma di sentimenti che le persone provano Emozioni: intensi sentimenti rivolti a qualcuno o a qualcosa Stati d animo: sentimenti meno intensi
Teoria dei pubblici Comunicazione ed effetti sull audience. Par. I Il pubblico dei media
 Teoria dei pubblici Comunicazione ed effetti sull audience Par. I Il pubblico dei media Teoria dei pubblici Comunicazione ed effetti sull audience Il pubblico dei media 25/10/2004 Il pubblico dei media
Teoria dei pubblici Comunicazione ed effetti sull audience Par. I Il pubblico dei media Teoria dei pubblici Comunicazione ed effetti sull audience Il pubblico dei media 25/10/2004 Il pubblico dei media
Perché andare dallo psicologo?
 Perché andare dallo psicologo? Idee e false credenze: Dal passato.. - Freud e il lettino: in base all'approccio teorico utilizzato ci possono essere diversi modi di entrare in relazione con l altra persona.
Perché andare dallo psicologo? Idee e false credenze: Dal passato.. - Freud e il lettino: in base all'approccio teorico utilizzato ci possono essere diversi modi di entrare in relazione con l altra persona.
LIM, didattica, gestione della classe e risultati di apprendimento: attività di ricerca nella scuola trentina
 LIM, didattica, gestione della classe e risultati di apprendimento: attività di ricerca nella scuola trentina Francesco Pisanu, IPRASE Trentino Maurizio Gentile, IUSVE Venezia 1. Ambienti di apprendimento
LIM, didattica, gestione della classe e risultati di apprendimento: attività di ricerca nella scuola trentina Francesco Pisanu, IPRASE Trentino Maurizio Gentile, IUSVE Venezia 1. Ambienti di apprendimento
ISTRUZIONI: seleziona il testo sopra riportato, copialo ed incollalo nella tab. incolla e poi descrivi le operazioni che hai compiuto
 page 1 of 5 Nome: Classe: Data: Intelligenza emotiva Il concetto ha conquistato l'interesse del pubblico solo di recente, grazie ai best-seller di Daniel Goleman "Intelligenza emotiva" (Rizzoli 1997) e
page 1 of 5 Nome: Classe: Data: Intelligenza emotiva Il concetto ha conquistato l'interesse del pubblico solo di recente, grazie ai best-seller di Daniel Goleman "Intelligenza emotiva" (Rizzoli 1997) e
Consulenza finanziaria e circuito della fiducia Caterina Cruciani e Ugo Rigoni
 Consulenza finanziaria e circuito della fiducia Caterina Cruciani e Ugo Rigoni Perché parlare di fiducia I recenti scandali finanziari che hanno caratterizzato il sistema bancario rischiano di minare la
Consulenza finanziaria e circuito della fiducia Caterina Cruciani e Ugo Rigoni Perché parlare di fiducia I recenti scandali finanziari che hanno caratterizzato il sistema bancario rischiano di minare la
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE I PROTAGONISTI NELLA VITA DELL IMPRESA PROF.SSA MIRELLA MIGLIACCIO
 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE I PROTAGONISTI NELLA VITA DELL IMPRESA PROF.SSA MIRELLA MIGLIACCIO Struttura della lezione - I protagonisti dell impresa e le scelte di governo - Gli organi di governo
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE I PROTAGONISTI NELLA VITA DELL IMPRESA PROF.SSA MIRELLA MIGLIACCIO Struttura della lezione - I protagonisti dell impresa e le scelte di governo - Gli organi di governo
Insegnamento di Psicologia sociale dei gruppi
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA KORE Insegnamento di Psicologia sociale dei gruppi Prof.ssa Irene Petruccelli e dott.ssa Angela Miccichè irene.petruccelli@unikore.it Seconda lezione Enna, 2 MARZO 2016 A.A.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA KORE Insegnamento di Psicologia sociale dei gruppi Prof.ssa Irene Petruccelli e dott.ssa Angela Miccichè irene.petruccelli@unikore.it Seconda lezione Enna, 2 MARZO 2016 A.A.
PERCORSI PER LO SVILUPPO
 Bologna. 02.03.2015 PERCORSI PER LO SVILUPPO Proposte Formative Generative Galleria del Toro, 3 Bologna 40121 www.quaero.it info@quaero.it P.IVA 04331540379 Premessa Metodologica La metodologia di lavoro
Bologna. 02.03.2015 PERCORSI PER LO SVILUPPO Proposte Formative Generative Galleria del Toro, 3 Bologna 40121 www.quaero.it info@quaero.it P.IVA 04331540379 Premessa Metodologica La metodologia di lavoro
CORSO DI INFOGRAFICA PROF. MANUELA PISCITELLI A.A.
 5. Il colore Il presente file costituisce una SINTESI del materiale presentato nel corso delle lezioni. Tale sintesi non deve essere ritenuta esaustiva dell argomento, ma andrà integrata dallo studente
5. Il colore Il presente file costituisce una SINTESI del materiale presentato nel corso delle lezioni. Tale sintesi non deve essere ritenuta esaustiva dell argomento, ma andrà integrata dallo studente
Processi elementari nei gruppi
 Processi elementari nei gruppi Temi: Entrare in un gruppo L interdipendenza all interno dei gruppi Esecuzione del compito e mantenimento delle relazioni La coesione Le regole A qualunque età entrare in
Processi elementari nei gruppi Temi: Entrare in un gruppo L interdipendenza all interno dei gruppi Esecuzione del compito e mantenimento delle relazioni La coesione Le regole A qualunque età entrare in
PROVE SCRITTE DI MATEMATICA APPLICATA, ANNO 2006/07
 PROVE SCRITTE DI MATEMATICA APPLICATA, ANNO 006/07 Esercizio 1 Prova scritta del 16/1/006 In un ufficio postale lavorano due impiegati che svolgono lo stesso compito in maniera indipendente, sbrigando
PROVE SCRITTE DI MATEMATICA APPLICATA, ANNO 006/07 Esercizio 1 Prova scritta del 16/1/006 In un ufficio postale lavorano due impiegati che svolgono lo stesso compito in maniera indipendente, sbrigando
LE MOTIVAZIONI ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA
 LE MOTIVAZIONI ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA 1. PREMESSA I comportamenti umani sono sostenuti da complessi processi motivazionali spesso difficilmente comprensibili dall esterno. La loro interpretazione
LE MOTIVAZIONI ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA 1. PREMESSA I comportamenti umani sono sostenuti da complessi processi motivazionali spesso difficilmente comprensibili dall esterno. La loro interpretazione
i dati escludono vi sia una relazione tra variabile indipendente e variabile dipendente (rispettivamente
 TEST DI AUTOVALUTAZIONE - SETTIMANA 6 I diritti d autore sono riservati. Ogni sfruttamento commerciale non autorizzato sarà perseguito. Metodi statistici per la biologia Parte A. La retta di regressione.2
TEST DI AUTOVALUTAZIONE - SETTIMANA 6 I diritti d autore sono riservati. Ogni sfruttamento commerciale non autorizzato sarà perseguito. Metodi statistici per la biologia Parte A. La retta di regressione.2
Capitolo 15. La pubblicità e le pubbliche relazioni. Capitolo 15 - slide 1
 Capitolo 15 La pubblicità e le pubbliche relazioni Capitolo 15 - slide 1 La pubblicità e le pubbliche relazioni Obiettivi di apprendimento Il ruolo della pubblicità nel mix promozionale Le principali decisioni
Capitolo 15 La pubblicità e le pubbliche relazioni Capitolo 15 - slide 1 La pubblicità e le pubbliche relazioni Obiettivi di apprendimento Il ruolo della pubblicità nel mix promozionale Le principali decisioni
IL MODELLO CAF GENERALITA E STRUTTURA
 1 IL MODELLO CAF GENERALITA E STRUTTURA Il Modello CAF - Struttura 2 2 Il Modello CAF Lo sviluppo negli elementi di dettaglio 3 Le nove caselle rappresentano i criteri in base ai quali valutare il percorso
1 IL MODELLO CAF GENERALITA E STRUTTURA Il Modello CAF - Struttura 2 2 Il Modello CAF Lo sviluppo negli elementi di dettaglio 3 Le nove caselle rappresentano i criteri in base ai quali valutare il percorso
Quadro di Riferimento di Matematica
 PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE SULL INDAGINE OCSE-PISA E ALTRE RICERCHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI Seminario provinciale rivolto ai docenti del Primo Ciclo Quadro di Riferimento di Matematica -la rilevazione
PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE SULL INDAGINE OCSE-PISA E ALTRE RICERCHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI Seminario provinciale rivolto ai docenti del Primo Ciclo Quadro di Riferimento di Matematica -la rilevazione
Progetto DSA: Guida al metodo di studio
 Progetto DSA: Guida al metodo di studio CESPD - Centro Studi e Ricerche per la Disabilità Scuola di Psicologia Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia Scuola di Ingegneria Dipartimento di
Progetto DSA: Guida al metodo di studio CESPD - Centro Studi e Ricerche per la Disabilità Scuola di Psicologia Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia Scuola di Ingegneria Dipartimento di
DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI EASY BASKET
 DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI EASY BASKET EASYBASKET SEMPLICE EMOZIONANTE A MISURA DI BAMBINO ALLA PORTATA DEGLI INSEGNANTI ma di TUTTI gli insegnanti e di TUTTI i bambini
DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI EASY BASKET EASYBASKET SEMPLICE EMOZIONANTE A MISURA DI BAMBINO ALLA PORTATA DEGLI INSEGNANTI ma di TUTTI gli insegnanti e di TUTTI i bambini
Psicoterapia cognitivo-comportamentale in età evolutiva. Dott.ssa Elena Luisetti
 Psicoterapia cognitivo-comportamentale in età evolutiva Dott.ssa Elena Luisetti PIU CHE UNA SCUOLA E UNA PROSPETTIVA EMERSE CON IL CONVERGERE DI PIU FILONI PRINCIPI BASE Kendell, 1993 A. L individuo reagisce
Psicoterapia cognitivo-comportamentale in età evolutiva Dott.ssa Elena Luisetti PIU CHE UNA SCUOLA E UNA PROSPETTIVA EMERSE CON IL CONVERGERE DI PIU FILONI PRINCIPI BASE Kendell, 1993 A. L individuo reagisce
IL COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE: le variabili personali, sociali e psicologiche
 IL COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE: le variabili personali, sociali e psicologiche 1. BACKGROUND Chi acquista? Quando acquista? Perché acquista? Quando acquista? Chi consuma? Quando consuma? Perché consuma?
IL COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE: le variabili personali, sociali e psicologiche 1. BACKGROUND Chi acquista? Quando acquista? Perché acquista? Quando acquista? Chi consuma? Quando consuma? Perché consuma?
Neuropsicologia. R-Bans
 Neuropsicologia R-Bans La memoria: RBANS Gli indici (o domini) della RBANS che si occupano di valutare la memoria sono: memoria immediata la memoria differita RBANS: Dominio Memoria immediata Indica l
Neuropsicologia R-Bans La memoria: RBANS Gli indici (o domini) della RBANS che si occupano di valutare la memoria sono: memoria immediata la memoria differita RBANS: Dominio Memoria immediata Indica l
MOTIVAZIONE AL LAVORO
 MOTIVAZIONE AL LAVORO La motivazione è L insieme degli stimoli che determinano il comportamento umano; è una determinante dell essere umano attraverso la quale, avendo un bisogno, la donna/l uomo orientano
MOTIVAZIONE AL LAVORO La motivazione è L insieme degli stimoli che determinano il comportamento umano; è una determinante dell essere umano attraverso la quale, avendo un bisogno, la donna/l uomo orientano
PRESENTAZIONE TEST CHE VALUTANO FUNZIONI ESECUTIVE
 WHO COLLABORATING CENTRE FOR RESEARCH, SERVICE EVALUATION AND TRAINING IN MENTAL HEALTH Programma Strategico PRESENTAZIONE TEST CHE VALUTANO FUNZIONI ESECUTIVE FUNZIONI ESECUTIVE Le funzioni esecutive
WHO COLLABORATING CENTRE FOR RESEARCH, SERVICE EVALUATION AND TRAINING IN MENTAL HEALTH Programma Strategico PRESENTAZIONE TEST CHE VALUTANO FUNZIONI ESECUTIVE FUNZIONI ESECUTIVE Le funzioni esecutive
Progetto di analisi di clima e benessere organizzativo. Ing. Giuseppe Galvan
 Progetto di analisi di clima e benessere organizzativo Ing. Giuseppe Galvan Rischio Lavorativo R = M x P Probabilità Bassa Media Alta Magnitudo Lieve 1 2 3 Grave 2 4 6 Gravissima 3 6 9 Il Clima Organizzativo
Progetto di analisi di clima e benessere organizzativo Ing. Giuseppe Galvan Rischio Lavorativo R = M x P Probabilità Bassa Media Alta Magnitudo Lieve 1 2 3 Grave 2 4 6 Gravissima 3 6 9 Il Clima Organizzativo
ESPERIMENTO DISEGNO SPERIMENTALE CLASSICO. Requisiti
 ESPERIMENTO INSIEME DI PROCEDURE LOGICHE E OPERATIVE SCHEMA OPERATIVO DI RACCOLTA E ANALISI DEI DATI DISEGNO SPERIMENTALE - ISPIRATO AL SISTEMA LOGICO-PROCEDURALE CHE PRESIEDE AL PROBLEMA DELL IMPUTAZIONE
ESPERIMENTO INSIEME DI PROCEDURE LOGICHE E OPERATIVE SCHEMA OPERATIVO DI RACCOLTA E ANALISI DEI DATI DISEGNO SPERIMENTALE - ISPIRATO AL SISTEMA LOGICO-PROCEDURALE CHE PRESIEDE AL PROBLEMA DELL IMPUTAZIONE
da valutare e certificare Seminario CIDI Milano 20 gennaio 2011 a cura di Daniela Bertocchi
 da valutare e certificare a cura di Daniela Bertocchi 1 Definizione europea (QEQ) di competenza La comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni
da valutare e certificare a cura di Daniela Bertocchi 1 Definizione europea (QEQ) di competenza La comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni
I PARADIGMI E LE RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE DI KUHN
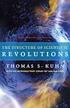 I PARADIGMI E LE RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE DI KUHN Corso di Dottorato di Ricerca Lezioni di Filosofia e Metodologia della Ricerca Scientifica Giacomo Zanni Dipartimento ENDIF Università di Ferrara Thomas
I PARADIGMI E LE RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE DI KUHN Corso di Dottorato di Ricerca Lezioni di Filosofia e Metodologia della Ricerca Scientifica Giacomo Zanni Dipartimento ENDIF Università di Ferrara Thomas
I seminario: Che cos è il tirocinio curricolare?
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA Facoltà di Lettere e Filosofia Corso di Laurea in Scienze dell educazione Seminari metodologici propedeutici al tirocinio A.A. 2009/2010 I seminario: Che cos è il tirocinio
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA Facoltà di Lettere e Filosofia Corso di Laurea in Scienze dell educazione Seminari metodologici propedeutici al tirocinio A.A. 2009/2010 I seminario: Che cos è il tirocinio
La teoria dell offerta
 La teoria dell offerta Tecnologia e costi di produzione In questa lezione approfondiamo l analisi del comportamento delle imprese e quindi delle determinanti dell offerta. In particolare: è possibile individuare
La teoria dell offerta Tecnologia e costi di produzione In questa lezione approfondiamo l analisi del comportamento delle imprese e quindi delle determinanti dell offerta. In particolare: è possibile individuare
Indice. Prefazione all edizione italiana. Gli Autori e i Curatori dell edizione italiana PARTE PRIMA ASPETTI GENERALI
 Indice Prefazione all edizione italiana Gli Autori e i Curatori dell edizione italiana XI XII PARTE PRIMA ASPETTI GENERALI Capitolo 1. Introduzione 1 1.1 La psicologia scientifica 1 1.2 I contesti della
Indice Prefazione all edizione italiana Gli Autori e i Curatori dell edizione italiana XI XII PARTE PRIMA ASPETTI GENERALI Capitolo 1. Introduzione 1 1.1 La psicologia scientifica 1 1.2 I contesti della
IMPARARE LE LINGUE STRANIERE A SCUOLA Un sondaggio delle convinzioni di studenti e insegnanti II ELABORAZIONE, Febbraio 2010
 1 IMPARARE LE LINGUE STRANIERE A SCUOLA II ELABORAZIONE, Febbraio 1 Scuole campione: 6 Istituti tecnici e professionali di cittadine medio-piccole del Nord Italia; 4 classi prime (N=84); 4 classi seconde
1 IMPARARE LE LINGUE STRANIERE A SCUOLA II ELABORAZIONE, Febbraio 1 Scuole campione: 6 Istituti tecnici e professionali di cittadine medio-piccole del Nord Italia; 4 classi prime (N=84); 4 classi seconde
Università degli Studi di Enna Kore
 Università degli Studi di Enna Kore Corso di Studi in Servizio Sociale Insegnamento di Psicologia sociale Prof.ssa Irene Petruccelli irene.petruccelli@unikore.it Enna, 3 novembre 2015 A.A. 2015-2016 RICEVIMENTO
Università degli Studi di Enna Kore Corso di Studi in Servizio Sociale Insegnamento di Psicologia sociale Prof.ssa Irene Petruccelli irene.petruccelli@unikore.it Enna, 3 novembre 2015 A.A. 2015-2016 RICEVIMENTO
ACUITÀ VISIVA, DIOTTRIE E LENTI CORRETTIVE: TUTTO CIÒ CHE NON SERVE SAPERE PER GUARIRE LA VISTA
 ACUITÀ VISIVA, DIOTTRIE E LENTI CORRETTIVE: TUTTO CIÒ CHE NON SERVE SAPERE PER GUARIRE LA VISTA Ci proponiamo in questo articolo di gettare luce su tre argomenti sempre molto confusi e malcompresi: l acuità
ACUITÀ VISIVA, DIOTTRIE E LENTI CORRETTIVE: TUTTO CIÒ CHE NON SERVE SAPERE PER GUARIRE LA VISTA Ci proponiamo in questo articolo di gettare luce su tre argomenti sempre molto confusi e malcompresi: l acuità
Gruppi di lavoro, processi decisionali ed efficacia
 Lezione 5 Gruppi di lavoro, processi decisionali ed efficacia Università Tor Vergata 1 Agenda Drammaturgia e impression management Capacità sociali Le decisioni nelle organizzazioni 2 Assunzioni di base
Lezione 5 Gruppi di lavoro, processi decisionali ed efficacia Università Tor Vergata 1 Agenda Drammaturgia e impression management Capacità sociali Le decisioni nelle organizzazioni 2 Assunzioni di base
PSICOLOGIA COGNITIVA. Gaia Vicenzi - Psicologia Cognitiva
 PSICOLOGIA COGNITIVA Che cosa studia la psicologia sociale? Doise (1982) ha individuato quattro diversi livelli in cui lo studio della psicologia si colloca a seconda della natura delle variabili coinvolte
PSICOLOGIA COGNITIVA Che cosa studia la psicologia sociale? Doise (1982) ha individuato quattro diversi livelli in cui lo studio della psicologia si colloca a seconda della natura delle variabili coinvolte
PRESENTAZIONE UNITÀ DI APPRENDIMENTO
 PRESENTAZIONE UNITÀ DI APPRENDIMENTO Struttura di base ordinaria dell azione formativa, ad ampiezza massima (tutti i formatori), media (alcuni) o minima (asse culturale/area formativa), autosufficiente
PRESENTAZIONE UNITÀ DI APPRENDIMENTO Struttura di base ordinaria dell azione formativa, ad ampiezza massima (tutti i formatori), media (alcuni) o minima (asse culturale/area formativa), autosufficiente
Grandezze fisiche e loro misura
 Grandezze fisiche e loro misura Cos è la fisica? e di che cosa si occupa? - Scienza sperimentale che studia i fenomeni naturali suscettibili di sperimentazione e caratterizzati da entità o grandezze misurabili.
Grandezze fisiche e loro misura Cos è la fisica? e di che cosa si occupa? - Scienza sperimentale che studia i fenomeni naturali suscettibili di sperimentazione e caratterizzati da entità o grandezze misurabili.
METACOGNIZIONE E STILI DI APPRENDIMENTO
 1) METACOGNIZIONE E STILI DI APPRENDIMENTO L'APPROCCIO METACOGNITIVO Lo studio delle funzioni del pensiero rende realmente capaci di organizzare, dirigere e controllare i processi mentali; adeguarli alle
1) METACOGNIZIONE E STILI DI APPRENDIMENTO L'APPROCCIO METACOGNITIVO Lo studio delle funzioni del pensiero rende realmente capaci di organizzare, dirigere e controllare i processi mentali; adeguarli alle
PARTE III MATERIALI PER LE ESERCITAZIONI E LA DIDATTICA
 PARTE III MATERIALI PER LE ESERCITAZIONI E LA DIDATTICA 54. Il diritto del lavoro spiegato partendo dal curriculum vitae degli studenti (mestieri, contratti, fonti di regolazione del lavoro) Il processo
PARTE III MATERIALI PER LE ESERCITAZIONI E LA DIDATTICA 54. Il diritto del lavoro spiegato partendo dal curriculum vitae degli studenti (mestieri, contratti, fonti di regolazione del lavoro) Il processo
Rischio Reale e Rischio Percepito: Il ruolo della comunicazione e delle emozioni
 Rischio Reale e Rischio Percepito: Il ruolo della comunicazione e delle emozioni M.R Ciceri Professore Associato Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano Responsabile Unità di Ricerca Psicologia del
Rischio Reale e Rischio Percepito: Il ruolo della comunicazione e delle emozioni M.R Ciceri Professore Associato Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano Responsabile Unità di Ricerca Psicologia del
Le principali teorie psico-pedagogiche. Modelli teorici e lavoro scolastico
 Le principali teorie psico-pedagogiche Modelli teorici e lavoro scolastico Teorie dell apprendimento APPRENDIMENTO =processo mediante il quale si acquisiscono nuove conoscenze Esterno Dipende dall ambiente
Le principali teorie psico-pedagogiche Modelli teorici e lavoro scolastico Teorie dell apprendimento APPRENDIMENTO =processo mediante il quale si acquisiscono nuove conoscenze Esterno Dipende dall ambiente
TITOLO: DATI IDENTIFICATIVI. Anno scolastico: Scuola: Destinatari: Insegnanti coinvolti: COMPITO UNITARIO IN SITUAZIONE
 PROGETTARE PER COMPETENZE TITOLO: DATI IDENTIFICATIVI COMPITO UNITARIO IN SITUAZIONE Anno scolastico: Scuola: Destinatari: Insegnanti coinvolti: COMPETENZE ATTESE ( dal Profilo dello studente ) CONTESTO
PROGETTARE PER COMPETENZE TITOLO: DATI IDENTIFICATIVI COMPITO UNITARIO IN SITUAZIONE Anno scolastico: Scuola: Destinatari: Insegnanti coinvolti: COMPETENZE ATTESE ( dal Profilo dello studente ) CONTESTO
Economia e Performance dei Gruppi. Il bilancio consolidato di gruppo secondo i principi Ias/Ifrs
 Il bilancio consolidato di gruppo secondo i principi Ias/Ifrs Riferimenti normativi Ifrs 3 - «Aggregazioni aziendali»: riguarda la contabilizzazione dei processi di aggregazione e disciplina il trattamento
Il bilancio consolidato di gruppo secondo i principi Ias/Ifrs Riferimenti normativi Ifrs 3 - «Aggregazioni aziendali»: riguarda la contabilizzazione dei processi di aggregazione e disciplina il trattamento
La Cultura. Roberto Pedersini
 La Cultura Roberto Pedersini La cultura La cultura è un insieme di valori, definizioni della realtà e codici di comportamento condivisi da persone che hanno in comune uno specifico modo di vita (Clyde
La Cultura Roberto Pedersini La cultura La cultura è un insieme di valori, definizioni della realtà e codici di comportamento condivisi da persone che hanno in comune uno specifico modo di vita (Clyde
LABORATORIO SPECIALISTICO: Buone pratiche di integrazione
 Facoltà di Psicologia Università di Milano-Bicocca Corso di laurea in PPSDCE LABORATORIO SPECIALISTICO: Buone pratiche di integrazione L IPOTESI DEL CONTATTO 1 IPOTESI DEL CONTATTO (Allport, 1954; Williams,
Facoltà di Psicologia Università di Milano-Bicocca Corso di laurea in PPSDCE LABORATORIO SPECIALISTICO: Buone pratiche di integrazione L IPOTESI DEL CONTATTO 1 IPOTESI DEL CONTATTO (Allport, 1954; Williams,
