LIBERAZIONE DI POLISACCARIDI DAI LIEVITI E LORO INTERAZIONI CON I POLIFENOLI DEL VINO
|
|
|
- Feliciano Marini
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 ESCOT EL AL. INTERAZIONI TRA POLISACCARIDI E POLIFENOLI PAG. 1 LIBERAZIONE DI POLISACCARIDI DAI LIEVITI E LORO INTERAZIONI CON I POLIFENOLI DEL VINO S. ESCOT (1), M. FEUILLAT (1), A.JULIEN (2), et C.CHARPENTIER (1) (1) Laboratoire d'œnologie, Institut Universitaire de la Vigne et du Vin, BP Campus Universitaire, 278 Dijon Cedex, France (2) Lallemand S.A, BP 4412, 3145 Toulouse Cedex France sandraescot@yahoo.fr I polisaccaridi rappresentano uno dei principali gruppi di macromolecole del vino. Tra di esse alcune, come le sostanze pectiche ed i polisaccaridi neutri, provengono dall uva. Altre sono invece di origine fungina, come ad esempio i glucani di peso molecolare kda prodotti da Botrytis cinerea quando infetta gli acini d uva. Esiste infine un gruppo importante di polisaccaridi, prodotti o liberati dai lieviti Saccharomyces cerevisie durante la fermentazione alcolica (Llaubères 1988) o l autolisi (Feuillat et al 1989). L effetto delle macromolecole dette «colloidi protettori» sulla stabilità del vino è conosciuto dal 1933 (Ribéreau-Gayon). Tuttavia nel passato questi colloidi venivano eliminati attraverso il collaggio o la filtrazione (Feuillat et al 1987) facendo uso di membrane non adatte. Alle mannoproteine vengono attribuite in enologia proprietà stabilizzanti rispetto alle precipitazioni tartariche (Lubbers et al 1994) e proteiche (Moine-Ledoux et al 1992), una funzione di supporto degli aromi (Lubbers et al 1994), oltre che la capacità di stabilizzare i composti fenolici (Saucier et al 1997). I polifenoli e più specificatamente gli antociani ed i tannini, giocano un ruolo importante per la qualità dei vini rossi essendo responsabili rispettivamente del colore e della struttura in bocca. Le prime osservazione fatte sulle interazioni tra componenti della parete del lievito e composti fenolici risalgono ai lavori di Augustin (1986) che mostrano come l aggiunta di scorze di lievito può portare ad un aumento dell intensità del colore e della tonalità. Il contributo degli antociani liberi al colore rosso viene ridotto e si osserva un aumento della frazione relativa ai complessi tannino-antociano decolorabili con la solforosa. Inoltre i tannini risultano meno reattivi alla gelatina. Tali risultati sono stati confermati la Llaubère nel 1988, che ha mostrato come aggiungendo al vino lieviti secchi attivi o mannoproteine estratte dagli stessi lieviti si ottiene una diminuzione dell indice di gelatina corrispondente ad una specie di collaggio, congiuntamente alla riduzione della reattività dei tannini. Saucier et al (2) hanno mostrato che alcuni polisaccaridi possono controllare o prevenire l instabilità colloidale «avvolgendo» i tannini, e tale fenomeno viene associato al concetto di «buoni» tannini e ad una sensazione organolettiche di corpo e rotondità. Alcune prove di affinamento di vini rossi su fecce fini, nel corso degli ultimi anni, hanno permesso di fare un certo numero di osservazioni sull evoluzione della qualità dei polifenoli, tra cui il fatto che l astringenza non può essere spiegata solamente attraverso la struttura chimica dei tannini, ma è necessario prendere in considerazione l entità delle loro combinazioni con sostanze non polifenoliche come le mannoproteine. La comprensione dell influenza delle mannoproteine sulla stabilità dei composti fenolici passa attraverso una migliore conoscenza della loro composizione fine oltre che dei meccanismi di liberazione ed azione. Per questo motivo le sopracitate osservazioni sono state completate con uno studio approfondito in laboratorio ed alcune verifiche in condizioni reali di cantina.
2 ESCOT EL AL. INTERAZIONI TRA POLISACCARIDI E POLIFENOLI PAG Liberazione di mannoproteine, loro composizione ed influenza del ceppo di lievito Uno studio compiuto su 27 ceppi di lievito vinario (Rosi et al 1998) ha mostrato che la liberazione di polisaccaridi da parte delle cellule durante la fermentazione di uno stesso mosto varia da un ceppo all'altro. Nelle condizioni sperimentali descritte la quantità di mannoproteine liberate variava tra e 144 mg/l con il 48% dei ceppi che liberavano da 51 a 8 mg/l e solamente il 4% che ne rilasciavano più di 121 mg/l. In seguito a questa osservazione, sono stati condotti lavori finalizzati ad una migliore comprensione dei meccanismi che causano questo «effetto lievito» sulla liberazione dei polisaccaridi durante la fermentazione alcolica. Sono state quindi condotte fermentazioni in mosto sintetico inizialmente povero in colloidi facendo uso di due ceppi diversi di lievito: uno in grado di liberare basse quantità di mannoproteine (LSA1) ed un altro che rilascia forti quantità (). Alla fine della fermentazione alcolica, i lieviti sono stati lasciati nel mezzo per giorni, simulando un inizio di affinamento «sur lies». Le mannoproteine sono state raccolte in diverse fasi della fermentazione (fase esponenziale, fine fermentazione e dopo giorni d autolisi) tramite precipitazione con etanolo, e quantificate per HPLC. L area dei picchi è stata misurata e comparata con quella ottenuta con iniezione di preparati commerciali di mannoproteine purificate. I risultati sono espressi in mg/l. Polys./g de biomasse p, expo Fin FA Autolyse Temps (heures) Figura 1 : Liberazione di mannoproteine da parte di 2 ceppi di lievito industriali : LSA1 e. Misure effettuate con HPLC. Si può constatare che il mezzo di fermentazione si arricchisce di mannoproteine e che tale arricchimento continua durante la conservazione del mezzo sulla biomassa al termine della fermentazione. L aumento del contenuto in mannoproteine risulta significativo fin dall inizio della fermentazione per il ceppo, mentre si verifica più tardivamente con il ceppo LSA1. In effetti, dopo 8 ore di fermentazione, il ceppo libera il 76% di mannoproteine in più rispetto al ceppo LSA1. Dopo due settimane d autolisi, la differenza tra i ceppi si è ridotta al %, anche se sempre in favore del ceppo. È stata determinata la composizione chimica di queste macromolecole, che sono risultate contenere un 8-9% di polisaccaridi ed un -2% di proteine, confermando quindi la loro origine parietale. Gli zuccheri principali della frazione polisaccaridica sono il mannosio ed il glucosio. Le glicoproteine liberate dal ceppo LSA1 sono costituite per l 8% da mannosio e per il 2% da glucosio, quale che sia la fase di fermentazione, mentre le glicoproteine parietali prodotte dal ceppo hanno un rapporto mannosio/glucosio vicino ad 1.
3 ESCOT EL AL. INTERAZIONI TRA POLISACCARIDI E POLIFENOLI PAG. 3 Le mannoproteine sono legate nella parete sia al β 1-3 o al β 1-6 glucano che alla chitina mediante il β 1-3 glucano. Sono state prese in esame la composizione della parete dei due ceppi e la rispettiva sensibilità al quantazyme, per capire se il fenomeno di liberazione era legato a delle differenze della parete cellulare. Il quantazyme è una β 1-3 glucanasi ad elevato grado di purezza (Quantum Biotechnologie). La sua applicazione sulla parete dei lieviti permette di caratterizzare i cambiamenti strutturali della parete stessa. L esperimento è stato realizzato in doppio su lieviti in fase esponenziale di crescita. Solamente il ceppo è risultato sensibile all enzima (figura 2). In questa fase di fermentazione, questo ceppo ha già liberato la maggior parte delle macromolecole (16.3 g/ g di biomassa in peso secco, rispetto ai 3.6 g del ceppo LSA1) : di conseguenza, la minor presenza di proteine intorno alla parete la rende maggiormente accessibile all azione dell enzima. I risultati di frazionamento delle proteine della parete del ceppo in questa fase della fermentazione mostra un tenore in proteine che si libera con la laminarinasi (β 1-3 glucanasi con attività β 1-6 glucanasi) di 2 volte inferiore a quello della parete del ceppo LSA1. Questo può significare che le macromolecole liberate sono mannoproteine legate a β 1-6 glucani. Infine, è interessante notare che il contenuto in chitina della parete del ceppo è 2 volte maggiore di quello del ceppo LSA1. Sensibilité à la quantazyme des souches LSA1 et % Abs. 6nm Temps (heures) LSA1 Figura 2 : Sensibilità a quantazyme dei ceppi LSA1 e in fase esponenziale di crescita cellulare. 2- Interazione tra le mannoproteine ed i composti fenolici Le differenza sopra descritte in termini di qualità delle mannoproteine liberate ci hanno portato a studiare le interazioni di queste macromolecole con alcuni costituenti del vino ed in particolare con i polifenoli. Il ceppo nella pratica di vinificazione viene considerato in grado di dare vini rotondi e con colore più stabile nel tempo. I tannini giocano un ruolo primordiale sulla qualità organolettica dei vini rossi, oltre che sulla loro attitudine all invecchiamento. Essi rinforzano il colore associandosi agli antociani (Ribereau-Gayon 1973). I tannini posso anche interagire con le macromolecole come le mannoproteine ed avere un effetto sull astringenza, la stabilità chimica e colloidale del vino. Durante l invecchiamento, sembra aumentino i legami tra i tannini ed i polisaccaridi (Glories, 1978), impedendo la reazione dei tannini stessi con le proteine salivari. Saucier (1997) mostra che a partire da una certa concentrazione si avrà stabilizzazione colloidale grazie all adsorbimento dei polisaccaridi attorno alle particelle colloidali di alcuni tannini (procianidine).
4 ESCOT EL AL. INTERAZIONI TRA POLISACCARIDI E POLIFENOLI PAG. 4 In un primo tempo, lo studio delle interazioni polifenoli / polisaccaridi è stato condotto in laboratorio aggiungendo mannoproteine purificate estratte dai due ceppi di lievito, in concentrazione di mg/l ad un vino giovane Pinot nero. Dopo giorni di contatto, sono state effettuate le misure dei diversi indici che danno informazioni sulla struttura ed i tannini e sul loro grado di combinazione con gli antociani (tabella 1). Ceppo di lievito Indice di gelatina (%) Indice di PVPP (%) Indice Etanolo (%) Testimone mg/l di mannoproteine liberate durante la fermentazione alcolica ,8 + 2 mg/l di mannoproteine liberate durante la fermentazione alcolica mg/l di mannoproteine liberate durante l autolisi 29,5 29, ,1 8,5 + 2 mg/l di mannoproteine liberate durante l autolisi 27, ,2 Tabella1 : influenza delle mannoproteine liberate dai due ceppi di lievito sulle proprietà dei composti fenolici I risultati ottenuti mettono in evidenza una reazione positiva di certe mannoproteine purificate sui composti fenolici. Le mannoproteine liberate durante la fermentazione alcolica dal ceppo sono molto reattive verso i composti fenolici. Si constata una riduzione dell indice di gelatina (che rappresenta l astringenza dei tannini) del 3% ed un aumento dei complessi mannoproteine / tannini (indice etanolo) e degli antociani combinati (indice PVPP). Questo fenomeno non si osserva con le mannoproteine liberate dal ceppo LSA1. Le mannoproteine liberate durante l autolisi risultano meno diverse da un ceppo all altro per quanto riguarda la reattività con i tannini, ed inoltre, indipendentemente dal ceppo di origine, non mostrano effetti sulle combinazioni con i tannini e sul grado di polimerizzazione degli antociani. 3- Prove di cantina Per confermare questi risultati, sono stati messi in opera numerose prove durante la vendemmia 2, per valutare gli effetti dell uso dei ceppi LSA1 e sul colore dei vini ottenuti e sulla loro sensazione di volume in bocca. Le prove sono state seguite da studenti del diploma di Enologia presso diverse aziende in Bourgogne, Beaujolais e Madiran. In tutti questi siti, le vasche dono state riempite in modo omogeneo, è stato seguito l andamento della fermentazione ed è stata verificata la dominanza del ceppo inoculato. Inoltre, in momenti differenti della fermentazione e dell affinamento, sono stati determinati altri parametri (colore, evoluzione dei composti fenolici).
5 ESCOT EL AL. INTERAZIONI TRA POLISACCARIDI E POLIFENOLI PAG. 5 In tutte le sedi sperimentali sono state osservate le stesse tendenze nei profili analitici e sensoriali, con una preferenza a favore del ceppo dall inizio della macerazione fino a 6 mesi di affinamento, dovuta a tannini più rotondi ed ad un colore più stabile. Viene riportato qui l esempio del Madiran, dove i vini sono più tannici e le differenze più evidenti. Le analisi sono state effettuate alla fine della fermentazione alcolica, alla fine della fermentazione malolattica ed dopo 6, e mesi di affinamento. Dalla fine della macerazione a 6 mesi di affinamento i risultati dei vari indici sono a favore del ceppo, con un colore più stabile (intensità colorante ed indice PVPP più elevati) e tannini più rotondi (indice etanolo ed indice di ionizzazione maggiori, indice di potere tannico inferiore) (figure 3 e 4). Si constata, tuttavia, che con il tempo certe differenze tendono a ridursi. Questo è coerente con quanto osservato in laboratorio, dove il ceppo LSA1 mostrava una liberazione di certe mannoproteine più tardi durante l autolisi. Ciò nonostante, come in laboratorio, si vede che la reattività verso i polifenoli di queste mannoproteine liberate durante l autolisi è meno importante. Indice d'éthanol Indice 3 2 LSA1 FIN FA FIN FML 6 Fermentation Figura 3 : Andamento dell indice Etanolo durante l affinamento dei 2 vini ottenuti con i ceppi LSA1 e Indice du pouvoir tannant Indice 5 LSA1 FIN FA FIN FML 6 Elevage Figura 4 : Andamento del potere tannico (indice di gelatina) durante l affinamento dei 2 vini ottenuti con i ceppi LSA1 e I risultati dell analisi sensoriale vanno nella stessa direzione : 8 degustatori su 12 (test significativo al 5%) trovano i vini ottenuti con il ceppo più morbidi di quelli derivanti dall impiego del ceppo LSA1. 9 giudici su 12 trovano inoltre nei vini più volume ed una minore intensità tannica (11 su 12) rispetto ai vini LSA1.
6 ESCOT EL AL. INTERAZIONI TRA POLISACCARIDI E POLIFENOLI PAG. 6 Conclusioni Sulla base di queste esperienze, si può affermare che i lieviti hanno la capacità di liberare quantità variabili di mannoproteine durante la fermentazione e durante l autolisi. La composizione di queste macromolecole varia in dipendenza della fase di liberazione e del ceppo di lievito. Il lavoro mostra inoltre che le mannoproteine hanno un effetto positivo sulle caratteristiche organolettiche dei vini rossi. In effetti alcune mannoproteine hanno una reattività positiva con i composti fenolici. Si possono distinguere due famiglie di mannoproteine: quelle liberate durante la fermentazione alcolica e quelle liberate durante l autolisi. Alcuni ceppi di lievito liberano durante la fermentazione alcolica quantità importanti di mannoproteine dotate di una buona reattività con i polifenoli e tale proprietà influenza l astringenza del vino finale e la stabilità del suo colore. Attualmente sono in corso studi di frazionamento delle diverse mannoproteine liberate durante la fermentazione o l autolisi, per meglio spiegare questi meccanismi. Le prove di cantina confermano ceppi diversi di lievito provocano differenze nella composizione dei vini, dovute certamente alla diversa presenza di mannoproteine ed agli effetti benefici di queste sull equilibrio organolettico dei vini (rotondità, volume in bocca). Il ceppo dà vini con tannini più morbidi, quale che sia la varietà e la tecnica di vinificazione. Questo ceppo si rivela essere adatto alla produzione di vini da bere giovani o prodotti con periodi di affinamento brevi.
7 ESCOT EL AL. INTERAZIONI TRA POLISACCARIDI E POLIFENOLI PAG. 7 Bibliografia AUGUSTIN M., (1986) : Etude de l influence de certains facteurs sur les composés phénoliques du raisin et du vin. Thèse de doctorat d université. Université de Bordeaux II. FEUILLAT M., (1987) : Stabilisation et clarification des vins : aspects colloïdaux. Revue des œnologues, 45, FEUILLAT M., FREYSSINET M., CHARPENTIER C., : L élevage sur lies des vins blancs de Bourgogne. Evolution des macromolécules : polysaccharides et protéines. Vitis, 28, GLORIES, Y. (1978) : Recherche sur la matière colorante des vins rouges. Thesis, University of Bordeaux. LLAUBERES, R.M. (1988) : Les polysaccharides sécrétés dans les vins par Saccharomyces cerevisiae et Pediococcus sp. Nouvelle thèse d'université. Université Bordeaux II. LUBBERS, S., CHARPENTIER, C., FEUILLAT, M. AND VOILLEY, A. (1994) : Influence of yeast walls on the behavior of aroma compounds in a model wine. American Journal of Enology and Viticulture, 45, MOINE LEDOUX, V., DULAU, L., DUBOURDIEU, D., (1992) : Interprétation de l'amélioration de la stabilité protéique des vins au cours de l'élevage sur lies. Journal International Scientifique Vigne Vin, 26, RIBEREAU-GAYON P. 1973: Interprétation chimique de la couleur des vins rouges. Vitis,12: RIBEREAU-GAYON J., (1933) : Vin et colloïdes protecteurs. Bull. Soc. Chimi. France 53, PV Soc. Phys. Bordeaux. ROSI, I., GHERI, A., et al. (1998): Effet des levures produisant des polysaccharides pariétaux sur certaines caractéristiques des vins rouges pendant la fermentation. Rev. Fr. Œnol.,172, SAUCIER, C. (1997): Les tanins du vin : Etude de leur stabilité colloïdale. Thèse de doctorat de l'université de Bordeaux. SAUCIER, C., GLORIES Y., ROUX, D., (2) : Interaction Tannins-colloïdes : nouvelles avancées concernant la notion de "bons" et de "mauvais" tanin. Revue des oenologues 94, 9-.
Ricerca finanziata dalla Regione Piemonte OBIETTIVI
 VALORIZZAZIONE DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E SENSORIALI DI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PRODOTTI DA UVE CORTESE ED ARNEIS, APPLICANDO TECNICHE INNOVATIVE DI AFFINAMENTO - PROGETTO VARCO Ricerca
VALORIZZAZIONE DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E SENSORIALI DI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PRODOTTI DA UVE CORTESE ED ARNEIS, APPLICANDO TECNICHE INNOVATIVE DI AFFINAMENTO - PROGETTO VARCO Ricerca
LIEVITI INATTIVI SPECIFICI PER LA VINIFICAZIONE IN ROSSO
 LIEVITI INATTIVI SPECIFICI PER LA VINIFICAZIONE IN ROSSO La massima Espressione dei tuoi vini I ntroduzione La domanda dei consumatori per vini rossi fruttati, dal colore intenso e tannini morbidi è in
LIEVITI INATTIVI SPECIFICI PER LA VINIFICAZIONE IN ROSSO La massima Espressione dei tuoi vini I ntroduzione La domanda dei consumatori per vini rossi fruttati, dal colore intenso e tannini morbidi è in
FILIERA UVA. Analisi del processo di vinificazione attraverso sistemi innovativi (obiettivo 3.4).
 FILIERA UVA Consolidamento di tecniche innovative per la qualificazione delle uve al conferimento presso le cantine e per il controllo del processo di vinificazione Analisi del processo di vinificazione
FILIERA UVA Consolidamento di tecniche innovative per la qualificazione delle uve al conferimento presso le cantine e per il controllo del processo di vinificazione Analisi del processo di vinificazione
modulo LA VINIFICAZIONE LA VINIFICAZIONE unità didattiche VINIFICAZIONE IN BIANCO ore richieste: 2 ore di lezione, con osservazioni in CANTINA
 modulo LA VINIFICAZIONE LA VINIFICAZIONE unità didattiche VINIFICAZIONE IN ROSSO VINIFICAZIONE IN BIANCO MACERAZIONE CARBONICA ore richieste: 2-3 ore di lezione integrate da osservazioni/sperimentazioni
modulo LA VINIFICAZIONE LA VINIFICAZIONE unità didattiche VINIFICAZIONE IN ROSSO VINIFICAZIONE IN BIANCO MACERAZIONE CARBONICA ore richieste: 2-3 ore di lezione integrate da osservazioni/sperimentazioni
Cessioni fenoliche dal tappo di sughero e potenziale effetto sulla stabilità proteica del vino
 Cessioni fenoliche dal tappo di sughero e potenziale effetto sulla stabilità proteica del vino Gabrielli M., Fracassetti D, Tirelli A. Dipartimento di Scienze per gli Alimenti la Nutrizione, l'ambiente.
Cessioni fenoliche dal tappo di sughero e potenziale effetto sulla stabilità proteica del vino Gabrielli M., Fracassetti D, Tirelli A. Dipartimento di Scienze per gli Alimenti la Nutrizione, l'ambiente.
Esperienze di produzione di vini in assenza di anidride solforosa C.Riponi, L.Pirrone, F.Chinnci, F.Sonni, N.Natali. Vicenza 12 dicembre 2009
 Esperienze di produzione di vini in assenza di anidride solforosa C.Riponi, L.Pirrone, F.Chinnci, F.Sonni, N.Natali Vicenza 12 dicembre 2009 Negli ultimi anni la ricerca nel settore alimentare è stata
Esperienze di produzione di vini in assenza di anidride solforosa C.Riponi, L.Pirrone, F.Chinnci, F.Sonni, N.Natali Vicenza 12 dicembre 2009 Negli ultimi anni la ricerca nel settore alimentare è stata
IMPIEGO DEGLI ENZIMI NELLA VINIFICAZIONE DEI VINI BIANCHI DI QUALITÀ
 GUERRAND & SCOTTI IMPIEGO DEGLI ENZIMI NELLA VINIFICAZIONE DEI VINI BIANCHI DI QUALITA, PAG. 1 IMPIEGO DEGLI ENZIMI NELLA VINIFICAZIONE DEI VINI BIANCHI DI QUALITÀ David GUERRAND 1, Barbara SCOTTI 2 1
GUERRAND & SCOTTI IMPIEGO DEGLI ENZIMI NELLA VINIFICAZIONE DEI VINI BIANCHI DI QUALITA, PAG. 1 IMPIEGO DEGLI ENZIMI NELLA VINIFICAZIONE DEI VINI BIANCHI DI QUALITÀ David GUERRAND 1, Barbara SCOTTI 2 1
Chimica Enologica e Analisi di Laboratorio 6 CFU
 Anno Accademico 2015/2016 Chimica Enologica e Analisi di Laboratorio 6 CFU Prof. Marco Rissone Obiettivi del corso Il Corso si propone di far conseguire conoscenze e competenze sufficienti per valutare
Anno Accademico 2015/2016 Chimica Enologica e Analisi di Laboratorio 6 CFU Prof. Marco Rissone Obiettivi del corso Il Corso si propone di far conseguire conoscenze e competenze sufficienti per valutare
ESEMPIO DI GESTIONE RAGIONATA DELLA MICROOSSIGENAZIONE APPLICATA AD UN VINO ROSSO
 CELOTTI ET AL., ESEMPIO DI MICROSSIGENAZIONE APPLICATA AD UN VINO ROSSO, PAG. 1 ESEMPIO DI GESTIONE RAGIONATA DELLA MICROOSSIGENAZIONE APPLICATA AD UN VINO ROSSO CELOTTI Emilio, ZUCCHETTO Marco Dipartimento
CELOTTI ET AL., ESEMPIO DI MICROSSIGENAZIONE APPLICATA AD UN VINO ROSSO, PAG. 1 ESEMPIO DI GESTIONE RAGIONATA DELLA MICROOSSIGENAZIONE APPLICATA AD UN VINO ROSSO CELOTTI Emilio, ZUCCHETTO Marco Dipartimento
Laurea in Viticoltura ed Enologia
 Laurea in Viticoltura ed Enologia settore Contenuti minimi Referenti CFU Analisi chimiche e fisiche dei prodotti enologici Operazioni unitarie Richiami di chimica inorganica e organica, equilibri chimici,
Laurea in Viticoltura ed Enologia settore Contenuti minimi Referenti CFU Analisi chimiche e fisiche dei prodotti enologici Operazioni unitarie Richiami di chimica inorganica e organica, equilibri chimici,
RICERCA ENOLOGICA PER LA VALORIZZAZIONE DEI VINI LIGURI
 RICERCA ENOLOGICA PER LA VALORIZZAZIONE DEI VINI LIGURI A cura di: Vincenzo GERBI e Luca ROLLE Di.Va.P.R.A. - Microbiologia e Industrie Agrarie OBIETTIVI PROGRAMMA REGIONALE Aspetti scientifici Caratterizzazione
RICERCA ENOLOGICA PER LA VALORIZZAZIONE DEI VINI LIGURI A cura di: Vincenzo GERBI e Luca ROLLE Di.Va.P.R.A. - Microbiologia e Industrie Agrarie OBIETTIVI PROGRAMMA REGIONALE Aspetti scientifici Caratterizzazione
TANNINI e MIGLIORATORI BIOLOGICI
 TANNINI e MIGLIORATORI BIOLOGICI MORBIDEZZA REDOX COLORE STRUTTURA AROMA ASSORBIMENTO ODORI RIDOTTO MICROTANN TANBLANCHE CRU TANNSTRUCTURE UVATANN ST DIRETTA MORBIDEZZA VOLUME COLORE STRUTTURA AROMA ASSORBIMENTO
TANNINI e MIGLIORATORI BIOLOGICI MORBIDEZZA REDOX COLORE STRUTTURA AROMA ASSORBIMENTO ODORI RIDOTTO MICROTANN TANBLANCHE CRU TANNSTRUCTURE UVATANN ST DIRETTA MORBIDEZZA VOLUME COLORE STRUTTURA AROMA ASSORBIMENTO
DERIVATI DI LIEVITO: CARATTERISTICHE COMPOSITIVE E ASPETTI PRATICI LEGATI ALL IMPIEGO ENOLOGICO
 CMUZZ ET AL., DERIVATI DI LIEVIT: CARATTERISTICHE E IMPIEG ENLGIC, PAG. 1 DERIVATI DI LIEVIT: CARATTERISTICHE CMPSITIVE E ASPETTI PRATICI LEGATI ALL IMPIEG ENLGIC Piergiorgio CMUZZ, Lara TAT, Anna LIESSI,
CMUZZ ET AL., DERIVATI DI LIEVIT: CARATTERISTICHE E IMPIEG ENLGIC, PAG. 1 DERIVATI DI LIEVIT: CARATTERISTICHE CMPSITIVE E ASPETTI PRATICI LEGATI ALL IMPIEG ENLGIC Piergiorgio CMUZZ, Lara TAT, Anna LIESSI,
DALL UVA AL MOSTO. Struttura del grappolo e composizione chimica dell uva
 DALL UVA AL MOSTO Struttura del grappolo e composizione chimica dell uva L infruttescenza della vite è un grappolo composto che si presenta, a seconda del vitigno, con forme e dimensioni diverse. Il peso
DALL UVA AL MOSTO Struttura del grappolo e composizione chimica dell uva L infruttescenza della vite è un grappolo composto che si presenta, a seconda del vitigno, con forme e dimensioni diverse. Il peso
movia vitigni autoctoni Tocai Friulano Sauvignon Merlot Pinot Nero Chardonnay vendemmia manualità macerazione
 21 ha - 100.000 bt primorski slovenia movia Mirko & Aleš Kristancic a Dobrovo 1820 peschi tradizionale Brda zac zac ciliegi humus collina vini del protocollo vigneron giardiniere albicocche vitigni autoctoni
21 ha - 100.000 bt primorski slovenia movia Mirko & Aleš Kristancic a Dobrovo 1820 peschi tradizionale Brda zac zac ciliegi humus collina vini del protocollo vigneron giardiniere albicocche vitigni autoctoni
Cabernet Sauvignon Doc Colli Bolognesi
 Cabernet Sauvignon Doc Colli Bolognesi Bonzarone è vino ottenuto da uve Cabernet Sauvignon prodotte da vigneti di circa quindici anni di età. Le uve vengono raccolte dopo un attenta scelta cominciata con
Cabernet Sauvignon Doc Colli Bolognesi Bonzarone è vino ottenuto da uve Cabernet Sauvignon prodotte da vigneti di circa quindici anni di età. Le uve vengono raccolte dopo un attenta scelta cominciata con
Valorizzazione dei raspi per il recupero di zuccheri e composti antiossidanti Giorgia Spigno Danila Amendola, Luana Maggi, Dante M.
 Valorizzazione dei raspi per il recupero di zuccheri e composti antiossidanti Giorgia Spigno Danila Amendola, Luana Maggi, Dante M. De Faveri Università Cattolica del Sacro Cuore Istituto di Enologia e
Valorizzazione dei raspi per il recupero di zuccheri e composti antiossidanti Giorgia Spigno Danila Amendola, Luana Maggi, Dante M. De Faveri Università Cattolica del Sacro Cuore Istituto di Enologia e
TANNINI ENOLOGICI. equilibrio, struttura, eleganza
 TANNINI ENOLOGICI equilibrio, struttura, eleganza Evoluzione dei polifenoli nel vino: una materia complessa ANTOCIANI FLAVANI monomeri TANNINI < 7 monomeri TANNINI > 7 monomeri VINO A LUNGO INVECCHIAMENTO
TANNINI ENOLOGICI equilibrio, struttura, eleganza Evoluzione dei polifenoli nel vino: una materia complessa ANTOCIANI FLAVANI monomeri TANNINI < 7 monomeri TANNINI > 7 monomeri VINO A LUNGO INVECCHIAMENTO
Test tecnico per culture starter di batteri lattici 2012
 Test tecnico per culture starter di batteri lattici 2012 Il presente rapporto contiene l esame tecnico per culture STARTER di batteri lattici per la fermentazione malolattica. Lo scopo non è quello di
Test tecnico per culture starter di batteri lattici 2012 Il presente rapporto contiene l esame tecnico per culture STARTER di batteri lattici per la fermentazione malolattica. Lo scopo non è quello di
Sfogliatura della vite e le sue conseguenze
 Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR Agroscope Sfogliatura della vite e le sue conseguenze Giornata del Viticoltore 21 novembre 2014 Perché sfogliare? Per garantire
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR Agroscope Sfogliatura della vite e le sue conseguenze Giornata del Viticoltore 21 novembre 2014 Perché sfogliare? Per garantire
Sperimentazione in scala di cantina presso azienda Capodarco (Grottaferrata- Roma)
 Sperimentazione in scala di cantina presso azienda Capodarco (Grottaferrata- Roma) Prof. Marco Esti Dipartimento per l Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) Università dellatuscia
Sperimentazione in scala di cantina presso azienda Capodarco (Grottaferrata- Roma) Prof. Marco Esti Dipartimento per l Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) Università dellatuscia
La Sicilia al naturale VITICOLTORI BIO. in CAMPOREALE
 La Sicilia al naturale VITICOLTORI BIO in CAMPOREALE NovitÀ Aziende ad alta biodiversità Nel 2010 è iniziato il programma «Aziende ad alta biodiversità» della Valdibella. Con l applicazione del programma
La Sicilia al naturale VITICOLTORI BIO in CAMPOREALE NovitÀ Aziende ad alta biodiversità Nel 2010 è iniziato il programma «Aziende ad alta biodiversità» della Valdibella. Con l applicazione del programma
Oenovin EPERNAY (ex r.f. Bayanus) Lievito selezionato in Champagne il cui utilizzo è indicato per il trattamento di mosti destinati alla produzione di
 La Gamma Oenovin I lieviti selezionati Oenovin sono il frutto della rigorosa selezione dei ceppi e di un processo produttivo attento alla qualità ed al rispetto della capacità fermentativa del lievito
La Gamma Oenovin I lieviti selezionati Oenovin sono il frutto della rigorosa selezione dei ceppi e di un processo produttivo attento alla qualità ed al rispetto della capacità fermentativa del lievito
Prove di confronto Cloni e Biotipi di Cannonau in Agro di Dorgali «Loc. Oddoene»
 Prove di confronto Cloni e Biotipi di Cannonau in Agro di Dorgali «Loc. Oddoene» Dorgali 25 Ottobre 2016 Onofrio Graviano Luca Demelas Gabriele Musa Laboratorio analisi Confronto cloni Cannnonau Dorgali
Prove di confronto Cloni e Biotipi di Cannonau in Agro di Dorgali «Loc. Oddoene» Dorgali 25 Ottobre 2016 Onofrio Graviano Luca Demelas Gabriele Musa Laboratorio analisi Confronto cloni Cannnonau Dorgali
USO DI ACQUA ELETTROLIZZATA ED OZONO SU UVE da VINO IN POST-RACCOLTA: ASPETTI TECNOLOGICI e MICROBIOLOGICI L. ROLLE, L. COCOLIN
 USO DI ACQUA ELETTROLIZZATA ED OZONO SU UVE da VINO IN POST-RACCOLTA: ASPETTI TECNOLOGICI e MICROBIOLOGICI L. ROLLE, L. COCOLIN Pretrattamenti con acqua elettrolizzata e ozono: prime osservazioni su uve
USO DI ACQUA ELETTROLIZZATA ED OZONO SU UVE da VINO IN POST-RACCOLTA: ASPETTI TECNOLOGICI e MICROBIOLOGICI L. ROLLE, L. COCOLIN Pretrattamenti con acqua elettrolizzata e ozono: prime osservazioni su uve
Microssigenazione Barbera 2008
 ANDREA BUZIO ENOLOGO in collaborazione con WINER Wine making equipments & technologies Microssigenazione Barbera 2008 Il vino utilizzato per la sperimentazione è un Barbera annata 2008 con le seguenti
ANDREA BUZIO ENOLOGO in collaborazione con WINER Wine making equipments & technologies Microssigenazione Barbera 2008 Il vino utilizzato per la sperimentazione è un Barbera annata 2008 con le seguenti
Vini bianchi Buone pratiche di lavoro con le doghe in vinificazione
 Vini bianchi Buone pratiche di lavoro con le doghe in vinificazione 1 Cosa sono le buone pratiche? Delle tecniche validate al livello scientifico, sperimentale e nella pratica delle cantine 2 A cosa servono?
Vini bianchi Buone pratiche di lavoro con le doghe in vinificazione 1 Cosa sono le buone pratiche? Delle tecniche validate al livello scientifico, sperimentale e nella pratica delle cantine 2 A cosa servono?
 AMA 2010 IL VIGNETO Con l annata 2010 nasce questo nuovo Chianti Classico. La superficie totale a vigneto specializzato di proprietà del Castello di Ama ammonta a circa 90 ettari, di questi circa 65 ettari
AMA 2010 IL VIGNETO Con l annata 2010 nasce questo nuovo Chianti Classico. La superficie totale a vigneto specializzato di proprietà del Castello di Ama ammonta a circa 90 ettari, di questi circa 65 ettari
SI PUÒ! MIGLIORARE L ECCELLENZA? in cantina
 NIR LEVAV*, MARCO SALIS*, MARCO TEBALDI*, BEATRICE PALADINI* MIGLIORARE L ECCELLENZA? SI PUÒ! DALL APPLICAZIONE DI PROTOCOLLI INNOVATIVI DI VINIFICAZIONE POSSONO DERIVARE PRODOTTI DIVERSI A PARTIRE DA
NIR LEVAV*, MARCO SALIS*, MARCO TEBALDI*, BEATRICE PALADINI* MIGLIORARE L ECCELLENZA? SI PUÒ! DALL APPLICAZIONE DI PROTOCOLLI INNOVATIVI DI VINIFICAZIONE POSSONO DERIVARE PRODOTTI DIVERSI A PARTIRE DA
Sabato da Bere. L Arte del Bere Giusto. Corso sul Vino in 5 Lezioni ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER ROMA
 Sabato da Bere ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER ROMA Con questo Corso desideriamo proporvi una meditata conversazione sul vino, un incontro e un colloquio "ʺsenza segreti"ʺ con i Docenti dell'ʹassociazione
Sabato da Bere ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER ROMA Con questo Corso desideriamo proporvi una meditata conversazione sul vino, un incontro e un colloquio "ʺsenza segreti"ʺ con i Docenti dell'ʹassociazione
RISOLUZIONE OIV-OENO 498-2013 MODIFICA DELLE SCHEDE CONCERNENTI LE PRATICHE ENOLOGICHE RELATIVE AGLI ENZIMI
 RISOLUZIONE OIV-OENO 498-2013 MODIFICA DELLE SCHEDE CONCERNENTI LE PRATICHE ENOLOGICHE RELATIVE AGLI ENZIMI L ASSEMBLEA GENERALE, Visto l Articolo 2, paragrafo 2 ii, dell Accordo del 3 aprile 2001 che
RISOLUZIONE OIV-OENO 498-2013 MODIFICA DELLE SCHEDE CONCERNENTI LE PRATICHE ENOLOGICHE RELATIVE AGLI ENZIMI L ASSEMBLEA GENERALE, Visto l Articolo 2, paragrafo 2 ii, dell Accordo del 3 aprile 2001 che
Gestione di alcune variabili di processo nella macerazione delle uve rosse
 Prof. Emilio Celotti Università degli Studi Udine Dipartimento di Scienze degli Alimenti Gestione di alcune variabili di processo nella macerazione delle uve rosse studio pubblicato a gennaio 2004 su Revue
Prof. Emilio Celotti Università degli Studi Udine Dipartimento di Scienze degli Alimenti Gestione di alcune variabili di processo nella macerazione delle uve rosse studio pubblicato a gennaio 2004 su Revue
L ACIDO TARTARICO. Fonti principali. Prof. Vincenzo Leo - Chimica Enologica - ITA Emilio Sereni 1
 L ACIDO TARTARICO Fonti principali www.oicce.it Prof. Vincenzo Leo - Chimica Enologica - ITA Emilio Sereni 1 I sali dell'acido tartarico Al ph dei vini, tenuto conto della presenza dei cationi K+ e Ca++
L ACIDO TARTARICO Fonti principali www.oicce.it Prof. Vincenzo Leo - Chimica Enologica - ITA Emilio Sereni 1 I sali dell'acido tartarico Al ph dei vini, tenuto conto della presenza dei cationi K+ e Ca++
Cod. EM2U3. Fermentazione dei vini bianchi
 Cod. EM2U3 Fermentazione dei vini bianchi Fermentazione in vasca Costituzione del lotto Ogni mescolanza di mosti deve essere fatta prima che la fermentazione sia iniziata (per evitare produzioni di H 2
Cod. EM2U3 Fermentazione dei vini bianchi Fermentazione in vasca Costituzione del lotto Ogni mescolanza di mosti deve essere fatta prima che la fermentazione sia iniziata (per evitare produzioni di H 2
Esperienze di Macerazione Dinamica Prefermentativa su uve bianche. Giorgio Todeschini
 Esperienze di Macerazione Dinamica Prefermentativa su uve bianche Giorgio Todeschini 1 Presentazione Sede della sperimentazione Cantina Rauscedo Obiettivo valutazione delle opportunità d uso di questa
Esperienze di Macerazione Dinamica Prefermentativa su uve bianche Giorgio Todeschini 1 Presentazione Sede della sperimentazione Cantina Rauscedo Obiettivo valutazione delle opportunità d uso di questa
PLATINUM Vini puliti e equilibrati: ceppo che non produce H 2
 CHEDE_IMPA 8-07-2008 16:02 Pagina 1 PLATINUM Vini puliti e equilibrati: ceppo che non produce H 2 MAURIVIN PLATINUM MAURIVIN PLATINUM Confezioni Conservazione Dose di utilizzo PLATINUM tds-it: 27/06/2008
CHEDE_IMPA 8-07-2008 16:02 Pagina 1 PLATINUM Vini puliti e equilibrati: ceppo che non produce H 2 MAURIVIN PLATINUM MAURIVIN PLATINUM Confezioni Conservazione Dose di utilizzo PLATINUM tds-it: 27/06/2008
Vinificazione in bianco
 Vinificazione in bianco Importanza delle operazioni prefermentative nei vini bianchi Stili attuali di vinificazione in bianco Vendemmia: criteri di qualità; stato sanitario; maturità dell uva e data di
Vinificazione in bianco Importanza delle operazioni prefermentative nei vini bianchi Stili attuali di vinificazione in bianco Vendemmia: criteri di qualità; stato sanitario; maturità dell uva e data di
Test per l'analisi di campioni di vino
 Test per l'analisi di campioni di vino veterinariavegetale.listarfish.it Kit colorimetrici e strumentazione per le analisi enologiche manuali ed automatizzate. L'analisi del vino ha lo scopo di stabilire
Test per l'analisi di campioni di vino veterinariavegetale.listarfish.it Kit colorimetrici e strumentazione per le analisi enologiche manuali ed automatizzate. L'analisi del vino ha lo scopo di stabilire
GESTIONE DELL OSSIGENO IN MACERAZIONE PER LA PRESTABILIZZAZIONE DEL COLORE
 GESTIONE DELL OSSIGENO IN MACERAZIONE PER LA PRESTABILIZZAZIONE DEL COLORE Emilio CELOTTI Dipartimento di Scienze degli Alimenti Università degli Studi di Udine emilio.celotti@uniud.it ENOFORUM 2007 Piacenza
GESTIONE DELL OSSIGENO IN MACERAZIONE PER LA PRESTABILIZZAZIONE DEL COLORE Emilio CELOTTI Dipartimento di Scienze degli Alimenti Università degli Studi di Udine emilio.celotti@uniud.it ENOFORUM 2007 Piacenza
La personalità di un vino nasce sempre dalla terra, dal sole e dall aria: non è qualcosa che si può costruire.
 La personalità di un vino nasce sempre dalla terra, dal sole e dall aria: non è qualcosa che si può costruire. E con questa filosofia, dall amore per la natura e dal lavoro quotidiano che Ivana Adami ed
La personalità di un vino nasce sempre dalla terra, dal sole e dall aria: non è qualcosa che si può costruire. E con questa filosofia, dall amore per la natura e dal lavoro quotidiano che Ivana Adami ed
Cod. EM7U1. Affinamento dei vini
 osario DI GENO Cod. EM7U1 ffinamento dei vini Fenomeni di invecchiamento L affinamento è il processo di trasformazione dei componenti del vino che si svolge dalla fine della fermentazione sino all imbottigliamento.
osario DI GENO Cod. EM7U1 ffinamento dei vini Fenomeni di invecchiamento L affinamento è il processo di trasformazione dei componenti del vino che si svolge dalla fine della fermentazione sino all imbottigliamento.
Microssigenazione Barbera 2008
 in collaborazione con Microssigenazione Barbera 2008 Aggiornamento Dicembre 2009 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Il vino utilizzato per la sperimentazione è un Barbera annata 2008
in collaborazione con Microssigenazione Barbera 2008 Aggiornamento Dicembre 2009 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Il vino utilizzato per la sperimentazione è un Barbera annata 2008
RISULTATI ANALITICI VENDEMMIA 2009
 RISULTATI ANALITICI VENDEMMIA 2009 L indagine analitica iniziata nel 2008, tesa a caratterizzare, così come indicato nel Protocollo Operativo, uve e vini delle tre aziende promotrici del progetto Sangioveseperamico,
RISULTATI ANALITICI VENDEMMIA 2009 L indagine analitica iniziata nel 2008, tesa a caratterizzare, così come indicato nel Protocollo Operativo, uve e vini delle tre aziende promotrici del progetto Sangioveseperamico,
CHIRIOTTI EDITORI MAGGIO/GIUGNO 2005 ANNO 34 - N. 197 ISSN
 MAGGIO/GIUGNO 2005 ANNO 34 - N. 197 Poste Italiane spa - Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n 46) art. 1, comma 1, DCB TO - n. 3/2005 - I.P. ISSN 0390-0541 CHIRIOTTI EDITORI 10064 PINEROLO
MAGGIO/GIUGNO 2005 ANNO 34 - N. 197 Poste Italiane spa - Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n 46) art. 1, comma 1, DCB TO - n. 3/2005 - I.P. ISSN 0390-0541 CHIRIOTTI EDITORI 10064 PINEROLO
CONDIZIONI DIFFICILI BIANCHI ROSATI ROSSI RIFERMENTAZIONE CRIO SP CRU 69 CRU 811 CRU 31 AROM ART IT 1818 CRU 31 CRU 611 CRU 811
 CRIO SP CHAMPAGNE IT 1818 IT 07 CRU 69 CRU 811 ROUGE CAB 90 FRUITY FLAVOUR CRU 05 CRU 12 CRU 211 IT 1936 ROSSI AROM FRUITY FLAVOUR PRIMEUR CRU 56 CRU 611 ROSATI AROM ART IT 1818 CRU 31 CRU 611 CRU 811
CRIO SP CHAMPAGNE IT 1818 IT 07 CRU 69 CRU 811 ROUGE CAB 90 FRUITY FLAVOUR CRU 05 CRU 12 CRU 211 IT 1936 ROSSI AROM FRUITY FLAVOUR PRIMEUR CRU 56 CRU 611 ROSATI AROM ART IT 1818 CRU 31 CRU 611 CRU 811
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA Chimica e laboratorio classe V A Anno scolastico 2008-2009
 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA Chimica e laboratorio classe V A Anno scolastico 2008-2009 ISTITUTO TECNICO AGRARIO Via Scacciapensieri, 8 53100 Siena tel. 0577/332411-332477 FAX 0577/333243 INSEGNANTE: LILIANA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA Chimica e laboratorio classe V A Anno scolastico 2008-2009 ISTITUTO TECNICO AGRARIO Via Scacciapensieri, 8 53100 Siena tel. 0577/332411-332477 FAX 0577/333243 INSEGNANTE: LILIANA
LAFFORT ŒNOLOGIE - INFO
 LAFFORT ŒNOLOGIE - INFO NUMERO 4 - AGOSTO 2000 SOMMARIO 1. Evoluzione delle concentrazioni 2. Evoluzione della struttura delle molecole 3. Nozione di maturità fenolica 4. Metodo di determinazione della
LAFFORT ŒNOLOGIE - INFO NUMERO 4 - AGOSTO 2000 SOMMARIO 1. Evoluzione delle concentrazioni 2. Evoluzione della struttura delle molecole 3. Nozione di maturità fenolica 4. Metodo di determinazione della
IL GUSTO
 IL GUSTO Il gusto del vino è la sensazione finale che ci viene trasmessa da quell insieme di organi ricettivi chiamati papille gustative. Ora, i principali sapori che solitamente percepiamo mediante la
IL GUSTO Il gusto del vino è la sensazione finale che ci viene trasmessa da quell insieme di organi ricettivi chiamati papille gustative. Ora, i principali sapori che solitamente percepiamo mediante la
«Polisac Stab» Una nuova soluzione EVER
 I polisaccaridi nella Stabilizzazione Tartarica dei vini da imbottigliare: «Polisac Stab» Una nuova soluzione EVER Incontro tecnico 30/04/2015 Enologica Friulana- Udine Relatore: Enol.Giovanni Branca SCOPO
I polisaccaridi nella Stabilizzazione Tartarica dei vini da imbottigliare: «Polisac Stab» Una nuova soluzione EVER Incontro tecnico 30/04/2015 Enologica Friulana- Udine Relatore: Enol.Giovanni Branca SCOPO
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
 FASE DI MATURAZIONE DELL UVA La maturazione è spesso definita come il periodo che porta dall'invaiatura alla vendemmia. Sarebbe più giusto dire periodo che va dall'invaiatura alla maturità. La maturazione
FASE DI MATURAZIONE DELL UVA La maturazione è spesso definita come il periodo che porta dall'invaiatura alla vendemmia. Sarebbe più giusto dire periodo che va dall'invaiatura alla maturità. La maturazione
LA MISURA DELL OSSIGENO DISCOLTO IN CANTINA : UN NUOVO PARAMETRO PER IL CONTROLLO QUALITÀ?
 MOUTOUNET ET AL., LA MISURA DELL OSSIGENO IN CANTINA, PAG. 1 LA MISURA DELL OSSIGENO DISCOLTO IN CANTINA : UN NUOVO PARAMETRO PER IL CONTROLLO QUALITÀ? Michel MOUTOUNET, J.C. VIDAL UMR-Sciences Pour l
MOUTOUNET ET AL., LA MISURA DELL OSSIGENO IN CANTINA, PAG. 1 LA MISURA DELL OSSIGENO DISCOLTO IN CANTINA : UN NUOVO PARAMETRO PER IL CONTROLLO QUALITÀ? Michel MOUTOUNET, J.C. VIDAL UMR-Sciences Pour l
Test tecnico dei lieviti selezionati 2011
 250 Land- und Forstwirtschaftliches Test tecnico dei lieviti selezionati 2011 Come l anno scorso all inizio dell estate è stato svolto un sondaggio nel quale abbiamo chiesto ai produttori di vino sudtirolesi
250 Land- und Forstwirtschaftliches Test tecnico dei lieviti selezionati 2011 Come l anno scorso all inizio dell estate è stato svolto un sondaggio nel quale abbiamo chiesto ai produttori di vino sudtirolesi
RISOLUZIONE ECO 5/2004
 LIVELLO DI BASE RICHIESTO PER IL CONFERIMENTO DI DIPLOMA AI PROFESSIONISTI COINVOLTI NELL INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DI ANALISI L ASSEMBLEA GENERALE, su proposta della Commissione III «Economia», sulla
LIVELLO DI BASE RICHIESTO PER IL CONFERIMENTO DI DIPLOMA AI PROFESSIONISTI COINVOLTI NELL INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DI ANALISI L ASSEMBLEA GENERALE, su proposta della Commissione III «Economia», sulla
Il lisozima è un agente antimicrobico
 ECNICA T ABBATTERE LA MICROFLORA LATTICA SPONTANEA NEL MOSTO E NEL VINO Il lisozima ritarda nei rossi e blocca nei bianchi la malolattica I risultati hanno evidenziato la diversa efficienza del lisozima
ECNICA T ABBATTERE LA MICROFLORA LATTICA SPONTANEA NEL MOSTO E NEL VINO Il lisozima ritarda nei rossi e blocca nei bianchi la malolattica I risultati hanno evidenziato la diversa efficienza del lisozima
DOSAGGIO DELLA CARBOSSIMETILCELLULOSA (GOMMA DI CELLULOSA, CMC) NEI VINI BIANCHI
 RISOLUZIONE OIV/ENO 404/2010 DOSAGGIO DELLA CARBOSSIMETILCELLULOSA (GOMMA DI CELLULOSA, CMC) NEI VINI BIANCHI L ASSEMBLEA GENERALE Visto l'articolo 2 paragrafo 2 iv dell'accordo del 3 aprile 2001 che istituisce
RISOLUZIONE OIV/ENO 404/2010 DOSAGGIO DELLA CARBOSSIMETILCELLULOSA (GOMMA DI CELLULOSA, CMC) NEI VINI BIANCHI L ASSEMBLEA GENERALE Visto l'articolo 2 paragrafo 2 iv dell'accordo del 3 aprile 2001 che istituisce
Pag. 1 di 6 Consorzio per la Revisione n: 20 Tutela dell Asti LISTINO PREZZI
 Pag. 1 di 6 PROVA COSTO ( ) Acido gluconico - LC massa metodo Consorzio MC 56 40,00 Acidi Idrossicinnamil tartarici - HPLC Acidità totale prova accreditata OIV MP15 3,00 Acidità totale metodo Consorzio
Pag. 1 di 6 PROVA COSTO ( ) Acido gluconico - LC massa metodo Consorzio MC 56 40,00 Acidi Idrossicinnamil tartarici - HPLC Acidità totale prova accreditata OIV MP15 3,00 Acidità totale metodo Consorzio
IL SOLFITAGGIO E LA LAVORAZIONE DELLE FECCE: PUNTI CHIAVE PER L AFFINAMENTO
 DELTEIL D., IL SOLFITAGGIO E LA LAVORAZIONE DELLE FECCE: PUNTI CHIAVE PER L AFFINAMENTO, PAG.1 IL SOLFITAGGIO E LA LAVORAZIONE DELLE FECCE: PUNTI CHIAVE PER L AFFINAMENTO Dominique DELTEIL, ICV Montpellier,
DELTEIL D., IL SOLFITAGGIO E LA LAVORAZIONE DELLE FECCE: PUNTI CHIAVE PER L AFFINAMENTO, PAG.1 IL SOLFITAGGIO E LA LAVORAZIONE DELLE FECCE: PUNTI CHIAVE PER L AFFINAMENTO Dominique DELTEIL, ICV Montpellier,
Cod. EM3U1. Vinificazione in rosso
 Cod. EM3U1 Vinificazione in rosso Vinificazione in rosso Ricevimento delle uve Diraspatura Pigiatura Trasferimento del pigiato Macerazione pre-fermentativa a freddo (opzionale) Fermentazione alcolica (macerazione
Cod. EM3U1 Vinificazione in rosso Vinificazione in rosso Ricevimento delle uve Diraspatura Pigiatura Trasferimento del pigiato Macerazione pre-fermentativa a freddo (opzionale) Fermentazione alcolica (macerazione
Caratterizzazione sensoriale dei vini rosati
 Caratterizzazione sensoriale dei vini rosati Università degli Studi di Torino Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 1 L Italia e i vini rosati Dati in milioni hl 2012 2013 2014 2015 Produzione
Caratterizzazione sensoriale dei vini rosati Università degli Studi di Torino Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 1 L Italia e i vini rosati Dati in milioni hl 2012 2013 2014 2015 Produzione
LIEVITI inattivi SPECIFICI
 LIEVITI inattivi SPECIFICI PER LA VINIFICAZIONE IN BIANCO La massima espressione dei tuoi vini I ntroduzione Nei vini bianchi non è sempre facile raggiungere un buon equilibrio tra le sensazioni fruttate,
LIEVITI inattivi SPECIFICI PER LA VINIFICAZIONE IN BIANCO La massima espressione dei tuoi vini I ntroduzione Nei vini bianchi non è sempre facile raggiungere un buon equilibrio tra le sensazioni fruttate,
INDAGINE QUALITATIVA SUI PREPARATI DI LIEVITO SECCO ATTIVO
 Fondazione Edmund Mach - Centro di Trasferimento Tecnologico Laboratorio Analisi Chimiche e Consulenza Enologica INDAGINE QUALITATIVA SUI PREPARATI DI LIEVITO SECCO ATTIVO Anno 2010 Raffaele Guzzon, Veronica
Fondazione Edmund Mach - Centro di Trasferimento Tecnologico Laboratorio Analisi Chimiche e Consulenza Enologica INDAGINE QUALITATIVA SUI PREPARATI DI LIEVITO SECCO ATTIVO Anno 2010 Raffaele Guzzon, Veronica
Varietà rosse per zone elevate: Gamay noir Gamaret Garanoir Cabernet Dorio Cabernet Dorsa Acolon Palas Varietà bianche
 Le prove varietali negli ultimi anni hanno interessato le varietà qui in elenco. Le pagine successive descrivono quelle varietà che hanno dato buoni risultati sia in coltivazione, che per la qualità del
Le prove varietali negli ultimi anni hanno interessato le varietà qui in elenco. Le pagine successive descrivono quelle varietà che hanno dato buoni risultati sia in coltivazione, che per la qualità del
Forum Top. L antiperonosporico che contribuisce a una gestione ottimale del lavoro in campo
 Forum Top L antiperonosporico che contribuisce a una gestione ottimale del lavoro in campo 2013 Forum Top: l antiperonosporico che contribuisce a una gestione ottimale del lavoro in campo Grazie alla formulazione
Forum Top L antiperonosporico che contribuisce a una gestione ottimale del lavoro in campo 2013 Forum Top: l antiperonosporico che contribuisce a una gestione ottimale del lavoro in campo Grazie alla formulazione
Dr.ssa Francesca Ciampini. ISVEA - Le tecniche analitiche di monitoraggio del Brettanomyces
 Le Tecniche Analitiche di monitoraggio del Brettanomyces Dr.ssa Francesca Ciampini Brettanomyces sp. La scoperta e le prime classificazioni dalle fermentazioni secondarie della birra (N.H. Claussen 1904).
Le Tecniche Analitiche di monitoraggio del Brettanomyces Dr.ssa Francesca Ciampini Brettanomyces sp. La scoperta e le prime classificazioni dalle fermentazioni secondarie della birra (N.H. Claussen 1904).
ELABORARE VINI ROSSI ROTONDI E FRUTTATI: DUE CHIAVI PER RACCOGLIERE LA SFIDA.
 FAUVEAU ET AL., ELABORARE VINI ROSSI ROTONDI E FRUTTATI, PAG. 1 ELABORARE VINI ROSSI ROTONDI E FRUTTATI: DUE CHIAVI PER RACCOGLIERE LA SFIDA. Céline FAUVEAU, Céline BAJARD-SPARROW, Catherine GRASSIN, Patrice
FAUVEAU ET AL., ELABORARE VINI ROSSI ROTONDI E FRUTTATI, PAG. 1 ELABORARE VINI ROSSI ROTONDI E FRUTTATI: DUE CHIAVI PER RACCOGLIERE LA SFIDA. Céline FAUVEAU, Céline BAJARD-SPARROW, Catherine GRASSIN, Patrice
Effetti della vendemmia di uve a temperatura elevata sulla qualità del vino
 Effetti della vendemmia di uve a temperatura elevata sulla qualità del vino È più critica per la qualità dell uva e del vino la raccolta o la maturazione in condizioni di temperatura elevata? Come viene
Effetti della vendemmia di uve a temperatura elevata sulla qualità del vino È più critica per la qualità dell uva e del vino la raccolta o la maturazione in condizioni di temperatura elevata? Come viene
Soluzioni allergen free per una chiarifica razionale dei mosti e dei vini, secondo la Dir. 2007/68/CE
 Chiarificanti P Soluzioni allergen free per una chiarifica razionale dei mosti e dei vini, secondo la Dir. 2007/68/CE A seguito dell entrata in vigore della direttiva comunitaria 2007/68/CE, i vini che
Chiarificanti P Soluzioni allergen free per una chiarifica razionale dei mosti e dei vini, secondo la Dir. 2007/68/CE A seguito dell entrata in vigore della direttiva comunitaria 2007/68/CE, i vini che
Caratteristiche dei vitigni e riconoscimento delle uve. - caratteristiche botaniche della specie Vitis vinifera
 Modulo n. 1 Caratteristiche dei vitigni e riconoscimento delle uve - caratteristiche botaniche della specie Vitis vinifera Durata in ore 20 - fasi fenologiche della vite, dalla gemma al grappolo maturo
Modulo n. 1 Caratteristiche dei vitigni e riconoscimento delle uve - caratteristiche botaniche della specie Vitis vinifera Durata in ore 20 - fasi fenologiche della vite, dalla gemma al grappolo maturo
TENUTA TRESANTI SCHEDE TECNICHE
 TENUTA TRESANTI SCHEDE TECNICHE Memento Rosso Toscana I.G.T. ESPOSIZIONE DEI VIGNETI: per la produzione del Memento si utilizzano le posizioni più fresche ed ariose; pleistocenica, che determinano terreni
TENUTA TRESANTI SCHEDE TECNICHE Memento Rosso Toscana I.G.T. ESPOSIZIONE DEI VIGNETI: per la produzione del Memento si utilizzano le posizioni più fresche ed ariose; pleistocenica, che determinano terreni
Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche
 Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche Modifica del 15 novembre 2006 Il Dipartimento federale dell interno ordina: I L ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 1 sulle bevande alcoliche è modificata come
Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche Modifica del 15 novembre 2006 Il Dipartimento federale dell interno ordina: I L ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 1 sulle bevande alcoliche è modificata come
Data di vendemmia: Merlot 1^ settimana di Settembre, Cabernet 1^ settimana di Ottobre. Fermentazione malolattica:
 IGT TOSCANA ROSSO 'RAFELE' E l unico vino di Poggio Trevvalle prodotto senza l impiego di uve Sangiovese. Di colore rosso rubino cupo, ha un complessità olfattiva che spazia dalla frutta matura alle spezie.
IGT TOSCANA ROSSO 'RAFELE' E l unico vino di Poggio Trevvalle prodotto senza l impiego di uve Sangiovese. Di colore rosso rubino cupo, ha un complessità olfattiva che spazia dalla frutta matura alle spezie.
Legami chimici. Covalente. Legami deboli
 Legami chimici Covalente Legami deboli Legame fosfodiesterico Legami deboli Legami idrogeno Interazioni idrofobiche Attrazioni di Van der Waals Legami ionici STRUTTURA TERZIARIA La struttura tridimensionale
Legami chimici Covalente Legami deboli Legame fosfodiesterico Legami deboli Legami idrogeno Interazioni idrofobiche Attrazioni di Van der Waals Legami ionici STRUTTURA TERZIARIA La struttura tridimensionale
LA PREVENZIONE DELLA PRECIPITAZIONE DEI SALI DELL'ACIDO TARTARICO Fonti principali. Prof. Vincenzo Leo - Chimica Enologica - ITA Emilio Sereni 1
 LA PREVENZIONE DELLA PRECIPITAZIONE DEI SALI DELL'ACIDO TARTARICO Fonti principali Prof. Vincenzo Leo - Chimica Enologica - ITA Emilio Sereni 1 La precipitazione dei sali dell'acido tartarico Il problema
LA PREVENZIONE DELLA PRECIPITAZIONE DEI SALI DELL'ACIDO TARTARICO Fonti principali Prof. Vincenzo Leo - Chimica Enologica - ITA Emilio Sereni 1 La precipitazione dei sali dell'acido tartarico Il problema
RISPOSTE SULLA MALOLATTICA
 LONVAUD, RISPOSTE SULLA MALOLATTICA, PAG. 1 RISPOSTE SULLA MALOLATTICA Aline Lonvaud, Faculté d oenologie, Talence, Bordeaux France Che cosa indica il termine FML in vinificazione? La fermentazione malolattica
LONVAUD, RISPOSTE SULLA MALOLATTICA, PAG. 1 RISPOSTE SULLA MALOLATTICA Aline Lonvaud, Faculté d oenologie, Talence, Bordeaux France Che cosa indica il termine FML in vinificazione? La fermentazione malolattica
VELLETRI, CREA: "LE STAGIONI DELLA VITE" SI CONCLUDE CON LA FESTA DELLA VENDEMMIA 22/09/ :56:00
 Eventi VELLETRI, CREA: "LE STAGIONI DELLA VITE" SI CONCLUDE CON LA FESTA DELLA VENDEMMIA 22/09/2015 07:56:00 Una trentina di sommelier di Roma e Provincia per l ultimo degli approfondimenti organizzati
Eventi VELLETRI, CREA: "LE STAGIONI DELLA VITE" SI CONCLUDE CON LA FESTA DELLA VENDEMMIA 22/09/2015 07:56:00 Una trentina di sommelier di Roma e Provincia per l ultimo degli approfondimenti organizzati
TERMOVINIFICAZIONI DEI VINI ROSSI : VINIFICAZIONE DELLE UVE ALTERATE
 DELTEIL, TERMOVINIFICAZIONE DI UVE ALTERATE, PAG. 1 TERMOVINIFICAZIONI DEI VINI ROSSI : VINIFICAZIONE DELLE UVE ALTERATE Dominique DELTEIL, ICV Montpellier 1 Le basi per la gestione delle uve, quando la
DELTEIL, TERMOVINIFICAZIONE DI UVE ALTERATE, PAG. 1 TERMOVINIFICAZIONI DEI VINI ROSSI : VINIFICAZIONE DELLE UVE ALTERATE Dominique DELTEIL, ICV Montpellier 1 Le basi per la gestione delle uve, quando la
NomaSense PolyScan. Analisi dei componenti ossidabili presenti in uva e vini
 NomaSense PolyScan Analisi dei componenti ossidabili presenti in uva e vini Fenoli presenti in uva e vino Principali fattori determinanti per la qualità tecnologica e percepita di uva e vino Direttamente
NomaSense PolyScan Analisi dei componenti ossidabili presenti in uva e vini Fenoli presenti in uva e vino Principali fattori determinanti per la qualità tecnologica e percepita di uva e vino Direttamente
Le proprietà periodiche degli elementi. Lezioni d'autore
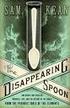 Le proprietà periodiche degli elementi Lezioni d'autore VIDEO VIDEO Introduzione (I) Le proprietà degli elementi mostrano delle tendenze che possono essere predette usando il sistema periodico ed essere
Le proprietà periodiche degli elementi Lezioni d'autore VIDEO VIDEO Introduzione (I) Le proprietà degli elementi mostrano delle tendenze che possono essere predette usando il sistema periodico ed essere
in cantina SECCO O FRESCO
 Reidratazione di lieviti secchi attivi. SECCO O FRESCO PURCHÉ DI QUALITÀ SELEZIONATO PER L OBIETTIVO ENOLOGICO DESIDERATO E RISPONDENTE A IRRINUNCIABILI STANDARD QUALITATIVI: ECCO IL LIEVITO GIUSTO, INDIPENDENTEMENTE
Reidratazione di lieviti secchi attivi. SECCO O FRESCO PURCHÉ DI QUALITÀ SELEZIONATO PER L OBIETTIVO ENOLOGICO DESIDERATO E RISPONDENTE A IRRINUNCIABILI STANDARD QUALITATIVI: ECCO IL LIEVITO GIUSTO, INDIPENDENTEMENTE
IL PIACERE DELLA VITA COLLANA DI CHIMICA DEGLI ALIMENTI MONOGRAFIE
 IL PIACERE DELLA VITA COLLANA DI CHIMICA DEGLI ALIMENTI MONOGRAFIE 4 Direttore Lydia FERRARA Università degli Studi di Napoli Federico II Comitato scientifico Daniele NAVIGLIO Università degli Studi di
IL PIACERE DELLA VITA COLLANA DI CHIMICA DEGLI ALIMENTI MONOGRAFIE 4 Direttore Lydia FERRARA Università degli Studi di Napoli Federico II Comitato scientifico Daniele NAVIGLIO Università degli Studi di
LIFE CYCLE ASSESSMENT:
 LIFE CYCLE ASSESSMENT: strumento che permette di valutare gli impatti ambientali associati al CICLO DI VITA di un prodotto, processo o attività, attraverso l identificazione e la quantificazione dei consumi
LIFE CYCLE ASSESSMENT: strumento che permette di valutare gli impatti ambientali associati al CICLO DI VITA di un prodotto, processo o attività, attraverso l identificazione e la quantificazione dei consumi
le tecnologie di vinificazione (I parte)
 le tecnologie di vinificazione (I parte) Gianpaolo Andrich email:gandrich@agr.unipi.it Vigna Cantina Accumulo granuli di amido Depolimerizzazione granuli di amido Fruttosio Glucosio Fruttosio Glucosio
le tecnologie di vinificazione (I parte) Gianpaolo Andrich email:gandrich@agr.unipi.it Vigna Cantina Accumulo granuli di amido Depolimerizzazione granuli di amido Fruttosio Glucosio Fruttosio Glucosio
LAFFORT - INFO. Affinamento dei vini bianchi sulle fecce, seconda parte: impatto sull evoluzione e sulla tipicità dei vini. NUMERO 35 Luglio 2004
 LAFFRT-INF LAFFRT - INF NUMER Luglio Affinamento dei vini bianchi sulle fecce, seconda parte: impatto sull evoluzione e sulla tipicità dei vini Valerie LAVIGNE Faculté d Œnologie del Université Victor
LAFFRT-INF LAFFRT - INF NUMER Luglio Affinamento dei vini bianchi sulle fecce, seconda parte: impatto sull evoluzione e sulla tipicità dei vini Valerie LAVIGNE Faculté d Œnologie del Université Victor
Elemento fondamentale
 Acqua Elemento fondamentale Usata x 90% Produzione Malteria Caldaie frigoriferi Lavaggio e sterilizzazione Ruoli dell acqua Permette il trasporto e la distribuzione nelle cellule delle sostanze Garantisce
Acqua Elemento fondamentale Usata x 90% Produzione Malteria Caldaie frigoriferi Lavaggio e sterilizzazione Ruoli dell acqua Permette il trasporto e la distribuzione nelle cellule delle sostanze Garantisce
STUDIO DELLA COMPOSIZIONE E DEL POTERE ANTIOSSIDANTE DI PRODOTTI DERIVATI DA MIRTILLI
 FILIERA MIRTILLI Valorizzazione della produzione locale attraverso l ottimizzazione delle operazioni lungo la filiera (raccolta, distribuzione del fresco, trasformazioni di alta qualità) Realizzazione
FILIERA MIRTILLI Valorizzazione della produzione locale attraverso l ottimizzazione delle operazioni lungo la filiera (raccolta, distribuzione del fresco, trasformazioni di alta qualità) Realizzazione
CATALOGO GENERALE Oenoitalia Biotecnologie s.r.l
 CATALOGO GENERALE Spesso le idee si accendono l'una con l'altra come scintille elettriche Nicola Tesla UN IDEA DI QUALITA SI TRASFORMA IN UN AZIENDA DI SUCCESSO Il Gruppo Oenoitalia, da lungo tempo impegnato
CATALOGO GENERALE Spesso le idee si accendono l'una con l'altra come scintille elettriche Nicola Tesla UN IDEA DI QUALITA SI TRASFORMA IN UN AZIENDA DI SUCCESSO Il Gruppo Oenoitalia, da lungo tempo impegnato
Frazioni. 18 gennaio Gruppo d esperti Regolamentazione e diritto
 Gruppo d esperti Regolamentazione e diritto 18 gennaio 2006 Frazioni IL Professor Monika Christmann, Presidente del gruppo d esperti «Tecnologia del Vino» dell Organizzazione Internazionale della Vigna
Gruppo d esperti Regolamentazione e diritto 18 gennaio 2006 Frazioni IL Professor Monika Christmann, Presidente del gruppo d esperti «Tecnologia del Vino» dell Organizzazione Internazionale della Vigna
Studio Comparativo di Due Tecniche di Tostatura della Barrique di Rovere. Realizzato per. Tonelería Nacional
 Studio Comparativo di Due Tecniche di Tostatura della Barrique di Rovere Realizzato per Tonelería Nacional da Laboratoire EXCELL 33700 MERIGNAC (France) I differenti metodi di tostatura utilizzati da Tonelería
Studio Comparativo di Due Tecniche di Tostatura della Barrique di Rovere Realizzato per Tonelería Nacional da Laboratoire EXCELL 33700 MERIGNAC (France) I differenti metodi di tostatura utilizzati da Tonelería
INTRODUZIONE ALLA TERMODINAMICA. Supponiamo di voler studiare il comportamento di una determinata quantità di gas contenuta
 INTRODUZIONE ALLA TERMODINAMICA Supponiamo di voler studiare il comportamento di una determinata quantità di gas contenuta in un recipiente, ad esempio 5g di ossigeno. Dato l elevato numero di molecole
INTRODUZIONE ALLA TERMODINAMICA Supponiamo di voler studiare il comportamento di una determinata quantità di gas contenuta in un recipiente, ad esempio 5g di ossigeno. Dato l elevato numero di molecole
La mobilità degli elementi chimici
 La mobilità degli elementi chimici Gli ioni contenuti nella parte sinistra del diagramma sono quelli che in soluzione si presentano sotto forma di cationi semplici. Gli ioni nella parte centrale del diagramma
La mobilità degli elementi chimici Gli ioni contenuti nella parte sinistra del diagramma sono quelli che in soluzione si presentano sotto forma di cationi semplici. Gli ioni nella parte centrale del diagramma
Risultati secondo monitoraggio giovani in servizio e OLP Università di Pavia progetti avviati il 2 aprile 2012
 Risultati secondo monitoraggio giovani in servizio e OLP Università di Pavia progetti avviati il 2 aprile 2012 (Pavia, 28 novembre 2012) 1. Progetto Career Guidance - Area progettuale Ufficio Mobilità
Risultati secondo monitoraggio giovani in servizio e OLP Università di Pavia progetti avviati il 2 aprile 2012 (Pavia, 28 novembre 2012) 1. Progetto Career Guidance - Area progettuale Ufficio Mobilità
RISOLUZIONE ECO 3/2004 LIVELLO DI BASE RICHIESTO PER IL CONFERIMENTO DI DIPLOMA AI PROFESSIONISTI COINVOLTI NELLE PRATICHE ENOLOGICHE
 LIVELLO DI BASE RICHIESTO PER IL CONFERIMENTO DI DIPLOMA AI PROFESSIONISTI COINVOLTI NELLE PRATICHE ENOLOGICHE L ASSEMBLEA GENERALE, su proposta della Commissione III «Economia», sulla base dei lavori
LIVELLO DI BASE RICHIESTO PER IL CONFERIMENTO DI DIPLOMA AI PROFESSIONISTI COINVOLTI NELLE PRATICHE ENOLOGICHE L ASSEMBLEA GENERALE, su proposta della Commissione III «Economia», sulla base dei lavori
LINEA ELECTIS ANTIPERONOSPORICO. La massima Protezione del grappolo
 LINEA ANTIPERONOSPORICO La massima Protezione del grappolo LINEA La peronospora della vite La peronospora è la più grave malattia che attacca la Vite. L agente patogeno, Plasmopara viticola, può infettare
LINEA ANTIPERONOSPORICO La massima Protezione del grappolo LINEA La peronospora della vite La peronospora è la più grave malattia che attacca la Vite. L agente patogeno, Plasmopara viticola, può infettare
28 marzo 2013 ASTRA Tebano Castellari Lorena e Jacopo Giovannini SELEZIONE DI LIEVITI AUTOCTONI PER LA VALORIZZAZIONE DI VINI ALBANA E SANGIOVESE DI
 28 marzo 2013 ASTRA Tebano Castellari Lorena e Jacopo Giovannini SELEZIONE DI LIEVITI AUTOCTONI PER LA VALORIZZAZIONE DI VINI ALBANA E SANGIOVESE DI UN AZIENDA DELL IMOLESE Premessa Lieviti indigeni/autoctoni
28 marzo 2013 ASTRA Tebano Castellari Lorena e Jacopo Giovannini SELEZIONE DI LIEVITI AUTOCTONI PER LA VALORIZZAZIONE DI VINI ALBANA E SANGIOVESE DI UN AZIENDA DELL IMOLESE Premessa Lieviti indigeni/autoctoni
RELAZIONE DEL PROGETTO RECUPERO DEL NIBIO DI TASSAROLO ANNO 2006 A cura dei Tecnici del Centro
 RELAZIONE DEL PROGETTO RECUPERO DEL NIBIO DI TASSAROLO ANNO 2006 A cura dei Tecnici del Centro Introduzione Nell anno 2000 il Centro Sperimentale Vitivinicolo Tenuta Cannona di Carpeneto venne contattato
RELAZIONE DEL PROGETTO RECUPERO DEL NIBIO DI TASSAROLO ANNO 2006 A cura dei Tecnici del Centro Introduzione Nell anno 2000 il Centro Sperimentale Vitivinicolo Tenuta Cannona di Carpeneto venne contattato
Prove di corrosione di vari acciai in miscele ternarie di nitrati fusi. E. Veca, M. Agostini, P. Tarquini. Report RdS/PAR2013/249
 Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l energia e lo sviluppo economico sostenibile MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Prove di corrosione di vari acciai in miscele ternarie di nitrati fusi E. Veca,
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l energia e lo sviluppo economico sostenibile MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Prove di corrosione di vari acciai in miscele ternarie di nitrati fusi E. Veca,
Cantus. Oidio e Botrite in un unica soluzione, a difesa della qualità
 Cantus Oidio e Botrite in un unica soluzione, a difesa della qualità Cantus Oidio e Botrite in un unica soluzione Le infezioni di Oidio, se non adeguatamente controllate, possono incidere negativamente
Cantus Oidio e Botrite in un unica soluzione, a difesa della qualità Cantus Oidio e Botrite in un unica soluzione Le infezioni di Oidio, se non adeguatamente controllate, possono incidere negativamente
L UVA E GLI INDICI DI QUALITA
 L UVA E GLI INDICI DI QUALITA PERCORSI ABILITANTI SPECIALI, 2014, CLASSE A057 e A058 Università degli Studi della Basilicata Prof.ssa Angela Carlucci INDUSTRIE AGRARIE E MECCANIZZAZIONE L ACINO La qualità
L UVA E GLI INDICI DI QUALITA PERCORSI ABILITANTI SPECIALI, 2014, CLASSE A057 e A058 Università degli Studi della Basilicata Prof.ssa Angela Carlucci INDUSTRIE AGRARIE E MECCANIZZAZIONE L ACINO La qualità
Università Degli Studi di Cagliari Facoltà Farmacia Corso di laurea in Tossicologia. Corso di Analisi Chimico-Tossicologica.
 Università Degli Studi di Cagliari Facoltà Farmacia Corso di laurea in Tossicologia Corso di Analisi Chimico-Tossicologica Distillazione La distillazione La distillazione consiste nel vaporizzare un liquido
Università Degli Studi di Cagliari Facoltà Farmacia Corso di laurea in Tossicologia Corso di Analisi Chimico-Tossicologica Distillazione La distillazione La distillazione consiste nel vaporizzare un liquido
L Azienda. Stoppervini SAGL - Via Losanna 1a - CH-6900 Lugano -
 L Azienda La Fattoria di Poggio Capponi domina da un colle della zona di Montespertoli uno splendido paesaggio di vigne, olivi, grano e cipressi. L azienda si estende su un territorio di 500 ettari. Produce
L Azienda La Fattoria di Poggio Capponi domina da un colle della zona di Montespertoli uno splendido paesaggio di vigne, olivi, grano e cipressi. L azienda si estende su un territorio di 500 ettari. Produce
