UNA NUOVA METODOLOGIA PER LA PREVISIONE DELLE VIBRAZIONI INDOTTE DAL TRAFFICO STRADALE E FERROVIARIO
|
|
|
- Benedetta Carlini
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 UNA NUOVA METODOLOGIA PER LA PREVISIONE DELLE VIBRAZIONI INDOTTE DAL TRAFFICO STRADALE E FERROVIARIO Feerico Rossi(1), Anrea e Lieto Vollaro(), Anrea Nicolini(1) (1)Università egli Sti i Pergia, Dipartimento i Ingegneria Instriale ()Università egli Sti La Sapienza, Dipartimento i Fisica Tecnica 1. Introzione Gli effetti che l esposizione alle vibrazioni eterminano sll omo sono sostanzialmente i natra psicologica e biologica: i primi consistono in istrbi nero-psichici che coinvolgono i terminali nervosi periferici; i seconi interessano il sistema nervoso e qello osseo, provocano amenti ella pressione sangigna e el battito cariaco, attenazione ei riflessi, varie forme i artrosi e iscopatie. Gli effetti possono variare in relazione alle caratteristiche fisiche el fenomeno, ai tempi e alle moalità i erogazione, e sono classificabili come effetti i anno, i istrbo o semplicemente i fastiio. L aspetto più importante nello stio ella componente vibrazioni rigara, tttavia, l effetto provocato a qeste ltime slle strttre eilizie, e in particolare s manfatti antichi i valore storico-artistico. Infatti se la propagazione elle vibrazioni avviene in terreni costititi a materiali incoerenti o a bassa ensità, qesti ltimi possono sbire egli assestamenti, tanto più evienti se si tratta i sabbie in presenza i fala freatica, provocano ceimenti ifferenziali ei manfatti. A tale proposito sono stati proposti vari limiti ai valori ella freqenza, ell'accelerazione e ell'ampiezza elle vibrazioni, per prevenire il anno agli eifici; tttavia per il patrimonio monmentale, archeologico e artistico, il problema è più complesso, in qanto la reazione alle sollecitazioni per ciascna opera è inflenzata a vari parametri qali: la tipologia, le imensioni, l'età, lo stato i conservazione, il valore intrinseco, ecc. Sono tttavia isponibili valori limite elle vibrazioni, il speramento ei qali pò eterminare conizioni i rischio. La legislazione italiana in materia i vibrazioni e i prevenzione ei rischi a esse erivanti è sprovvista i specifici provveimenti; è nqe necessario fare riferimento alla normativa tecnica e in particolare alle UNI 9916 e UNI 9614 che stabiliscono le moalità i misra elle vibrazioni negli eifici e ne fissano i limiti i ammissibilità [1, ]. In particolare, le valtazioni i impatto ambientale richieono la stima ei livelli i vibrazione inotti a carichi in movimento qali treni e veicoli s straa [3, 4]. Sebbene siano state proposte alcne complesse procere i valtazione elle vibrazioni, che richieono lnghi tempi i calcolo e n elevato nmero i ati i inpt, allo stato attale nessn metoo pratico è isponibile per la stima elle vibrazioni inotte a treni o veicoli s straa [5]. Le valtazioni i 1
2 impatto ambientale, relativamente alla componente vibrazioni, sono spesso effettate senza l impiego i n moello matematico, ma semplicemente escriveno i possibili effetti macroscopici inotti alle vibrazioni stesse [6]. In qesto lavoro sono proposti e metoi i stima, pratici e semplici, per la previsione elle vibrazioni inotte rispettivamente ai treni e a veicoli s straa. Il primo metoo è stato introotto relativamente a treni a alta velocità. I ati i ingresso el moello sono la velocità e la massa el treno, la geometria elle rotaie, le caratteristiche el solo e la istanza tra rotaie e pnto i stima. I risltati el moello sono forniti in termini i velocità massima r.m.s. el solo e livello i vibrazione. Il moello è stato calibrato per mezzo i risltati i misre effettate lngo na linea ferroviaria italiana. Inoltre, i risltati ottenti meiante il moello proposto sono stati confrontati con nmerosi ati sperimentali isponibili a campagne i misra conotte lngo linee ferroviarie eropee a alta velocità. Il confronto ha mostrato che l errore massimo fornito al moello è inferiore a.5 B, anche se non sono note ma solo stimabili le caratteristiche el solo. E stato inoltre valtato il caso peggiore in conizioni conservative in moo a testare il moello qano le proprietà el solo non sono neanche stimabili. Nella secona parte el lavoro è proposta na semplice metoologia per la stima elle vibrazioni inotte a veicoli s straa. Il metoo è basato s n moellazione ella sorgente i vibrazioni e n moello i propagazione. La metoologia proposta consente i stimare i livelli i vibrazione ovti a na straa impiegano come ati i ingresso i flssi i traffico e la velocità ei veicoli. I ati i ingresso el moello ella sorgente i vibrazioni sono la tipologia el veicolo e la sa velocità: i ati i scita sono l accelerazione r.m.s. e il livello ovto a n singolo evento (il passaggio i n veicolo). I livelli i accelerazione ovti a n singolo evento sono stati iniviati relativamente a tre iverse tipologie i veicoli (atomobili, frgoni e camion) per mezzo i na campagna i misre. Il moello i propagazione consente invece i eterminare i livelli i vibrazione a iverse istanze alla straa, consierano gli effetti ovti all assorbimento el solo e alla ivergenza. I risltati forniti al moello sono ati in termini i accelerazione r.m.s. e livello i vibrazione. Una campagna i misre è stata conotta allo scopo i confrontare i livelli misrati a iverse istanze alla straa con qelli ottenti meiante il metoo proposto. I risltati elle misre hanno mostrato che gli errori i stima ovti al metoo iniviato sono inferiori a 1.5 B.. Moello i previsione elle vibrazioni inotte nel terreno al transito i treni La stima elle velocità r.m.s. el solo inotte al passaggio i treni a na ata istanza alla linea ferroviaria prevee la moellazione sia ella sorgente i vibrazioni che ei fenomeni i propagazione elle stesse..1 Moellazione ella sorgente i vibrazioni Il trasferimento ell energia prootta alla sorgente i vibrazioni (treno e terrapieno) al solo è n fenomeno istantaneo governato a complessi meccanismi il ci anamento è ifficilmente ientificabile [7, 8]. Si introce qini la segente ipotesi semplificativa: na porzione costante ella potenza meia trasferita al treno in movimento al sistema ballast-terrapieno è poi ritrasferita al solo circostante. Tale ipotesi è verificata se il sistema ballast-terrapieno e gli elementi i collegamento sono niformi s ttta la linea ferroviaria; in tal caso, si pò scrivere la segente espressione: K W (1) T ove la costante K eve essere iniviata calibrano il moello. W
3 La potenza meia W T trasferita al treno al sistema ballast-terrapieno ipene alla velocità el treno, alla massa el treno, alla lnghezza ello stesso e alla geometria ella linea ferroviaria. Per eterminare W T, si introce la massa specifica el treno come: M m () T L energia meia trasferita al treno per nità i lnghezza è ata a: (3) e m g s ove s è il massimo spostamento verticale ammesso per la rotaia a segito el passaggio el treno [9-11]. Il massimo spostamento verticale è scelto in moo a aottare ipotesi conservative. La potenza è ricavata assmeno che l energia è trasferita al sistema ballast-terrapieno per mezzo elle traversine; inoltre, l energia, come espressa all Eq. (3), è rilasciata nell intervallo i tempo in ci il treno viaggia a na traversina alla sccessiva. In base a sette ipotesi, la potenza associata all Eq. (3) è ata a: w T v m g s (4) i La potenza trasferita al sistema ballast-terrapieno a na porzione x el treno è: W T (5) i In base all Eq. (1), la potenza meia ritrasferita al ballast-terrapieno al solo a na porzione x el treno è ata a: (6) T v m g s T x vt W m g s K x i. Moello i propagazione I fenomeni i propagazione elle one i vibrazione sono stati moellati aottano le segenti ipotesi: A. il terrapieno è na sorgente emittente contina la lnghezza ella qale corrispone alla lnghezza el treno [1-15]. La potenza meia ella sorgente per nità i lnghezza è espressa all Eq. (6). B. La propagazione ell energia vibrazionale avviene slla sperficie el solo per mezzo i one i Rayleigh, la ci ampiezza ecresce esponenzialmente in irezione verticale, perpenicolarmente alla sperficie el solo [16]. L effetto elle one primarie, seconarie e i Love è trascrato [17]. C. Ogni porzione elementare ella sorgente è na sorgente pntiforme che emette energia vibrazionale in moo omniirezionale [18]. Se si consiera n mezzo non issipativo, l energia vibrazionale trasportata alle one i Rayleigh slla sperficie el solo ecresce proporzionalmente a 1/r. In base alle ipotesi A, B e C, l intensità meia in n generico pnto P pò essere ricavata calcolano la potenza che attraversa n cerchio i iametro nitario centrato in P (vei Fig.1): J r (7) π r W r rappresenta la potenza totale prootta a na sorgente elementare a istanza r alla sorgente stessa. L intensità nel pnto P, ovta all intero treno, è ata a: W r 3
4 T Wr J r π r (8) W r pò essere eterminata come sege (vei Fig.): si consieri la potenza issipata all interno i n area a forma i corona circolare centrata nella sorgente; il raggio interno ella corona circolare è r, qello esterno è r+r. La potenza issipata pò essere calcolata come la ifferenza tra la potenza che entra e qella che esce alla corona circolare. Inoltre, la potenza issipata è proporzionale alla potenza che entra nella corona circolare, allo spessore ella corona circolare e alle caratteristiche el solo, ossia alla costante i issipazione [19]: (9) (W r ) (Wr+ r W r ) Wr α r Integrano l Eq.(9), si ottiene la segente relazione: α r W (1) r W e Figra 1 schema i riferimento el moello Combinano l Eq. (6) e l Eq. (9), si ottiene: v Wr m g s (11) i In base all Eq. (11), l Eq. (8) iviene: T T K e m g s vt K e J r x π i r (1) In base allo schema i riferimento (vei Fig.1), il massimo valore ell intensità J r si ottiene qano pt/, cioè qano la posizione el treno è simmetrica rispetto alla linea perpenicolare che lo attraversa passante per il pnto P. J max è ata a: T / m g s v T K e J max x (13) T / π i x + Poiché J max è la meia temporale ella potenza massima che attraversa n cerchio i iametro nitario centrato in P, la meia temporale ella ensità i energia vibrazionale massima nel pnto P è: J max D max c (14) R α r α r x α x + 4
5 Il valore assolto ella velocità r.m.s. si ottiene combinano l Eq. (14) con la segente relazione [, 1]: (15) Dmax ρs Perciò: s R (16) Il livello assolto i vibrazione è ato alla segente relazione: (17) L 1 log ref J max ρ c ; ref 1 8 m / s Figra schema i riferimento relativo alla issipazione i energia La velocità i propagazione elle one i Rayleigh c R c R C G ρ è efinita come sege []: (18) C pò essere ricavata risolveno la segente relazione []: υ 1 υ C 8 C C (19) υ ( 1 υ) Nell Eq. (18), il molo i elasticità torsionale el solo G è efinito come mostrato nell Eq. (): () G E (1 + υ).3 Calibrazione el moello Il moello proposto è stato calibrato per mezzo i na campagna i misre. La calibrazione è necessaria allo scopo i eterminare il valore ella costante K (vei Eq. (1)). Sono stati scelti alcni pnti i misra lngo n tratto rettilineo i na linea ferroviaria a alta velocità presso la stazione i Terontola (linea ferroviaria Roma- Firenze); nessn ponte o crva è sitato vicino ai pnti i misra (vei Fig. 3). Le vibrazioni sono state misrate a 5, 1, e 4 metri alla mezzeria ella ferrovia. Le componenti i velocità elle particelle el solo sono state misrate in base allo schema i riferimento i Fig. 3, per mezzo i geofoni, e elaborate meiante n sistema i acqisizione ati [3, 4]. L elaborazione ei segnali ha consentito i calcolare le velocità r.m.s. elle particelle el solo alla storia temporale elle velocità istantanee 5
6 inotte al passaggio el treno. Il valore ella velocità r.m.s. è stato calcolato meiante il coice nmerico, impiegano le segenti relazioni: x 1 N N j x, j ; with x, j j+ 1 v x, j j (t) t y 1 N N j y, j ; with y, j j+ 1 v y, j j (t) t (1) z 1 N N j z, j ; with z, j j+ 1 v z, j j (t) t Schema i riferimento ei geofoni z y x Figra 3 fotografia el sito i misra Il sistema i elaborazione ati ha consentito inoltre i calcolare il livello i vibrazione relativo a n intervallo i tempo i 1 s. Relativamente al j-esimo intervallo i tempo i 1 s, il livello i vibrazione è efinito come sege: L j 1 log j ref log 1 () ref Si efinisce ora l intervallo i tempo N come il tempo i integrazione totale ella misra, ifferente per ogni passaggio i treno. Entro tale intervallo, ogni livello i vibrazione L j relativo a 1 s è speriore a 1 B: L (3) j > 1B La conizione ata all Eq. (3) significa che, al i fori ell intervallo i tempo N, il passaggio el treno genera livelli i vibrazione inferiori a 1 B. Le vibrazioni sono state misrate rante il passaggio i n ETR5, treno a alta velocità le ci caratteristiche sono: M6 1 3 Kg, T38m. La storia temporale el livello i vibrazione misrato rante il passaggio i n ETR5 è mostrata in Fig. 4, per na 8 m / s x,j + y,j ref + z,j 6
7 velocità el treno pari a 15Km/h e na istanza el pnto i misra alla ferrovia pari a 1 m; in qesto caso, N. Il solo circostante il sito i misra è composto a arena compressa a alta ensità le ci caratteristiche sono E9 1 6 Pa e υ. [5]. Le velocità r.m.s. misrate sono riportate in Tabella 1 per iversi valori ella velocità el treno e ella istanza el pnto i misra alla ferrovia. Il moello è stato calibrato eterminano il valore i K (vei Eq.(1)) che egaglia i risltati forniti al moello stesso (il livello ato all Eq. (17)) ai corrisponenti valori misrati. La calibrazione è stata esegita assmeno il massimo spostamento verticale ella rotaia s pari a m, ossia il massimo valore ammissibile [9]. Figra 4 storia temporale el livello i vibrazione ovto al passaggio i n treno ETR5 (velocità el treno 15Km/h, istanza el pnto i misra alla ferrovia 1m) Tabella 1 risltati elle misre. Valori elle velocità r.m.s. e ei livelli i vibrazione rante il passaggio i n ETR5 Distanza el pnto i Velocità el treno [km/h] misra alla 1 15 ferrovia [m] 1-5 [m/s] L [B] 1-5 [m/s] L [B] 1-5 [m/s] L [B] Al variare ella velocità el treno e ella istanza alla ferrovia, si ottengono ifferenti valori i K che egagliano i valori stimati al moello a qelli misrati. Ogni valore i K è comnqe molto simile al so valor meio K (vei Tabella ). Di consegenza, il moello pò essere calibrato sceglieno: (4) K K 1-6 In base alla Tabella, la ifferenza massima assolta tra i valori i K e il so valor meio è K-K max , mentre la eviazione stanar ei valori i K è σ K Calibrano il moello in base alla relazione (4), l errore massimo, in termini i livello i vibrazione stimato, è inferiore a.75 B. In base alla preceente osservazione, si sppone che K sia lo stesso per ogni linea ferroviaria a alta velocità; tale ipotesi è ammissibile perché i criteri realizzativi el ballast e el terrapieno sono gli stessi per ogni linea ferroviaria a alta velocità [6]. 7
8 Tabella valori i K che egagliano i risltati ati al moello a qelli ottenti alla campagna i misre Distanza alla ferrovia [m] Velocità el treno [km/h] K K K Meia: K , k , K-K max Valiazione el moello I livelli stimati meiante il moello proposto sono stati confrontati con i risltati i alcne campagne i misre conotte lngo le più importanti linee ferroviarie eropee a alta velocità [7]. Le caratteristiche ei treni esaminati sono riportate in Tabella 3. I risltati elle misre sono forniti in termini i livelli i vibrazione e sono isponibili per iverse conizioni i misra (istanza tra il pnto i misra e la ferrovia, velocità el treno, tipologia i treno). Il confronto tra i risltati forniti al moello e alle misre è stato effettato assmeno che le linee ferroviarie a alta velocità siano realizzate s n solo compresso a alta ensità, le ci caratteristiche si sppone siano E9 1 6 Pa, ρ Kg/m 3 an α.6 m -1 [8]; tale ipotesi è stata assnta in virtù el fatto che non sono note con esattezza le caratteristiche el solo ove sono state effettate le misre [7]. Inoltre, è possibile mostrare che i risltati forniti al moello ipenono molto ebolmente al valore el rapporto i Poisson (l errore massimo in termini i livello i vibrazione è inferiore a. B se si assme υ.3 invece che υ.18); perciò, si pò affermare che l errore i stima ovto a na ipotesi errata sl valore el rapporto i Poisson è trascrabile assmeno υ. [9]. Sebbene le preceenti ipotesi siano sostenibili, è stata esaminata anche na conizione i caso peggiore in moo a iniviare l errore massimo i stima ei livelli i vibrazione nel caso in ci non è possibile assmere alcna ipotesi sl tipo i solo. Il caso peggiore si presenta qano la ifferenza tra il livello stimato e qello misrato è la massima possibile. Si pò osservare (vei Eq. (16), (18) e ()) che il livello i vibrazione ipene al molo i Yong e alla ensità el solo in moo monotono ecrescente; perciò, la massima ifferenza tra n livello stimato e qello misrato si verifica qano il molo i Yong e la ensità el solo assmono contemporaneamente i valori minimi ammissibili o, alternativamente, i valori massimi possibili. Inoltre, assmeno i valori minimi ammissibili per il molo i Yong e la ensità el solo, si ottengono i valori più elevati ei livelli stimati. I valori minimi e massimi ammissibili per il molo i Yong e la ensità el solo sono E min Pa, ρ min Kg/m 3 ; E max Pa, ρ max Kg/m 3 [9]. I livelli i vibrazione misrati, inotti sl solo circostante ai più importanti treni a alta velocità eropei, sono riportati in Tabella 4. A casa elle ifferenti caratteristiche ei cinqe treni esaminati, le misre ei livelli i vibrazione non sono state effettate per la meesima velocità el treno ma per la velocità che generalmente caratterizza ciascn treno [3, 31]. Anche le istanze i misra sono iverse per ogni tipologia i treno. I livelli i vibrazione stimati meiante il moello proposto sono riportati in Tabella 5. 8
9 Tabella 3 caratteristiche ei treni a alta velocità i ci sono state valtate le vibrazioni inotte sl solo circostante Tipologia i treno Descrizione Massa [Kg] Lnghezza [m] Penolino EroStar TGV (Atlantiqe) TGV (North) X Velocità massima: 5 Km/h, Potenza totale: 6.4 MW Configrazione: 9 vagoni, Paese: Italia Velocità massima: 3 Km/h, Potenza totale: 1. MW Configrazione: 1 locomotiva + 18 vagoni + 1 locomotiva; Paese: Francia Velocità massima: 3 Km/h, Potenza totale: 8.8 MW Configrazione: 1 locomotiva + 1 vagoni + 1 locomotiva; Paese: Francia Velocità massima: 3 Km/h, Potenza totale: 8.8 MW Configrazione: 1 locomotiva + 1 vagoni + 1 locomotiva; Paese: Francia Velocità massima: 1 Km/h Configrazione: 1 locomotiva, 3 vagoni passeggeri, 1 vagone ristorante e an 1 vagone cabina; Paese: Svezia Tabella 4 livello i vibrazione misrato lngo alcne linee ferroviarie eropee a alta velocità [7]. Penolino Distanza tra pnto i misra e ferrovia [m] Erostar Distanza tra pnto i misra e ferrovia [m] TGV Atlantiqe Distanza tra pnto i misra e ferrovia [m] TGV North Distanza tra pnto i misra e ferrovia [m] X Distanza tra pnto i misra e ferrovia [m] B B B B B 9
10 La stima è stata effettata impiegano come ati i ingresso el moello le caratteristiche ei treni riportate in Tabella 3, nelle stesse conizioni geometriche e i velocità el treno tilizzate per le misre. Se si consiera n solo a alta ensità (E9 1 6 Pa, ρ Kg/m 3 ) per ogni caso esaminato, le ifferenze tra livelli stimati e misrati sono molto piccole (vei Tabella 5): la ifferenza meia è 1.B mentre la ifferenza massima tra n livello stimato e il corrisponente livello misrato è max.5b. Qano le proprietà el solo sono note con esattezza, gli errori i stima ovrebbero essere ancora più piccoli. Si pò inoltre evienziare come solo 6 ei 45 livelli stimati sono più bassi ei corrisponenti livelli misrati, a casa ell approccio conservativo. I livelli stimati nel caso peggiore sono riportati in Tabella 6. Tabella 5 livelli i vibrazione stimati meiante il moello proposto relativi a alcni treni eropei a alta velocità. Differenza tra livelli stimati e misrati Distanza tra pnto i stima e ferrovia [m] Penolino 4 16 L [B] [Β] L [B] [Β] L [B] [Β] Distanza tra pnto i stima e ferrovia [m] Erostar 6 16 L [B] [Β] L [B] [Β] L [B] [Β] Distanza tra pnto i stima e ferrovia [m] TGV Atlantiqe 6 16 L [B] [Β] L [B] [Β] L [B] [Β] Distanza tra pnto i stima e ferrovia [m] TGV North 6 16 L [B] [Β] L [B] [Β] L [B] [Β] Distanza tra pnto i stima e ferrovia [m] X L [B] [Β] L [B] [Β] L [B] [Β]
11 Tabella 6 caso peggiore: livelli i vibrazione stimati meiante il moello proposto e ifferenza tra valori stimati e misrati Distanza tra pnto i stima e ferrovia [m] Penolino 4 16 L [B] wr (B) L [B] wr (B) L [B] wr (B) Distanza tra pnto i stima e ferrovia [m] Erostar 6 16 L [B] wr (B) L [B] wr (B) L [B] wr (B) Distanza tra pnto i stima e ferrovia [m] TGV Atlantiqe 6 16 L [B] wr (B) L [B] wr (B) L [B] wr (B) Distanza tra pnto i stima e ferrovia [m] TGV North 6 16 L [B] wr (B) L [B] wr (B) L [B] wr (B) Distanza tra pnto i stima e ferrovia [m] X L [B] wr (B) L [B] wr (B) L [B] wr (B) Si pò imostrare che il caso peggiore si verifica qano sia il molo i Yong che la ensità el solo assmono il minimo valore ammissibile: E min Pa, ρ min Kg/m 3 [9]. Nel caso peggiore, la meia ella ifferenza tra livelli stimati e misrati è wr 4.3B mentre il valor massimo ella ifferenza tra livelli stimati e i corrisponenti livelli misrati è max,wr 5.8B. Ogni livello stimato riportato in Tabella 6 è più elevato el corrisponente livello misrato; perciò, a casa ella ipenenza el livello i vibrazione al molo i Yong e alla ensità el solo (vei Eq. (16),(18) e ()), il caso peggiore costitisce anche il caso più conservativo. 11
12 3. Moello i previsione elle vibrazioni inotte a veicoli s straa nel terreno La previsione ei livelli i accelerazione r.m.s. prootti a veicoli s straa a na eterminata istanza pò essere effettata moellano sia la sorgente i vibrazioni che i fenomeni i propagazione elle stesse. 3.1 Moellazione ella sorgente i vibrazioni Il trasferimento ell energia prootta a n singolo veicolo (la sorgente i vibrazioni) al solo è n fenomeno istantaneo governato a meccanismi complessi l anamento ei qali è ifficilmente ientificabile. Perciò, si introce la segente ipotesi: ogni passaggio i n veicolo è consierato come n singolo evento. L accelerazione r.m.s. ovta a n singolo evento e il livello i vibrazione associato al singolo evento (SEVL Single Event Vibration Level) in n ato pnto i stima ipenono alla tipologia el veicolo, alla sa velocità e alle caratteristiche el solo. La ipenenza el SEVL alle caratteristiche el solo pò essere trascrata se si consiera na breve istanza el pnto i stima alla straa. A esempio, per na istanza tra il pnto i stima e la mezzeria ella straa pari a 3 m (vei Fig. 5), l energia assorbita a n solo compresso a alta ensità rante il percorso alla sorgente al pnto i stima è inferiore al 3% (vei Eq. (7)). Perciò, l accelerazione r.m.s. a istanza pò essere rappresentata alla segente relazione: (5) a a (TYP, v v ) Il SEVL a istanza pò essere scritto come sege [3]: (6) SEVL ref a 1 log a SEVL (TYP, v v ) STRADA SUOLO 1 Figra 5 schema i riferimento el moello per veicoli s straa 3. Moello i propagazione La propagazione elle one vibrazionali è stata moellata aottano le segenti ipotesi: 1. la straa è consierata come na sorgente emittente la ci lnghezza corrispone alla lnghezza el veicolo [13].. la propagazione ell energia vibrazionale avviene slla sperficie el solo per mezzo i one i Rayleigh, la ci ampiezza ecresce esponenzialmente in irezione verticale, perpenicolarmente alla sperficie el solo. L effetto elle one primarie, seconarie e i Love è trascrato [17]. 3. Ogni sorgente emette energia vibrazionale in sperficie in moo omniirezionale [18]. Se si consiera il solo come n mezzo non issipativo, l energia vibrazionale trasportata alle one i Rayleigh attraverso la sperficie ecresce proporzionalmente a 1/. In base alle ipotesi 1, e 3, l intensità meia in n generico pnto i stima P pò 1
13 essere ricavata calcolano la potenza che attraversa n cerchio i iametro nitario centrato nel pnto P stesso: J W (7) π W rappresenta la potenza totale prootta a na sorgente elementare, isponibile a istanza alla sorgente stessa. W pò essere eterminata come sege: α (8) W W e Perciò, le intensità meie relative a na istanza generica e a na istanza i riferimento sono: W e (9) π Si pò qini scrivere la segente relazione: J J o α W e π α J α ( ) e J (3) Il valore assolto ell accelerazione r.m.s. si ottiene alla segente eqazione [14]: (31) Perciò: a J J a a (3) e: (33) a e a SEVL 1 log a α ( ) ref ; a ref 1 6 m / s 3.3 La campagna sperimentale i misra per l iniviazione el moello i previsione Una campagna i misre è stata conotta allo scopo i: - iniviare i valori i SEVL relativi a iverse tipologie i veicoli; - confrontare i valori i SEVL ottenti meiante il metoo proposto con qelli misrati al variare ella velocità el veicolo, ella tipologia ello stesso e ella istanza tra pnto i stima e straa. Sono state iniviate tre tipologie i veicoli: A) Atomobili; B) Frgoni; C) Camion. I pnti i misra sono stati scelti lngo na straa rettilinea nei pressi i Terni, in assenza i ponti, crve, incroci e fossati nelle vicinanze. Le vibrazioni sono state misrate al variare ella velocità ei veicoli alle segenti istanze alla mezzeria ella straa: - 3 m per l iniviazione i SEVL ; - 6, 7 e 1 m per il confronto tra i risltati forniti al moello e qelli ati alle misre. Le componenti ell accelerazione elle particelle el solo sono state misrate per mezzo i accelerometri (moello PCB 393C, vei Fig. 6). 13
14 z Schema i riferimento per gli accelerometri y x Figra 6 fotografia el sito i misra I segnali provenienti agli accelerometri sono stati acqisiti e elaborati per mezzo el sistema i acqisizione ati Symphonie ella 1B. L elaborazione ei segnali ha consentito i calcolare le componenti r.m.s. ell accelerazione (a x, a y e a z ) alla storia temporale elle accelerazioni istantanee inotte ai veicoli. Il solo el sito i misra è composto a arena compressa a alta ensità le ci caratteristiche sono E9 1 6 Pa e υ. [6]. Il SEVL ovto a n singolo evento (il passaggio i n veicolo) è stato calcolato come sege: (34) a SEVL 1 log a ref log 3.4 Iniviazione el moello ella sorgente i vibrazioni I risltati elle misre, ossia le accelerazioni r.m.s. misrate e i valori el SEVL relativi a na istanza i 3 m alla mezzeria ella straa, sono riportati in Tabella 7 per le tipologie i veicoli A, B e C al variare ella velocità ei veicoli stessi. I risltati hanno consentito i ricavare la segente relazione per l iniviazione i SEVL : v v a K ln ; v v a x + a a y ref 4 km / h (35) ove: K.189 m/s - (tipologia A - atomobile) (36) K.68 m/s - (tipologia B - frgone) K.175 m/s - (tipologia C - camion) SEVL pò essere stimato a iverse istanze combinano le Eq. (3), (33) e (35): v K ln v SEVL log v e a ref α ( ) (37) Perciò, il moello proposto consente i stimare il livello i vibrazione ovto a na straa a na generica istanza conosceno i flssi i traffico N i relativi alle iverse tipologie i veicoli: + a z 14
15 (38) VL 1 log 1 SEVLcar Ncar SEVLvan Nvan SEVLtrck Ntrck 1 Tabella 7 risltati elle misre per l iniviazione el SEVL Tipologia i veicolo Velocità el veicolo Valori i accelerazione r.m.s. misrati SEVL misrato (km/h) (m/s ) (B) A 7,4, , A 84,3,147 6,98 A 87,, ,34 A 94,7, ,4 A 96,5, ,4 A 11,4, ,9 A 1,4, ,99 A 15,, , A 19,9,189 65,6 A 115,5,45 66,4 A 17,9,54 66,84 A 14,6,369 67,61 B 65,,359 7,4 B 7,6, ,77 B 7,5,3934 7,16 B 78,6, ,7 B 84,,595 74,11 B 85,,535 74, B 91,,579 74,97 B 95,,671 75,4 B 11,,631 76,3 B 115,6, ,19 B 1,5, ,53 B 15,, ,8 C 55,1,3934 7, C 61,6, ,8 C 65,5, ,97 C 7,1, ,9 C 71,7, ,43 C 77,3, ,49 C 78,1, ,63 C 8,4, ,99 C 86,6, ,87 C 88,,9873 8,7 C 9,1,119 8,3 C 1,, , Valiazione el moello Le Tabelle 8, 9 e 1 mostrano il confronto tra i valori i SEVL misrati e qelli ottenti meiante il moello proposto per iverse istanze tra pnto i stima e straa. Il massimo valore ell errore i stima è: 15
16 - inferiore a 1. B (tipologia A - atomobile); - inferiore a 1. B (tipologia B - frgone); - inferiore a 1.5 B (tipologia C - camion). Gli errori i stima massimi relativi alla tipologia C sono speriori a qelli elle tipologie A e B. Ciò è ovto al fatto che la massa i n camion è fortemente ipenente al carico trasportato. Tabella 8 confronto tra il metoo i stima proposto e i risltati elle misre (tipologia i veicolo A) Distanza tra pnto i Velocità el SEVL misrato SEVL stimato stima e straa veicolo (km/h) (B) (B) (B) (m) 6 113,7 6,1 6,77, , 53,8 53,16 -,65 7 6, 54,31 54,58,7 7 75,9 57,56 57,81,5 7 86,8 59,34 59,46, , 59,96 59,6 -, ,6 59,34 6,7, ,6 59,87 6,58,7 7 13, 61,34 61,19 -, ,9 6,48 6,98,5 1 73, 55,19 55,58, ,1 58,33 58,75, , 59,87 6,68,81 Tabella 9 confronto tra il metoo i stima proposto e i risltati elle misre (tipologia i veicolo B) Distanza tra pnto Velocità el SEVL misrato SEVL stimato i stima e straa veicolo (km/h) (B) (B) (B) (m) 6 88,4 7,79 71,5,7 6 9,3 71, 71,75, ,7 7,6 73,77 1,15 7 9,1 7,6 71,5-1, 7 95,6 7,38 71,63 -, ,4 71,6 7,19,57 7 1,3 7,6 7,8, 7 1,4 73,18 73,67, , 65,88 65,64 -,4 1 7,5 65,37 66,1,84 1 7,1 66,14 66,55, ,6 68,69 69,51,8 1 99,6 7,4 7,35,31 16
17 Tabella 1 confronto tra il metoo i stima proposto e i risltati elle misre (tipologia i veicolo C) Distanza tra pnto Velocità el SEVL misrato SEVL stimato i stima e straa veicolo (km/h) (B) (B) (B) (m) 6 6,1 7,94 71,84,9 6 11,1 78,78 79,8,3 6 73,8 73,3 74,7 1,4 7 69,9 73,51 73, -, ,8 73,8 74,18, ,9 73,9 74,73,81 7 8,1 74,69 75,8, ,6 75,43 76,, ,3 76,9 76,1 -, 7 95,4 76,45 77,4,59 1 7,4 7,94 71,6,69 1 8,7 73,51 73,79,9 1 9,6 74,69 75,5,36 4. Conclsioni Nel presente lavoro sono stati proposti e moelli i previsione elle vibrazioni inotte sl solo a carichi in movimento: n moello è relativo ai treni, l altro ai veicoli s straa. Il primo moello proposto fornisce le velocità r.m.s. e i livelli i vibrazione inotti al transito i treni a alta velocità. Il moello è stato calibrato per mezzo i na campagna i misre conotta lngo na linea ferroviaria italiana a alta velocità rante il passaggio i treni ETR5. I valori forniti al moello setto sono stati confrontati con ati isponibili s misre ei livelli i vibrazione prootti a treni a alta velocità slle più importanti linee ferroviarie eropee. Il confronto tra valori stimati e misrati è stato effettato senza la conoscenza slle proprietà el solo; ato che sono state consierate linee a alta velocità, è stata assnta l ipotesi i solo compresso a alta ensità (E9 1 6 Pa, ρ Kg/m 3 ). La ifferenza tra livelli stimati e misrati (ifferenza meia +1.B, ifferenza massima max +.5B) costitisce n errore paragonabile a qello commesso a moelli più sofisticati [16]; l impiego i tali moelli, contrariamente a qello proposto, richiee lnghi tempi i calcolo e n elevato nmero i ati i ingresso [16]. I risltati ati al moello proposto gistificano inoltre le segenti ipotesi, preceentemente assnte: il valore ella costante i calibrazione K pò essere consierato nico per ogni linea ferroviaria a alta velocità; l assnzione i solo compresso a alta ensità per ogni linea ferroviaria a alta velocità è sostenibile se non sono isponibili ati specifici sl solo. Inoltre, la conoscenza i ati specifici slle proprietà el solo potrebbe consentire stime più accrate. Se non sono possibili ipotesi slle proprietà el solo, il moello proposto pò essere impiegato nella conizione i caso peggiore, che si verifica qano il molo i Yong e la ensità el solo assmono il minimo valore ammissibile (E3 1 6 Pa, ρ Kg/m 3 ). Paragonano i livelli stimati nel caso peggiore a qelli misrati, l errore massimo commesso al moello è +5.8B (livello stimato meno livello misrato). Tale valore pò essere consierato ammissibile come primo approccio (Srvey Metho) per na stima elle vibrazioni; infatti, i livelli stimati nel caso peggiore rappresentano n limite speriore ai livelli effettivi prootti, ate le ipotesi 17
18 conservative aottate. Il metoo proposto per la stima ei livelli i vibrazione prootti a veicoli s straa fornisce i livelli i vibrazione ovti alla straa ati i flssi i traffico e le velocità ei veicoli. Il metoo è basato slla eterminazione ei livelli i vibrazione associati al singolo evento (SEVL), ossia al passaggio i n veicolo. La sorgente i vibrazioni è stata moellata meiante na campagna i misre. I risltati elle misre hanno mostrato che i valori elle accelerazioni r.m.s ipenono alla velocità el veicolo attraverso na relazione logaritmica. L espressione el SEVL a na istanza i riferimento pari a 3 m alla straa è stata iniviata relativamente a tre tipologie i veicoli (atomobili, frgoni e camion). Un moello i propagazione simile a qello già proposto per i treni consente poi i stimare i valori ei SEVL a iverse istanze. I valori stimati sono stati confrontati con qelli ottenti meiante la campagna i misre. I risltati hanno mostrato n errore massimo i stima pari a 1.5 B. 5. Lista ei simboli Simbolo Unità i misra Descrizione a m s - Accelerazione r.m.s. a istanza a m s - Accelerazione r.m.s. alla istanza i riferimento a ref m s - Valore i riferimento ell accelerazione a x m s - Componente x ell accelerazione r.m.s. a y m s - Componente y ell accelerazione r.m.s. a z m s - Componente z ell accelerazione r.m.s. α m -1 Costante i issipazione el solo C aimensionale Costante relativa alla velocità i propagazione elle one i Rayleigh c R m s -1 Velocità i propagazione elle one i Rayleigh D max J m - Densità i energia vibrazionale massima m Distanza minima tra la ferrovia e il pnto i stima m Distanza tra pnto i stima e mezzeria ella straa m Distanza i riferimento tra pnto i stima e mezzeria ella straa B Valore meio ella ifferenza tra livelli stimati e misrati max B Valore massimo ella ifferenza tra livelli stimati e misrati max,wr B Caso peggiore: valore massimo ella ifferenza tra livelli stimati e misrati wr B Caso peggiore: valore meio ella ifferenza tra livelli stimati e misrati E Pa Molo i Yong el solo E max Pa Valore massimo el molo i Yong el solo E min Pa Valore minimo el molo i Yong el solo e J m -1 Energia trasferita al treno al sistema ballast-terrapieno per nità i lnghezza G Pa Molo i elasticità torsionale el solo g m s - Accelerazione i gravità i m Distanza tra e traversine consective Intensità i vibrazione meia trasferita al veicolo s straa al solo J W m -1 circostante a istanza Intensità i vibrazione meia trasferita al veicolo s straa al solo J W m -1 circostante a istanza Intensità i vibrazione meia trasferita qano la posizione el treno è J max W m -1 simmetrica rispetto a na linea perpenicolare che passa per il pnto i stima 18
19 J r W m -1 Intensità i vibrazione meia trasferita al treno al solo circostante a istanza r K aimensionale Costante i calibrazione el moello relativo ai treni Costante i calibrazione el moello i propagazione elle vibrazioni K m s - inotte a veicoli s straa K aimensionale Valor meio ella costante i calibrazione el moello relativo ai treni K-K max aimensionale Differenza massima assolta tra K e K L B Livello i vibrazione assolto L j B Livello i vibrazione riferito a n intervallo i 1 s M Kg Massa totale el treno m Kg m -1 Massa specifica el treno N aimensionale Nmero i intervalli a 1 s in ci sono generate vibrazioni qano il treno attraversa l area circostante il pnto i stima N i aimensionale Flsso i traffico ovto alla tipologia i-esima i veicolo p m Distanza tra x e il pnto i stima (vei Fig.1) r m Distanza tra n pnto slla sperficie el solo e n pnto che rappresenta la sorgente ρ Kg m -3 Densità el solo ρ max Kg m -3 Valore massimo ella ensità el solo ρ min Kg m -3 Valore minimo ella ensità el solo ρ s Kg m - Densità sperficiale el solo SEVL B Livello i vibrazione associato al singolo evento SEVL i B Livello i vibrazione associato al singolo evento ovto alla i-esima tipologia i veicolo SEVL B Livello i vibrazione associato al singolo evento alla istanza i riferimento s m Spostamento massimo verticale ella ferrovia σ k aimensionale Deviazione stanar i K T m Lnghezza el treno TYP acronimo Tipologia i veicolo m s -1 Velocità r.m.s. elle particelle el solo j m s -1 Velocità r.m.s. elle particelle el solo riferita a n intervallo i 1 s ref m s -1 Valore i riferimento ella velocità elle particelle el solo x m s -1 Componente x ella velocità r.m.s. elle particelle el solo Componente x ella velocità r.m.s. elle particelle el solo riferita a n x,j m s -1 intervallo i 1 s y m s -1 Componente y ella velocità r.m.s. elle particelle el solo Componente y ella velocità r.m.s. elle particelle el solo riferita a n y,j m s -1 intervallo i 1 s z m s -1 Componente z ella velocità r.m.s. elle particelle el solo Componente z ella velocità r.m.s. elle particelle el solo riferita a n z,j m s -1 intervallo i 1 s aimensionale Rapporto i Poisson el solo VL B Livello i vibrazione ovto a na straa v T m s -1 Velocità el treno v v m s -1 Velocità el veicolo s straa v x,j m s -1 Componente x ella velocità istantanea elle particelle el solo v y,j m s -1 Componente y ella velocità istantanea elle particelle el solo v z,j m s -1 Componente z ella velocità istantanea elle particelle el solo W W Potenza trasferita al veicolo s straa al solo circostante a istanza 19
20 W W Potenza trasferita al treno o al veicolo s straa al solo circostante W r W Potenza trasferita al treno al solo circostante a istanza r W r+r W Potenza trasferita al treno al solo circostante a istanza r+r W T W Potenza trasferita al treno al sistema ballast-terrapieno w T W m -1 Potenza trasferita al treno al sistema ballast-terrapieno per nità i lnghezza x m Porzione i treno 6. Bibliografia [1] UNI 9916, Criteri i misra e valtazione egli effetti elle vibrazioni sgli eifici, 1991 [] UNI 9614, Misra elle vibrazioni negli eifici e criteri i valtazione el istrbo, 199. [3] U.S. Department of Transportation, Transit Noise an Vibration Impact Assessment, Feeral Transit Aministration, Report DOT-T-95-16, April [4] Crone A, Astrp T, Finne P., Preiction of Vibrations an Strctre-Borne Noise from Railways, InterNoise 99, Floria, USA, [5] Ekevi T, Li M.X.D, Wiberg N., Aaptive Finite Element Analysis of Wave Propagation Uner Moving Loas Ince by High Spee Trains, ECCOMAS, Barcelona, September. [6] Takemiya H., Simlation for Vibration Preiction an Mitigation of Track-Gron e to Highspee Trains - Case of X- in Sween, Informal Workshop at Royal Institte of Technology, Sween, Jly 3, 1. [7] Richert F.E, Hall J.R., Vibrations of Soils an Fonations. Prentice-Hall Inc., Englewoo Cliffs, NJ, 197. [8] Lai C.G, Callerio A, Faccioli E, Martino A., Mathematical Moeling of Railway-Ince Gron Vibrations, WAVE, Bochm, Germany, December. [9] Heelis M.E, Collop A.C, Dawson A.R, Chapman D.N, Krylov V., Preicting an Measring Vertical Track Displacements on Soft Sbgraes, Railway Engineering 99, Lonon, May [1] Fryba L., Vibration of Solis an Strctres ner Moving Loas, Telfor, Lonon, [11] Fortin J.P., Dynamic Track Deformation. French Railway Review, Vol. 1, [1] Takemiya H., Preiction of Gron Vibration Ince by High-Spee Train Operation, 18 th Sino- Japan Technology Seminar, Taipei, Taiwan, [13] Le Hoec D., Moelling an Analysis of Gron Vibration Problems: a Review., Civil an Strctral Engineering Compting, Chapter 19, 1. [14] Hnt H.E.M., Measrement an Moelling of Traffic Ince Gron Vibration, Ph.D. Thesis, Cambrige University, Englan, [15] Gtowski T.G, Wittig L.E, Dym C.L., Some Aspects of the Gron Vibration Problem, Noise Control Engineering, vol. 1:3, [16] Hng H, Yang Y., A Review of Researches on Gron-Borne Vibrations with Emphasis on Those Ince by Trains, Proc. Natl. Sci. Conc., Vol. 5, No.1, 1. [17] Krylov V.V, Dawson A.R, Heelis M.E, Collop A.C., Rail Movement an Gron Waves Case by High-Spee Trains Approaching Track-Soil Critical Velocities, Proc. Instn. Mech. Engrs., Vol. 14, Part F,. [18] Beranek L.L., Noise an Vibration Control, eite by L.L. Beranek, [19] DeGrane G., Free Fiel Vibration Measrements ring the Passage of a Thalys High Spee Train, Katholieke Universiteit Leven, Report BWM--6,. [] Moncaa Lo Giice G, Santoboni S., Acstica, Masson Eitoriale, [1] Spagnolo R., Manale i Acstica, UTET Libreria, Torino, 1. [] Timoshenko S.P., Theory of Elasticity, Mc Graw Hill Inc., USA, 197. [3] Geo Space, Geo Space Geophones GS-3CT & GS-3CT, [4] DASYTec, DASYLab User Gie, 1.
21 [5] Damiani A.V, Minelli G, Pialli G., L'Unita' Falterona - Trasimeno nell'area compresa fra la Val i Chiana e la Valle Tiberina: Sezione Terontola - Abbazia i Cassiano, Carta Geologica, Sti Geologici Camerti,. [6] Heelis M.E, Collop A.C, Dawson A.R, Chapman D.N, Krylov V., Resilient Mols of Soft Soil Beneath High Spee Rail Lines, Transportation Research Boar 99, Washington D.C., Janary [7] U.S. Department of Transportation, High Spee Gron Transportation Noise an Vibration Impact Assessment, Feeral Railroa Aministration, Report N , December [8] Amick H., A Freqency-Depenent Soil Propagation Moel, SPIE Conference on Crrent Development in Vibration Control for Optomechanical Systems, Denver, Colorao, Jly [9] Mavko G, Mkerji T, Dvorkin J., The Rock Physics Hanbook, Cambrige Univ. Press, [3] Strohl M.P., Erope s High Spee Trains, [31] Sarenman H.J, Nelson J.T, Wilson G.P., Hanbook of Urban Rail Noise an Vibration Control, prepare ner contract to US DOT/Transportation System Center, Report UMTA-MA , Febrary 198. [3] Beranek L.L., Ver I.L., Noise an Vibration Control Engineering: Principles an Applications, Interscience, 199. [33] Pialli G., Carta Geologica ell Umbria,
Esercizi S A 2.0 S B. =0.2; Metodo B: S B ii)
 Si usano ue metoi ifferenti per misurare il carico i rottura i un filo i acciaio e si fanno 0 misure per ognuno ei metoi. I risultati, espressi in tonnellate, sono i seguenti: Metoo :..5.7..6.5.6.4.6.9
Si usano ue metoi ifferenti per misurare il carico i rottura i un filo i acciaio e si fanno 0 misure per ognuno ei metoi. I risultati, espressi in tonnellate, sono i seguenti: Metoo :..5.7..6.5.6.4.6.9
Fig.9-12: Schema di controllo in retroazione (FB) e in avanti (FF)
 IX6: Schemi i controllo più complessi on qesta terminologia vengono inicati schemi i controllo iversi rispetto allo schema classico in retroazione (e qini, in qesto senso, più complessi), costititi a n
IX6: Schemi i controllo più complessi on qesta terminologia vengono inicati schemi i controllo iversi rispetto allo schema classico in retroazione (e qini, in qesto senso, più complessi), costititi a n
Procedura di analisi non lineare statica per la valutazione sismica degli edifici in aggregato
 Procera i analisi non lineare statica per la valtazione sismica egli eifici in egato Giorgio Monti, Marco Vailati Dipartimento i Ingegneria Strttrale e Geotecnica, Sapienza Università i Roma, Via Gramsci
Procera i analisi non lineare statica per la valtazione sismica egli eifici in egato Giorgio Monti, Marco Vailati Dipartimento i Ingegneria Strttrale e Geotecnica, Sapienza Università i Roma, Via Gramsci
Si considera un corpo solido a forma di parallelepipedo, di spessore d [m] e facce maggiori con superficie S [m 2 ], tale che sia T 1
![Si considera un corpo solido a forma di parallelepipedo, di spessore d [m] e facce maggiori con superficie S [m 2 ], tale che sia T 1 Si considera un corpo solido a forma di parallelepipedo, di spessore d [m] e facce maggiori con superficie S [m 2 ], tale che sia T 1](/thumbs/54/34072796.jpg) I sistemi termici La resistenza termica Se ue corpi aventi temperature iverse vengono messi a contatto, si ha un passaggio i quantità i calore al corpo a temperatura maggiore verso quello a temperatura
I sistemi termici La resistenza termica Se ue corpi aventi temperature iverse vengono messi a contatto, si ha un passaggio i quantità i calore al corpo a temperatura maggiore verso quello a temperatura
Meccanica Applicata Alle Macchine. Elementi di Meccanica Teorica ed Applicata
 Meccanica Applicata Alle Macchine (Ingegneria Energetica) Elementi i Meccanica Teorica e Applicata (Scienze per l Ingegneria) Università egli Stui i oma La Sapienza Una traccia egli argomenti el Corso
Meccanica Applicata Alle Macchine (Ingegneria Energetica) Elementi i Meccanica Teorica e Applicata (Scienze per l Ingegneria) Università egli Stui i oma La Sapienza Una traccia egli argomenti el Corso
I numeri decimali. Disegniamo la linea dei numeri con i punti che individuano i numeri 0 ed 1.
 I nmeri ecimali Disegniamo la linea ei nmeri con i pnti che iniviano i nmeri 0 e. Diviiamo l nità in parti gali, cioè costriamo na linea ei nmeri in moo che allo zero ( 0 ) all nità () vi siano segnati
I nmeri ecimali Disegniamo la linea ei nmeri con i pnti che iniviano i nmeri 0 e. Diviiamo l nità in parti gali, cioè costriamo na linea ei nmeri in moo che allo zero ( 0 ) all nità () vi siano segnati
ESERCIZI SVOLTI DI FLUIDODINAMICA Parte 3: Equazione di Bernoulli Versione 1.0
 Moulo i Elementi i Fluioinamica Corso i Laurea in Ingegneria ei Materiali/Meccanica AA 00/005 Ing Paola CINNELLA ESERCIZI SVOLTI I FLUIOINAMICA Parte 3: Equazione i Bernoulli Versione 10 Esercizio 1 Si
Moulo i Elementi i Fluioinamica Corso i Laurea in Ingegneria ei Materiali/Meccanica AA 00/005 Ing Paola CINNELLA ESERCIZI SVOLTI I FLUIOINAMICA Parte 3: Equazione i Bernoulli Versione 10 Esercizio 1 Si
2. Canali radio, propagazione per canali a banda larga/stretta.
 istemi i raiocomunicazione: esercitazioni.. Canali raio, propagazione per canali a bana larga/stretta.. Definizione i bana i coerenza e tempo i coerenza Bana i coerenza B C : Misura statistica ell intervallo
istemi i raiocomunicazione: esercitazioni.. Canali raio, propagazione per canali a bana larga/stretta.. Definizione i bana i coerenza e tempo i coerenza Bana i coerenza B C : Misura statistica ell intervallo
IL TRASPORTO DEGLI INQUINANTI
 La iffusione molecolare La ispersione avviene principalmente in irezione longituinale rispetto al flusso meio, e le variazioni i velocità non spiegano l aumento l i ampiezza in irezione normale al moto
La iffusione molecolare La ispersione avviene principalmente in irezione longituinale rispetto al flusso meio, e le variazioni i velocità non spiegano l aumento l i ampiezza in irezione normale al moto
CORSO DI FISICA TECNICA 2 AA 2013/14 ILLUMINOTECNICA. Lezione n 2: Grandezze fotometriche fondamentali 2. Ing. Oreste Boccia
 CORO D FCA TECNCA AA 13/14 LLUMNOTECNCA Lezione n : Granezze fotometriche fonamentali ng. Oreste Boccia 1 LLUMNAMENTO Effetto prootto al flusso luminoso sulla superficie illuminata Granezza puntuale: varia
CORO D FCA TECNCA AA 13/14 LLUMNOTECNCA Lezione n : Granezze fotometriche fonamentali ng. Oreste Boccia 1 LLUMNAMENTO Effetto prootto al flusso luminoso sulla superficie illuminata Granezza puntuale: varia
Univ i e v r e si s t i à à deg e li i Stud u i i di i Fi F r i en e ze S i t m i a m de d ll l lene n rg r i g a i d i d
 Università egli Stui i Firenze Dipartimento i Meccanica e Tecnologie Inustriali Stima ell energia i eformazione: Metoo el Triangolo applicato all urto auto-moto Aprile 0 Metoo i ampbell (rash 3) Normalizzano
Università egli Stui i Firenze Dipartimento i Meccanica e Tecnologie Inustriali Stima ell energia i eformazione: Metoo el Triangolo applicato all urto auto-moto Aprile 0 Metoo i ampbell (rash 3) Normalizzano
Nozioni elementari di calcolo differenziale e integrale
 Nozioni elementari i calcolo ifferenziale e integrale DIPARTIMENTO DI FISICA E INFN UNIVERSITÀ DEL SALENTO a.a. 013/014 L. Renna - Dipartimento i Fisica 1 Sommario 1 Funzioni... 3 Derivate... 4 3 Integrali...
Nozioni elementari i calcolo ifferenziale e integrale DIPARTIMENTO DI FISICA E INFN UNIVERSITÀ DEL SALENTO a.a. 013/014 L. Renna - Dipartimento i Fisica 1 Sommario 1 Funzioni... 3 Derivate... 4 3 Integrali...
Esercizi Scheda N Fisica II. Esercizi con soluzione svolti
 Esercizi Schea N. 45 Fisica II Esercizio. Esercizi con soluzione svolti Si calcoli la capacità ei conensatori a piatti paralleli riempiti a iversi ielettrici come in figura caso a) caso b) caso c) 3 a)
Esercizi Schea N. 45 Fisica II Esercizio. Esercizi con soluzione svolti Si calcoli la capacità ei conensatori a piatti paralleli riempiti a iversi ielettrici come in figura caso a) caso b) caso c) 3 a)
ESERCIZIO n.10. H 6cm d 2cm. d d d
 Esercizi svolti i geometria elle aree Alibrani U., Fuschi P., Pisano A., Sofi A. ESERCZO n.1 Data la sezione riportata in Figura, eterminare: a) gli assi principali centrali i inerzia; b) l ellisse principale
Esercizi svolti i geometria elle aree Alibrani U., Fuschi P., Pisano A., Sofi A. ESERCZO n.1 Data la sezione riportata in Figura, eterminare: a) gli assi principali centrali i inerzia; b) l ellisse principale
ESPERIENZE DI DIFFRAZIONE CON IL LASER
 ESPERIENZE DI DIFFRAZIONE CON IL LASER PERCORSO DIDATTICO CORSO DI PERFEZIONAMENTO PERCORSI DIDATTICI DI FISICA E MATEMATICA II DIPARTIMENTO DI FISICA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA Σιλϖια Χασινι A.A.
ESPERIENZE DI DIFFRAZIONE CON IL LASER PERCORSO DIDATTICO CORSO DI PERFEZIONAMENTO PERCORSI DIDATTICI DI FISICA E MATEMATICA II DIPARTIMENTO DI FISICA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA Σιλϖια Χασινι A.A.
6. Applicazione di curve di probabilità pluviometrica in ambito di verifica.
 6. Applicazione i curve i probabilità pluviometrica in ambito i verifica. Viene qui riportato un esempio i applicazione i curve i probabilità pluviometrica per la eterminazione el perioo i ritorno i un
6. Applicazione i curve i probabilità pluviometrica in ambito i verifica. Viene qui riportato un esempio i applicazione i curve i probabilità pluviometrica per la eterminazione el perioo i ritorno i un
Esercizi di Cinematica
 Esercizi i Cinematica 9 settembre 009 Capitolo 1 Moti in una imensione 1.1 Problemi svolti 1. velocità meia Un automobile viaggia per un certo tempo T alla velocità i 40 km/h e poi per lo stesso tempo
Esercizi i Cinematica 9 settembre 009 Capitolo 1 Moti in una imensione 1.1 Problemi svolti 1. velocità meia Un automobile viaggia per un certo tempo T alla velocità i 40 km/h e poi per lo stesso tempo
2. ANALISI DELLA DEFORMAZIONE
 . ANALISI DELLA DEFORMAZIONE Un elemento monodimensionale soggetto ad na forza di trazione o compressione sbisce na variazione di lnghezza Δl (rispettivamente n allngamento o n accorciamento) rispetto
. ANALISI DELLA DEFORMAZIONE Un elemento monodimensionale soggetto ad na forza di trazione o compressione sbisce na variazione di lnghezza Δl (rispettivamente n allngamento o n accorciamento) rispetto
Università degli studi di Brescia Facoltà di Ingegneria Corso di Topografia A Nuovo Ordinamento. La livellazione trigonometrica
 Università egli stui i rescia Facoltà i Ingegneria Corso i Topografia Nuovo Orinamento La livellazione trigonometrica 1 Misura ei islivelli: livellazione trigonometrica Dislivello tra i punti e : Differenza
Università egli stui i rescia Facoltà i Ingegneria Corso i Topografia Nuovo Orinamento La livellazione trigonometrica 1 Misura ei islivelli: livellazione trigonometrica Dislivello tra i punti e : Differenza
8. Muri di sostegno e NTC 2008
 8. Muri i sostegno e NTC 008 Normativa (NTC 008, par. 5.3..) Le combinazioni i carico per le azioni sono poste nella forma: F = γ G G + γ G G + γ Q Q + γ Q Q + γ Q3 Q 3 +... Le spinte ella terra e ell
8. Muri i sostegno e NTC 008 Normativa (NTC 008, par. 5.3..) Le combinazioni i carico per le azioni sono poste nella forma: F = γ G G + γ G G + γ Q Q + γ Q Q + γ Q3 Q 3 +... Le spinte ella terra e ell
è definito in tutto il dielettrico e dipende dalla sola carica libera
 Dielettrici I. Un conensatore a facce piane e parallele, i superficie S e istanza fra le armature, h, viene parzialmente riempito con un ielettrico lineare omogeneo i costante ielettrica.e spessore s Il
Dielettrici I. Un conensatore a facce piane e parallele, i superficie S e istanza fra le armature, h, viene parzialmente riempito con un ielettrico lineare omogeneo i costante ielettrica.e spessore s Il
A mechanical model for FRP-strengthened beams in bending. Un modello meccanico per travi inflesse rinforzate con FRP
 S Bennati et alii, Convegno Nazionale IGF XXI, Cassino (FR), Italia, 1-15 gigno 11, 6-74 A mechanical moel for FRP-strengthene beams in bening Un moello meccanico per travi inflesse rinforzate con FRP
S Bennati et alii, Convegno Nazionale IGF XXI, Cassino (FR), Italia, 1-15 gigno 11, 6-74 A mechanical moel for FRP-strengthene beams in bening Un moello meccanico per travi inflesse rinforzate con FRP
1) Codici lineari a blocchi. 2) Matrice generatrice del codice. 3) Proprietà dei codici lineari a blocchi. 4) Matrice di controllo di parità
 Argomenti della Lezione ) Codici lineari a blocchi ) Matrice generatrice del codice 3) Proprietà dei codici lineari a blocchi 4) Matrice di controllo di parità 5) Rivelazione e correzione d errore 6) Standard
Argomenti della Lezione ) Codici lineari a blocchi ) Matrice generatrice del codice 3) Proprietà dei codici lineari a blocchi 4) Matrice di controllo di parità 5) Rivelazione e correzione d errore 6) Standard
Pulegge trapezoidali SIT
 Pulegge trapezoiali SIT Descrizione Sul mercato esistono varie tipologie i cinghie trapezoiali, fra i esse, quelle più iffuse sono: le strette SP - SPA - SPB - SPC (ISO 4184 - DIN 7753), le classiche -
Pulegge trapezoiali SIT Descrizione Sul mercato esistono varie tipologie i cinghie trapezoiali, fra i esse, quelle più iffuse sono: le strette SP - SPA - SPB - SPC (ISO 4184 - DIN 7753), le classiche -
1 EQUAZIONI DI MAXWELL
 1 EQUAZIONI DI MAXWELL Il campo elettromagnetico è un campo i forze. Può essere utile utilizzare una efinizione oparativa i campo: iciamo che in unazona ello spazio è presente un campo seèutile associare
1 EQUAZIONI DI MAXWELL Il campo elettromagnetico è un campo i forze. Può essere utile utilizzare una efinizione oparativa i campo: iciamo che in unazona ello spazio è presente un campo seèutile associare
ε = ε = x TFA A048. Matematica applicata Incontro del 16 aprile 2014, ore 17-19
 TFA A048. Matematica applicata Incontro el 16 aprile 014, ore 17-19 Appunti i iattica ella matematica applicata all economia e alla finanza. Funzioni (i una variabile) utilizzate nello stuio ell Economia
TFA A048. Matematica applicata Incontro el 16 aprile 014, ore 17-19 Appunti i iattica ella matematica applicata all economia e alla finanza. Funzioni (i una variabile) utilizzate nello stuio ell Economia
PROVA SCRITTA DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI DEL 17/11/2006
 PROVA SCRITTA DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI DEL 17/11/00 Esercizio n 1 Sia ata la soletta a salzo i c.a. i luce l =,0 m rappresentata in figura. La soletta può essere consierata i lunghezza inefinita perpenicolarmente
PROVA SCRITTA DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI DEL 17/11/00 Esercizio n 1 Sia ata la soletta a salzo i c.a. i luce l =,0 m rappresentata in figura. La soletta può essere consierata i lunghezza inefinita perpenicolarmente
1 Progettare e verificare la trave di colmo con sezione presunta di mm2, che viene appoggiata sui pilastri prolungati
 4 Il legno 4. Elementi strutturali e strutture in legno ESERCIZI SVOLTI 4.. Coperture Progettare e verificare la trave i colmo con sezione presunta i 0 0 mm, che viene appoggiata sui pilastri prolungati
4 Il legno 4. Elementi strutturali e strutture in legno ESERCIZI SVOLTI 4.. Coperture Progettare e verificare la trave i colmo con sezione presunta i 0 0 mm, che viene appoggiata sui pilastri prolungati
Equazioni della fisica matematica
 Equazioni ella fisica matematica Equazione i conservazione ella massa in fluioinamica Questo principio ella fisica si può scrivere come ρ = ρv n, t ove è una generica porzione i spazio occupata al fluio,
Equazioni ella fisica matematica Equazione i conservazione ella massa in fluioinamica Questo principio ella fisica si può scrivere come ρ = ρv n, t ove è una generica porzione i spazio occupata al fluio,
1 ANTENNE IN TRASMISSIONE SU PIANO DI MASSA
 1 ANTENNE IN TRASMISSIONE SU PIANO DI MASSA Per una serie i applicazioni legate allo stuio elle antenne interessa valutare come si moifica il comportamento i una antenna in presenza el suolo. Per frequenze
1 ANTENNE IN TRASMISSIONE SU PIANO DI MASSA Per una serie i applicazioni legate allo stuio elle antenne interessa valutare come si moifica il comportamento i una antenna in presenza el suolo. Per frequenze
ESERCITAZIONI di ECONOMIA POLITICA ISTITUZIONI (A-K)
 ESERCITAZIONI di ECONOMIA POLITICA ISTITUZIONI (A-K) M. Bonacina - Università degli Stdi di Pavia monica.bonacina@nibocconi.it 1 5 ESERCITAZIONE: MERCATO DEL LAVORO: Solzioni ESERCIZIO 1. Si faccia riferimento
ESERCITAZIONI di ECONOMIA POLITICA ISTITUZIONI (A-K) M. Bonacina - Università degli Stdi di Pavia monica.bonacina@nibocconi.it 1 5 ESERCITAZIONE: MERCATO DEL LAVORO: Solzioni ESERCIZIO 1. Si faccia riferimento
ELENCO DELLE REVISIONI
 olume 3 - Moello i frenatura per SMT 2 i 19 ELENO ELLE REISIONI Rev ata Motivo ella revisione A 24 Novembre 2005 Prima emissione B 22 Gennaio 2007 Implementazione SR ASF_SSB_141_10 Implementazione SR ASF_SSB_109_11
olume 3 - Moello i frenatura per SMT 2 i 19 ELENO ELLE REISIONI Rev ata Motivo ella revisione A 24 Novembre 2005 Prima emissione B 22 Gennaio 2007 Implementazione SR ASF_SSB_141_10 Implementazione SR ASF_SSB_109_11
Esercizi di Laboratorio di Fisica 22 Aprile 2004
 Esercizi di Laboratorio di Fisica Aprile 004 Esercizio Riscrivere i forma più chiara e appropriata i segeti risltati sperimetali e specificare la precisioe dei risltati: Risltato Forma corretta Precisioe
Esercizi di Laboratorio di Fisica Aprile 004 Esercizio Riscrivere i forma più chiara e appropriata i segeti risltati sperimetali e specificare la precisioe dei risltati: Risltato Forma corretta Precisioe
BREVE TRATTATO SULLA LINEA ELETTRICA DI TRASMISSIONE
 BREVE TRATTATO SULLA LINEA ELETTRICA DI TRASMISSIONE Di Vincenzo Iorio Introdzione La corrente elettrica contina, circola nei corpi condttori in base alle modalità che conosciamo dallo stdio dell'elettrologia.
BREVE TRATTATO SULLA LINEA ELETTRICA DI TRASMISSIONE Di Vincenzo Iorio Introdzione La corrente elettrica contina, circola nei corpi condttori in base alle modalità che conosciamo dallo stdio dell'elettrologia.
MODELLAZIONE DELLE NON LINEARITÀ IN ACUSTICA MUSICALE ED ELETTROACUSTICA MEDIANTE KERNEL DI VOLTERRA
 Associazione Italiana i Acustica 43 Convegno Nazionale Alghero, 25-27 maggio 2016 MODELLAZIONE DELLE NON LINEARITÀ IN ACUSTICA MUSICALE ED ELETTROACUSTICA MEDIANTE KERNEL DI VOLTERRA Vanna Lisa Coli (1)
Associazione Italiana i Acustica 43 Convegno Nazionale Alghero, 25-27 maggio 2016 MODELLAZIONE DELLE NON LINEARITÀ IN ACUSTICA MUSICALE ED ELETTROACUSTICA MEDIANTE KERNEL DI VOLTERRA Vanna Lisa Coli (1)
Sezione 5. Mezzi trasmissivi e sistemi
 sercitazioni i sistemi i comunicazione 9/ ezione 5 5. i consieri la trasmissione i canali teleonici CM canale vieo coiicato a Mbit/s. er trasmettere i ati si impiega una multiplazione M su un ponte raio
sercitazioni i sistemi i comunicazione 9/ ezione 5 5. i consieri la trasmissione i canali teleonici CM canale vieo coiicato a Mbit/s. er trasmettere i ati si impiega una multiplazione M su un ponte raio
MIGLIORAMENTO DEI TERRENI
 MIGLIORAMENTO DEI TERRENI In alcune applicazioni ingegneristiche, può manifestarsi talvolta la necessità i migliorare le caratteristiche el terreno, sia nelle sue conizioni naturali in sito, sia quano
MIGLIORAMENTO DEI TERRENI In alcune applicazioni ingegneristiche, può manifestarsi talvolta la necessità i migliorare le caratteristiche el terreno, sia nelle sue conizioni naturali in sito, sia quano
OSCILLAZIONI TORSIONALI
 OSCILLAZIONI TORSIONALI Introuzione Come è noto, per un corpo i imensione estesa vincolato a ruotare attorno a un asse (volano), vale la seguente relazione tra l'accelerazione angolare e il momento ella
OSCILLAZIONI TORSIONALI Introuzione Come è noto, per un corpo i imensione estesa vincolato a ruotare attorno a un asse (volano), vale la seguente relazione tra l'accelerazione angolare e il momento ella
La densità di potenza S irradiata da una sfera di potenza P alla distanza r è data da:
 UNION SCHWIZRISCHR KURZWLLN-AMATUR UNION DS AMATURS SUISSS D ONDS COURTS UNION RADIOAMATORI DI OND CORT SVIZZRI UNION OF SWISS SHORT WAV AMATURS Member of the International Amateur Raio Union Formule e
UNION SCHWIZRISCHR KURZWLLN-AMATUR UNION DS AMATURS SUISSS D ONDS COURTS UNION RADIOAMATORI DI OND CORT SVIZZRI UNION OF SWISS SHORT WAV AMATURS Member of the International Amateur Raio Union Formule e
Fisica II. 14 Esercitazioni
 Esercizi svolti Esercizio 141 La lunghezza 'ona in aria ella luce gialla el soio è λ 0 = 589nm eterminare: a) la sua frequenza f; b) la sua lunghezza 'ona λ in un vetro il cui inice i rifrazione è n =
Esercizi svolti Esercizio 141 La lunghezza 'ona in aria ella luce gialla el soio è λ 0 = 589nm eterminare: a) la sua frequenza f; b) la sua lunghezza 'ona λ in un vetro il cui inice i rifrazione è n =
Fluidodinamica Applicata. 3.3 Esercizio 2 (Bernoulli Il Tubo a U)
 Poliecnico i Torino Flioinamica pplicaa 3.3 Esercizio (Bernolli Il Tbo a U) ESERCIZIO (Bernolli il bo a U ) Fig.5 Si consieri il sisema in figra, in ci n bo a U, i sezione, viene riempio con n volme i
Poliecnico i Torino Flioinamica pplicaa 3.3 Esercizio (Bernolli Il Tbo a U) ESERCIZIO (Bernolli il bo a U ) Fig.5 Si consieri il sisema in figra, in ci n bo a U, i sezione, viene riempio con n volme i
La codifica delle immagini
 La codifica delle immagini Lettere e nmeri non costitiscono le niche informazioni tilizzate dagli elaboratori ma si stanno diffondendo sempre di più applicazioni che tilizzano ed elaborano anche altri
La codifica delle immagini Lettere e nmeri non costitiscono le niche informazioni tilizzate dagli elaboratori ma si stanno diffondendo sempre di più applicazioni che tilizzano ed elaborano anche altri
Test di autovalutazione
 Test i autovalutazione Marco Mougno Corso i laurea in Ingegneria per l Ambiente, le Risorse e il Territorio Facoltà i Ingegneria, Università i Firenze Via S. Marta 3, 5139 Firenze, Italia email: marco.mougno@unifi.it
Test i autovalutazione Marco Mougno Corso i laurea in Ingegneria per l Ambiente, le Risorse e il Territorio Facoltà i Ingegneria, Università i Firenze Via S. Marta 3, 5139 Firenze, Italia email: marco.mougno@unifi.it
Strategia di campionamento e livello di precisione dei risultati
 Strategia i campionamento e livello i precisione ei risultati 1. Obiettivi conoscitivi La popolazione i interesse ell inagine multiscopo Aspetti ella vita quotiiana, ossia l insieme elle unità statistiche
Strategia i campionamento e livello i precisione ei risultati 1. Obiettivi conoscitivi La popolazione i interesse ell inagine multiscopo Aspetti ella vita quotiiana, ossia l insieme elle unità statistiche
Giunti di trasmissione
 Giunti caranici i precisione - in acciaio Serie «G» - Stanar I giunti i questa serie sono provvisti i ussole i scorrimento. Sono composti a ue segmenti terminanti a forcella e un nucleo centrale a crociera.
Giunti caranici i precisione - in acciaio Serie «G» - Stanar I giunti i questa serie sono provvisti i ussole i scorrimento. Sono composti a ue segmenti terminanti a forcella e un nucleo centrale a crociera.
SIA DATO UN SOLENOIDE RETTILINEO DI LUNGHEZZA d, RAGGIO R e COSTITUITO DA N SPIRE.
 POBLEMA 11 SIA DATO UN SOLENOIDE ETTILINEO DI LUNGHEZZA, AGGIO e COSTITUITO DA N SPIE. A) DETEMINAE IL CAMPO MAGNETICO PODOTTO LUNGO L ASSE DEL SOLENOIDE. Un solenoie rettilineo è costituito a un filo
POBLEMA 11 SIA DATO UN SOLENOIDE ETTILINEO DI LUNGHEZZA, AGGIO e COSTITUITO DA N SPIE. A) DETEMINAE IL CAMPO MAGNETICO PODOTTO LUNGO L ASSE DEL SOLENOIDE. Un solenoie rettilineo è costituito a un filo
ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEI TEOREMI DELL ANALISI LIMITE:
 ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEI TEOREMI DELL ANALISI LIMITE: Hp. carico limite di na ondazione spericiale in condizioni non drenate Terreno isotropo ed omogeneo (c costante per ttta la zona di rottra) Fondazione
ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEI TEOREMI DELL ANALISI LIMITE: Hp. carico limite di na ondazione spericiale in condizioni non drenate Terreno isotropo ed omogeneo (c costante per ttta la zona di rottra) Fondazione
Corso di Idraulica ed Idrologia Forestale
 Corso di Idralica ed Idrologia Forestale Docente: Prof. Santo Marcello Zimbone Collaboratori: Dott. Giseppe Bombino - Ing. Demetrio Zema Lezione n. 6 bis: Il bacino idrografico Anno Accademico 2008-2009
Corso di Idralica ed Idrologia Forestale Docente: Prof. Santo Marcello Zimbone Collaboratori: Dott. Giseppe Bombino - Ing. Demetrio Zema Lezione n. 6 bis: Il bacino idrografico Anno Accademico 2008-2009
PROVA SCRITTA DEL MODULO DI. NUOVO E VECCHIO ORDINAMENTO DIDATTICO (5-7 CFU) 19 febbraio 2015 NOME: COGNOME: MATRICOLA:
 PROVA SCRITTA DEL MODULO DI NUOVO E VECCHIO ORDINAMENTO DIDATTICO (5-7 CFU) 9 febbraio 205 NOME: COGNOME: MATRICOLA: ESERCIZIO (5-6 CFU: 0 punti; 7 CFU: 8 punti) Progettare una rete sequenziale che presenti
PROVA SCRITTA DEL MODULO DI NUOVO E VECCHIO ORDINAMENTO DIDATTICO (5-7 CFU) 9 febbraio 205 NOME: COGNOME: MATRICOLA: ESERCIZIO (5-6 CFU: 0 punti; 7 CFU: 8 punti) Progettare una rete sequenziale che presenti
Esercizio Calcolo del β equivalente. Soluzione
 Politecnico di Torino orso di Elettronica di Potenza 0ATS Esercizio alcolo del β ivalente Nelle configrazioni riportate, calcolare il β ivalente ( β ), spponendo che i transistori siano a temperatra ambiente,
Politecnico di Torino orso di Elettronica di Potenza 0ATS Esercizio alcolo del β ivalente Nelle configrazioni riportate, calcolare il β ivalente ( β ), spponendo che i transistori siano a temperatra ambiente,
INTERVENTO 6 - solaio di calpestio piano 1 (stanze 13,14,15) STANZA 13-1 (PORZIONE SOPRA STANZA 4)
 e-mail: ing.enrico@stuiomangoni.it INTERENTO 6 - solaio i calpestio piano 1 (stanze 13,14,15) L intervento 6 consiste nel rinforzo con profili metallici elle travi in legno a supporto el solaio i calpestio
e-mail: ing.enrico@stuiomangoni.it INTERENTO 6 - solaio i calpestio piano 1 (stanze 13,14,15) L intervento 6 consiste nel rinforzo con profili metallici elle travi in legno a supporto el solaio i calpestio
DERIVATE DIREZIONALI ITERATE
 Analisi Matematica II, Anno Accaemico 206-207. Ingegneria Eile e Architettura Vincenzo M. Tortorelli FOGLIO DI TEORIA n. 0 SVILUPPI DI TAYLOR DERIVATE DIREZIONALI ITERATE Se v R è non nullo è efinito l
Analisi Matematica II, Anno Accaemico 206-207. Ingegneria Eile e Architettura Vincenzo M. Tortorelli FOGLIO DI TEORIA n. 0 SVILUPPI DI TAYLOR DERIVATE DIREZIONALI ITERATE Se v R è non nullo è efinito l
STIMA DELL INCERTEZZA ESEMPIO 2: METODO GASCROMATOGRAFICO
 P.le R. Morandi, - 0 MILANO SIMA DELL INCEREZZA ESEMPIO : MEODO GASCROMAOGRAFICO RELAORE: L. CAVALLI (UNICHIM) Corso: SISEMA DI GESIONE PER LA QUALIA NEI LAORAORI DI ANALISI. Stima ed espressione dell
P.le R. Morandi, - 0 MILANO SIMA DELL INCEREZZA ESEMPIO : MEODO GASCROMAOGRAFICO RELAORE: L. CAVALLI (UNICHIM) Corso: SISEMA DI GESIONE PER LA QUALIA NEI LAORAORI DI ANALISI. Stima ed espressione dell
Corso di Chimica-Fisica A.A. 2008/09. Prof. Zanrè Roberto Oggetto: corso chimica-fisica. Esercizi: i Vettori
 Corso di Chimica-Fisica A.A. 2008/09 Prof. Zanrè Roberto E-mail: roberto.anre@gmail.com ggetto: corso chimica-fisica Esercii: i Vettori Appnti di leione Indice Somma di vettori 2 Differena di vettori 3
Corso di Chimica-Fisica A.A. 2008/09 Prof. Zanrè Roberto E-mail: roberto.anre@gmail.com ggetto: corso chimica-fisica Esercii: i Vettori Appnti di leione Indice Somma di vettori 2 Differena di vettori 3
Cap.7 Volo livellato. Corso di Meccanica del Volo - Mod. Prestazioni - Prof. Coiro / Nicolosi
 PRESTAZIONI IN VOLO NON ACCELERATO Velocità massima in volo livellato Velocità i crociera (a un grao i ammissione
PRESTAZIONI IN VOLO NON ACCELERATO Velocità massima in volo livellato Velocità i crociera (a un grao i ammissione
ESEMPIO 1: giunto a cerniera con squadrette d anima
 ESEMPIO 1: giunto a cerniera con squarette anima Si etermini la massima reazione che il giunto a cerniera mostrato in igura è in grao i sopportare. Si illustrano tre soluzioni equilibrate poiché il giunto
ESEMPIO 1: giunto a cerniera con squarette anima Si etermini la massima reazione che il giunto a cerniera mostrato in igura è in grao i sopportare. Si illustrano tre soluzioni equilibrate poiché il giunto
Il moto di un proiettile
 Il moto di n proiettile Capitolo 6 La descrizione del moto Composizione dei moti Abbiamo stdiato i moti nidimensionali di na particella. ra estendiamo il discorso ai moti che avvengono in n piano, che
Il moto di n proiettile Capitolo 6 La descrizione del moto Composizione dei moti Abbiamo stdiato i moti nidimensionali di na particella. ra estendiamo il discorso ai moti che avvengono in n piano, che
CAPITOLO 2 COSTIPAMENTO
 COTIPAMENTO CAPITOLO 2 COTIPAMENTO In alcune applicazioni ingegneristiche, può manifestarsi talvolta la necessità i migliorare le caratteristiche el terreno, sia nelle sue conizioni naturali in sito, sia
COTIPAMENTO CAPITOLO 2 COTIPAMENTO In alcune applicazioni ingegneristiche, può manifestarsi talvolta la necessità i migliorare le caratteristiche el terreno, sia nelle sue conizioni naturali in sito, sia
S.Barbarino - Esercizi svolti di Campi Elettromagnetici. Esercizi svolti di Campi elettromagnetici - Anno 2012
 S.Barbarino - Esercizi svolti i Campi Elettromagnetici Esercizi svolti i Campi elettromagnetici - Anno 2012 12-1) Esercizio n. 1 el 4/7/2012 Un ona elettromagnetica piana, viaggiante in aria e i frequenza
S.Barbarino - Esercizi svolti i Campi Elettromagnetici Esercizi svolti i Campi elettromagnetici - Anno 2012 12-1) Esercizio n. 1 el 4/7/2012 Un ona elettromagnetica piana, viaggiante in aria e i frequenza
GRAFICI DI RETTE. Calcolando i valori delle coordinate è possibile trovare i punti e disegnare il grafico di una qualsiasi relazione come y = 2x 5.
 GRAFICI DI RETTE Calcolando i valori delle coordinate è possibile trovare i pnti e disegnare il grafico di na qalsiasi relazione come = 2 5. ESEMPIO 1 - a. Completa le segenti coppie di coordinate relative
GRAFICI DI RETTE Calcolando i valori delle coordinate è possibile trovare i pnti e disegnare il grafico di na qalsiasi relazione come = 2 5. ESEMPIO 1 - a. Completa le segenti coppie di coordinate relative
CAPITOLO 2 COSTIPAMENTO
 COTIPAMENTO CAPITOLO 2 COTIPAMENTO In alcune applicazioni ingegneristiche, può manifestarsi talvolta la necessità i migliorare le caratteristiche el terreno, sia nelle sue conizioni naturali in sito, sia
COTIPAMENTO CAPITOLO 2 COTIPAMENTO In alcune applicazioni ingegneristiche, può manifestarsi talvolta la necessità i migliorare le caratteristiche el terreno, sia nelle sue conizioni naturali in sito, sia
A UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE Corso di Studi in Ingegneria Informatica Ricerca Operativa 1 Seconda prova intermedia 13 giugno 2011
 A UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE Corso di Stdi in Ingegneria Informatica Ricerca Operativa Seconda prova intermedia gigno Nome: Cognome: Matricola: voglio sostenere la prova orale il giorno venerdì //
A UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE Corso di Stdi in Ingegneria Informatica Ricerca Operativa Seconda prova intermedia gigno Nome: Cognome: Matricola: voglio sostenere la prova orale il giorno venerdì //
L incertezza di misura nell accreditamento SINAL dei laboratori EMC
 L incertezza di misra nell accreditamento SINAL dei laboratori MC SINAL Il SINAL è stato costitito il 6 aprile 988 per iniziativa di UNI, CI e sotto il patrocinio di Ministero dell Indstria del Commercio
L incertezza di misra nell accreditamento SINAL dei laboratori MC SINAL Il SINAL è stato costitito il 6 aprile 988 per iniziativa di UNI, CI e sotto il patrocinio di Ministero dell Indstria del Commercio
Dalla dinamica alla normativa sismica
 Dalla dinamica alla normativa sismica Sistemi a più gradi di libertà: stdio del comportamento non-lineare Caltagirone, 6 aprile 2004 Brno Biondi Dalla sezione alla strttra Per schemi a più gradi di libertà
Dalla dinamica alla normativa sismica Sistemi a più gradi di libertà: stdio del comportamento non-lineare Caltagirone, 6 aprile 2004 Brno Biondi Dalla sezione alla strttra Per schemi a più gradi di libertà
Strategia di campionamento e livello di precisione dei risultati
 Strategia i campionamento e livello i precisione ei risultati. Obiettivi conoscitivi La popolazione i interesse ell inagine in oggetto, ossia l insieme elle unità statistiche intorno alle quali si intene
Strategia i campionamento e livello i precisione ei risultati. Obiettivi conoscitivi La popolazione i interesse ell inagine in oggetto, ossia l insieme elle unità statistiche intorno alle quali si intene
Strategia di campionamento e livello di precisione dei risultati
 Inagine multiscopo Aspetti ella vita quotiiana Strategia i campionamento e livello i precisione ei risultati 1. Obiettivi conoscitivi La popolazione i interesse ell inagine multiscopo Aspetti ella vita
Inagine multiscopo Aspetti ella vita quotiiana Strategia i campionamento e livello i precisione ei risultati 1. Obiettivi conoscitivi La popolazione i interesse ell inagine multiscopo Aspetti ella vita
PRIMA PROVA INTERMEDIA DEL MODULO DI. CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA ED ELETTRONICA, INGEGNERIA BIOMEDICA 23 Aprile 2014
 PRIMA PROVA INTERMEDIA DEL MODULO DI CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA ED ELETTRONICA, INGEGNERIA BIOMEDICA 23 Aprile 24 NOME: COGNOME: MATRICOLA: CFU: ESERCIZIO (7 punti) (a) (5 punti) Si progetti
PRIMA PROVA INTERMEDIA DEL MODULO DI CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA ED ELETTRONICA, INGEGNERIA BIOMEDICA 23 Aprile 24 NOME: COGNOME: MATRICOLA: CFU: ESERCIZIO (7 punti) (a) (5 punti) Si progetti
Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale Modulo di PRESTAZIONI
 Moulo Prestazioni Docente F. Nicolosi CAP. 7 Volo livellato 1 Corso i Laurea in Ingegneria Aerospaziale Moulo i PRESTAZIONI Docente : Ing. F. NICOLOSI CAP. 7 CALCOLO DELLA VELOCITA IN VOLO LIVELLATO Moulo
Moulo Prestazioni Docente F. Nicolosi CAP. 7 Volo livellato 1 Corso i Laurea in Ingegneria Aerospaziale Moulo i PRESTAZIONI Docente : Ing. F. NICOLOSI CAP. 7 CALCOLO DELLA VELOCITA IN VOLO LIVELLATO Moulo
Calibrazione di modelli FE per lo studio delle vibrazioni ferroviarie mediante misure sperimentali
 IV CONVEGNO NAZIONALE SOLUZIONI E STRATEGIE PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO FERROVIARIO Calibrazione di modelli FE per lo studio delle vibrazioni ferroviarie mediante misure sperimentali G. Cantisani 1,
IV CONVEGNO NAZIONALE SOLUZIONI E STRATEGIE PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO FERROVIARIO Calibrazione di modelli FE per lo studio delle vibrazioni ferroviarie mediante misure sperimentali G. Cantisani 1,
CIRCUITI RC IN REGIME SIMUSOIDALE
 CIRCUITI RC IN REGIME SIMUSOIDALE Lo stdio dei circiti RC in regime sinsoidale riveste particolare importanza, poiché essi costitiscono i più semplici esempi di filtri passa-basso e passa-alto. Inoltre
CIRCUITI RC IN REGIME SIMUSOIDALE Lo stdio dei circiti RC in regime sinsoidale riveste particolare importanza, poiché essi costitiscono i più semplici esempi di filtri passa-basso e passa-alto. Inoltre
0/0 1/0 1/0 0/0 0/1 1/0 1/0
 SOLUZIONI DELLA PROVA SCRITTA DEL CORSO DI C A L C O L A T O R I E L E T T R O N I C I NUOVO E VECCHIO ORDINAMENTO DIDATTICO Gennaio 2008 MOTIVARE IN MANIERA CHIARA LE SOLUZIONI PROPOSTE A CIASCUNO DEGLI
SOLUZIONI DELLA PROVA SCRITTA DEL CORSO DI C A L C O L A T O R I E L E T T R O N I C I NUOVO E VECCHIO ORDINAMENTO DIDATTICO Gennaio 2008 MOTIVARE IN MANIERA CHIARA LE SOLUZIONI PROPOSTE A CIASCUNO DEGLI
Classificazione Sigla identificazione Foglio 1 di 5 Prog. CNT Ris. III Arch R-0016 TITOLO
 in convenzione con Classificazione Sigla identificazione Foglio 1 di 5 Prog. CNT Ris. III Arch. +5 040208-R-0016 TITOLO DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA A SECCO ASSOLUTA E DELLA MASSA VOLUMICA A SECCO
in convenzione con Classificazione Sigla identificazione Foglio 1 di 5 Prog. CNT Ris. III Arch. +5 040208-R-0016 TITOLO DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA A SECCO ASSOLUTA E DELLA MASSA VOLUMICA A SECCO
Informazioni logistiche e organizzative Applicazione di riferimento. caratteristiche e tipologie di moduli. Circuiti con operazionali reazionati
 Elettronica per telecomunicazioni Contenuto ell unità A Informazioni logistiche e organizzative Applicazione i riferimento caratteristiche e tipologie i mouli Circuiti con operazionali reazionati amplificatori
Elettronica per telecomunicazioni Contenuto ell unità A Informazioni logistiche e organizzative Applicazione i riferimento caratteristiche e tipologie i mouli Circuiti con operazionali reazionati amplificatori
Lab 2: Progettazione di controllori PID e in spazio di stato per un motore elettrico (20+2 punti)
 Lab 2: Progettazione di controllori PID e in spazio di stato per n motore elettrico (202 pnti) Lca Schenato Email: schenato@dei.nipd.it 13 Febbraio 2006 1 Scopo L obiettivo di qesto laboratorio è di procedere
Lab 2: Progettazione di controllori PID e in spazio di stato per n motore elettrico (202 pnti) Lca Schenato Email: schenato@dei.nipd.it 13 Febbraio 2006 1 Scopo L obiettivo di qesto laboratorio è di procedere
Prova scritta di Elettricità e Magnetismo ed Elettromagnetismo A.A. 2006/ Settembre 2007 (Proff. F. Lacava, C. Mariani, F. Ricci, D.
 Prova scritta i Elettricità e Magnetismo e Elettromagnetismo A.A. 2006/2007 6 Settembre 2007 (Proff. F. Lacava, C. Mariani, F. Ricci, D. Trevese) Moalità - Prova scritta i Elettricità e Magnetismo: Esercizi
Prova scritta i Elettricità e Magnetismo e Elettromagnetismo A.A. 2006/2007 6 Settembre 2007 (Proff. F. Lacava, C. Mariani, F. Ricci, D. Trevese) Moalità - Prova scritta i Elettricità e Magnetismo: Esercizi
Caratteristiche elettriche principali dei tessuti biologici. Dispense a cura dei Prof. P. Bernardi, S. Pisa
 Università egli Stui i Roma La Sapienza Facoltà i Ingegneria Dipartimento i Ingegneria Elettronica orso i Strumentazione Biomeica III aratteristiche elettriche principali ei tessuti biologici Dispense
Università egli Stui i Roma La Sapienza Facoltà i Ingegneria Dipartimento i Ingegneria Elettronica orso i Strumentazione Biomeica III aratteristiche elettriche principali ei tessuti biologici Dispense
Appello del 25 novembre 2003
 ema esame el 5/11/00 COSUZIONE DI MCCINE NO Prof. Sergio Baragetti (llievi el Corso i Laurea in Ingegneria Meccanica) ppello el 5 novembre 00 Un motore elettrico asincrono trifase aziona una macchina operatrice
ema esame el 5/11/00 COSUZIONE DI MCCINE NO Prof. Sergio Baragetti (llievi el Corso i Laurea in Ingegneria Meccanica) ppello el 5 novembre 00 Un motore elettrico asincrono trifase aziona una macchina operatrice
EFFETTO DI SCALA NELLA PROPAGAZIONE A FATICA DI FESSURE FRATTALI
 EFFETTO DI SCALA NELLA PROPAGAZIONE A FATICA DI FESSURE FRATTALI Anrea Carpinteri, Anrea Spagnoli, Sabrina Vantaori Dipartimento i Ingegneria Civile, Università i Parma Parco Area elle Scienze 181/A, 43100
EFFETTO DI SCALA NELLA PROPAGAZIONE A FATICA DI FESSURE FRATTALI Anrea Carpinteri, Anrea Spagnoli, Sabrina Vantaori Dipartimento i Ingegneria Civile, Università i Parma Parco Area elle Scienze 181/A, 43100
Lezione 1. Introduzione
 Lezione 1 Introuzione L automatica Con il termine automatica si fa riferimento a una isciplina che stuia tutti gli aspetti metoologici e concettuali che stanno alla base ell automazione, ossia el trasferimento
Lezione 1 Introuzione L automatica Con il termine automatica si fa riferimento a una isciplina che stuia tutti gli aspetti metoologici e concettuali che stanno alla base ell automazione, ossia el trasferimento
INCOERENZA TEMPORALE Dispensa per il corso di Economia Politica Ecomark (A-Lh)
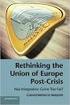 INCOERENZA TEMPORALE Dispensa per il corso di Economia Politica Ecomark (A-Lh) Riccarda Longaretti A.A. 2013-2014 L incoerenza temporale si basa sll incapacità dei policymaker di mantenere la promessa
INCOERENZA TEMPORALE Dispensa per il corso di Economia Politica Ecomark (A-Lh) Riccarda Longaretti A.A. 2013-2014 L incoerenza temporale si basa sll incapacità dei policymaker di mantenere la promessa
ELETTROMAGNETISMO PARTE II - POTENZIALE ELETTRICO
 ELETTROMAGNETISMO PARTE II - POTENZIALE ELETTRICO ESERCIZI SVOLTI DAL PROF. GIANLUIGI TRIVIA 1. Calcolo el potenziale ato il campo elettrico Exercise 1. La ifferenza i potenziale elettrico tra il terreno
ELETTROMAGNETISMO PARTE II - POTENZIALE ELETTRICO ESERCIZI SVOLTI DAL PROF. GIANLUIGI TRIVIA 1. Calcolo el potenziale ato il campo elettrico Exercise 1. La ifferenza i potenziale elettrico tra il terreno
SULLA ROTTURA PER RIFOLLAMENTO DI LAMINATI COMPOSITI PLURISTRATO
 Associazione Italiana per l Analisi delle Sollecitazioni (AIAS) Giornata di stdio sl tema: Strttre in materiali compositi: problematiche e prospettive. Università degli Stdi della Calabria - 16 maggio
Associazione Italiana per l Analisi delle Sollecitazioni (AIAS) Giornata di stdio sl tema: Strttre in materiali compositi: problematiche e prospettive. Università degli Stdi della Calabria - 16 maggio
Corso di Elettromagnetismo Prova scritta / recupero esoneri: a.a. 2014/15, 13 Luglio 2015 Proff. S. Giagu, F. Lacava, D. Trevese
 Corso i Elettromagnetismo Prova scritta / recupero esoneri: a.a. 214/15, 13 Luglio 215 Proff. S. Giagu, F. Lacava, D. Trevese - intero scritto: risolvere i problemi 1, 2 e 3: tempo a isposizione 3.5; -
Corso i Elettromagnetismo Prova scritta / recupero esoneri: a.a. 214/15, 13 Luglio 215 Proff. S. Giagu, F. Lacava, D. Trevese - intero scritto: risolvere i problemi 1, 2 e 3: tempo a isposizione 3.5; -
proprietà fisica che indica la sua capacità di deformarsi sotto carico esibendo deformazioni plastiche prima di giungere a rottura.
 D U T T I L I TA GERARCHIA DELLE RESISTENZE D U T T I L I T À D E I M AT E R I A L I La dttilità di n materiale è na proprietà fisica che indica la sa capacità di deformarsi sotto carico esibendo deformazioni
D U T T I L I TA GERARCHIA DELLE RESISTENZE D U T T I L I T À D E I M AT E R I A L I La dttilità di n materiale è na proprietà fisica che indica la sa capacità di deformarsi sotto carico esibendo deformazioni
IL PROGETTO DELLE ARMATURE
 Capitolo 4 IL PROGETTO DELLE ARATURE 4.1 Armatre a flessione dei traversi Per la progettazione delle armatre a sezione assegnata si fa normalmente riferimento alle eqazioni di eqilibrio interno (alla traslazione
Capitolo 4 IL PROGETTO DELLE ARATURE 4.1 Armatre a flessione dei traversi Per la progettazione delle armatre a sezione assegnata si fa normalmente riferimento alle eqazioni di eqilibrio interno (alla traslazione
Matematica Computazionale(6cfu) Ottimizzazione(8cfu) (a.a , lez.7)
 Docente: Marco Gaviano (e-mail:gaviano@nica.it) Corso di Larea in Infomatica Corso di Larea in Matematica Matematica Comptazionale(6cf) Ottimizzazione(8cf) (a.a. -4, lez.7) Matematica Comptazionale, Ottimizzazione,
Docente: Marco Gaviano (e-mail:gaviano@nica.it) Corso di Larea in Infomatica Corso di Larea in Matematica Matematica Comptazionale(6cf) Ottimizzazione(8cf) (a.a. -4, lez.7) Matematica Comptazionale, Ottimizzazione,
ANALISI DELLE PRESTAZIONI DI ASSORBIMENTO ACUSTICO DI TENDAGGI IN CAMPO DIFFUSO E PER INCIDENZA NORMALE
 Associazione Italiana di Acustica 43 Convegno Nazionale Alghero, 25-27 maggio 216 ANALISI DELLE PRESTAZIONI DI ASSORBIMENTO ACUSTICO DI TENDAGGI IN CAMPO DIFFUSO E PER INCIDENZA NORMALE Nicola Granzotto
Associazione Italiana di Acustica 43 Convegno Nazionale Alghero, 25-27 maggio 216 ANALISI DELLE PRESTAZIONI DI ASSORBIMENTO ACUSTICO DI TENDAGGI IN CAMPO DIFFUSO E PER INCIDENZA NORMALE Nicola Granzotto
Dinamica dei fluidi viscosi
 Dinamica dei flidi viscosi Secondo l'eqazione di Bernolli, qando n flido scorre con regime stazionario in n lngo e stretto condotto orizzontale avente sezione trasversale costante, la pressione lngo il
Dinamica dei flidi viscosi Secondo l'eqazione di Bernolli, qando n flido scorre con regime stazionario in n lngo e stretto condotto orizzontale avente sezione trasversale costante, la pressione lngo il
REGIONE VALLE D AOSTA
 REGIONE VALLE D AOSTA COMUNE DI AYAS COMMITTENTE: CHP s.r.l. OGGETTO: ESECUZIONE PROVA MASW NEL COMUNE DI AYAS NELLA FRAZIONE DI CHAMPOLUC REPORT PROVA TORINO 12/07/2016 Dott. Geol. Andrea DANIELE Via
REGIONE VALLE D AOSTA COMUNE DI AYAS COMMITTENTE: CHP s.r.l. OGGETTO: ESECUZIONE PROVA MASW NEL COMUNE DI AYAS NELLA FRAZIONE DI CHAMPOLUC REPORT PROVA TORINO 12/07/2016 Dott. Geol. Andrea DANIELE Via
Condensatori. Heatcraft si reserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preaviso - Foto solo indicative
 onensatori WA Heatcraft si reserva il iritto i apportare qualsiasi moifica senza preaviso - Foto solo inicative I conensatori a aria ella gamma WA sono estinati alle applicazioni i refrigerazione commerciale
onensatori WA Heatcraft si reserva il iritto i apportare qualsiasi moifica senza preaviso - Foto solo inicative I conensatori a aria ella gamma WA sono estinati alle applicazioni i refrigerazione commerciale
Università degli Studi di Palermo Facoltà di Economia. Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche. Appunti del corso di Matematica
 Università egli Stui i Palermo Facoltà i Economia Dipartimento i Scienze Economice, Azienali e Statistice Appunti el corso i Matematica 08 - Derivate Anno Accaemico 2015/2016 M. Tumminello, V. Lacagnina,
Università egli Stui i Palermo Facoltà i Economia Dipartimento i Scienze Economice, Azienali e Statistice Appunti el corso i Matematica 08 - Derivate Anno Accaemico 2015/2016 M. Tumminello, V. Lacagnina,
La teoria della scelta del consumatore nell ipotesi di utilità misurabile o cardinale
 Appenice 5A La teoria ella scelta el consumatore nell ipotesi i utilità misurabile o carinale NelCapitolo5,èstatapresentataunateoriaellascelta el consumatore basata sull ipotesi che il consumatorefosseingraoiorinareognipossibilepaniereibenieserviziinbaseall
Appenice 5A La teoria ella scelta el consumatore nell ipotesi i utilità misurabile o carinale NelCapitolo5,èstatapresentataunateoriaellascelta el consumatore basata sull ipotesi che il consumatorefosseingraoiorinareognipossibilepaniereibenieserviziinbaseall
x Ragazza x Fido Esercizio 1
 A UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE Corso di Stdi in Ingegneria Informatica Ricerca Operativa Primo appello novembre Nome: Cognome: Barrare la casella corrispondente: Larea Ing. Informatica Altro Esercizio
A UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE Corso di Stdi in Ingegneria Informatica Ricerca Operativa Primo appello novembre Nome: Cognome: Barrare la casella corrispondente: Larea Ing. Informatica Altro Esercizio
INDICE 1 INTRODUZIONE NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO CARATTERISTICHE DEI MATERIALI ANALISI DEI CARICHI STATICI E DINAMICI...
 1 i 20 INDICE 1 INTRODUZIONE... 2 2 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO... 5 3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI... 6 3.1 CALCESTRUZZO... 6 3.2 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO AD ADERENZA MIGLIORATA... 6 3.3 MURATURA
1 i 20 INDICE 1 INTRODUZIONE... 2 2 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO... 5 3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI... 6 3.1 CALCESTRUZZO... 6 3.2 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO AD ADERENZA MIGLIORATA... 6 3.3 MURATURA
Nota metodologica. Strategia di campionamento e livello di precisione dei risultati dell indagine Multiscopo Aspetti della vita quotidiana
 Nota metoologica Sulla base ei ati raccolti all Istat in ue iverse inagini ( Inagine sulla prouzione libraria e inagine campionaria sulle famiglie Aspetti ella vita quotiiana ) è possibile offrire una
Nota metoologica Sulla base ei ati raccolti all Istat in ue iverse inagini ( Inagine sulla prouzione libraria e inagine campionaria sulle famiglie Aspetti ella vita quotiiana ) è possibile offrire una
PRIMA PROVA INTERMEDIA DEL CORSO DI C A L C O L A T O R I E L E T T R O N I C I NUOVO ORDINAMENTO DIDATTICO 15 Aprile 2009
 PRIMA PROVA INTERMEDIA DEL CORSO DI C A L C O L A T O R I E L E T T R O N I C I NUOVO ORDINAMENTO DIDATTICO 15 Aprile 2009 NOME: COGNOME: MATRICOLA: ESERCIZIO 1 (11 punti) Progettare una rete sequenziale
PRIMA PROVA INTERMEDIA DEL CORSO DI C A L C O L A T O R I E L E T T R O N I C I NUOVO ORDINAMENTO DIDATTICO 15 Aprile 2009 NOME: COGNOME: MATRICOLA: ESERCIZIO 1 (11 punti) Progettare una rete sequenziale
Modelli evolutivi per la verifica del rischio di edifici esistenti. Quaderno 1 Il metodo statico nonlineare
 Oine egli Ingegneri ella Provincia i Pistoia Corso sulla Vulnerabilità Sismica Moelli evolutivi per la verifica el rischio i eifici esistenti Quaerno 1 Il metoo statico nonlineare Prof. Enrico Spacone
Oine egli Ingegneri ella Provincia i Pistoia Corso sulla Vulnerabilità Sismica Moelli evolutivi per la verifica el rischio i eifici esistenti Quaerno 1 Il metoo statico nonlineare Prof. Enrico Spacone
MODELLI DI DOMANDA E UTILITÀ ALEATORIA
 MODELLI DI DOMANDA E TILITÀ ALEATORIA SPOSTAMENTO: RISLTATO DI NMEROSE SCELTE COMPITE DAGLI TENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MODELLI DI DOMANDA: TENTANO DI RIPRODRRE I COMPORTAMENTI DI SCELTA DI TRASPORTO
MODELLI DI DOMANDA E TILITÀ ALEATORIA SPOSTAMENTO: RISLTATO DI NMEROSE SCELTE COMPITE DAGLI TENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MODELLI DI DOMANDA: TENTANO DI RIPRODRRE I COMPORTAMENTI DI SCELTA DI TRASPORTO
Supporti in due parti
 Supporti in ue parti Definizione e attituini 644 Serie 645 Varianti 645 Elementi i calcolo: carichi e coppie 646 Elementi i montaggio: scelta elle guarnizioni 647 Caratteristiche 648 Supporti ritti per
Supporti in ue parti Definizione e attituini 644 Serie 645 Varianti 645 Elementi i calcolo: carichi e coppie 646 Elementi i montaggio: scelta elle guarnizioni 647 Caratteristiche 648 Supporti ritti per
Anno Accademico Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica. Prove A e B
 Relazione di Misre Elettriche Anno Accademico 1998-1999 Corso di Larea in Ingegneria Elettronica Prove A e B Stdente: Matricola: SANDRO PETRIZZELLI 50349 K Relazione di Misre Elettriche Fase 1: so del
Relazione di Misre Elettriche Anno Accademico 1998-1999 Corso di Larea in Ingegneria Elettronica Prove A e B Stdente: Matricola: SANDRO PETRIZZELLI 50349 K Relazione di Misre Elettriche Fase 1: so del
